di Fabio Santopietro
Abito alla cosiddetta china town da poco più di un anno in una bella casa borghese, in effetti la prima della mia vita e che se non fosse per la donna con cui vivo non potrei neanche permettermi. La casa sta addirittura su due piani. La mia è la visione di superficie del cittadino qualunque. Non ho fatto indagini, domande, ricerche o interviste. E le cose che sul tema ho ascoltato di solito mi sono state riferite da altri e di loro iniziativa. E non sono nemmeno molte.
Leggendo un articolo apparso sul “Corriere della Sera” un paio di giorni dopo le manifestazioni e gli scontri che hanno movimentato il quartiere scopro con sorpresa che qui i residenti sarebbero italiani al 95 per cento. In effetti non è quello che si vede andando a zonzo. Ho il sospetto che sia una cifra gonfiata allo scopo di rendere ancora più “duro” constatare che la stragrande maggioranza dei negozi sono invece gestiti da cinesi. Scarpe, mutande – di mutande c’è una varietà fantastica, mezze dozzine di esercizi che vendono solo mutande per lo più coloratissime – film di produzione orientale, internet point, vestiti, e sono di solito inaccessibili perché a quanto pare vendono solo all’ingrosso, mentre fino a una decina d’anni fa la zona di Paolo Sarpi era una specie di propaggine del centro per gli acquisti privati.
L’aggettivo duro l’ho messo fra virgolette perché, nello stesso articolo, così un’intervistata diceva del vivere in un quartiere che conta quattro scuole e nemmeno una cartoleria. È sorprendente che per quella signora sia duro vivere in quartiere senza cartolerie. Addirittura duro.

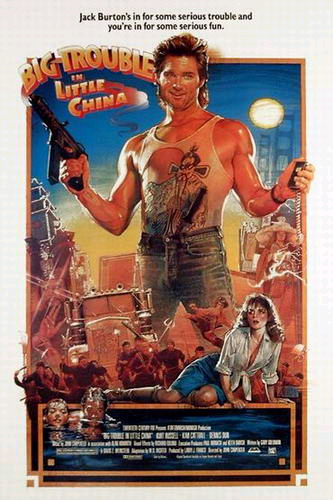



 di Flavio Santi
di Flavio Santi





