[Pubblico alcuni estratti dal libro We Matter: Athletes and Activism di Etan Thomas, Akashic Books 2018, tradotti e introdotti da Riccardo Valsecchi, che ringrazio – JR]
Da ragazzino, il basket era tutto per me. Per la verità, non avevo un gran talento, ma conoscevo ogni dettaglio di qualsiasi giocatore NBA : dati biografici, caratteristiche tecniche, interviste, statistiche anno per anno, partita per partita. Sicché, anche se oggi vivo negli Stati Uniti, in questi tempi di COVID, quando in concomitanza con l’Italia Netflix ha trasmesso il documentario “Last Dance” su Michael Jordan ed i Chicago Bulls, non ho potuto fare a meno di parlarne con i miei compagni di squadra di allora. Mentre in Italia i miei amici si dimostravano estremamente entusiasti, riportati indietro nel tempo dalla memoria delle gesta atletiche di Sua “Airness”, io, a miglia di chilometri di distanza, ragionavo con i miei colleghi odierni sulle critiche e polemiche che il documentario aveva suscitato qui, soprattutto per il disimpegno politico di MJ simbolizzato dalla famosa frase “Republicans buy sneakers too” – anche i Repubblicani comprano scarpe – pronunciata per giustificare il suo mancato appoggio ad un candidato afroamericano democratico del North Carolina nelle elezioni per il Senato del 1990.
Poi, quando il 25 maggio 2020 George Floyd è stato barbaramente ucciso da un poliziotto di Minneapolis, scatenando proteste in tutti gli Stati Uniti, per una volta con il sostegno esplicito anche del riservato ed apolitico MJ, in Italia sono cominciati a circolare sui social network montaggi fotografici come questo qui sotto. Allora ho avuto l’impressione che per gli italiani anche MJ, probabilmente il più grande atleta di tutti i tempi, non è un uomo, non ha diritto di avere un’opinione, di pensare; in Italia, come ogni afro-europeo che corre sui nostri campi di calcio, è considerato solo un animale, tale e quale ad una bestia da trotto, che abbiamo celebrato quando era il più veloce, ed uccidiamo a sangue freddo quando decide di non seguire gli ordini – e le frustate – del fantino.
Per questo, con questi estratti, vorrei farvi conoscere il lavoro e le testimonianze raccolte da Etan Thomas, ex giocatore NBA, poeta, scrittore ed attivista. – Riccardo Valsecchi

ETAN THOMAS – WE MATTER
Dall’introduzione:
Nel momento in cui questo libro viene pubblicato, il Presidente Donald Trump ha lanciato un violento attacco contro ogni giocatore della NFL [Lega professionista di football americano] che ha protestato contro i soprusi della polizia a danno della communita afroamericana, ed alla Lega stessa per non avere sanzionato gli stessi. Il presidente ha pubblicato numerosi tweet chiedendo alla Lega di obbligare i giocatori di stare sull’attenti durante l’inno nazionale. La maggior parte dei giocatori della NFL, e gli amministratori delegati delle squadre, sembrano aver compreso che, in realtà, viviamo in una democrazia, e non sotto dittatura, e che la vera libertà di stampa e la libertà d’espressione sono i valori essenziali su cui si basa una democrazia. Trump, forse inconsciamente, ha gettato benzina sul fuoco della giustizia.
Sfortunatamente, la tempesta di fuoco creata dal Presidente ha creato solo confusione intorno a ciò per cui veramente le proteste sono nate. Non si è mai trattato di protestare contro di lui, contro i militari, o contro la bandiera. Si è trattato e si tratta piuttosto di fare sentire il proprio dissenso contro le uccisioni di esseri umani neri disarmati da parte della polizia, e contro l’inadempienza della giustizia di fronte a queste morti.
Dal cap. 1: I FIGLI DEL MOVIMENTO
Mio figlio Malcolm aveva appena sei anni quando Trayvon Martin fu ucciso. Era un bambino amabile, a cui piacevano gli sport, il cartone animato di Avatar, il nuoto. Chiunque lo considerava un bambino adorabile. Osservavano i lunghi dreads, il gigantesco sorriso, ne ammiravano la gentilezza nel parlare con gli adulti. Era anche un bambino enorme: io sono due metri e sei centimetri, mia moglie un metro ed 80, quindi Malcolm avanzava di testa e spalle sopra tutti i suoi compagni di classe. Perciò, mi sono sentito in dovere di spiegargli che non sarebbe stato sempre guardato come un dolce bambino. Dovevo spiegargli che, più cresceva, essendo così alto per la sua età, più sarebbe stato guardato con timore. Aveva un’innocenza che avrei dovuto rovinare per il suo bene. Si comportava ancora come se chiunque lo avrebbe trattato gentilmente per sempre.
Il caso di Trayvon Martin mi ha sconvolto da così tanti punti di vista che non saprei neppure da dove iniziare. Secondo il rapporto della polizia, il 26 febbraio 2012, Trayvon si sta recando presso un negozio 7-Eleven prima dell’inizio dell’All Star Game della NBA. Passeggia tranquillamente attraversando un quartiere privato dove si era recato per visitare un conoscente. George Zimmerman, non un membro delle forze dell’ordine, ma semplicemente una guardia privata di quartiere, chiama il 911 per segnalare una persona sospetta.
Zimmerman: “Hey, abbiamo avuto alcuni furti nel quartiere e c’è un ragazzo molto sospetto… sembra che abbia brutte intenzioni o che sia sotto l’effetto di stupefacenti o qualche cosa del genere…”
Zimmerman poi specifica che il ragazzo è un nero.
Infine, aggiunge: “Mi ha appena fissato minaccioso.”
Mentre è al telefono con il centralino della polizia, Zimmerman spiega che il ragazzo sta “correndo”. Quando gli viene chiesto dove, risponde, “verso il cancello d’entrata del quartiere.”
Nella registrazione si può sentire il respiro affannato mentre il centralinista chiede a Zimmerman: “Lo sta seguendo?”
Zimmerman risponde di sì, ed il centralinista replica: “Non abbiamo bisogno che lo seguiate.”
Da questa registrazione si evince che sia Trayvon quello spaventato, il che sarebbe anche comprensibile. Se io stesso mi voltassi e vedessi un uomo che mi squadra in un SUV nascosto nell’oscurità senza alcun motivo apparente, mi sentirei altrettanto a disagio.
Quando la polizia arriva, il diciassettenne Trayvon Martin, fedina penale immacolata, nessun precedente, in possesso di una borsa di plastica contenente un pacchetto di caramelle Skittles, una confezione di tè freddo, il proprio cellulare e degli auricolari, giace inerme freddato da un colpo di arma da fuoco.
Zimmerman non viene arrestato, anche se ammette di avere sparato. La polizia ritiene di non aver riscontrato alcuna evidenza probatoria e Zimmerman sostiene di essersi autodifeso.
Mi chiedo, che cosa significa esattamente auto-difesa?
La malaugurata realtà è che nella mente di Zimmerman non c’era alcun bisogno di vedere una pistola, o di notare qualche cosa di pericoloso nel comportamento di Trayvon. È semplicemente una sfortunata realtà che “giovane maschio nero” sia l’equivalente di “minaccia”, e “giovane maschio nero di notte” equivalga ad una minaccia ancora più pericolosa?
Non importa che le direttive su come debbano essere svolte le sorveglianze di quartiere prevedano come regola primaria che la guardia non sia armata.
Non voglio nemmeno soffermarmi sul fatto che nell’arco di otto anni Zimmerman abbia chiamato la polizia 46 volte, o che nel 2005 fosse stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale — un dato che di per sé avrebbe per lo meno dovuto avanzare alcuni dubbi sulla sua compatibilità con il ruolo di vigilante di quartiere.
Non voglio neppure argomentare che la difesa del proprio territorio, garantita dalla legge in Florida, non sia applicabile in questo caso, per il semplice fatto che, come si evince dalle registrazioni, Zimmerman abbandona il proprio veicolo ed insegue Trayvon.
Sicuramente, inoltre, non ho alcuna intenzione di fare delle illazioni sul colore della pelle di Zimmerman. Come ha detto il reverendo Al Sharpton, “il colore della pelle o l’etnia di Zimmerman o di qualsiasi altro cittadino in questo scenario non conta; alla fine ciò che conta è il colore della pelle della vittima, di Trayvon. È il colore della pelle ed il gruppo demografico a cui appartiene la vittima che viene costantemente rappresentato come una minaccia, che viene ripetutamente descritto in maniera negativa nella cultura di massa.”
È questa percezione che ho dovuto insegnare a mio figlio: la mera verità che, nella sua mente, Zimmerman si sentisse giustificato e ragionevolmente spaventato appena ha messo gli occhi su Trayvon. Non ha visto un innocente ragazzino che beveva il tè freddo. Ha visto una minaccia, un criminale, qualcuno che poteva essere sotto l’effetto di droghe, o intento a qualche cosa di malvagio.
Ho dovuto rovinare la visione rosea del mondo di mio figlio. Ho dovuto insegnargli:
- che ci saranno persone che lo vedranno come un nemico anche se non avrà fatto nulla di male;
- che spesso sarà braccato ed accusato, e ci saranno persone che saranno spaventate dal suo aspetto;
- che se la polizia lo ferma, deve cercare di trovarsi in una zona ben visibile, e di non fare alcun movimento brusco;
- di tenere le mani sempre ben visibili, di evitare di tenerle in tasca;
- di spiegare a voce ogni azione (per esempio, “signore, sto mettendo la mano in tasca per prendere la patente”);
- di tenere sempre la ricevuta di ogni acquisto, sicché nessuno lo può accusare falsamente di furto;
- che molto spesso non c’è differenza tra “essere colpevoli” ed “essere visti come colpevoli”
Ho dovuto anche insegnargli di Emmett Till, James Byrd Jr., Amadou Diallo, Sean Bell, Oscar Grant, Rodney King, Eric Garner, Tamir Rice, Rekia Boyd, Philando Castile, Sandra Bland, Michael Brown, Terence Crutcher, John Crawford, Alton Sterling, e Freddie Gray.
Ho dovuto insegnargli tutto questo per la sua sicurezza. Non avrei mai voluto sottrargli la sua innocenza, ma per il suo stesso bene, ho dovuto.
Dal Cap. 2 – L’attivismo degli atleti conta (ATHLETE ACTIVISM MATTERS)
Il commentatore televisivo Geraldo Rivera ha dichiarato durante il programma Fox & Friends che la felpa con cappuccio indossata da Martin quando è stato ucciso è stata responsabile della sua morte tanto quanto l’uomo che l’ha ucciso. L’americano medio sembra essere d’accordo con questa asserzione.
Ciò ha indotto atleti di ogni sport ad aderire alla protesta.
Dwayne Wade e LeBron James, verosimilmente due dei migliori giocatori nella NBA, ma, cosa più importante, anche genitori, decisero allora che era arrivato il momento di far sentire la propria voce, come stavano facendo molti altri nella Lega.
In dimostrazione di solidarietà, LeBron James ha postato una foto di tutta la squadra dei Miami Heat con felpe, testa incappucciata e mani in tasca. Tra gli hashtag aggiunti nella foto: #WeWantJustice #vogliamogiustizia.
(…)
Intervista a Dwyane Wade
Etan: Raccontami della decisione di indossare i cappucci come team.
Dwyane Wade: È stato decisamente normale per molti ragazzi della squadra. Ovviamente, essendo afroamericani, abbiamo dovuto andare a casa e spiegare ai nostri figli questa situazione, rispondere alle loro domande e preoccupazioni, tranquillizzare le loro paure. È stata una conversazione molto difficile, perché si tratta di qualche cosa che potrebbe succedere ad ognuno di noi. Giocavamo in Florida, e sapendo che Travis era un fan dei Miami Heat, ci siamo sentiti in dovere di rilasciare una dichiarazione che aprisse uno spiraglio di luce sulla situazione e cercare di capire che cosa potessimo fare. Non volevamo che si trattasse dell’ennesimo incidente passato inosservato, non ascoltato, non visto. Volevamo che fosse trasmesso in tutto il Paese ed in tutto il mondo, e, dal momento che siamo volti noti della NBA, quindi abbiamo una enorme piattaforma a disposizione, abbiamo utilizzato il nostro potenziale comunicativo per trasmettere questo messaggio. Ed ha trovato riscontro in tantissime altre persone, specialmente dopo che abbiamo mostrato quanto avesse colpito noi.
Etan: Ricordo che tu hai raccontato dei tuoi figli e di quanto adorassero le felpe con il cappuccio. Allo stesso modo, infatti, anch’io raccontavo in giro quanto mio figlio amasse indossare felpe.
Wade: Infatti, questo è il punto. I ragazzini afroamericani, quelli alti quanto i nostri figli… qualsiasi sia la situazione, tutti noi indossiamo felpe con il cappuccio. E da lì a usare quest’aspetto come giustificazione per l’omicidio, come ragione per cui questo ragazzino, Trayvon Martin, non sarà mai più in grado di assaporare i frutti della vita, e non potrà crescere, laurearsi, sposarsi, avere figli, vivere… tutto ciò è molto triste. È stato spazzato via dalla faccia della terra. Per cosa? Per il suo cappuccio? Perché non aveva il diritto di camminare nel quartiere in cui stava semplicemente camminando? Per molti di noi è stato un momento di riflessione da condividere con i nostri figli, per poter discutere il motivo per cui ci sono cose che non teniamo da conto, che diamo per garantite, ed improvvisamente tutto potrebbe finire in tragedia per un nonnulla. Ricordo di avere avuto questa conversazione con i miei figli, ed anche se non hanno capito tutto esattamente, è stato importante informali, cercare di rispondere alle loro domande e parlare di tutto ciò che stava succedendo.
Etan: C’è la percezione errata che l’organizzazione imporrebbe di non parlare pubblicamente su problemi come questo perché potrebbe essere deleterio per il business. O che il proprietario della squadra si potrebbe rivalere sui giocatori multandoli o sospendendoli o addirittura cedendoli se viene fatto qualche cosa del genere riguardo ad un tema che si è rivelato così divisivo e controverso. Ma questo non sembra essere il caso di ciò che è successo qui con i Miami Heat. Inoltre, a me sembra che anche se l’organizzazione fosse stata contro di voi, avendo fatto questa cosa tutti insieme, avete in qualche modo forzato loro la mano a seguirvi su questa strada.
Wade: Penso che oggi viviamo in tempi differenti. Con i social media così potenti, oggi tutti quanti siamo essenzialmente reporter. È diventato così difficile importi di non fare o dire una determinata cosa che tu vuoi comunicare sulla tua piattaforma social. Se l’unico sbocco fosse un giornale o televisione locale, allora forse le squadre avrebbero più controllo su ciò che passa e non passa all’esterno, ma con i social media, siamo in grado di dire praticamente tutto ciò che vogliamo. Comunque, con noi, gli Heat sono stati molto di supporto e non hanno mai provato a dissuaderci dall’essere coinvolti. Sono stati anzi proprio i nostri allenatori a fare le fotografie per noi.
Etan: Gli allenatori?
Wade: Sì, ci hanno aiutato perché sapevano che era molto importante per noi… Onestamente, non sono mai stato in un’organizzazione che non ha dato il proprio supporto ai giocatori che volevano esprimere o fare qualche cosa collettivamente.
Etan: Ora passiamo alla serata di premiazione per l’eccellenza sportiva annuale, durante la quale tu, Carmelo (Anthony) e Chris Paul siete saliti sul palco ed avete rilasciato ognuno la vostra dichiarazione, chiedendo partecipazione ed attivismo ai giocatori, nonché denunciato il sistemico svilimento di neri e latini negli Stati Uniti d’America. Che cosa vi ha indotto a fare queste dichiarazioni congiunte e usare questo particolare evento come piattaforma?
Wade: Beh, non puoi essere nella posizione di LeBron, Carmelo, mia o di Chris Paul, e dare peso a quello che la gente dice. Come sai bene, dobbiamo tutti quanti confrontarci con le critiche, questo fa parte della carriera di atleta. Il 50% del pubblico ti elogerà, il restante 50% sarà lì pronto a criticarti, non importa quello che fai… guarda solo agli attacchi che abbiamo subito per essere amici… questa è semplicemente la natura della bestia. Quindi devi essere sincero con te stesso, con chi sei, e devi compiere determinate azioni perché ci credi veramente. Per quanto riguarda noi, si trattava di un momento più grande di noi stessi, più grande del basket stesso. Era un momento in cui dovevamo rimanere uniti, usare la nostra forza, parlare di qualche cosa che sentivamo importante, e che aiutasse a spingere altri atleti a fare lo stesso… quindi abbiamo usato questo evento come piattaforma per raggiungere questo scopo.
Etan: Molte volte le persone confondono e alterano i messaggi.
Wade: Per quanto riguarda noi, ognuno aveva il proprio messaggio da presentare ed ognuno si è concentrato su questo. Volevamo parlare delle uccisioni da parte della polizia. Della brutalità della polizia in particolare. E, allo stesso tempo, ci siamo confrontati. Chris Paul ha dichiarato sul palco che suo zio e suo nonno sono poliziotti, quindi lui personalmente non è contro la polizia. Ma ha anche dimostrato di essere consapevole della violenza della polizia, delle uccisioni, ed ha fatto i nomi: Trayvon Martin, Mike Brown, Freddy Gray, Alton Sterling, Philando Castile. Quindi ci siamo chiesti quale messaggio sarebbe venuto fuori prendendo in considerazione che se da una parte siamo tra di noi come fratelli, ognuno di noi avrebbe espresso il proprio messaggio nel suo modo. Ci siamo seduti ed abbiamo scritto il messaggio particolare che ognuno di noi voleva presentare al mondo. E se ascolti i discorsi, ognuno di noi ha espresso ciò che era vicino e caro ai propri cuori, alle proprie comunità ed alle proprie famiglie. Il mio punto generale era che troppo è troppo; sono stanco di vedere tutte queste uccisioni, di prendere in mano il giornale o ascoltare il notiziario e scoprire che un’altra persona è stata uccisa dalla polizia.
Etan: Che cosa è necessario fare per cambiare? Ci sono così tanti giovani che hanno sviluppato una diffidenza nei confronti della polizia come risultato di qualche cosa che continuano a vedere. Le uccisioni, la violenza, le botte, i video sui social networks. Che cosa vorresti dire a loro?
Wade: Li capisco benissimo. Ho avuto conversazioni con giovani e anche con le forze dell’ordine. Ed uno dei miei messaggi alle forze dell’ordine è stato: “Ascoltate, sapete benissimo che c’è diffidenza nei confronti dei poliziotti, anche da parte mia: se io vedo una pattuglia dietro la mia macchina, è una situazione poco confortevole. Ed io sono uno sportivo, e so di non aver fatto nulla di sbagliato.” Ho detto ai poliziotti: “Ascoltate, se volete veramente cambiare questa situazione, dovete lavorare per colmare il divario.”
Stiamo organizzando tutti questi incontri cittadini e pannelli di discussione: sediamoci tutt’intorno ad un tavolo come comunità – poliziotti, leaders della comunità e delle organizzazioni giovanili -, discutiamo e facciamo in modo che ogni voce possa essere ascoltata. Dovete sapere ciò che le persone nella comunità provano e come vi vedono e perché vi vedono in quel modo. Non è che non hanno legittime ragioni o semplicemente non gli piacete, punto e basta. Hanno le loro motivazioni. Le loro esperienze. Cose che hanno visto. Che le loro famiglie, i loro amici, le persone a cui vogliono bene hanno visto e provato sulla loro pelle. E lo stesso dalla parte opposta. Anche la comunità deve ascoltare la testimonianza dei poliziotti. Ascoltare le loro esperienze, ciò che hanno visto e sentito. Come in ogni relazione, il miglior modo per veramente comprendere il punto di vista di ognuno, è prima di tutto ascoltarsi l’un l’altro. Non ascoltare per dissentire, piuttosto ascoltare per cercare di capire il diverso punto di vista. Ed entrambe le parti hanno bisogno di sentire verbalmente ciò che l’altra parte si aspetta. Al momento abbiamo a che fare con due lati opposti che non si capiscono affatto. E questo non porta ad una relazione costruttiva e di successo. Questo è stato il mio messaggio ai dipartimenti di polizia nelle varie città in cui ho avuto l’opportunità di incontrarmi e parlare con loro.
Dal Cap.3, Il movimento di Kaepernick conta
[Colin Rand Kaepernick è un giocatore di football americano che nel 2016 è stato bandito dalla Lega NFL per essersi inginocchiato durante l’inno in segno di protesta contro le uccisioni di afroamericani da parte della polizia. Il gesto di inginocchiarsi mostrato nelle recenti dimostrazioni per l’uccisione di George Floyd è ispirato dall’atto di protesta iniziato da Kaepernick.]
Nel settembre 2016, Kaepernick ha riferito di aver ricevuto minacce di morte a seguito della sua decisione di inginocchiarsi durante l’inno nazionale. Non è un fatto sorprendente. Muhammad Ali, Mahmoud Abdul-Rauf, John Carlos, Tommie Smith e innumerevoli altri atleti che hanno preso posizioni considerate “non patriottiche” hanno ricevuto minacce simili.
Non è però interessante il fatto che molte delle stesse persone che chiamano Kaepernick “antipatriottico” abbiano mancato di rispetto per otto anni al presidente Obama ed alla First Lady Michelle Obama?
Non è inoltre interessante che quelle stesse persone che descrivono la presa di posizione di Kaepernick come irrispettosa nei confronti dei veterani, non abbiano espresso affatto rabbia nei confronti di George W. Bush, il quale ha inviato soldati coraggiosi, le cui vite sono altrettanto preziose e degne di essere ricordate, a morire per una bugia? Non è interessante che questi stessi conservatori abbiano votato contro una migliore assistenza sanitaria e aiuti ai reduci dopo il loro ritorno a casa?
Molte persone hanno un’interpretazione confusa del patriottismo. Se non sei offeso dal fatto che uno su due dei veterani tornati dall’Iraq o dall’Afghanistan conosce un compagno che ha tentato di suicidarsi, o dal mezzo milione di reduci che non hanno un’assicurazione, o dai 39mila veterani senzatetto, ma sei offeso dal fatto che Colin Kaepernick si metta in ginocchio durante l’inno nazionale, allora c’è qualche cosa che non va nel tuo patriottismo.
È fantastico come il messaggio di Colin Kaepernick si stia diffondendo e riecheggi tra così tanti altri atleti, dalle squadre di football delle scuole superiori alle cheerleader della Howard University.
Inizialmente solo il compagno di squadra dei San Francisco 49ers Eric Reid si è unito a Kaepernick. Ma poi altri compagni di squadra, tra cui Antoine Bethea, Eli Harold, Jaquiski Tartt e Rashard Robinson, hanno alzato i pugni durante l’inno nazionale prima di una partita contro i Carolina Panthers.
Successivamente, Jeremy Lane dei Seattle Seahawks si è seduto durante l’inno nazionale. Il cornerback dei Kansas Chiefs, Marcus Peters, ha alzato il pugno ed ha esortato i giornalisti a sostenere gli sforzi di Kaepernick in modo da aumentare la consapevolezza del malfunzionamento del nostro sistema giudiziario. Durante il Sunday Night Football, Martellus Bennett e Devin McCourty dei New England Patriots hanno alzato i pugni durante l’inno nazionale.
Anche se ha perso due contratti di sponsorizzazione per questo, anche Brandon Marshall, il linebacker dei Denver Broncos, si è messo in ginocchio ed ha dichiarato che avrebbe continuato ad inginocchiarsi.
Ancora più impressionante è come questo messaggio colpisca gli atleti delle scuole superiori, che, come sappiamo, sono fortemente influenzati dagli atleti professionisti. Guardano, imparano e prendono proprie posizioni perché hanno esperienze d’ingiustizia in prima persona. Alcuni hanno coraggiosamente affrontato avversità, odio e minacce di attacchi fisici.
Nel settembre 2016, un giocatore di football del liceo di Brunswick, Ohio, di nome Rodney Axson Jr., è stato minacciato di linciaggio e chiamato con la parola N dai suoi compagni bianchi dopo essersi inginocchiato per protestare contro il razzismo.
A Seattle, l’intera squadra di football e lo staff tecnico della Garfield High School si sono messi in ginocchio durante l’inno nazionale prima della partita del 16 settembre 2016. Non si sono fatti intimidire da un folto gruppo di personaggi pubblici che hanno usato le loro piattaforme per screditare, condannare e ridicolizzare Colin Kaepernick e altri atleti che hanno avuto il coraggio morale di difendere ciò in cui credono. Si potrebbe anche obiettare che questo stesso folto gruppo avrebbe potuto usare tanta forza vocale per condannare le ingiustizie sociali e gli innumerevoli omicidi per mano della polizia che sono rimasti impuniti. Più di due dozzine di neri sono stati uccisi durante gli scontri con la polizia solo nelle prime sei settimane dopo che Kaepernick ha iniziato a protestare. Dove sono le condanne?
Questa stessa gente è rimasta in silenzio quando la polizia ha ucciso il disarmato Terence Crutcher, a Tulsa, in Oklahoma, colpevole di avere dei problemi con la macchina ed in attesa di aiuto da parte della polizia stessa. Non hanno avuto nulla da dire quando la polizia di Charlotte ha ucciso Keith Lamont Scott, un nero colpevole di stare leggendo un libro in macchina. In entrambi i casi, gli agenti sono stati esonerati con un congedo amministrativo retribuito. Come ha detto Colin Kaepernick in un’intervista post-partita, “ci sono cadaveri in strada e questa gente riceve un compenso di buonuscita e se la cava con un omicidio alle spalle.” La gente dovrebbe essere indignata per questi fatti e non per il fatto che Colin Kaepernick e altri atleti stanno seduti o in piedi durante l’inno nazionale.
Come dice un saggio proverbio, la giustizia non sarà servita fino a quando coloro che non sono influenzati dai fatti non saranno altrettanto indignati come quelli che lo sono.
Intervista a David West
È importante notare che Kaepernick non è il primo atleta moderno a prendere una posizione di questo tipo. Come Mahmoud Abdul-Rauf, la cui intervista appare più avanti in questo libro, il veterano della NBA David West è un altro atleta le cui azioni di protesta sono state ampiamente dimenticate. Molti non sanno che David West ha protestato durante l’inno nazionale per molti anni, anche prima di Kaepernick. L’ho notato personalmente in piedi per ultimo, nella fila, circa tre o quattro piedi dietro i suoi compagni di squadra, mentre l’inno nazionale veniva suonato prima delle partite nel 2004, quando giocava con i New Orleans Hornets. Quando lo incontravo, gli facevo sapere che lo rispettavo per le posizioni che prendeva, ed il rispetto era reciproco. Col passare degli anni, mi imbattei in lui durante alcune conferenze e discussioni, ed in diversi eventi, e l’ho ascoltato esprimere le sue preoccupazioni su diverse questioni che affliggono la nostra società. Ha una passione profonda e articola e dettaglia i suoi discorsi così bene che sarebbe capace di incantare le folle.
West si è concesso del tempo libero durante il suo impegno stagionale con i Golden State Warriors per parlare con me di alcuni di questi temi. Sono perfettamente in linea con tutto ciò di cui Kaepernick ha discusso in modo così eloquente, e talvolta vanno persino più in profondità.
Etan: Protesti costantemente l’inno nazionale da qualche tempo. Potrebbe essere passato inosservato perché non era un atteggiamento così drastico come inginocchiarsi come Kaepernick. Potresti spiegare le tue ragioni per posizionarti dietro al resto della squadra durante l’inno.
David West: Durante il mio secondo anno nella NBA, abbiamo avuto un incontro di gruppo in cui il proprietario ci ha chiesto di mettere le mani sul cuore mentre veniva suonato l’inno nazionale. Ho alzato la mano e ho semplicemente dichiarato la mia posizione. Ho detto che non avevo intenzione di farlo. . . Quindi il fatto di stare in piedi alla fine della fila, un passo o due dietro i miei compagni di squadra, è qualcosa che ho cominciato a fare solo a causa di quell’incontro. Non aveva nulla a che fare con qualche evento pubblicizzato. . . Volevo dare rilievo al fatto che c’è qualcosa al di fuori di questo mondo in cui viviamo chiamato sport o NBA. Quest’atto è sempre stato un promemoria per me stesso. Vedo che i ragazzi passano attraverso alcuni rituali prima della partita. Bene, per me, era qualcosa di semplice che avrei potuto fare in quel momento per riflettere su quanto sono fortunato nel fare qualcosa che amo; ma allo stesso tempo riconoscere che c’è una maggiore severità nella vita al di fuori di questa piccola bolla chiamata NBA.
Etan: Qualcuno ha tentato di dissuaderti? In tal caso, quale è stata la tua reazione e qual è stata la loro reazione? Hai mai temuto le critiche dei media o dei fan?
West: Non ho mai temuto le critiche da parte dei media o dei fan perché mi sono sempre sentito di parlare da una posizione chiara. Parlo dal punto di vista dell’onestà. Cerco di essere il più sincero possibile nelle mie dichiarazioni. Spesso, quando parlo, non si tratta di me. Non si tratta di far uscire David davanti alla telecamera o cercare di diventare un attivista. Quando fui esplicito su Donald Sterling [Ex proprietario dei Los Angeles Clippers, costretto a vendere la propria franchigia e bandito a vita dalla NBA dopo la pubblicazione di telefonate private in cui insultava giocatori e personaggi pubblici afro-americani], e fui una delle prime persone a chiamarlo per quello che era – senza mezzi termini, razzista – non c’era altro modo per descrivere in modo tangibile ciò che aveva detto e ciò che sottintendeva con quelle parole nei suoi messaggi. Si trattava di un’ideologia direttamente derivata dalla schiavitù delle piantagioni, e non mi sono vergognato, né ho avuto paura di dirlo. . . C’è questo modo di pensare, che in qualche modo perderemo seguito o saremo meno visibili se parliamo di ciò che sta accadendo nella società. Penso che sia falso.
Quello che ho scoperto è che i fan apprezzano l’intelligenza. Apprezzano l’impegno sociale. In realtà li fa sentire più a loro agio delle persone che stanno supportando e che se ne fregano di quello che sta succedendo nel mondo. In realtà ho avuto una maggiore risposta da parte di persone che apprezzano gli atleti che dicono cose positive, perché riconoscono il tipo di peso che le nostre parole hanno sui giovani. Gli insegnanti sono tra i nostri più grandi sostenitori. Li ho sentiti dire: “Grazie a Dio hai detto quello che hai detto”, “Apprezzo le tue parole”, ecc. Sono commenti che sento costantemente, apprezzano che mostriamo una dimensione diversa. . . Ora c’è la speranza di non dover essere unidimensionali. Non puoi essere uno stupido idiota. Puoi leggere libri, puoi essere socialmente e politicamente impegnato. . . Per presentare una versione migliore di te stesso, devi acquisire dimensioni diverse rispetto a ciò che sei. La tua esperienza professionale, la tua esperienza personale, la tua esperienza sociale e la tua capacità di pensare ed esprimere criticamente i tuoi pensieri attraverso il linguaggio aiutano a trasmettere il tuo messaggio. . .
Quando tutto si riconduce ad un unico scopo, non puoi aver paura di dire la tua verità, in particolare quando si tratta di un contesto storico. Non puoi aver paura di raccontare la storia come è realmente accaduta, non ciò che vogliamo sentire, e non ciò che vogliamo estrapolare da esso o revisionare. . . Questo è il motivo per cui continuo a parlare e non ho paura di essere criticato.
Etan: Ecco una citazione da una potente intervista che hai fatto in una puntata di Undefeated [Programma sportivo sul canale ESPN]: “Non posso iniziare a parlare di civiltà e di cittadinanza se non credete neppure che io sia un essere umano. Come puoi parlare di progresso e di come gli esseri umani si relazionano tra loro quando non riconosci nemmeno la nostra umanità? Prima di tutto dobbiamo essere d’accordo su questo, poi possiamo pensare di giocare sullo stesso campo “. Quelle sono parole potenti. Potresti spiegarti in modo più dettagliato?
West: Credo che il contesto storico sia il contesto più importante in questa nazione per quanto riguarda gli afroamericani, i popoli africani in America, i neri, i le persone di colore, i negri o qualunque altro nome o termine con cui si desidera chiamarci. La radice di tutti questi problemi non è solo la schiavitù. Molte volte le persone da entrambe le parti ci accusano di usare la carta schiavitù… Quando parliamo di brutalità della polizia, dei profitti delle carceri, della schiavitù dei carcerati, della pena di morte, del braccio della morte, di sotto educazione, di cattiva istruzione, di incarcerazioni di massa, di tutte le diverse questioni civili e sociali che subiamo come gruppo, in questo Paese in particolare ed in molti altri posti in tutto il mondo, ci troverai relegati in fondo…
Tutti gli indicatori socioeconomici indicano che il nostro gruppo subisce le maggiori privazioni in questo paese. E quegli stessi indicatori socioeconomici possono essere tagliati, copiati e incollati su ogni nero da qualsiasi altra parte del mondo. Siamo ben consapevoli di quanto l’Africa stessa è stata saccheggiata, distrutta e derubata per centinaia di anni ininterrottamente. . . Lo stupro costante delle risorse, la costante tortura ed il tormento dei cittadini africani si fondano principalmente sull’idea che noi non facciamo parte della famiglia umana.
Tutte queste ideologie hanno una ragione contestuale nella storia in cui sono nate. . . Per trattare queste persone nella misura in cui sono state trattate, devi renderle qualcosa di diverso da quello che sei tu. Quindi, se classifichi e crei scienze che ti innalzano allo status d’élite in termini di umanità, da dove viene chi è escluso da quelle classi? Ciò che rimane è semplicemente uguale o inferiore agli animali. Pertanto, ti è consentito di giustificare il trattamento di queste “cose” o di questi “altri” e farne uso a tuo piacimento. Vuoi sapere perché Tamir Rice [ Dodicenne afroamericano ucciso il 22 novembre 2014 a Cleveland, Ohio, da un poliziotto] è stato ucciso in meno di due secondi? Perché centinaia e centinaia di anni fa le persone hanno iniziato a propagare queste idee sul fatto che noi fossimo qualcosa di diverso dagli esseri umani. Che in qualche modo non meritassimo o non avessimo i diritti garantiti da Dio al resto dell’umanità… La più grande battaglia che abbiamo di fronte è quella di ridefenirci come esseri umani nello spettro dell’umanità. Quando osservi cosa è successo a Ferguson con Mike Brown [Diciottenne afroamericano ucciso dal poliziotto Darren Wilson il 9 agosto del 2014 a Ferguson, Missouri] e ascolti il linguaggio usata da Darren Wilson per descrivere Mike Brown, quella è stata una narrazione disumanizzante: “Le sue dimensioni… la sua forza sovrumana…” Questo è l’ABC del razzismo. Questo è razzismo antico riutilizzato nel 2015. Questo è ciò con cui abbiamo a che fare. . .
Se vogliamo affrontare e arrivare alla causa principale di alcuni dei mali sociali come l’incarcerazione di massa ed il crimine che accade nelle nostre comunità, bisogna iniziare con l’istruzione. Sebbene sappiamo che il crimine nero contro nero non è diverso dal crimine bianco contro bianco, né da qualsiasi altro tipo di crimine, dato che le persone che vivono in stretta vicinanza l’una dell’altra tendono a commettere crimini l’uno contro l’altro. Ciò che viene mostrato e visualizzato tramite immagini parla di una narrazione negativa che rafforza vecchi stereotipi e generalizzazioni. Nuove persone vengono addestrate ed istruite contro di noi. Vengono diseducati su dove ci dovremmo disporre ed adattarci sulla mappa dell’esistenza umana.
Dal Cap 10 – Parlarne con i giovani atleti conta
Un fine settimana, abbiamo organizzato con la squadra di mio figlio una raccolta fondi presso un autolavaggio in una stazione di servizio ExxonMobil. È stato un bellissimo evento, soprattutto per alcuni dei nuovi giocatori. Appartengo alla vecchia scuola, non credo nelle concessioni ai giovani. Sono dell’opinione che apprezzeranno di più quando avranno lavorato per ottenere qualche cosa.
Tutto stava andando bene fino a quando un uomo bianco non si è avvicinato a Nichole ed ha detto che i ragazzi non potevano stare lì e avrebbe chiamato la polizia. Poco dopo, il proprietario dell’Exxon mi ha chiamato e mi ha detto che l’uomo aveva chiamato la polizia per denunciarci.
Quest’uomo ha visto un gruppo di ragazzi neri fare qualcosa di positivo e ha pensato che fossero lì per compiere qualche danno? Che fossero lì illegalmente? Per molestare le persone? È triste che una squadra delle leghe giovanili non possa nemmeno fare un evento di raccolta fondi senza confrontarsi con la dura realtà della vita.
Un’altra lezione per i ragazzi è arrivata un giorno dopo gli allenamenti. Stavo portando a casa Malcolm e il suo compagno di squadra Camar quando abbiamo notato dei lampeggianti dietro di noi seguite da una sirena. Ho visto i loro occhi spalancarsi per la paura e ho detto loro di rilassarsi, fare un respiro profondo e sedersi.
Mi sono fermato e ho spento la musica. Ho azionato il registratore vocale sul mio telefono e l’ho messo nel porta bicchieri di fronte al parabrezza. Ho tolto il portafogli dalla tasca e l’ho appoggiato sul cruscotto. Ho abbassato tutti i finestrini e messo le mani sul volante. Mentre un poliziotto si avvicinava al mio finestrino, il suo collega illuminava con la torcia dal lato opposto della macchina Camar, e poi l’interno della macchina.
Il primo poliziotto: “Patente e libretto”.
Rispondo con voce molto chiara: “Il mio libretto di circolazione è nel mio vano portaoggetti, va bene se la prendo?”
Dice di sì, quindi lentamente allungo la mano verso il mio vano portaoggetti mentre il suo compagno illumina con la torcia la mia mano tutto il tempo.
Poi esclamo: “La mia patente è nel portafogli, va bene se lo raggiungo e la tiro fuori dal mio portafoglio?”
Dico di sì, e lentamente sposto le mani verso la console e recupero la patente.
L’ufficiale prende le informazioni e torna alla sua macchina. Osservo così tante emozioni diverse sulla faccia di Malcolm. Confusione, paura, preoccupazione. Guardo di nuovo Camar e vedo lo stesso. Chiedo loro se stanno bene ed entrambi annuiscono con la testa. Dico loro di fare un respiro profondo, di rilassarsi e che tutto andrà bene.
Dopo circa dieci minuti, i poliziotti tornano. Mi ridanno la patente e registrazione, quindi mi informano che ho un fanale posteriore fuori uso. Mi consegnano un pezzo di carta e spiegano che ho dieci giorni per ripararlo. Infine, il poliziotto esclama “buona notte” e se ne va.
Ho immediatamente riconosciuto che questo era un momento da cui trarre insegnamenti. Ho chiesto a Malcolm e Camar se avessero notato tutto quello che ho fatto prima che il poliziotto si avvicinasse alla mia finestra. Malcolm ha detto: “Sì, hai spento la musica, hai abbassato i finestrini e hai messo le mani sul volante”, e Camar ha aggiunto: “Hai tolto il portafogli prima che potesse chiedertelo.”
Ho detto, “corretto”.
Malcolm ha replicato: “Capisco perché hai fatto tutto ciò, ma non dovresti farlo. Non hai fatto niente di male. Tutto questo per un fanale posteriore rotto? Trattarti in quel modo e creare tutta quella tensione per questo? Non avrebbero potuto scattare una foto della tua patente con le loro telecamere speciali e spedirti una multa o qualcosa del genere? ”
Stava cominciando a ragionare.
Gli ho detto: “Okay, riepiloghiamo tutto. Uno: ho spento la musica per evitare un’atmosfera di aggressività. Stavamo ascoltando hip-hop, che è qualcosa di aggressivo per molte orecchie estranee, ed è comunque una buona idea in generale spegnere la musica quando ci si ferma.
Due: ho abbassato tutti i finestrini, anche i finestrini posteriori, perché i miei vetri sono oscurati e non volevo che la polizia avesse problemi di visibilità quando si sono avvicinati alla mia auto. La prima cosa che hanno fatto è stata illuminare l’interno. Hanno puntato la luce sulla faccia di Camar nella parte posteriore, sul pavimento, sul posto vuoto, hanno illuminato tutto quanto.
Tre: ho messo entrambe le mani sul volante in modo che potessero vedere le mie mani.
Quattro: non ho fatto movimenti improvvisi. Anche quando mi hanno detto di prendere la patente e libretto, non sono andato subito a prenderli. Ho chiesto a voce alta e chiaramente se andasse bene che aprissi il mio vano portaoggetti e prendessi il libretto. Mi sono mosso lentamente. Molto lentamente. E avevano ancora le loro torce puntate sulle mie mani per guardarmi attentamente.”
Malcolm ha continuato: “Non avresti dovuto fare tutto questo. Capisco, ma non abbiamo fatto nulla di male e ci hanno trattato come criminali. Che cosa dobbiamo dimostrargli, che non siamo criminali? Non è giusto.”
Ho spiegato a Malcolm che la fierezza non ha niente a che fare con questo. L’obiettivo numero uno è tornare a casa sani e salvi, punto. Nove volte su dieci i poliziotti hanno paura quando si avvicinano ad un’auto con dentro dei neri. È così e basta. È giusto che sia così? No, certo che non lo è. Ma è così. Hanno il potere, le armi, l’autorità, ma sono quelli che hanno paura. E quando sai che qualcuno è terrorizzato da te, e ha tutto il potere, ed è in una posizione di autorità, devi essere saggio con le tue azioni. Si tratta di tornare a casa sani e salvi. Questo è tutto ciò che conta. È la realtà, e non serve a nessuno di noi morire per dimostrare che non è giusto. Perché è quello che è, una questione di vita o di morte. La differenza sta nel tornare a casa e discuterne come stiamo facendo adesso, o diventare un hashtag ed avere il tuo nome stampato su una maglietta. Non è quello che voglio. Sono stanco di vederlo. Dobbiamo capire la differenza tra vincere la battaglia e vincere la guerra.
In questa situazione mi sono preparato per vincere la guerra. Ho messo il mio telefono nel porta bicchieri, ho mostrato verbalmente di essere pienamente in regola. E se qualcosa fosse andato storto, ne avevo le prove.
NOTE BIOGRAFICHE
ETAN THOMAS 1978
Ex professionista della NBA dal 2001 al 2011, ha militato nei Washington Wizards, Oklahoma Thunder e negli Atlanta Hawks. Poeta, scrittore, attivista, collabora con molte testate come opinionista su diritti civili e razzismo nello sport, tra cui Guardian e Huffington Post
DWYANE TYRONE WADE JR 1982
Ex cestista statunitense, professionista nella NBA. Ha militato per tutta la sua carriera ai Miami Heat, con cui ha vinto tre anelli (2006-2012-2013), fatta eccezione per una breve parentesi ai Chicago Bulls nel 2016 e ai Cleveland Cavaliers nel 2017. È considerato uno dei giocatori più forti della sua generazione.
DAVID WEST 1980
Cestista statunitense, professionista nella NBA. Ha giocato con New Orleans Hornets, Indiana Pacers, San Antonio Spurs e Golden State Warriors, con cui si laureato 2 volte campione NBA (2017-2018).
Etan Thomas
We Matter: Athletes and Activism
Akashic Books 2018
 di Gilles Weinzaepflen
di Gilles Weinzaepflen










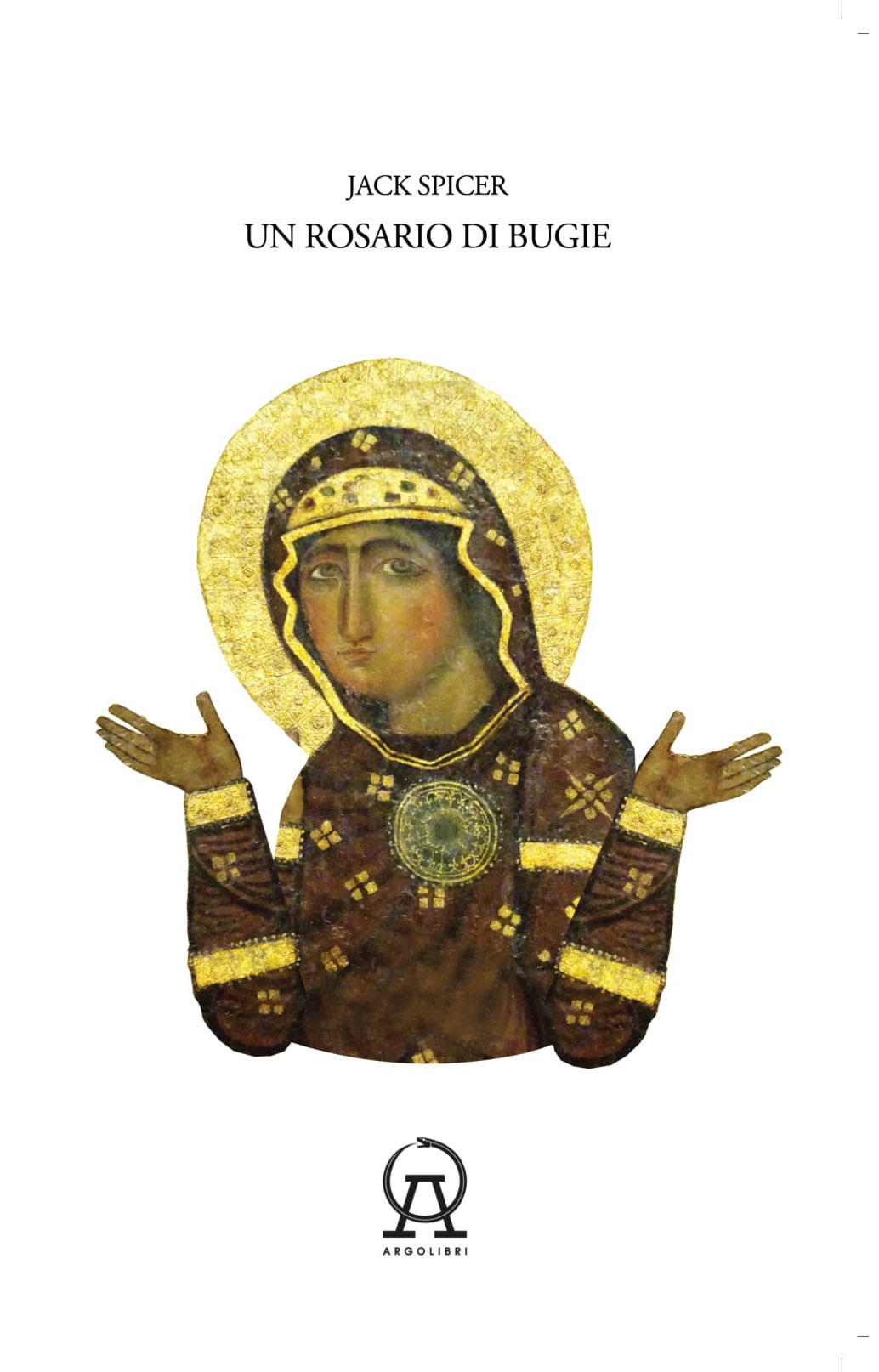
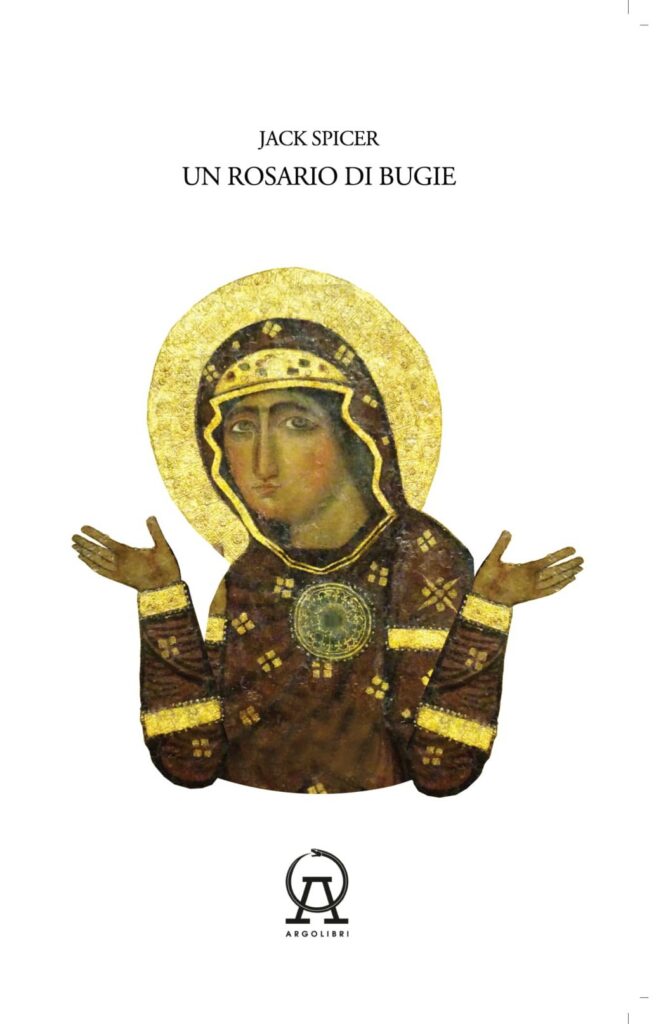
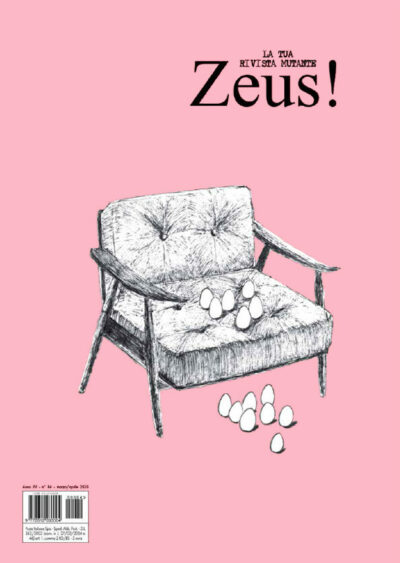

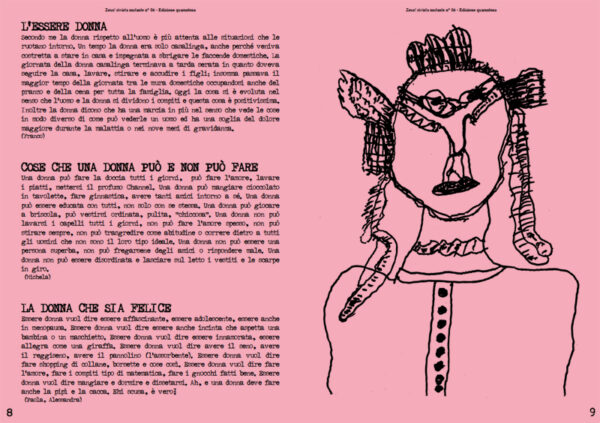
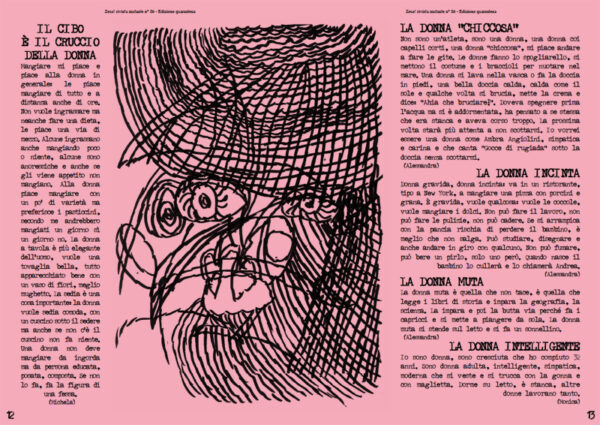







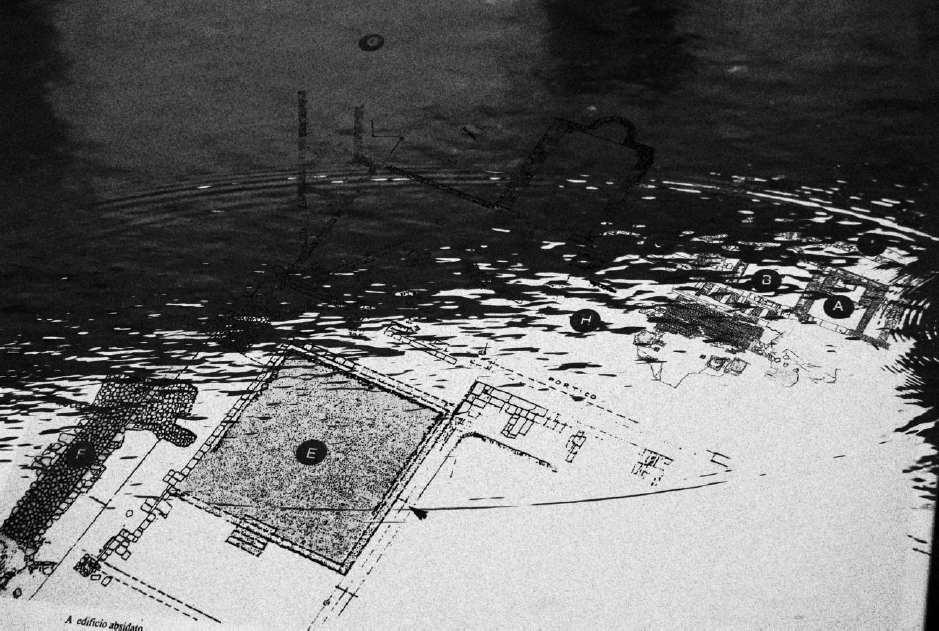





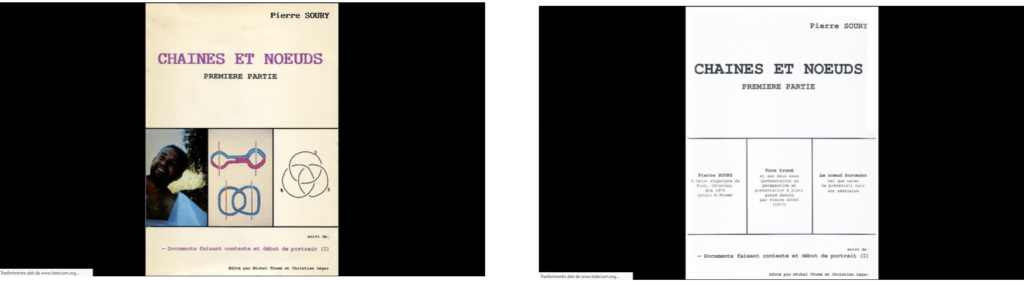
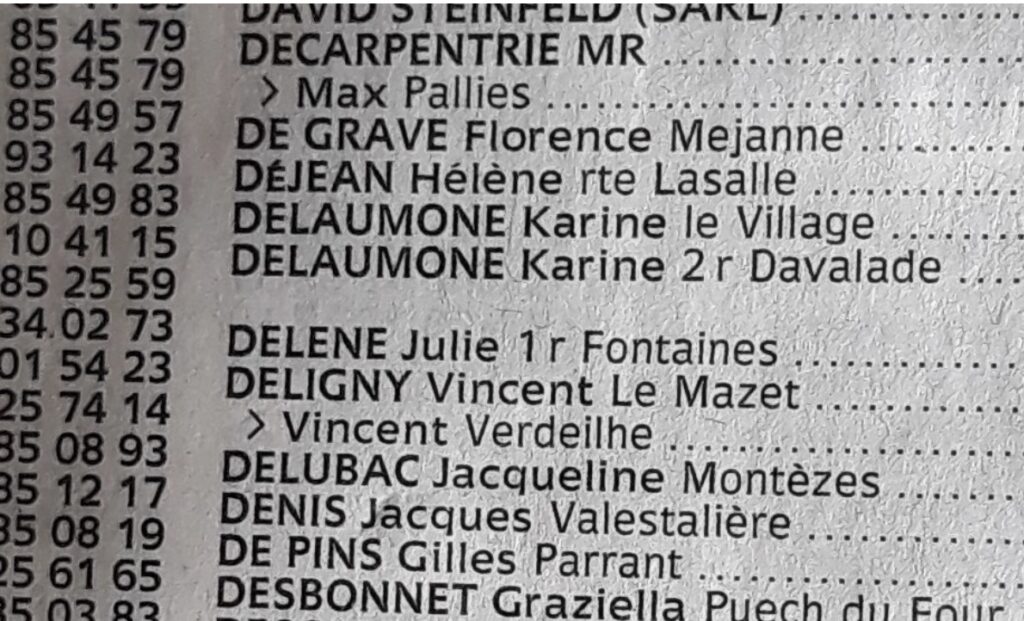



 Quanti grammi pesa il cuore di un ragazzo di strada a Napoli? mi sono chiesto nel primo articolo di questo nascente confronto con alcuni esperti del tema della criminalità adolescenziale a Napol.
Quanti grammi pesa il cuore di un ragazzo di strada a Napoli? mi sono chiesto nel primo articolo di questo nascente confronto con alcuni esperti del tema della criminalità adolescenziale a Napol.

