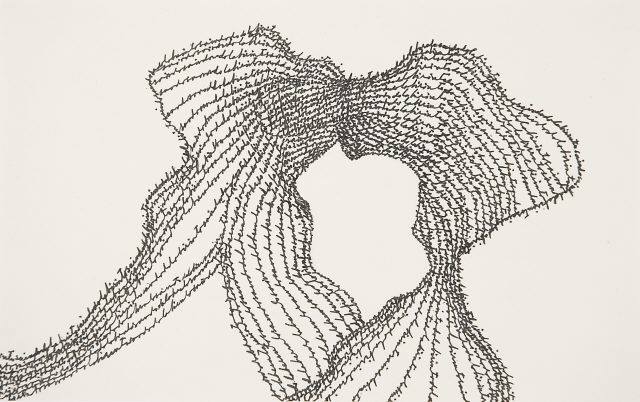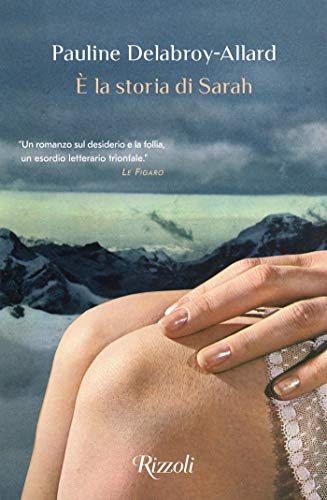di Michele Neri
 Sono il padre dell’uomo con il mare dentro e, sebbene abbia fatto di tutto per evitarlo, sto per morire. Non sono spaventato, la stanchezza, la disillusione quotidiana l’ha reso accettabile: è per lui, nato dalla mia carne e che di questa ha preso solo il manto sottile necessario a rivestirlo e impedire che l’acqua fuoriesca, uno strato che non posso chiamare pelle, tanto è trasparente come la superficie del mare a riva. Ributtante, aggiungo, e meraviglioso. Anche adesso, mentre lo osservo di sottecchi, sdraiati uno di fianco all’altro sui lettini di un albergo in alta montagna, i raggi del sole fuoriusciti da cime lavanda, prima di annullarsi dentro la notte estiva illuminano ora quell’agglomerato di alghe tremolanti sotto la superficie del ventre, ora la risacca che, dal petto, monta senza un rumore fino alla base del collo.
Sono il padre dell’uomo con il mare dentro e, sebbene abbia fatto di tutto per evitarlo, sto per morire. Non sono spaventato, la stanchezza, la disillusione quotidiana l’ha reso accettabile: è per lui, nato dalla mia carne e che di questa ha preso solo il manto sottile necessario a rivestirlo e impedire che l’acqua fuoriesca, uno strato che non posso chiamare pelle, tanto è trasparente come la superficie del mare a riva. Ributtante, aggiungo, e meraviglioso. Anche adesso, mentre lo osservo di sottecchi, sdraiati uno di fianco all’altro sui lettini di un albergo in alta montagna, i raggi del sole fuoriusciti da cime lavanda, prima di annullarsi dentro la notte estiva illuminano ora quell’agglomerato di alghe tremolanti sotto la superficie del ventre, ora la risacca che, dal petto, monta senza un rumore fino alla base del collo.
Superata la prima infanzia, rassicurato sulla sua sopravvivenza –fu il dottor Willi di Innsbruck a dover ammettere il miracolo tangibile di una persona alimentata e riempita dall’acqua, e salata com’è al largo nei giorni in cui il mare si tende sotto un vento di settentrione –è a questo pensiero, alla sua esistenza dopo che la mia sarà conclusa, lui pupazzo fluido in mezzo alle asperità, che io dedicai angoscia e veglie interminabili. Sempre da solo perché, quando si trovò di fronte un neonato piegato in due come un pantalone sul braccio dell’infermiera, una zampogna cascante, braccine e gambette rugose a penzoloni, e che emanava quell’odore salmastro e corroborante oppure di alghe cotte dal sole e, occorre dirlo, nauseabonde, secondo che accostassimo il naso al viso piuttosto che alle numerose pieghe dove nei neonati si ferma il sudore, mia moglie scosse la testa senza dire una parola, si morse il labbro fino a far colare un rigo di sangue sul camicione bianco e, non appena fu in grado di andarsene dal piccolo ma attrezzato ospedale sulle pendici del monte Zirler, si dileguò, non dando più notizie di sé.
Ricordo che esaminai mio figlio, mentre trascorrevo la notte con lui in quella stanzetta d’ospedale dove avrei vissuto le successive 365; non dormendo, cercando di comprendere che cosa fosse accaduto e in quale punto oscuro della genesi, perché il mio bambino avesse più in comune con un aquario che con gli altri nuovi umani tra le braccia di genitori impacciati. Presto, forse quella stessa notte, l’ira o un inderogabile senso di protezione per quella creatura più indifesa delle altre, trasformò la domanda in un’altra meno oziosa e però affacciata su risposte che niente avrebbe potuto illuminare: che cosa sarebbe successo dopo.
Lo spogliai. Il sonno era pesante, l’avevano nutrito artificialmente e il latte si era fermato, creando una chiazza perlacea lì, dove un neonato avrebbe avuto il proprio stomaco minuto, per poi espandersi in bollicine pallide. Tenendolo in verticale, gli organi in miniatura si avviarono pigramente verso il basso: nuotavano dentro un liquido che opponeva una resistenza viscosa, simile –o era il primo confronto in cui incappasse la mente– alle lampade a forma di missile con le bolle di cera variopinta dei primi anni settanta, e che da ragazzino amavo tanto.
In poco più di un minuto, attorno alle caviglie e da lì salendo fino sopra al ginocchio si erano accatastati senza logica i polmoni, il triangolo rosso-bruno del fegato e altri organi flosci, uniti tra loro da filamenti che avrei voluto rigidi e di cui nessuno avrebbe capito la natura, nonostante indagini e raffronti con l’anatomia di qualunque forma di vita conosciuta.
Era una clessidra vivente: la giravo e il contenuto scendeva, oppure risaliva, sistemandosi con calma e senza che lui desse mostra di risentirne. Ribaltando mio figlio con delicatezza, gli organi ritrovavano il loro posto. Non erano troppo precisi nel ricollocarsi ma, anche di questo, non sembrava accorgersi. Il solo organo a non allontanarsi dalla sede era il cervello, più piccolo del normale, saldo nel cranio trasparente. Forse, pensai, non riusciva ad attraversare la strettoia della gola. E il pensiero ostruì la mia.
Quella prima notte tenni una lampada dietro di lui per studiare ogni corrente e anfratto di quel mare iridato. Cercavo uno scheletro, speravo che la natura avesse fornito un sostegno, ma non c’era niente che somigliasse a un osso o non oscillasse al primo urto. Mi calmai ricordando che non esiste neonato capace di restare seduto.
Arrivò l’alba; il sole, inondando il corpicino addormentato, portò alla superficie un limpido reticolo oro e turchese, per restituire poi al mio sguardo velato di lacrime, ogni sfumatura di azzurro, via via più impenetrabile in prossimità di quella che mio figlio, pur rivelandone eccezionalmente l’ideale dislocazione, non possedeva: la colonna vertebrale.
Lo girai, mi ostinai: il centro restava prigioniero delle tenebre.
Ora che siamo seduti a cena ancora una volta uno di fronte all’altro, alti uguali e protetti dal paravento che l’hotel è rapido a piazzare di sera in sera, estate dopo estate, devo riconoscere che, nonostante la mia dedizione più che trentennale, ben poco è cambiato. Nemmeno il silenzio tra noi. Nessun tentativo di comunicare ha avuto successo. Il suo aprire la bocca sembra rispondere a una necessità meccanica, o di incrementare la quantità d’ossigeno.
Non saprò mai ciò che lui pensava e se ne era capace; peggio: temeva e desiderava, perché allora sarei stato un padre, sì, non un voyeur. Amore imponderabile di padre, passione timorosa e che parla quando si è troppo lontani, per sentire. Io ne so qualcosa. Chi sono stato per lui, contenuto dall’attività immutabile che egli stesso contiene? La mia solitudine si nutriva del convincimento della sua; poi, quando nell’espressione rivedevo la consueta serenità disinteressata, tornava a soffocarmi la mia. La solitudine è mio figlio. Ha l’età che avevo quando è nato lui.
L’acqua di quel mare interiore non è più cristallina; il cibo ingerito ha posato una nebbia sbiadita, simile al plancton al microscopio o alla neve appena smossa in una palla di vetro. Il mio stupore non è però diminuito di fronte all’inusitata capacità di sciogliere i bocconi e di espellerli così da non lasciare concrezioni sul fondale, (del vetro mi verrebbe da dire accettando che l’errore riveli la mia volontà di passarci sopra uno straccio, quando si tratta del rivestimento interno della pelle); permettendomi, proprio ora, dopo che il figlio, da me accudito, ha ingerito la trota salmonata all’aneto servita il giovedì, di distinguere nei dettagli l’articolato profilo della barriera corallina principale che, negli anni dello sviluppo, prese il posto del bacino. E se un frammento di carne resta impigliato tra i denti delle madrepore, i policheti e altri organismi di cui non ho imparato i nomi si affrettano a pulire il proprio domicilio.
Talvolta essere l’unico ad aver assistito a questa come a ogni procedura del suo esistere, fa sorgere il dubbio di essermi inventato tutto; perché ho fatto in modo che mio figlio non si presentasse mai a tavola o di fronte a qualcuno, se non indossando una tunica molto più ampia del necessario, un indumento che non richiedesse la spiegazione degli improvvisi rigonfiamenti e avvallamenti sotto il tessuto. Che cosa rispondere a chi già non giustificava il suo perenne procedere sulla carrozzella, un ragazzo di cui erano visibili occhi e bocca, essendo il resto del volto fasciato, il capo coperto perché il cervello non si trovasse nudo come in un barattolo di formaldeide; per poi camminare appeso al mio braccio e, pur lento, prudente, suscitando nel corpo una concatenazione di onde proporzionali alla velocità di movimento. Mi dispiace non aver mostrato a nessuno l’incantevole braccio (curiosa corrispondenza) di mare che termina in falangi verdazzurre, con miriadi di bollicine ripiene di fitoplancton cremisi.
E’ stata una vita tormentata e soprattutto laboriosa: lo sforzo incessante di non presentarmi sconfitto davanti a lui, mi ha probabilmente ammalato. Riconoscendomi, oltre la tovaglia sparecchiata, nei suoi occhi trasognati e della trasparenza pietosa di meduse affiorate, davanti al rosa vibrante delle nostre rocce dolomitiche, io provo però fino in fondo il piacere dell’equità. L’enigma con cui ho convissuto per trent’anni e che sto per abbandonare, insieme all’incapacità di risolverlo, ha risvegliato e stretto i nostri vincoli di sangue. Il mistero si è impadronito del mio amore e non ha ceduto spazio, ma l’ha tenuto in vita fino a qui, alla vigilia del mio e suo dissolvimento. E’ stato un fatto compiuto e sono grato.
Abbiamo attraversato insieme i confini della ragione, sigillata dentro un’acqua su cui non si è poggiato cielo o vento. Avrà sognato un’isola su cui posare un’impronta? Non ho invidiato un figlio normale. Ogni strada è buona se percorsa tutta, diceva mio padre.
Ancora bambino mi costrinse al silenzio e alla segretezza. Poteva crescere per diventare l’incredibile e grottesco caso dell’uomo con il mare dentro. Preferii comprare il riserbo del personale di quell’ospedale tirolese, minacciando tutti, in caso avessero rivelato un dettaglio di quell’evento straordinario, delle peggiori ritorsioni. Il mio avvertimento fu una bottiglia scagliata contro il muro. Spaventati, ammutolirono, io calmo, un minuto per scegliere un destino. Decisione giusta e l’intuizione che il dottor Willi soltanto avrebbe potuto accompagnarci in una spedizione oltre il sistema solare della fisiologia, fece il resto. Il dottor Willi, mio testimone, spalla nell’incredulità, fu la coscienza critica, portatore di una conoscenza incapace a dare risposte. Almeno una, aritmetica, elementare. Perché noi siamo fatti per sette decimi d’acqua e lui dieci.
Lo stetoscopio appoggiato sopra un cuore che all’improvviso, anche se mio figlio rimaneva immobile, beccheggiava come un gavitello o era nascosto da un’alga che volteggiava dopo essersi staccata dai coralli che parodiavano la gabbia toracica. Il dottor Willi rinunciò, né c’era bisogno di cure: mio figlio si era dimostrato un ecosistema autosufficiente. Tornava però a trovarci ogni settimana nel nostro chalet a metà costa, battendo con le nocche sulla vetrata intiepidita dal sole pomeridiano. Con il viso ben rasato, il capello corto, il fisico compatto, regalava ore di concretezza alla nostra fragilità, alla comune deriva.
Prima di entrare, confessò il giorno in cui mio figlio festeggiò cinque anni, aveva sempre avuto paura di non trovarlo vivo. Oltre ai rischi prevedibili e che esaurivano i prontuari medici –e se una lama avesse provocato la fuoriuscita dell’acqua, sarebbe bastata una trasfusione allo stesso grado di salinità?– c’erano quelli sconosciuti. E se i molluschi che con l’adolescenza avevano colonizzato gli arti si fossero rivelati nocivi per l’organismo? Tentare con la somministrazione forzata di gamberetti famelici? Imparammo a memoria manuali di biologia marina.
Il dottore è suo padre tanto quanto me; meglio, perché avrebbe saputo dargli più risposte.
Il mare. Dentro. Tornava di continuo l’immagine di un nuotatore. Inutile. Lui stava diventando un uomo con il mare dentro. L’inversione diventò una sfida: assicurato il bambino a una routine efficace, trascorsi ogni giorno cercando l’origine di questo ribaltamento. Lo cercai lì, dove poteva trovarsi. Nella mia storia.






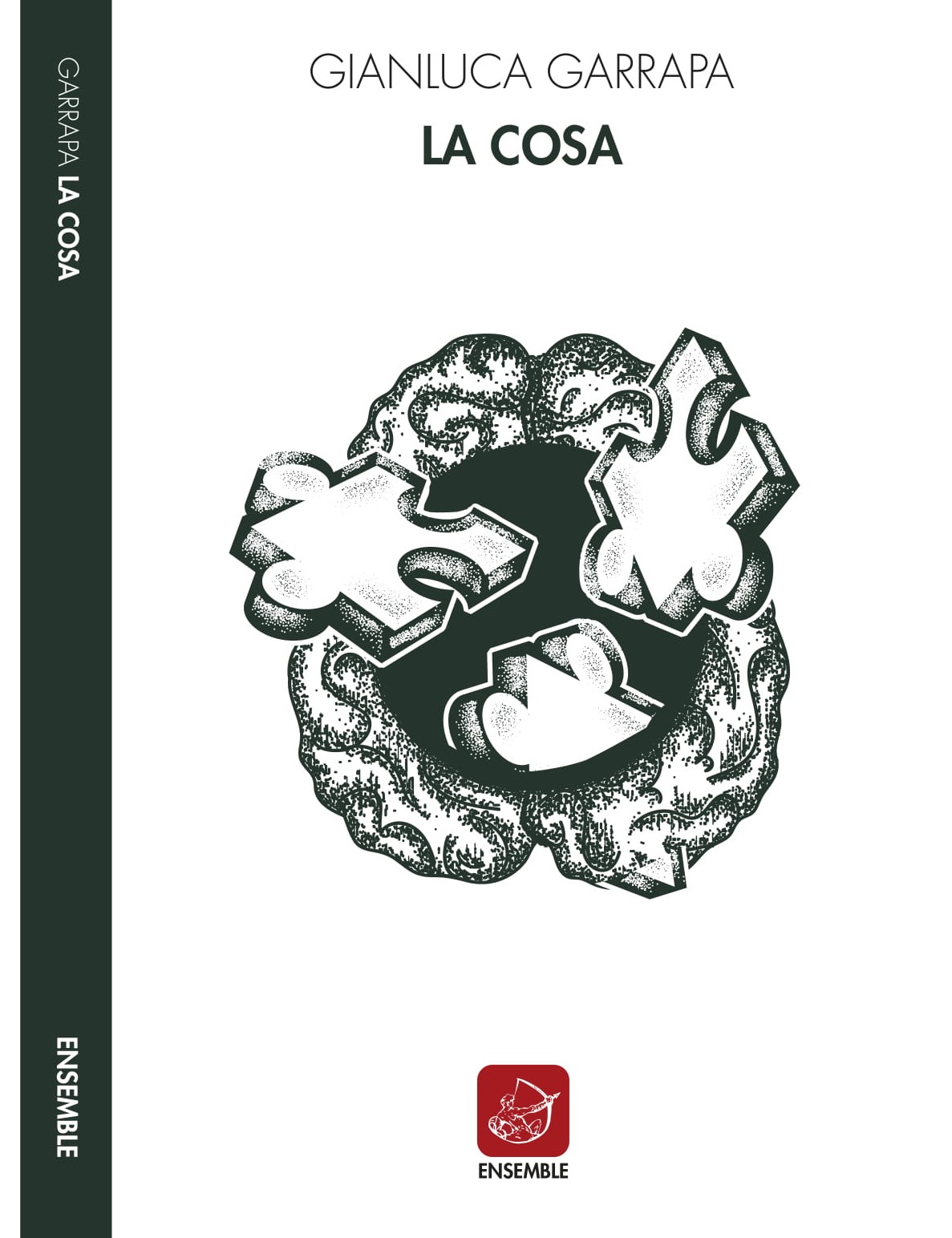








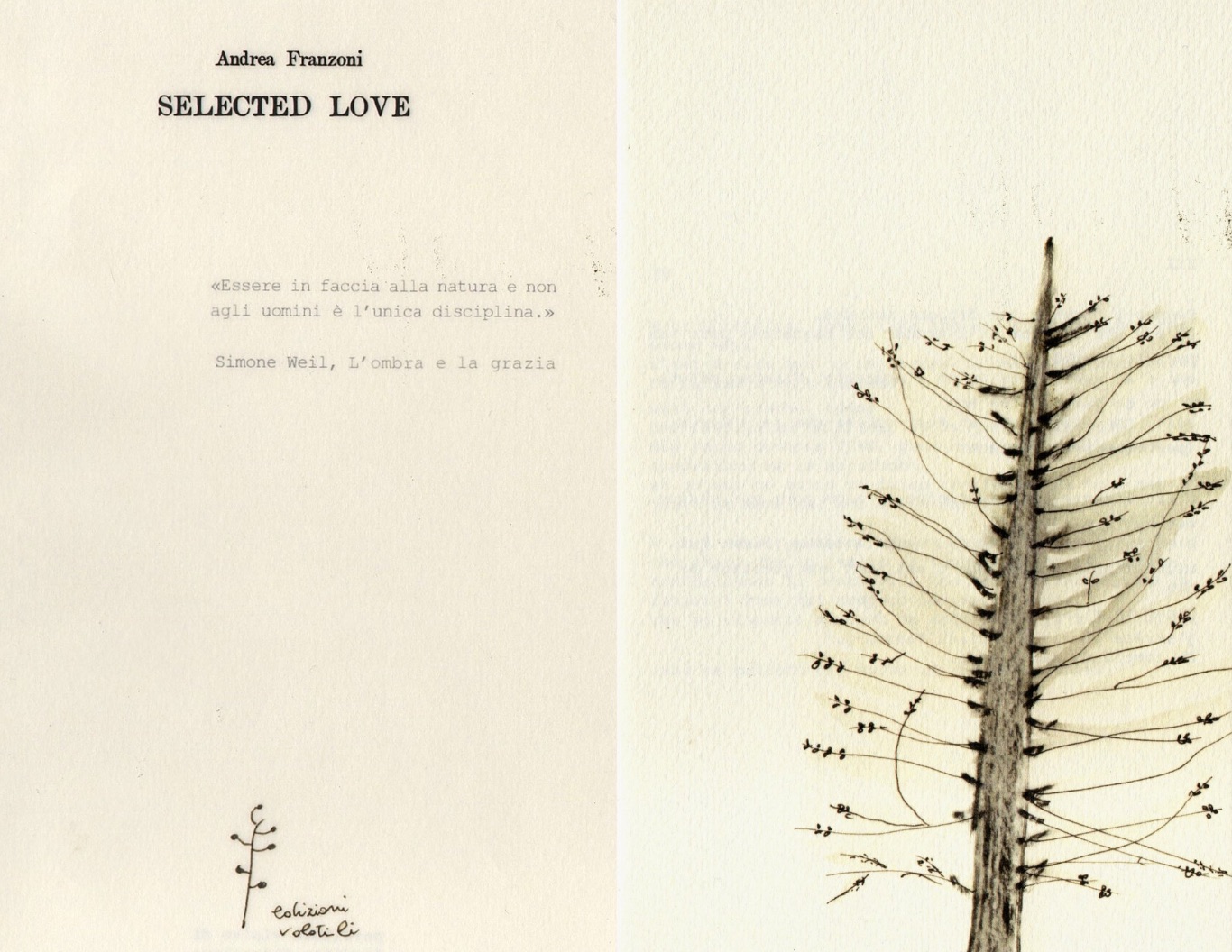
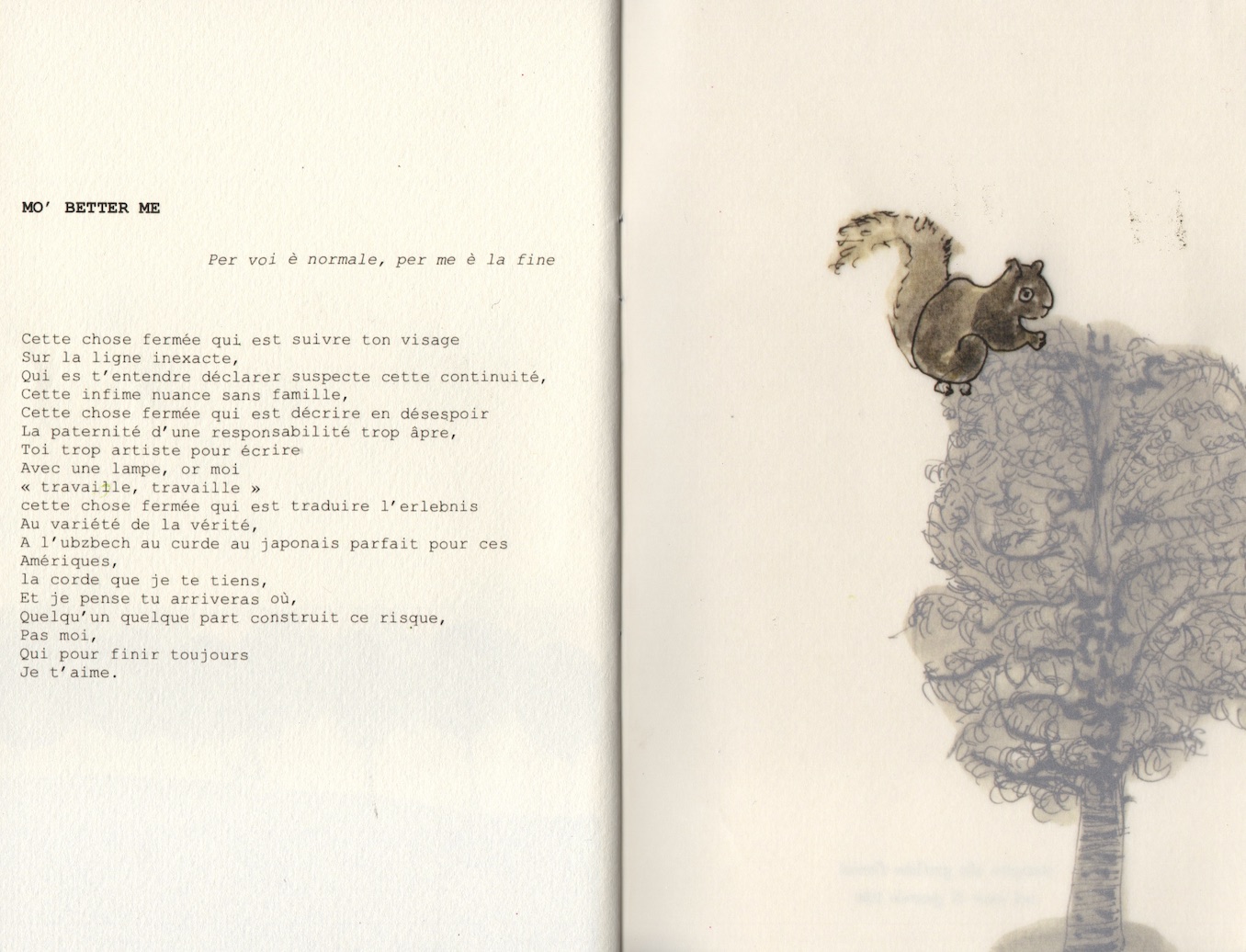
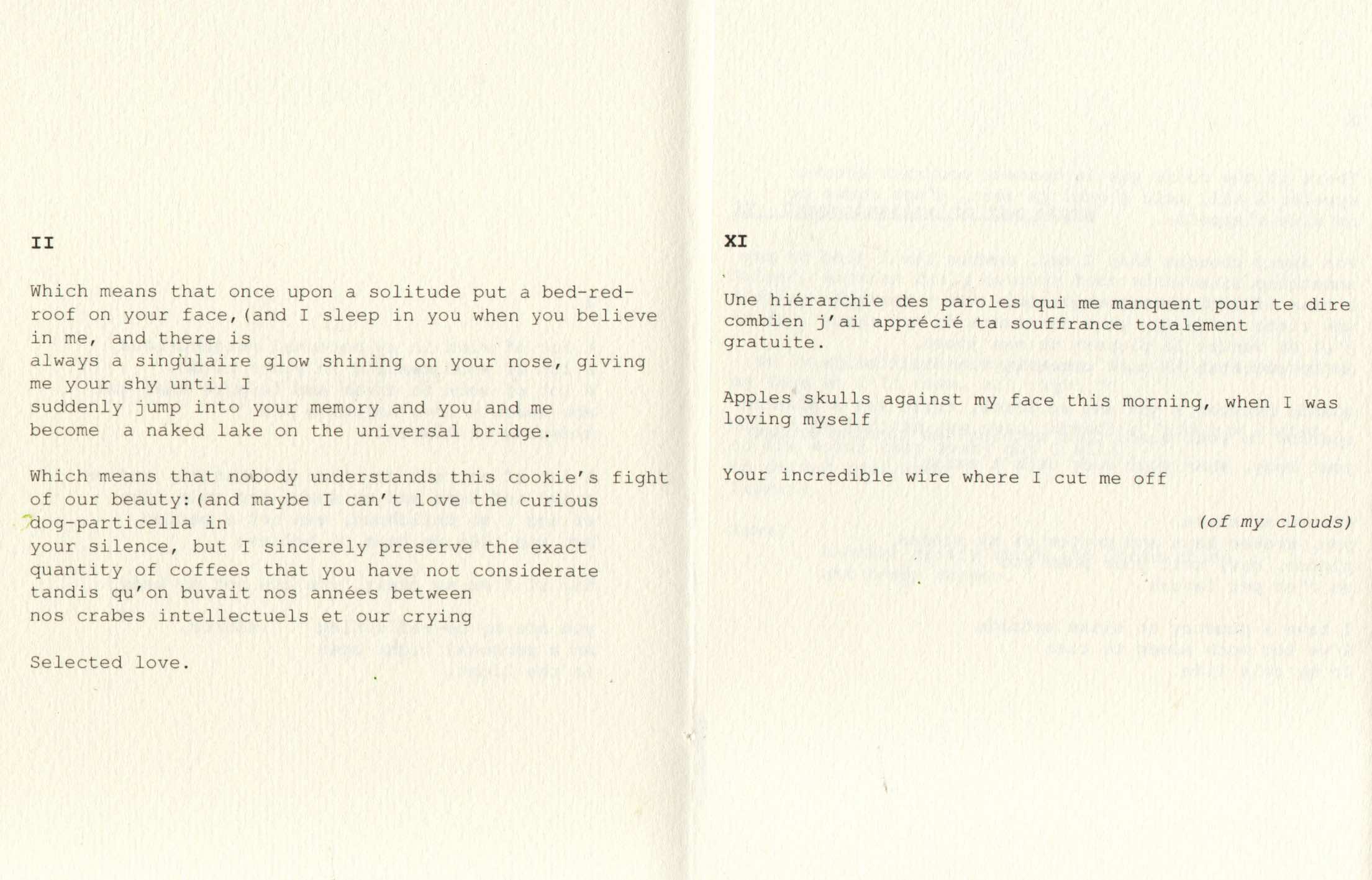












 nante di quella particolare lucidità che è di una visuale di straniero il cui prisma ottico venga trasfigurato dall’arte.
nante di quella particolare lucidità che è di una visuale di straniero il cui prisma ottico venga trasfigurato dall’arte. Al centro c’è la realtà, ben più dei suoi pittori, per quanto lo sguardo di Pavel Muratov sa moltiplicarsi fondendosi con gli occhi di grandi artisti del passato. Diffrazione indotta, senza che il risultato in termini di resa sia meno potente; l’entusiasmo del coltissimo ricercatore è contagioso, tanto quanto inaspettato ed enorme fu il successo di Immagini dell’Italia. Libro “culto” negli ambienti degli emigrati russi (nella postfazione Rita Giuliani dice della grande ammirazione che per Muratov nutriva Joseph Brodskij). Una lezione di sguardo, e di sguardi incrociati. La visione di uno studioso d’arte si interseca con quella dei pittori, il guardare di chi scopre e s’innamora di un paese nuovo quasi si sovrappone a quello di chi ritorna là dove si è svolto il passato. Punto medio di ciascuna traiettoria, la nostalgia. Un moto illogico quanto del tutto poetico: dove il rammarico di poter solo ipotizzare un tempo raffigurato dall’arte converge con la nostalgia di un passato amato e odiato – quando si torna “a casa”, anche se per poco, e mai si sarebbe voluti tornare.
Al centro c’è la realtà, ben più dei suoi pittori, per quanto lo sguardo di Pavel Muratov sa moltiplicarsi fondendosi con gli occhi di grandi artisti del passato. Diffrazione indotta, senza che il risultato in termini di resa sia meno potente; l’entusiasmo del coltissimo ricercatore è contagioso, tanto quanto inaspettato ed enorme fu il successo di Immagini dell’Italia. Libro “culto” negli ambienti degli emigrati russi (nella postfazione Rita Giuliani dice della grande ammirazione che per Muratov nutriva Joseph Brodskij). Una lezione di sguardo, e di sguardi incrociati. La visione di uno studioso d’arte si interseca con quella dei pittori, il guardare di chi scopre e s’innamora di un paese nuovo quasi si sovrappone a quello di chi ritorna là dove si è svolto il passato. Punto medio di ciascuna traiettoria, la nostalgia. Un moto illogico quanto del tutto poetico: dove il rammarico di poter solo ipotizzare un tempo raffigurato dall’arte converge con la nostalgia di un passato amato e odiato – quando si torna “a casa”, anche se per poco, e mai si sarebbe voluti tornare.