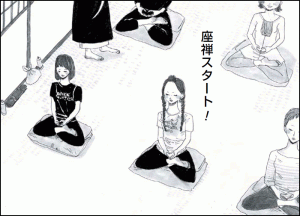di Daniele Muriano
(Questo lungo racconto fa parte del romanzo di racconti Le avventure di un testone, inedito. L’autore ce lo regala e noi lo ringraziamo. G.B.)

Sono nella casa tutta silenzio e virgole. Dappertutto un’attesa di virgole mi strappa ogni sistematica ordinarietà. Ci vedo, nella sala stranamente così squadrata, tutta spigoli… Ci vedo una pausa del significato moltiplicata per la quantità – all’eccesso calcolando e cioè in questo panico – di angoli, angolini e luridi angolacci non ancora esplorati, o forse sì, soltanto da ragnacci che non vorrei vedere nemmeno con l’immaginazione: ah: ormai è tardi, ecco.
Mi sembra che ci sia un romanzo inciso nelle porosità invisibili dei muri. Ogni casa racconta una storia, è vero, parlo adesso all’interiorità, alla mia interiorità, che è testo. Perché io sono testuale, in ogni momento che mi pare di abitare con dignità o addirittura con la mia felicità. Io sono un testo. E sì. La mia casa è anch’essa testo: racconta la mia improntitudine e l’inadeguatezza a vivere senza definire improntitudine una innata e, sì, sfacciata attitudine al suicidio che, del resto, non sono mica sicuro di poter comprendere senza ridermi addosso. Sono pio. Sono un inetto e non farei male ad una mosca. Figurati al mio testo. Me.
Comunque, dicevo, alla mia interiorità fattasi frase… testo, dicevo che la casa è parlante. E sono soprattutto le virgole incise a dolermi. A immagazzinarmi nell’infaticabile ristagno. Pure sono certo che la donna delle pulizie abbia ripulito ogni dolore. Volevo dire, pardon, ogni DISORDINE.
Ho salutato Mariangela sfiorando la sgarberia. “Grazie del lavoro. Ci vediamo mercoledì”. E chiuso. Quando resto solo nella casa rigovernata e mi guardo tutto estraniato dappertutto – è così. Non sono più davvero lo stesso. Anche il sale reperibile alla distanza di sei-sette centimetri dentro la credenza rispetto al suo posto – vale a dire mio –, mi comunica un senso di vita disadattata, di continua correzione da parte altrui: e di fatto, senza Mariangela, senza la governante o chiamiamola come gli pare, al testo, senza qualcuno che m’accudisce io non posso vivere. Il mio testo, la mia vita e quindi anche la mia casa, non potrebbero essere. Il mio esserci è eterodosso. Perché è esservi lontano dal testo. Lasciato in balia del mio testone, bello e pensante, sarei fritto, cucinato alla bell’e meglio in un pentolone d’un inferno interiorizzato.
Guardo ora l’ombra della testa spinta lungo il muro dalla cattiveria d’una lampadina nuda, là impiccata dal soffitto, un’ombra enorme che purtroppo non è riflesso di un’intelligenza. Il mio testone è scritto nell’ombra e si mangia il divano e parte del muro ripiegandosi contro al soffitto. È lui.
Mi parla.
La tua casa, dice, è un messaggio continuo che rasenta l’indicibile. Ricordi, dice, il primo appartamento in cui andammo ad abitare noi due soli, dice, quanto puzzava. Eravamo così addentro alla scrittura, dice, e intendo dire la testualità addomesticata, cioè domestica, scrivevamo poemi concentrici in un disordine tale da averci nessun conforto. Era il dicembre 2008, ad esempio – dice l’ombra di testone immobilizzata al muro – quando decidemmo che nella tua casa volevamo un biliardo: furono prese le misure al centimetro e, in effetti, nella vecchia mansarda si rivelò uno svuotamento praticabile per 540 x 410, appena necessario per il tavolo, sì: ma non sufficiente a giocarci agilmente in due, con tanto di movimento d’aste e spazio vitale per non soffocare, dato che, spostati l’armadio e l’amena cassapanca belli combaciati contro la parete, inutilizzabilmente, e resi vani le sedie e il tavolino da pranzo a gambe all’aria contro la finestra (da giù molto probabilmente avranno visto in quei mesi uno strano accrocchio d’insenature mobiliari e misterioso sarà parso il contenuto del nostro appartamento) rimaneva appena, ahi, lo spazio per muoversi e mirare e sparare le palle in buca per un unico, ben snodabile dove la testa va abbassata, tiratore di biliardo. Ma questo lo scopristi, eh, soltanto l’insano 22 o 23 dicembre quando completasti il montaggio. Che gioia! Però sì, il nostro loft di periferia in cima alla palazzina era una dolce meraviglia. Per Natale ci eravamo fatti il biliardo e cominciammo così a diventare precisi, a ogni tiro più determinati e precisi senza perdere di vista l’abitabilità del nostro piccolo loft attrezzato (quanto ai pasti apparecchiavamo su tovaglia plastificata occupando la metà sinistra del biliardo), benché certo, come abbiamo detto, l’insieme iniziò a impestarsi e puzzare e puzzare incontrollabilmente per l’impossibilità di tenere scopato, spolverato, pulito il posto. Non ci hai pensato prima, ecco tutto.
Ora questo mio testone mi recrimina, pensa un po’, ma non era presente mentre accumulavamo pattume in sacchi della spesa in giro, specialmente sotto al tavolo da biliardo, e pisciavamo nelle bottiglie dell’acqua Vera per pigrizia, per divertimento e anche un po’ per restare concentratissimi sul biliardo nelle intense speculazioni di geometria applicabili al tiro del momento, magari meditato per lunghi e tossici quarti d’ora, per eternità ancora più vaste e incalcolate finché stoc e dunque l’esistente si riconfigurava: i pianeti si riallineavano, non era presente, qui sulle virgole delle mie stoc, spalle, che avevano attirato tutta la tensione del tiro diventando per l’appunto come delle virgole, insane virgole tese e rattratte, quando un tiro ben fatto era l’azione unica ed essenziale nel pomeriggio di gelo, così unica ed essenziale da divenire il centro assoluto di ogni cosa, compresa la forma d’ordine casalingo, non era presente lui, il testone? Sì.
Capii tutto nel momento in cui, tornato dal capodanno in montagna coi soliti amici e persa ordunque l’abitudine, guardai per la prima volta la casa. Mi sembrò un’inezia la lacuna dello spazio. Anche le bottiglie in terra piene di giallori, alcune chiuse altre chissacome stappate in un tributo all’afrore domestico – erano niente. Tutto il dentellato disordine degli oggetti era messaggio, e non mi ero accorto. Prima. Non avevo capito il testo. Non avevo saputo decifrare la scrittura.
L’appartamento, mio caro testone adombrato da una lampadina, l’appartamento o loft, come l’abbiamo in gran pompa definito, il bugigattolo con al centro il biliardo era il nostro testo, l’abbiamo in quel modo impaginato: cioè abbiamo scelto una forma, difficile sì, ti concedo, con cui operare forti delle nostre ottime capacità di scrittura. Le bottiglie colme di urina, i sacchetti del super con quelle scatole di tonno guaste, la mattanza dei fazzoletti e dei tovaglioli, come delle forchette dimenticate e dei brani di cellophane – e di questi brani sarebbe bello vantare un apparato di note e concordanze per capirli in fondo – con anche le stoviglie disperse, tutto il testo insomma è messaggio che, per quanto disperato e per quanto disperante, ha una coerenza, può essere perciò analizzato proprio come un’opera.
Dirò di più, mio testone, ovvero. Non solo quel che chiamiamo disordine è testo analizzabile coi crismi del testo, ma è anche innegabilmente stato scritto con un’intenzione, artistica o meno, un’intenzione del comunicare. E sono tutte cose che sai, ma devo ricordarle, ora che stai come un’ombra sulle pareti, mentre io mi trovo all’in piedi come un idiota su questa sedia, spalle alla luce, con un cappio testuale in cui infilarci.
Mi sei complice. E se tutto questo è testo, che somigli a una pungente deposizione quanto meno, non a un repertorio di strali da suocere. Il giudice, in un secondo tempo, lo sapremo ingaggiare. Non è un’evidenza che… entrambi… speriamo sarà redatta una corposa sentenza alla fine? No? Altrimenti perché stare in una posizione patibolare fermi non si sa per ancora quanto… E così nella scomodità.
Noi siamo, dice il testone dalle porosità murali, noi testualmente siamo: colpevoli. Il nostro testo miniato laggiù nel mondo in ogni passo, gesto, contrasto, apposizione, marchio, assestamento, intoppo, scarto, sorpasso lo dice, apertamente quasi lo spiega. Abbiamo già deposto un verbale. Prendi il vecchio, dice, quel balordo di anni novanta che, per 320, ci ha affittato la scomoda e inabitabile mansardina. Non aveva no i crismi burocratici dell’abitabilità. Eppure il vecchio bussava in quel gennaio spappato di neve. “Si può entrare, per favore?”. Silenzio. “Dalla finestra si vede tutto un cumulo…” Silenzio noi due. Ma un proprietario ha diritto a entrare nell’immobile quando desidera? Nell’immobile c’è l’inquilino: lui… veramente immobile, schiena incollata a una parete. Inquilino fra i cumuli. E la domenica successiva ancora a esercitare un diritto inventato il vecchio dietro la porta di mansarda diceva: “Per favore, per favore. Non mi distrugga casa”. E quant’era affezionato alla maledetta casa sua! Ma noi sempre reticenti, se non silenziosi. E dopo la domenica di fine gennaio in cui il vecchio proprietario si era dato al pianto vero e proprio dietro il suo legno, abbiamo provveduto: al negozio di Leroy Merlen abbiamo fatto tagliare una lastra nera di un materiale plastico e abbiamo interamente nascosto la cazzo di finestra; così dal basso non si poteva vedere l’accumulo dovuto al biliardo né il nostro addomesticato testo domestico: il “DISORDINE”.
O almeno questa in brutto maiuscolo è l’espressione che avrebbe usato il povero Geremia che possedeva quella mansarda riadattata e voleva pure fosse trattata con i guanti – DISORDINE? Oh no, la disposizione delle cose nel mondo ha l’architettura di un leggibilissimo testo. E il lettore è un Dio supremo, un Dio plurigalattico, un Dio inimmaginabile anche a chi si dichiara religiosissimo e non ha capito quanto siamo espliciti noi altri viventi. Siamo autori ignoranti. Afferrai tutto grazie a Iris. Alle grazie, di Iris.
Non andavamo così forte al biliardo da essere infallibili al Palla 8 del bar sulla parte nuova del corso? Così forte da risultare persino appetibili, caro testone? Il 5 di marzo, sia messo a verbale (questo nostro verbale), fu un giorno di grandi scopate. Indeclinabili i nostri favori per la scultura in minigonna che gradevolmente ambiva a stracciare il liso panno verdognolo di un bombardato biliardo provinciale, ambiva, ah già, al punto da riuscirci in pieno squilibrandosi per un appoggio mal portato, tentativo questo di tiro indiretto su sponda troppo vicina, e noi, seduti al tavolo con una Beck’s, a esprimere i nostri, a-ehm, indeclinabili favori con una, urgh, spiegazione teorica grondante luppolo: così e così, dicevi, e poi là e adesso stoc, caro mio, quella sbandata venne cucinata con poche parole. Il padrone del bar, l’uomo tozzo e cinese ma gentile ci chiese un nonnulla per il panno, pagai comunque io e l’indomani già potrò giocare su un tavolo come nuovo; un nonnulla, be’, nonnulla di duecentocinquanta fave. Servì comunque alla causa, ora: il 5 di marzo che stranamente ho saputo datare, considerato il minus di smemoratezza di questo testone, ma ho ricostruito la data partendo a ritroso di tre giorni dall’8, 8 marzo festa della donna. E la festa fu di entrambi quel pomeriggio. Cavata dagli impicci, la povera Iris – che non si chiamava Iris ma si era cambiata di nome perfezionando insomma il testo suo e nostro – salì le scale gonfie d’un gelo umido guidata dalle nostre amenità: “Vedrai che casa strana che ho”, “E sarà un pomeriggio come non t’immagini”, “Attenta alla testa”, “Ecco: è buio perché ho dovuto coprire questa finestra”. E salito l’ultimo gradino si ritrovò nel morso del testo.
Mentre la spogliavo di camicetta pushup e gonnettina, lei gettava occhiate stralunate all’ambiente, deglutiva forte ma, senza molte rimostranze, si lasciava manipolare. La luce era sordida, dobbiamo ammetterlo, ma una luce più intensa avrebbe rovinato l’atmosfera da sala del biliardo; ed era precisamente l’atmosfera che avevo scelto di scrivere, o non so come dire. C’era qualche bottiglia d’urina che per fortuna si poteva spacciare per del tè nel quasi-buio (e devo ricordare al mio testone che quel bel mattino avevo irritualmente levato di lì tutto il pattume come presentendo…) Ma insomma la mite Iris in groppa a una buca del biliardo divaricata interamente per me orante tutto dentro l’umido viscere, la mite Iris non aveva nessuna voglia di criticarmi l’arredo e forse qualche voglia di farsela leccare.
Più tardi in quel lettino sordido abbracciati come due estranei ci levammo la curiosità.
Io: “Come ti sembra il posto…”
Iris: “Fa schifo, ma sono abituata. Tu vivi qui?”
Io: “È la mia casa”.
Probabilmente pensava, posata testa sul gomito e ascella lungo il letto, a come cacchio avevo potuto permettermi di pagare il conto: 250 fave, io che vivevo in quello schifo. Ma non aveva coraggio sufficiente per dirlo, forse temeva le avrei chiesto dell’altro in cambio, in fondo era molto bella.
La guardavo da una distanza improbabile: avevo sempre saputo in quale pizzeria lei serviva e, vedendola con tipacci sempre diversi al baraccio, anche la vita approssimativa che faceva, il lunedì sera ubriaca e il giorno dopo nelle cucine per poi scattare verosimilmente al motorino negli uffici per l’asporto, sfrecciando di fatto davanti al bar del biliardo con la faccia sfatta dal vento, o così io la vedevo, o addirittura la immaginavo indovinando la sua persona in quel movimento, avevo sempre insomma sognato di penetrarmela, anche con una stecca del biliardo, lì, nel bar mentre… Ma caro testone, non perdiamoci in ciò che già conosci e accontentiamoci di mettere a verbale: ero sorpreso che non le facessi molto schifo.
“Sei abituata, così hai detto”.
“A farmi degradare dagli altri. Non so perché succede ogni volta. Dev’essere un destino”.
Le tolgo la mano da sopra il mio fianco sinistro.
“Te la sei presa. Ma lo sai che è vero?”
E allora ho cominciato a tempestarla di quesiti sfruttando l’ultima, l’unica volta che avevo quella boccuccia a così breve distanza. Cosa provi nel venire scopata in queste condizioni? Cosa immagini mentre stai a occhi chiusi e mugoli e mugoli… o vedi il nero? Cosa ti piace fare a letto? Cosa avresti voglia di sentirti dire nel mentre? Come ti farebbe piacere esser nominata da un amante quando ti degradi? Come ti senti…?
Niente e niente e niente, ancora niente e niente.
Lei sembrava voler essere, per conto suo, niente. Se le chiedevo chi era poco ci mancava rispondesse “chi vuoi”. E sono certo che se le avessi domandato qualcosa di poco più personale mi avrebbe risposto: “decidi tu”.
Era nuda e splendida sulle mie ciabatte in quella luce che col buio serale diventava quasi magica, indescrivibile. Ferma come un’icona dipinta nella cornice tridimensionale della porta. Coi vapori di doccia che l’avvolgevano di schiena voluttuosamente. Mi guardava e io ricambiavo, in una posizione ritorta e fetale, schiacciato nel lettino affiancato a muro, accipicchia, sublime. Ed è stato allora che ho fantasticato.
“Hai detto che il degrado è un destino”, ho fantasticato e non ho detto.
“Io non scelgo. Perciò alle domande ho risposto: niente. Io sono scelta. Altri mi scelgono. E io sono. O perché credi che sarei venuta a scopare con te in questo tugurio?”
“E cosa è il destino?”, ho fantasticato e non ho detto.
“È qualcosa che ciascuno scrive”.
“Ciascuno?”
“Ciascuno, scrive”.
“Ma cos’è?”
“È un fatto di gesti, posture, azioni piccole e indecifrate, ma soprattutto gesti”.
“Una scrittura… di gesti”.
E così riflettevo su come noi viventi scriviamo, scriviamo e scriviamo le nostre vite. Chi come Iris, che ora osservavo con la distrazione dovuta alle allucinazioni, e in generale come la gente che si fa scrivere. La gente ineludibilmente passiva in questo senso. Chi, invece, come la persona che aspiravo da un’eternità, ma solo ora mi riducevo… a diventare e cioè, ci riflettevo nella luce sordida, una persona vera: architettata da se stessa. Stavo annaspando in questi ragionamenti appiccicosi quando la sentii, distintamente, canterellare una preghiera: “Dio li fa e poi li accoppia”. O non era una preghiera, ma un’esclamazione semi-volontaria. In ogni caso sono sicurissimo che non fu niente di immaginario: disse.
“In che senso?”
Sguardo franco, ai limiti dell’oscenità: il potere del sopracciglio coordinato con quelle ciglia.
Ripeti, per piacere, mi sovreccitavo interiormente, ripeti.
E lei: “Cosa c’è. Non ho detto a. Come mi guardi uf”.
“Hai parlato di Dio”, dico.
“Sei pazzo? È così…”
“Io ci sento bene”.
Sono sempre stato un tipo fantasioso. A volte persino non so distinguere le due campane. Ma quelle parole appartenevano alla sonorità del mondo reale. Le aveva enunciate realmente lei. Porca miseriaccia.
Si era immersa nel getto informe dell’acqua calda. Senza commentare più. Era un modo probabilmente per lavarsi di dosso me e la mia stranezza. Credo.
Ora da quelle chiacchiere, quali immaginate e quali invece testuali, mi ero fatto suggestionare nel modo meno salutare per uno immaginoso e infelice come il personaggio che scrivo, mi ero fatto condizionare, complice la peccaminosa indecenza di quella doccia spiata (dove il peccato era l’acclarata non riproducibilità in futuro dell’incontro), mi ero fatto condizionare e, dunque, tutta la mia vita conseguente si è in effetti rivelata sotto il segno di quelle cocenti immaginazioni. Io – e questo è ovvio – non avevo avuto mai idee sane sul (e del) mondo. Ma insomma non ne avevo neanche ritrattato la natura noumenica, per così dire, quanto alla sua forma testuale. Quindi ho pensato, osservando minutamente le righe fluide in trasparenza dallo smerigliato, che il mondo non fosse, come pensato fino ad allora, un semplice ambaradan testuale una volta che i suoi narratori avessero semplificato il raccontabile, ma che proprio, noi, io e te, e l’intera umanità inconsapevole non fossimo che elementi testuali in un grande infinito e irrisolvibile libro considerando anche che – chi più chi meno – ci dedichiamo a scriverne delle volte dei cospicui capitoli. Fin dall’inizio del millennio, quando cioè avevo cominciato a considerare le varie pose dei miei compagni d’università (la risatina, il colpo di tosse voluto, il voltafaccia durante una discussione in corridoio, ogni tentativo di ordire una concepibile prossemica) come anche le pose dei docenti e delle altre persone che frequentando in un modo o nell’altro mi sforzavo di comprendere, e ne avevo tratto la conclusione per cui tutto il marasma di quei gesti avrebbero potuto leggerlo dall’alto di una nuvola loro, i nostri lettori, come un testo dotato di struttura, fin dai primi anni di vera solitudine di studentino fuorisede mi ero incrudelito con gli altri per poi arrivare con la maturità, diciamo, a miniaturizzarli umanamente come entità testuali piccolissime. Il colpo di mento all’aria di una ragazza, nella piazza del Duomo, mimato per attribuirsi un’importanza era nientemeno che una virgola. Il punto l’occhio dell’uomo che vendeva i gelati d’estate sul lungomare a Saint Tropez. Il punto in una frase di gesti complicati quali: spingere il carretto refrigerato fino all’imbocco del parcheggio, asciugarsi il sudore da quella fronte larga da etiope, macinare col suo cucchiaio di metallo in uno dei contenitori, il che gli dava un’aria tutta strana, da misterioso personaggio di un romanzo di spionaggio. Solo dopo una lunga preparazione il suo occhio vitreo con minuscola pupilla poteva affermare suggellando il contenuto dell’intera frase. E poi ogni particolare mi diventava il tassello di un grande romanzo, di un grande libro, o che so io d’una bibbia in corso d’opera. Ma ero, laureato in lettere e insegnante precario, poco più d’un eversivo psicotico totalmente invisibile. Adesso, dopo il crollo e un quinquennio di allegro vivacchiare con i soldi di un’eredità salvifica, per una scopata inattesa tutto poteva modificare il proprio andamento. Con lei il mondo avrebbe potuto rifarsi. Ma non con lei, non… con lei. Insomma, non ambivo a diventare qualcuno per Iris. Iris, la più manierosa fra le donne prive di maniere, la più sofisticata tra le fiere del reame, era una madonna. Ma non vorrei, caro testone che mi ascolti (lo spero), oh non vorrei bestemmiare in questo testo. Non la madonna, no, ma: una luce armoniosa di carne e ossa. Un suggerimento venuto dall’alto, o uno svelamento metanarrativo piovuto da chissà quale dio testuale. Lei con quel nome da romanzo scelto con stile, lei ombra in movimento nella cabina della mia doccia, lei accondiscendente, Iris la mite però impeccabile formalmente nella lasciva intimità concessa all’estraneo. Lei si spiegò perfettamente.
E poi. Oh si mise a sculettare per casa biascicando: “I fazzoletti si buttano nel cestino”, “Le briciole si possono raccogliere così e voilà”, “Ecco ecco, non ti pare che il piscio stia meglio qui nel gabinetto piuttosto che imbottigliato, ecco ecco”. Ondeggiava nella sua minigonna ultraterrena e la casa a ogni passaggio ne emergeva corretta e più bella. Era con la stessa determinazione che cinque anni fa, io il Prof Terrificante, mi ero adoperato a dare un’impostazione accettabile ai temi dei miei ragazzi: cambia una virgola qua, segnala a penna rossa una figura retorica sballata e – infine rivisto rapidamente il brutto tema – esprimi un voto caritatevole. Non sempre c’ero riuscito però, poiché la bruttezza del testo qualche volta parlava più chiaramente del disagio sociale del malcapitato. Ma comunque, la mia salvatrice in conclusione mi poteva soltanto giudicare.
“La tua vita sembra meno schifosa, adesso”.
“Non dovevi, forse sì”.
“A me fai pena”.
“Dovrei ringraziare”.
“Anche no, qui si fa quel che si può”.
“Mi hai insegnato una verità talmente grande che non puoi immaginarla, sai.”
“Sei mezzo matto, guarda, e poi vuoi dirmi che ci fai in uno stanzino con un biliardo?”
“Giocare è rilassante. Da ragazzo il mio fratello maggiore ci faceva dei capolavori con un biliardo identico. Mi ha regalato dei momenti meravigliosi giocando insieme, nel bar dei nostri fratelli adottivi. Ah, i nostri genitori sono morti presto, entrambi della stessa merdosa malattia, che tipo triste che sembro, vero…”
“Be’, non sei uno molto allegro, ma si fa quel che si può!”
“Comunque il biliardo è un pezzo di storia, mi ricorda quando riuscivo a ricavare un sorso di felicità dalla mia adolescenza e da ciò che restava della famiglia. Ma perché ti dico questi mezzi romanzi?”
Tacemmo un tempo straziante (perciò lunghissimo) in fondo al quale lei mi salutò sulla porta con due bacetti nelle guance. Ed eravamo al di qua. Al suono flebile flebile dei passi all’imo delle scale potei anzichenò socchiudere la portina, per poi in tutto silenzio bloccare il passaggio al maledetto novantenne.
“E ora?”
“Ora silenzio…”
“È un altro dei tuoi momentacci?”
“Zitta, porco cane!”
“Fammi scendere. Non ne posso più”.
“Sta arrivando”.
“Chi? Sei matto!”
“Devi stare zitta, puttana”.
E subito mi pentii di averla insultata. Tale era il pentimento da mettermi brividi incontrollabilmente lungo la schiena. Ma il vecchio arrivato coi suoi ansimanti passi al bersaglio di sempre, incominciò a dar di nocche.
Iris era terrorizzata e non abbandonava la verticalità della parete laterale. Io stavo, abituato al silenzio come al fingermi inesistente.
“Oddio”, bisbigliò Iris.
“È in casa? Possiamo parlare? Sento delle voci”.
Un vecchio decrepito non ancora sordo era più di quel che meritavo, arrivò a dare alla luce questo orrore la mia testa cattiva. Ma eri tu, testone incoercibile. Il mio unico vero amico, diciamo; l’interno suggeritore di sempre, il vero autore dei miei terreni e inverecondi testi. Dio giudicherà.
A fine mese scartai la lettera che m’aspettavo: il proprietario, Geremia mi invitava in un italiano zoppicante a lasciare il prima possibile il suo… magazzino (dal momento che, per ovvie ragioni, quel buco non ci aveva i crismi dell’abitabilità e io ero semplicemente il… conduttore – ah i legulei immobiliari – di un contratto di affitto di un immobile in uso magazzino, capirai, ma che razza di magazzino poteva essere il sottotetto con bagno e con letto solo Dio saprà), e io non sapevo davvero se considerato il tipo di contratto aveva piena legittimità di mandarmi a marcire altrove con preavviso così scarso, ma dopo che tutto, ma proprio tutto aveva mostrato la corda, e che corda, per esempio la mia nascente relazione con Iris era morta sul nascere avendola vista l’8 marzo con le amiche lungo il corso vistosamente a disagio per me che tutto mi sbracciavo a una decina di metri da lì, felicissimamente ignorato, e ancora quando la avevo cercata nella pizzeria dove lavorava in schiavitù, ricevendo un epiteto gentile e nuovo: testone, eh testone, ma non la vuoi capire? testone eccetera, dopo tutto insomma, tutto il sopportabile, mi ero deciso ad accettare la risoluzione del contratto.
Era il primo d’aprile. Ma che bello scherzo. Effetto burla o coincidenza da romanzo impubblicabile, mi domandavo. E comunque il primo aprile, con tanto che ero un altro uomo rispetto all’anno prima, quando invece avevo febbrilmente rinnovato il contratto in virtù del “ma dove trovo un affitto così basso?”, mi trovai senza casa e però felice. Ma ero un altro soprattutto grazie a Iris; o alle grazie concesse una tantum o, meglio, alla grazia con la g maiuscola, foss’anche alla grazia espressa nei confronti di un condannato.
Torniamo, caro testone (non, però, nel senso in cui intendeva Iris), all’esecuzione. Un’esecuzione di cui s’ignora forse la sentenza? Oh evidentemente no. Il verbale è scritto.
Con ordine.
Andavo sprecando la mia bruta e romanzesca vita? Certo che no. Ogni cosa era organizzata per essere bella e goduta dall’altissimo. Il nostro grande lettore solo alla fine potrà giudicare. Questo mi ha mostrato la donna che ho chiamato Iris. Mi ha mostrato con l’esempio di bellezza da lei incarnato la necessità estetica di fronte a Dio. Ora so, per dire, che trovandomi dall’inizio del testo sopra alla sedia, in una posa che ricorda quella d’un condannato all’impiccagione, il mio grande lettore mi osserva con interesse. Ho fatto qualche cosa di notevole e di strano, promettendo una ancora incerta bellezza, e mettendomi in ogni modo nel centro della scena. Così che egli mi guardi. Sono sopra una sedia. Il cappio è qui. Lettore altissimo vuoi considerarmi? Vuoi? Questo Iris ha mostrato, ha spiegato, ha incarnato momentaneamente. A Dio non importa un cazzo se noi uomini ci facciamo del bene, se non ci ammazziamo l’un l’altro o se, per dire un caso qualsiasi, ci scopiamo eventualmente la donna d’un altro: a Dio preme solo la bellezza: dei nostri gesti, delle nostre malefatte, dei nostri spasmi, dei nostri avvicendamenti, dei nostri mortal sospiri, è così orribilissimamente ovvio. Io mi trovo in piedi su questa bella sedia. La mia ombra riveste l’intera parete qui frontale, ed è la famosa figura di testone, la casa galleggia sul dubbio più terribile. Al lettore che si trova in alto, sulla mia vita, importerà granché come mi sono condotto con la morale? Importerà quanto male ho fatto io, al di là di quanto interessante sia su uno spettatore quel male? Oh il lettore ha facoltà di scelta: quale vita sceglierà di seguire da vicinissimo… Quale personaggio gli toglierà la noia dell’infinito? Le letture sono molte, pensavo e dicevo al mio testone mentre in bilico tra la vita e la morte mi inchiostravo ombreggiante qui sulla parete. Io – assicuravo fino a pochi attimi fa – produco una qualche bellezza, io. Dio mi sta osservando… Adesso mi viene il gran dubbio, ho il dubbio per cui qualsiasi altro dubbio è proprio un dubbio qualsiasi.
Questo show per cui mi sono mostrato sopra alla sedia, ho parlato come in un monologo all’ombra e come un ventriloquo ho animato la risposta dell’ombra – non sarà uno show noioso e privo di bellezza? Soprattutto ora guardandomi intorno non vedo che una scenografia anonima, a base di pulitissimi e degnissimi pavimenti come anche degni e puliti sono i mobili: persino lo sperma secco sul copridivano zebrato non si vede mica più! Miracoli della Mariangela che tre volte a settimana mi monda lo scenario senza scandalo per il padrone di casa. Persino i malvagi reperti di una sessualità solitaria, ma pornografica finché agita in fronte al Dio che legge, con tutte le oscenità testuali esibite Mariangela, instancabile, è autorizzata a far sparire. Perché sì, bisogna trovare un equilibrio fra il valore artistico della scultura messa in esposizione in questa casa e l’idea di abitabilità dell’uomo medio, privo di sensibilità al valore artistico. Ogni tanto qualcuno viene a trovarmi. Qualcuno che può rivelarsi pure il padrone di casa. E io non… Be’, nessuno veramente mi obbliga. Diciamo che ho scelto. La mia vita non avrà la potenza estetica che mi spetta. La casa apparirà meno disperante e l’effetto sarà certo ridotto. Niente sospiri e niente fitte al fegato per chi dall’alto del testo guarderà dentro casa. (Mentre quando vivacchiavo nella mansarda preparata e allestita per quelle performance, con Iris e col vecchio, la mia scenografia tra schifo e biliardo poteva commuovere il lettore in un modo più semplice e istantaneamente. Venduto però il biliardo per 150 fave a un inesperto ragazzino tutto brufoli e capelli unti, il povero biliardo compagno di giochi, ho deciso di cambiar vita. Non sarò mai un vero artista agli occhi di Dio). E insomma adesso che non son più giocatore di biliardo e ho abbandonato quell’esistenza artistica, sono solo un uomo su una sedia pronto a impiccarsi, un grammo di attenzione me lo si dedica ormai solamente per via del cappio; e sì, risulto avvincente o interessante solo come potenziale suicida, dal momento che ringraziando Mariangela non sono più l’uomo sepolto in casa da un mare di oggetti. Ma perché ci si dovrebbe interessare al mio destino?
Il destino ce lo si scrive, o è necessario arrendersi a che siano degli estranei a scriverlo per noi: il messaggio di Iris è pressapoco questo e, se avesse avuto proprietà di linguaggio, lo avrebbe espresso in questi termini: non avrei dovuto interpretare i suoi poveri gesti, le sue battute striminzite, né cambiarle il nome per suggerire a chi legge un’importanza fuori del comune, visto che non è bello né fruibile che una donna su cui si concentra il moto di conversione a una nuova e testuale religione si chiami, per dire, ma per dire… Genoveffa. Ah, sono stato convertito alla mia nuova religione da una certa Genoveffa…! Non risulterebbe interessante al mio Dio. O mio Dio, esclamerebbe ora. E invece gli tocca guardare me che con un gesto ampio e semicircolare, in piedi su una sedia, così, disegno in quest’aria una virgola, una virgola, e agisco in nome del mio testone. Lui è me. Ma io non sono lui. Lui è quello che scrive, io sono lo strumento, come una penna o una tastiera. O meglio, il mio testone pensa, io agisco.
Da quando ti sei rammollito e hai preso parola qui, in questo nostro testo, dice qui e, inevitabilmente per mia bocca, il testone proiettato su quel muro, da quando hai smesso di fare come dico e giù a pontificare pontificare, hai dato un gran brutto esempio di retorica, hai dato ragione a quello straccio di prete.
E sì. Ricordo bene il monito del prete che in un modo o nell’altro ispirò (quasi: mi dettò) questa parte di testo che scrivo. Questo pezzo di esistenza del personaggio che sono, con tutti i limiti del testo, della vita pratica. Siamo al 9… 10 di aprile 2009, mi trovo finalmente tra quattro mura, di nuovo, dopo il calcio nel culo avuto dal proprietario della triste mansardina, in una casa che non avrei voluto abitare; delle volte è necessario stare dove non si vorrebbe stare neanche morti, neanche morti. Tant’è. La casa è piena di ricordi. Hanno il corpo e la densità di dolorosi fantasmi. Abbiamo abitato tra questi muri nel frattempo muffiti fino a venti, ventun anni fa, io e i miei fratelli. Noi tre sempre uniti e vicini, con accanto i genitori malati di quella innominabile, invincibile malattia. Alla loro morte, annunciata e quasi in contemporanea, era tutto già disposto: io settenne, e mio fratello che aveva da poco iniziato a parlare, e il maggiore che più che parlare pronunciava bestemmie indicibili dall’alto degli undici anni psicofisicamente in grembo alla rabbia, noi tre andammo a stare senza colpo ferire dai vicini di casa: erano più famigliari di altri parenti che, per guai loro di vecchiaia o di vita, non avevano possibilità né spazio per accudirci, e poi, da sempre, li chiamavamo zii anche se, per età e modi, avrebbero potuto essere soltanto i nostri nonni. La casa fu venduta. L’acquirente era un amico dei nostri fratelli adottivi. La comprò per pietà, credo, perché in tutti questi anni non mi risulta che l’abbia abitata né affittata a chicchessia. Ad ogni modo il denaro ricavato andò ad alimentare dei buoni postali, quello che non servì, negli anni, come da programma premorte dei genitori, per noi, per la nostra educazione il che, infatti, è lo scopo di questa fretta di vender tutto alla morte dei miei. Poi cresciamo quindi nella villa con giardino e cagnetti anche meglio della villetta venduta, cresciamo come possiamo, con tutte le giornate vuote trascorse nel bar dei fratelli adottivi, ad aiutare un poco, ciascuno secondo il proprio possibile.
Stavo per scrivere la continuazione di questo ultrasintetico romanzo di formazione quando, come in un romanzo, suonò il prete. Lo guardavo ora dalla finestra della cucina mentre, fermo al cancello come un manichino, guardava evidentemente la villa in cui non avrei dovuto trovarmi. Il suo abito scuro segnato dalle linee della cancellata rimaneva fermo: un papavero nero sulla linea verdastra della campagna per orizzonte. Gli avevano detto che la casa era stata riaperta? O mi aveva incredibilmente adocchiato dalla lunga distanza l’istante in cui m’ero sporto? Sventolava ora un braccio e si rendeva disponibile. A me. Che credevo in un altro Dio. E non mi sentii di rimandarlo da dove era venuto, in più dovendomi abituare alle visite del padrone di casa un prete non avrebbe cambiato la mia solitudine.
“Lei non mi conosce. Abitavo in questa casa moltissimi anni fa. Poi è stata venduta”.
Annuì severamente come chi è stato mandato e conosce più dell’interessato i casi. Si guardò intorno; c’era la sedia in mezzo al soggiorno nel buio, gli scuri chiusi sinistramente. Andammo invece per il corridoio e poi in cucina lo invitai a sedere.
“È venuto per conto di chi?”
Mi sentivo talmente addentro al testo in lavorazione, che il mio atteggiamento era quello di un pazzo. È venuto per conto di chi… Non avrei potuto calarmi più intimamente nei miei panni – e allora? Il racconto narrava la vicenda di un uomo che si sente come imprigionato dentro un racconto dove ogni cosa è in effetti testo. L’uomo si sente in dovere, come il personaggio di un racconto, o come agirebbe il personaggio di un racconto imprigionato dentro un racconto, in dovere, si sente in dovere sì nei confronti del proprio lettore. Che ovviamente considera una specie di Dio. In quanto da lui dipende la propria vita testuale. Il tutto succede in un quadretto annebbiato dai colori tediosi d’una provincia di mezza campagna. L’uomo che non ha nome si rivolge alla propria ombra millantando di esser disposto a impiccarsi. La sua pazzia è tale da fargli credere nell’intelligenza autonoma e scissa dell’ombra, il testone. Il testone gli parla, caro testone risponde lui eccetera, finché io – lo scrittore di questo testo – non mi sono sentito identicamente nel ciclone impazzito di quel montato. Non ho raccolto altro che il sentimento di prigionia esistenziale. Ho assunto su di me il dolore di chi si sente un personaggio di carta. Ho fatto diventare la mia mente un testo.
“Ma come, figliolo, vengo per conto del Signore, di Dio”.
Ho toccato con le quattro dita il testone qui sulla nuca. Poi ho indicato una delle sediole. “Mi scusi, prego, si sieda. E mi dica”.
Sguardo d’una pietà contratta. Vorrebbe irriflessivamente scappare… Sì.
“Sono qui per la benedizione della casa”.
“Ah… Non l’ho fatta parlare, ma vede: sono molto stressato”.
“Abita da solo in questa casa?”
“Sono tornato da poco, la casa non appartiene più a noi, il proprietario mi ha dato le chiavi per amicizia, mi segue? Ha l’aria confusa”.
Guarda in un guizzo gli angoli della finestra. S’irradia un velo irregolare di muffa, che cresce d’intensità verso l’altissimo soffitto.
“È chiusa da tempo, ogni tanto la domestica viene ad arieggiare e spolverare questa bella casa”, mi giustifico.
Io che colpa ne ho, se la villetta è vuota da secoli? Ci penso e mi avviluppo in una mantella di sensi di colpa.
Guardo il prete e ancora una volta gli propongo la vecchia sedia.
“Ho ancora molte case da visitare, abbia pazienza”.
Il viso gentile di una giovinezza mai vissuta mi suggeriva un’età: trentacinque o poco più. Eravamo coetanei. Eppure non guardava bene negli occhi mentre comunicava col destinatario d’una benedizione con il più glaciale Lei. Aveva paura di sporcarsi, mi venne subito in mente.
“Le sedie sono pulite. Mariangela la domestica viene almeno una volta alla settimana.”
“Lei ha fede, dica”, dice ora con un tono da predica comprensibilmente: ha paura di sporcarsi anche moralmente, quest’uomo.
“È venuto da solo?”, devio.
“Gian Andrea il chierichetto è malato, purtroppo”.
Ora gli faccio una mascherata a questo coglione, non avrò pietà io, oh non più del suo Dio con gli ingiusti. Lo farò cacare sotto, o anche peggio di così. Vuol essere un martire? Eh vediamo. Questo pensavo nel mio sì… mio testone.
“Cominciamo dal salone, venga”, bisbigliai andando dritto per il corridoio e subito dentro.
Pensai che se non fosse passata Mariangela in una settimana avrei ridotto il salone muffito a una vera latrina; non mi sarei contentato di pisciare in bottiglia – come d’abitudine quel mio personaggio – e avrei urinato come un cane lungo i muri, e cacato proprio come i cani a una spanna dal pavimento. Poi accesi la luce, con la luce vennero i ricordi: dal mio ritorno non si erano ripresentati con quella violenza. Canzoni suonate dal giradischi a alto altissimo volume, i giochi da tavolo spianati al pavimento e papà a giocare pazientemente con noi, il vento che entrava direttamente dalla campagna riarsa, l’odore di letame dai campi dei nostri vicini e ancora fotogrammi schegge impazzite e cocci di storia. Tutto ciò s’era interrotto molto presto, eppure aveva lasciato le tracce più sanguinose – e io su tutto avrei cacato spruzzato la mia rabbia fisiologica. Ma mi accontentai di guardare la lampadina nuda, la sedia al centro e i due metri più in alto la corda: guardai al palcoscenico rinunciando ad ogni altro gioco (che avrebbe prima o dopo mostrato la corda). La tonaca la sentivo alle mie spalle, spargeva un piccolo odore di pulito.
Ero un uomo solo nel testo. Non avevo più fratelli: uno viveva in un altro stato e dopotutto l’altro, il maggiore aveva progetti più importanti di me, sull’orlo di un nuovo matrimonio che festeggeranno a fine primavera – mi rimaneva poco altro che non fosse il mio testone.
Mi divertiva l’idea d’essere un personaggio in un testo; ogni gesto avrebbe dovuto essere potente in modo da convincere profondamente il lettore mio Dio, arrecargli sollievo dal grigiore dell’infinito a costo ovviamente di atroci reali sofferenze; e con questo spirito presi posizione. E.
E il prete che aveva la sua fede ma non sapeva – assolutamente – di trovarsi nelle maglie di questo testo; quel giovanotto insicuro e distante cominciò a strillare a vuoto.
“Dio misericordioso, cosa sta facendo! Sono venuto a benedire la casa! Per la santa Pasqua!”. Come se volesse chiamare disperatamente aiuto sì, ma rivolgendosi a chi, a chi – pensavo. E stringevo il nodo alla nuca, sguardo fisso su di lui.
Dopo la prima ondata, tentò di forzare a cigolii e clangori la vecchia porta. Poverino. Chi sa cosa provava in quegli sbalzi. Io non ebbi un brivido di pietà.
“Se non mi ascolta mi lascio molleggiare all’ingiù. Vede, ho bisogno di parlare”.
Il colletto dell’abito faceva da diga a tutto quel sudare; ma rimase in un modo o nell’altro rivolto verso di me. Gli occhi aperti forse non guardavano.
“Stia zitto, bravo. Lei non immagina nemmeno in quale situazione si trova”.
Pallido.
“Lei pensa di esser nelle mani di Dio. Vero? Eppure qui decido io ogni virgola”.
Sospiri.
“Vede, lei crede in quel Dio ma, in un testo come questo, non c’è nessuna inopinabile misericordia, qui si rende conto solamente al nostro lettore, Dio nient’affatto misericordioso, non riesco a spiegarmi meglio in una congestione simile!”
“Cosa dice: Dio ci guarda”.
“Non è il Dio in cui lei ha fede. Capisce?”
“Lei è matto, deve farsi curare”.
“Esistono personaggi che si scrivono il destino, e guardi me per esempio; e personaggi completamente in preda a testi altrui”.
Guardava me invece come il Diavolo. Credeva davvero di essere se stesso, una persona vera.
Io ero entrato perfettamente nel temibile personaggio, mi muovevo sopra una sedia esattamente in quel modo e, guarda caso, proiettavo sul muro e parte del soffitto l’ombra. La lampadina nuda alle mie spalle mi sbalzava nero sulla muraglia. Hai visto, disse, o meglio: l’hai visto… È alla mercé del testo. Hai seguito il consiglio del tuo… geniale testone, hai fatto come t’ho ordinato. Io che scrivo questa virgola, qui nel testo luminoso e bianco, io sono il tuo testone. Sono la parte più intelligente del tuo corpo. Non potrai darmi torto, sicuro, o non mi chiamo Daniele Muriano. Io sono l’enorme testo che ti comprende, l’intelligenza che ti è stata riconosciuta, la memoria e la forma dei tuoi ricordi, la follia.
“Senti quel che dice? E riesci a capire in che situazione ci troviamo? Capisci che scherzo?”
Mi rivolgeva una preghiera recondita col tip tap delle gambette. Le travi al soffitto erano sempre più nere. Il puzzo della muffa agli angoli delle pareti era una forma vivente. Gli occhi di tutto il pianeta erano idealmente alle pareti di questa bestemmia dall’aspetto di salone.
“Dio ingiusto e lordo, Dio ingiusto e lordo”, disse il prete.
Lo guardai con le convessità degli occhi sprizzate (come palle di biliardo colpite da un punto imprecisato della testa o del testone) fuori di me o di lui, mentre mi lasciavo tirare dalla sempre uguale a se stessa forza di gravità.
Mi considerai, pochi attimi prima della fine del testo, in quel merdoso scenario.
“Con le tue parole hai fatto strage della verità”, disse il personaggio del prete. E c’era un vaso vuoto e smerigliato all’angolo a destra dell’ingresso. C’era un fazzoletto per terra, appallottolato e come appena sbocciato su un campo grigio pietra. E c’era in questa trasfigurazione un cane di umidità alla parete opposta, la forma era esatta e dai bordi, fra poco, avrebbe potuto staccarsi un cane d’intonaco e pietrame pronto a saltare nella stanza. C’era l’ombra del testone penzolante e morto. C’era infine il quadernetto in un angolo del salone che oscillava insieme all’ombra della stanza. Come oscillavo io, nelle ultime valutazioni sul misfatto. Avevo, sì, montato bene la scenografia all’alba subito dopo essermi affacciato alla finestra. L’avevo ben chiusa. Giro degli scuri. La sedia. Doveva stare là dov’è stata scalciata or ora. E montato il patibolo: il cappio di là dalla trave. Ma perché. Perché si arriva perfino a mimare nella realtà quel che s’inventa… Perché si deve piegare la propria vita all’esigenza dell’invenzione? Ho voluto stupidamente fare nella mia vita ciò che un personaggio ha vissuto immaginalmente e adesso sono qui a spenzolarmi nel salone. Ero una persona e mi sono immaginato d’essere un personaggio scritto. È la fine che mi merito.
Mi sorprendo a rileggere questo testo, mentre è tutta la mattina che mi muovo per casa in preda all’immaginazione e cerco una fine a questo miserabile personaggio. Si ostina a voler sopravviversi ma della sua fine toccherà sentenziare al giudice ultimo, che è rimasto ad ascoltare fino quest’ultima mia parola.

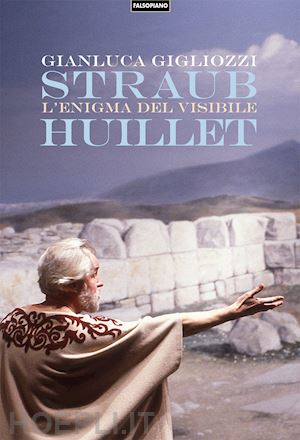 di Gianluca Gigliozzi
di Gianluca Gigliozzi

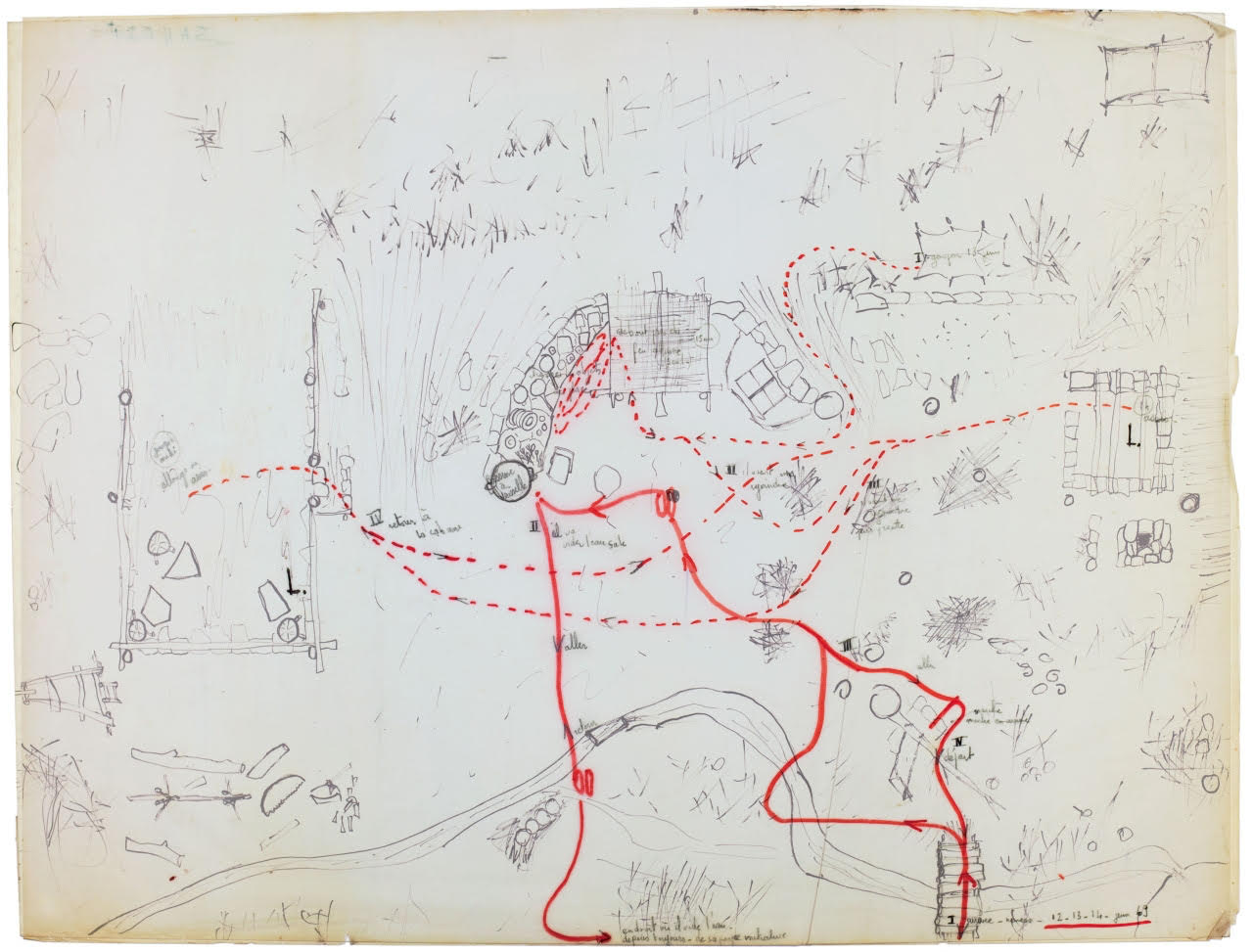

 Prende un piatto dalla credenza, lo scalda sul fuoco.
Prende un piatto dalla credenza, lo scalda sul fuoco.