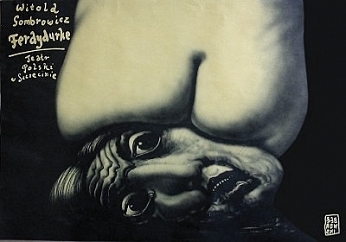Nota
Nota
di
Salvatore D’Angelo
su:
Felice Piemontese (Il lavoro rende liberi – Stampa Alternativa collana Eretica, 2018 pagg.147 € 14,00)
e
Renzo Paris (Bambole e schiavi – Elliot collana Scatti, 2018 pagg.185 € 18,50)
Raramente capita di leggere in successione due romanzi diversissimi per stile, impostazione e formazione degli autori, eppure simili per sottotesti.
È quanto mi è accaduto con Piemontese e Paris, autori rispettivamente di Il lavoro rende liberi e Bambole e schiavi.
Lo dico subito, due romanzi che catturano e si fanno leggere con interesse. Riporto qui le mie suggestioni, senza nulla dire delle trame per rispetto di chi volesse leggerli.
Stile e struttura de Il lavoro rende liberi sono quelli dell’ informe (relazione): otto capitoli, ciascuno dei quali intessuti di sequenze verbovisuali da discorso libero indiretto, ma in prima persona, che scorre asciutto e senza intoppi ad opera del protagonista, Stefano Rinaldi, cinquantino professore di letteratura alla Sorbona, esperto di Guy Debord, l’autore de La società dello spettacolo, teorico e fondatore dell’Internazionale Situazionista.
Rinaldi, inquieto, precario professore di origini pugliesi trapiantato a Napoli e poi trasferitosi in Francia, vive con disincanto i turbolenti avvenimenti politici parigini, in una sorta di esilio per disadattamento dalla realtà napoletana, avendoci comunque lasciato gli anni migliori della sua vita e alla quale ritorna per subito rifuggirne, dopo un viaggio-confronto con la realtà di parigino d’adozione, a pro di una narrazione che si sviluppa in un futuro quasi presente – siamo infatti nel 2022, nel periodo in cui si stanno svolgendo i due turni delle elezioni presidenziali francesi.
La referenza narrativa è l’apologo politico; contesto, trama e riferimento finzionale sono quelli di Soumission (Sottomissione) di Michel Houellebecq.
Piemontese, da seguace di Guy Debord, teorico del citazionismo dell’arte/nell’arte, ne utilizza ampiamente contesti, trama, personaggio e situazioni per ribaltarne però esiti e punto di vista, mutatis mutandis, in piena coerenza con quanto da lui prodotto come scrittore: penso a Epidemia (1989) romanzo con cui rileggeva/riscriveva La Peste di Albert Camus, riallocandolo a Napoli e nel micromondo radiotelevisivo napoletano dell’O.R.T.I. (Organizzazione Radio Televisione Italiana). Ma penso anche alle prove poetiche di La città di Ys e Il migliore dei mondi.
Il François protagonista di Soumission è anch’egli un (quasi) cinquantino docente universitario, appassionato fino all’ossessione di J.K. Huysmans (1848-1907), autore di Á Rebours, A ritroso (1884), romanzo epocale sulla crisi del vecchio, inerte mondo borghese, paralizzato sulle soglie del Novecento e della definitiva nevrotica industrializzazione; romanzo di un personaggio, Jean Desseintes che osserva controcorrente, a ritroso il flusso di un mondo in cui non si riconosce, ma da cui, in definitiva, non riesce ad isolarsi, accettandone la deriva. Giusto quello che accade – mutatis mutandis– anche al François di Soumission e a Stefano Rinaldi, il personaggio del romanzo di Piemontese, ossessionato non da J.K. Huysmans, ma da Guy Debord (1931-1994), artista, pensatore e filosofo postmarxista, controcorrente autore dell’altrettanto epocale saggio de La società dello spettacolo (1967), sorta di must sessantottesco contro la società del danaro e dello spettacolo, cartina di tornasole della crisi del mondo post-industriale e dell’Occidente, i cui tratti sono nella spettacolarizzazione parossistica di ogni piega della vita quotidiana, sia nel micro che nel macro sociale. Toh, proprio l’epoca che c’investe in pieno, al tempo di facebook, di twitter, della società liquida e dei non luoghi. Un quadro di fondo, umano e sociale, che ritroviamo pari pari sia nel romanzo di Piemontese che in quello di Paris.
A leggere tra le pieghe del romanzo di Houellebecq e di Piemontese, referenze e sottili legami teorici non stanno solo nel riferimento letterario dei due protagonisti (Huysmans, Debord) ma anche in molto altro, che lascio individuare alla curiosità degli appassionati e/o dei potenziali lettori.
Direte, e Paris? E il suo romanzo, Bambole e schiavi? Che c’entra con Piemontese, esponente dell’avanguardia, seguace di Debord e delle sue rivoluzionarie teorie, sull’uso e riuso dell’arte in senso citazionista e in direzione ostinata e contraria alla classicità e alla tradizione, dal momento che Renzo Paris non è stato di sicuro un appassionato dell’avanguardia e del Gruppo 63?
C’entra, c’entra. Anche se l’apparenza di Bambole e schiavi direbbe di no.
Qui abbiamo tutt’altra trama, struttura e stile rispetto al romanzo di Piemontese. Trenta capitoli con intestazione illustrativa del contenuto, alla maniera del grande romanzo francese ed europeo del settecento; trenta capitoli serrati che contengono due romanzi e due narratori, giustapposti e/o intrecciati in maniera dialettica. 
I personaggi principali sono Francesco Cosini (cognomen omen, come vedremo), attempato scrittore in visita alla casa di Freud a Vienna, nel cui aeroporto incontra Dana, ventenne e bella ragazza di un villaggio dei Carpazi rumeni, in fuga da Berlino e da un misterioso delitto che avrebbe commesso e diretta a Roma. Ingredienti adatti a sviluppare una trama in cui vengono ibridati generi e stili, in ispecie il noir e il romanzo dell’eroina settecentesca alla Moll Flanders, ma anche il romanzo psicologico del Novecento europeo ed italiano via Joyce, Svevo e Moravia, con tocchi di classicità internazionale alla Philip Roth e Yasunari Kawabata (1899 -1972), giapponese autore de La casa delle belle addormentate (1962) pubblicato in Italia nel 1972 , premio Nobel per la letteratura nel 1968 ( appuntatevi l’anno), romanzo da cui Paris attinge, riportando lunghe citazioni che fanno da motivo conduttore dialettico e tematico in Bambole e schiavi .
Infatti siamo, col romanzo di Paris, alla dura e disincantata analisi di un tema ricorrente in letteratura: la vecchiaia, il decadimento, il desiderio senza desiderio.
Le epigrafi d’apertura, dànno subito la chiave al potenziale lettore:
Lasso! Che bramo ancor, che più voglio
Se nulla cosa da voler mi resta
E son, senza disio, pien di disio?
(Ludovico Ariosto)
La donna a me non piaceva intera…ma a pezzi
(Italo Svevo)
Non ci si mette l’animo in pace, mai
Per vecchio che uno sia.
(Philip Roth)
Il suo personaggio, l’attempato Francesco Cosini – scrittore, tre mogli e svariate amanti, alle prese con la giovane Elsina, che lo irretisce in una relazione estenuata, fatta di cupo, triste sesso sado-maso – ha lo stesso cognome di Zeno Cosini, il personaggio de La coscienza di Zeno, per non dire di Svevo come autore di Senilità. Francesco è ossessionato dal sesso: “Il sesso è la mia tragedia. Bambole e schiavi!” riferisce in un grido. E’ lui che narra in prima persona ed è lui che ci riporta le citazioni tratte da La casa delle belle addormentate di Kawabata, l’altro punto di riferimento letterario.
Paris ha già trattato il tema della vecchiaia, il tema dell’esser “senza disio, pien di disio” ne Il mattino di domani, volume di poesie uscito appena nel giugno del 2017, che ha preceduto di poco Bambole e schiavi; libri legati da uno stretto rapporto di filiazione, in quanto a temi. Nel primo c’è il riflettere del settantino Paris in quanto tale, attraverso la voce poetica, sulla vita personale nel corso della senilità, nel momento in cui la vive: ne vien fuori un ritratto in chiaro, organizzato strutturalmente nel ciclo delle stagioni, ma temi quadro di fondo e alcuni personaggi del reale sono, a ben vedere, gli stessi di quelli fittizi di Bambole e schiavi: una Roma decadente e decaduta, le strade frequentate dai colorati fantasmi delle etnie, la stazione Termini come una riva, sorta di Gange in cui si bagnano e/o approdano gruppi umani in cerca di salvezza, in fuga da mondi di fame, miseria e dannazione, fantasmi ai margini di un banchetto pullulante di accidiosi, sazi, disperati, assediati internamente da ben altre paure e fantasmi, in preda allo sradicamento, all’informe blob del presente fatto di luci e merci ormai asfittici. Su questo sfondo, che è anche europeo, si muovono, in flashes raccapriccianti, le ombre terribili e inquietanti dei terroristi islamisti, nuovi barbari le cui azioni e linguaggi violenti appaiono sempre più insensati, paralizzanti. En passant, questo è il medesimo sfondo che ritrovate ne Il lavoro rende liberi di Piemontese.
Nel quadro ritroviamo Dana la Moldava, “…silenziosa, / anoressica, non guarda mai negli occhi/le persone, si difende/dai giovanotti/ russi che vorrebbero condurla/ a battere in via Palmiro Togliatti./ E’ di religione ortodossa. Vive/ con dieci euro a settimana bevendo latte. /Ti ho rivista con il tuo giubbetto bianco/ dietro i finestrini di un autobus. / Ho rincorso inutilmente il tuo sorriso/ ironico, meravigliata delle mie attenzioni. / E io sono ancora qui a ricordare/ quel tuo improvviso ridere brutale”(Il mattino di domani, pag.47).
Ecco un fantasma del reale che in Bambole e schiavi diviene la giovane co-protagonista e co-narratrice. Ecco, nelle terzine, il nucleo di uno dei due romanzi che formano il romanzo unitario di Bambole e schiavi, ecco il romanzo di Dana la Moldava, narrato in prima persona grazie a Francesco che ne registra, a pagamento, la storia e che noi possiamo leggere in presa diretta.
Dicevo del desiderio senza desiderio, della senilità e dell’ombra della morte. “(…) Il desiderio/ si accontenta di guardare la vita/ degli altri, nelle mie passeggiate/affollate di ricordi spuntano/guance arrossate, occhi complici, /svogliati. E quando la luce/ridiventa chiara, autunnale, / il desiderio grida tutto il suo dolore. / (Il mattino di domani pag. 88)
“(…) Non mi piace/marcire in una nicchia per trent’anni/sfamando gli insetti voraci. Mi chiedo/ come ho fatto a credere nella vita, /perché ho amato la consolazione/della scrittura. Il corpo detta legge, /vuole essere nutrito, protetto, vuole fare/l’amore finché dura. Anche lo spirito/non dura. Fuggo come posso la pira/che giunge. Ricorda che anch’io non sono più chi ero. O luce della vita, /lascia che abbiano fine le mie canzoni. / (Il mattino di domani pag. 107)
Tutto ciò confluisce in Bambole e schiavi, ma trasfuso in un ritratto in nero, per una struttura fatta di due romanzi, due protagonisti, due voci e due punti di vista. Lo sdoppiamento reiterato serve da filtro, come a mettere distanza tra l’autore e una materia e dei personaggi duri, orribili nel loro disfacimento e negatività. Ma è anche un procedimento per osservare, a contrappunto, i lati in ombra della vecchiaia, del decadimento del corpo e della vita, attraverso personaggi quali l’Architetto e l’avvocato Surace, con quest’ultimo che richiama il pittore Balestrieri, de La noia, uno dei romanzi più noti di Alberto Moravia, ma un Balestrieri decrepito, impotente e tuttavia psicologicamente vorace; entrambi condividono lo stesso destino finale per mano, pardon, per il corpo, è il caso di dire, di Cecilia ne La noia e di Dana in Bambole e schiavi.
E Kawabata, che c’entra Kawabata?
C’entra e come. Eguchi Yoshio, il protagonista di La casa delle belle addormentate è un sessantasettenne che si reca in una casa di piacere frequentata da vecchi senza più desiderio che pagano per coricarsi con giovanissime donne, senza tuttavia avere rapporti completi con loro. Dunque lo stesso tema della vecchiezza e della decadenza, del desiderio senza pulsione fisica; Kawabata, inoltre, è un raffinato scrittore che ha scandagliato in profondità le regioni della coscienza in cui si incontrano sesso e pulsione di morte, gioventù e vecchiaia, leggerezza e decadenza, vita e morte. Paris nel suo romanzo lo utilizza come termine di paragone alto, rispetto alla materia terribilmente negativa che sta rappresentando.
 E Piemontese? E il suo Stefano Rinaldi de Il lavoro rende liberi? Che c’entrano con questi temi?
E Piemontese? E il suo Stefano Rinaldi de Il lavoro rende liberi? Che c’entrano con questi temi?
Anche qui, a leggere bene tra le righe della diversità di stili, generi e temi, c’è la sottile linea rossa della decadenza e della vecchiaia.
Nel romanzo di Piemontese autore e personaggio, sul tema, sono in rapporto dialettico, s’interrogano e si scandagliano l’uno attraverso l’altro. Ricorre spesso, nel flusso di coscienza del personaggio di Piemontese, il tema della solitudine, della vecchiaia e del decadimento, dall’inizio alla fine, in un crescendo che non è casuale ed è emblematico del significante ipertestuale, come si direbbe in termini specialistici.
“Tutto sta per finire, pensavo, presto ci sarebbero stati i primi segnali di marasma o di demenza, il venir meno delle funzioni vitali, insomma quello che il mio amico Spinelli definiva sprofondamento” considera Rinaldi, nel finale, in uno dei suoi abituali flussi di pensieri. E va qui detto che Spinelli, caro amico cumano che Rinaldi rivede nel breve viaggio di ritorno a Napoli, si suicida lasciandogli una lettera da cui emerge la disperazione e la solitudine, la caduta delle illusioni e il senso ineluttabile della fine.
Ripeto, quello che più colpisce, nei romanzi di Piemontese e Paris, al di là della psicologia dei protagonisti, entrambi vili, inetti, sostanzialmente conformisti, è un sentimento pervasivo di un mondo confuso, in disfacimento, un diffuso senso di vampirismo autistico e di caduta che tocca in profondità il tessuto sociale, la sua coesione.
A ben vedere, poi, sia Piemontese (1942) che Paris (1944), due settantini, imbevuti di Sessantotto da sponde letterarie diverse, sono accomunati dall’amore per la Francia, la sua cultura e letteratura (Corbière, Mallarmé, Apollinaire, Breton, Debord, l’école du regard e il romanzo sperimentale); l’uno ha eletto Parigi a sua seconda patria, risiedendovi per lunghi tratti dell’anno, l’altro per anni docente di letteratura francese all’Università di Salerno prima e di Viterbo poi.
Il 1968, inoltre, è l’anno in cui Yasunari Kawabata, riceve, primo giapponese, il premio Nobel per la letteratura. Anno fatidico per i due romanzieri di cui tratto. Il primo, sull’onda e nell’humus di quel periodo, buttandosi a capofitto nelle prove di romanzo sperimentale e dei saggi di rottura rispetto alla tradizione letteraria, il secondo, cantore del fallimento degli ideali di quell’epoca con Cani sciolti, diventato un classico. Insomma, tutto si tiene.
Ma qual è, nelle mie suggestioni di lettura, il significante ipertestuale che accomuna il romanzo di Piemontese e quello di Paris?
È l’affresco di un mondo in crisi, la decadenza inarrestabile di una civiltà (quella occidentale) che ha perso la spinta propulsiva. La vecchiaia dei personaggi, vissuta o paventata, come metafora della vecchiaia di un mondo, di un sistema ormai senza grandi coordinate, i cui valori sono come svuotati, un mondo che si trascina vampirizzando coloro che vi affluiscono, quelli che sono comunque esclusi e mai ammessi alla mensa del ricco epulone (il capitalismo), come si inferisce attraverso Dana, la co-protagonista di Bambole e schiavi e come si legge in trasparenza nel suicidio di Spinelli e nel conformistico accomodamento di Rinaldi, il protagonista di Il lavoro rende liberi.
A ben vedere, pur da sponde di stile e formazione diverse, Piemontese e Paris, sembrano suggerirmi un affresco in nero di un mondo confuso, aggrappato alle sue evanescenti certezze, roso dal cinismo, pronto a vampirizzare, divorare, masticare e sputare via popoli e persone in fuga dalla desertificazione: gli uni da quella geoeconomica, gli altri, abitanti della vecchia Europa/Occidente, da quella interiore.
Sicché le convulsioni, la confusione politica e morale, la violenza parigina e francese dell’apologo di Piemontese, con gli esiti ribaltati rispetto a quello di Soumission di Houellebecq, il vile scivolamento del protagonista verso l’ineluttabile sottomissione ai nuovi vampiri del potere; lo sprofondamento dei Surace e dell’architetto, dello stesso Francesco assoggettato al gioco perverso di Elsina di Bambole e schiavi, emblemi di relazioni umane e sessuali segnate dalla violenza del potere, per quanto psicologico o economico e personale, e dalla sopraffazione, altro non sono che emblemi della vecchiezza di un mondo al capolinea, o quanto meno a un capolinea epocale, sullo sfondo del crollo delle grandi narrazioni ideologiche.
Il Rinaldi de Il lavoro rende liberi, aggirantesi col suo carrello per il centro commerciale (non luogo per antonomasia), contento di quel piccolo piacere di fronte alla gravità del disastro, che cinicamente/ciecamente riflette “ma mi piaceva l’idea che forse, col passar del tempo, avrei avuto almeno qualcosa da rimpiangere”, mentre la voce autoriale, qui e là nel romanzo, mimeticamente commenta, ora attraverso una quartina di Franco Cavallo, lasciata nello scritto del personaggio Spinelli – non c’è dunque un futuro,/non c’è rimasto più niente,/ solo un brusio che si spegne,/solo qualcuno che si pente- ora attraverso il flusso dei pensieri dell’ormai anestetizzato professore Rinaldi “Forse, come aveva detto qualcuno, Shakespeare credo, se il mondo significa qualcosa, è che non significa niente, tranne che esiste. E si tratta di farlo continuare ad esistere”.
C’è poco spazio per l’ottimismo consolatorio, com’è giusto. Forse solo Dana e la sua amica, quintessenze dell’ingenuità, le cui violenze e corruzioni umane subite, la cui estraneità a una qualsiasi forma di consapevolezza intellettualistica di sé che non sia la pura vitalità di sopravvivere sempre e comunque al male, pur di tornare al proprio villaggio, in fuga dagli orrori del mondo ricco, dopo essere state in fuga da quelli del mondo povero, lasciano spazio a un barlume di speranza nel futuro.
Forse nel ribaltamento dell’esito dell’apologo di Soumission operato da Piemontese in Il lavoro rende liberi, proposto all’intelligenza del lettore, perché consideri con lucida amarezza “gli eterni ritorni” del “fascismo strutturale” insito nelle forme del potere, sta quel minimo di luce, Dal limite estremo e Sotto gli occhi dell’Occidente, postindustriale e finanziarizzato, cento e più anni dopo i romanzi di Conrad, l’altro grande apolide della letteratura decadente tra Otto e Novecento.
E Huysmans di Á rebours, l’ossessione dell’intellettuale François di Soumission? Che c’entrano? Á rebours, a ben vedere, è il romanzo chiave della letteratura francese di fine ottocento: segna il vero e proprio inizio del decadentismo, la linea di confine con il romanzo naturalista e l’apertura al Novecento letterario.
Ecco, Huysmans, Joyce, Svevo, Conrad, Kawabata, Moravia, Roth, Debord, Paris, Piemontese, autori diversi tra loro, eppure, fatte le debite proporzioni e detto delle differenze di scuola e di stili, mi sembrano tutti uniti dalla sottile linea rossa della letteratura di tipo decadente o neodecadente, chi per vie classiche, chi per vie sperimentali. Tutto si tiene, alla fine.
Potenza e forza della letteratura. Pardon, potenza e forza delle sue suggestioni.
 di Frédéric Montferrand
di Frédéric Montferrand


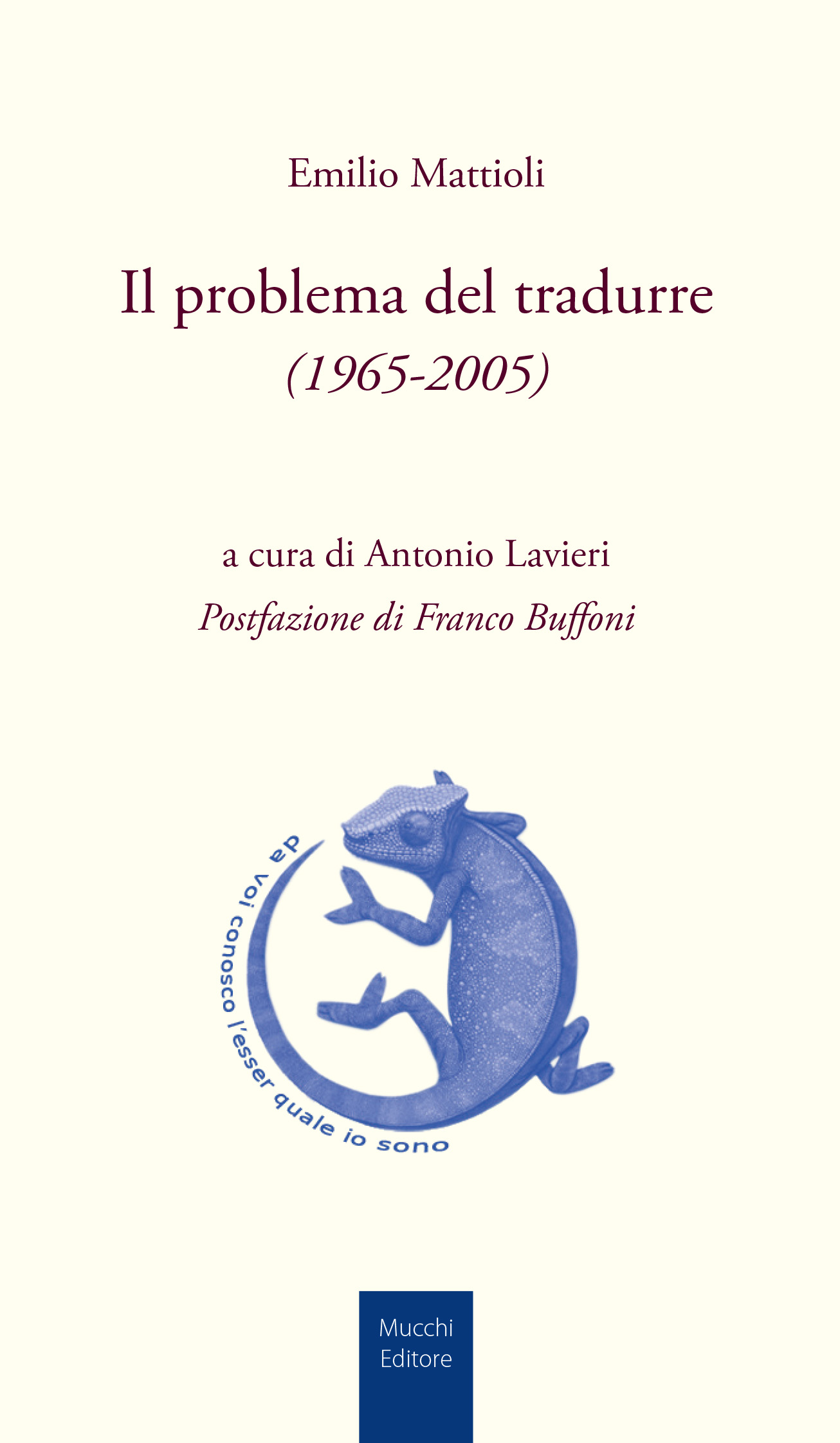

 Nota
Nota
 E Piemontese? E il suo Stefano Rinaldi de Il lavoro rende liberi? Che c’entrano con questi temi?
E Piemontese? E il suo Stefano Rinaldi de Il lavoro rende liberi? Che c’entrano con questi temi?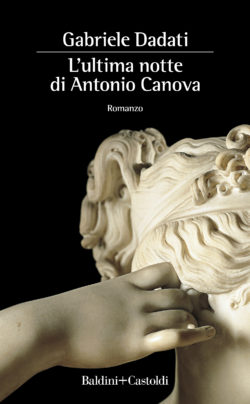 di Edoardo Zambelli
di Edoardo Zambelli
 Il 1816 passò alla storia come “l’anno senza estate”. Infatti gravi anomalie del clima – provocate da un insieme di concause quali imponenti eruzioni vulcaniche che immisero nell’atmosfera, di fatto raffreddandola, ingenti quantità di cenere, fenomeni astronomici come il “minimo di Dalton” (un periodo di bassa attività solare) e la “piccola era glaciale” che dalla metà del XIV alla metà del XIX secolo produsse un brusco abbassamento della temperatura media terrestre – determinarono in Europa del Nord, ma anche in Canada e Stati Uniti d’America, grandi tempeste di neve, piogge torrenziali e inondazioni che si protrassero fino ai mesi estivi, distruggendo i raccolti e determinando carestie e incremento dei prezzi.
Il 1816 passò alla storia come “l’anno senza estate”. Infatti gravi anomalie del clima – provocate da un insieme di concause quali imponenti eruzioni vulcaniche che immisero nell’atmosfera, di fatto raffreddandola, ingenti quantità di cenere, fenomeni astronomici come il “minimo di Dalton” (un periodo di bassa attività solare) e la “piccola era glaciale” che dalla metà del XIV alla metà del XIX secolo produsse un brusco abbassamento della temperatura media terrestre – determinarono in Europa del Nord, ma anche in Canada e Stati Uniti d’America, grandi tempeste di neve, piogge torrenziali e inondazioni che si protrassero fino ai mesi estivi, distruggendo i raccolti e determinando carestie e incremento dei prezzi.
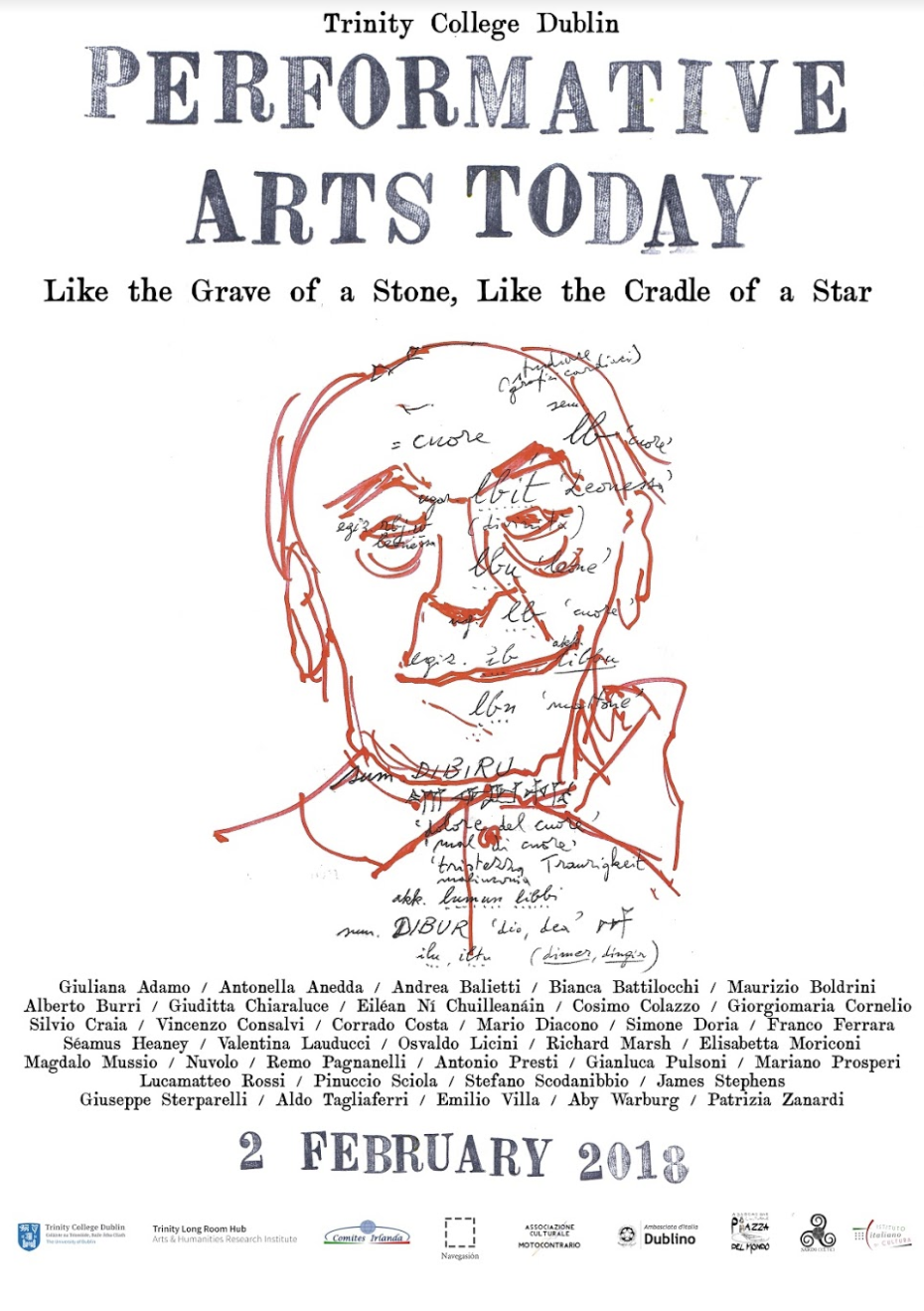



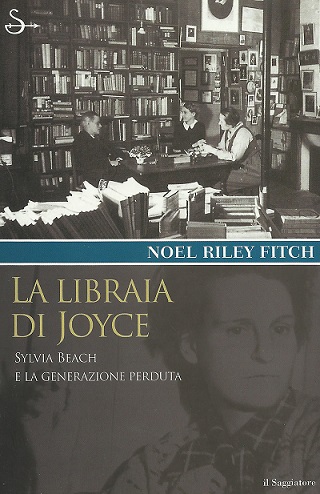 di Romano A. Fiocchi
di Romano A. Fiocchi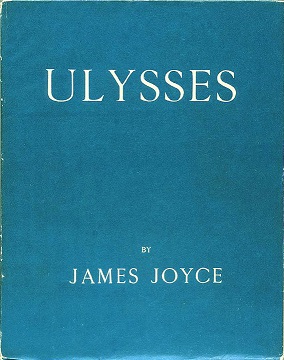 Dalla storia della pubblicazione dell’Ulisse emergono due immagini contrastanti dei protagonisti: la tenacia e la generosità di Sylvia Bech e la fragilità di un Joyce pieno di ossessioni e spesso dedito all’alcol, squattrinato ma sempre pronto a vivere oltre le sue possibilità a scapito di amici e conoscenti, arrivando al punto di sfruttare le risorse economiche della stessa Sylvia e di “tradirla”, dopo undici edizioni, cedendo i diritti ad un importante editore americano.
Dalla storia della pubblicazione dell’Ulisse emergono due immagini contrastanti dei protagonisti: la tenacia e la generosità di Sylvia Bech e la fragilità di un Joyce pieno di ossessioni e spesso dedito all’alcol, squattrinato ma sempre pronto a vivere oltre le sue possibilità a scapito di amici e conoscenti, arrivando al punto di sfruttare le risorse economiche della stessa Sylvia e di “tradirla”, dopo undici edizioni, cedendo i diritti ad un importante editore americano.

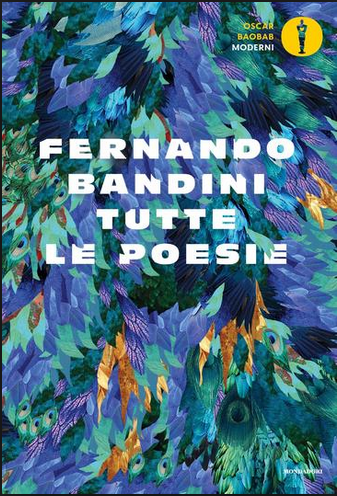 Nota
Nota
 di Matteo Pelliti
di Matteo Pelliti