di Matteo Cavalleri

Italo Calvino – introducendo, nel 1978, l’edizione italiana di Rizzoli dell’Anabasi di Senofonte – rintraccia una problematica prossimità, sia contenutistica sia formale, tra l’opera greca e la memorialistica italiana sulla ritirata di Russia:
Questa lotta per il ritorno d’un esercito condotto alla sconfitta in una guerra non sua e abbandonato a se stesso, questo combattere ormai solo per aprirsi una via di scampo contro ex-alleati ed ex-nemici, tutto questo avvicina l’Anabasi a un filone di nostre letture recenti: i libri di memorie sulla ritirata di Russia degli alpini italiani. Non è una scoperta di oggi: nel 1953 Elio Vittorini, presentando quello che doveva restare nel genere un libro esemplare, Il sergente nella neve di Mario Rigoni Stern, lo definiva «piccola anabasi dialettale»[1].
La problematicità di un tale accostamento, segnalata dallo stesso Calvino, consiste nella sua manifesta caducità nei confronti di uno sguardo più sensibile a quelle che sono le declinazioni antropologiche che i due orizzonti testuali manifestano. Senofonte riesce infatti ad individuare con sicurezza, nel guerriero ellenico impegnato nel periglioso ritorno in patria, una capacità militare-stilistica che permette al soggetto di convivere con l’esperienza di derelizione che la situazione gli impone: «l’uomo può ridursi a cavalletta e pure applicare a questa sua condizione di cavalletta un codice di disciplina e di decoro – in una parola: uno “stile” –, e dirsene soddisfatto; non discutere né tanto né poco il fatto d’essere cavalletta ma solo il miglior modo d’esserlo».[2] I mercenari greci «in qualche modo portano con sé la patria»[3], individuano nella meta del loro stentato peregrinare l’orizzonte assiologico – quello rappresentato dall’«esercizio delle virtù classiche, filosofico-civico-militari»[4] – nel quale riconoscersi e rispetto al quale intenzionare la propria azione. È grazie alla fiducia nella riserva di senso incarnata dall’idea stessa di patria che i guerrieri ellenici riescono a preservare la propria impronta umana in una situazione che costantemente li spinge, tramite la seduzione della violenza, verso il baratro del non-umano.
Le pagine vergate dagli alpini italiani prendono invece le mosse dal sempre più acuto contrasto tra «una Italia umile e sensata» e «le follie e il massacro della guerra totale»[5]. La compossibilità tra ritirata di Russia e anabasi si interrompe proprio dove il rigore glaciale e mortifero della steppa russa recide il rapporto con il termine ad quem, recide il rapporto con la patria a cui ritornare. L’«Italia umile» non è più la stessa, non appartiene più, non si riconosce più nell’Italia da cui è partita. L’anabasi, l’accordo tra gettatezza e tensione etica in vista del rientro in Italia, non è possibile proprio perché manca il terzo oggettivo a cui far riferimento. La ritirata di Russia non è un ritorno in patria, ma è la genesi preistorica di un nuovo inizio, di un viaggio verso una patria a venire.
L’alpino italiano nella tragedia di Russia appercepisce – ovvero “riflette” su di un piano di consapevolezza una percezione che fa del dolore fisico la sua marca dirimente – la vacuità del regime fascista, della sua patria. Nuto Revelli rintraccia in questa vivida appercezione del fascismo come epopea nichilista, estenuatasi nell’invasione russa, la matrice, la genesi a venire della sua scelta partigiana. È la necessità esperita nella tragedia bellica del fronte orientale il luogo in cui il futuro partigiano trova i germi, i pertugi, per la propria scelta, in cui riscopre il gesto della libertà. È una scelta che si incide su di un piano di chiarezza, ma di intrinseca difficoltà[6]:
Senza la Russia, all’8 settembre, mi sarei forse nascosto come un cane malato. Se nella notte del 25 luglio mi fossi fatto picchiare, oggi forse sarei dall’altra parte. Mi spaventano quelli che dicono di avere sempre capito tutto, che continuano a capire tutto. Capire l’8 settembre non era facile![7].
L’accadere di una tale scelta, il suo segnarsi nella coscienza individuale come una frattura originante, permette un recupero del concetto di anabasi come euristica positiva atta alla delineazione della nuova erranza che la Resistenza inaugura. La scelta infatti rinviene nella contingenza necessitante delle determinazioni storiche un registro valoriale, di giustizia, che le trascende, che assume la necessità al livello della decisione. Si riafferma, nella sua iniziale balbuzie, un orizzonte assiologico verso il quale andare-ritornare. È un andare non verso un luogo fisico, geografico, ma, nella piena fisicità della traslazione, verso un’idea che con grande difficoltà tratteggia il proprio profilo. Il partigiano, come dichiara il giornale clandestino L’Uomo, risale ad un nuovo inizio a partire dal ritorno alla propria matrice umana, a quel quanto che la fascistizzazione non è riuscita ad intaccare:
Il nome stesso di questo giornale, oggi o dimani potrà apparire astratto o superbo; ma quando cominciò a circolare nascosto, il suo nome significava fare appello, perduto tutto, ad una indeclinabile sostanza. L’uomo doveva restare il principio e la fine di ogni discorso fra gli uomini e se lo stato unitario era caduto in rovina nel crepuscolo della storia degli stati nazionali d’Europa, se l’economia del paese non sopravviveva che per il servizio provvisorio degli invasori, se la terra stessa, battuta, spogliata, lacera, corsa, non era che un campo di battaglia di secondaria importanza (ma il nostro dolore era lui sì al centro del mondo), una moribonda spoglia offerta allo strazio di un esercizio cauto per gli uni, di un puntiglio caparbio per gli altri, se ogni intermezzo o sussidio di storia, di civiltà, di convivenza era smarrito, la qualità umana no, non poteva essere tolta di mezzo.
Qui risiede il senso dell’anabasi, la sua accezione antropologica. È, nel vuoto prodotto dal collasso delle istituzioni e della loro portata morale, un ritornare a se stessi, una fedeltà a se stessi e alla propria costitutiva eccedenza rispetto alla «nuda vita»[8]. È un ritorno che si scopre tale solamente facendosi.
La Resistenza inaugura infatti una traiettoria temporale che scompagina l’asse storico nella sua accezione di progresso lineare, inaugura un tempo intessuto da un sincopato susseguirsi di tracciati di provenienza e di movimento: è cristallizzarsi di «adesso»[9] che sono «già» e «non ancora», disposizione dialettica di un passato attuale che cairologicamente muove il tempo senza, tuttavia, avervi mai luogo[10].
Quale figura, quale traiettoria e storica e spaziale impone al movimento del soggetto il concetto di anabasi?
L’Anabasi di Senofonte prende le mosse dall’appercezione, da parte del soggetto, di situarsi in una topica di esclusione, di trovarsi fuori luogo e fuori legge; parimenti, l’8 settembre obbliga il cittadino italiano ad una similare esperienza di spaesamento, di smarrimento, alla negazione del proprio statuto di cittadinanza. Il soggetto resistente inizia l’anabasi a partire da un volontario mettersi fuori legge; il partigiano è infatti clandestino in un paese che non riconosce più e che non permette lui nessuna possibilità di riconoscimento sia normativo sia etico. Nell’eruzione dell’8 settembre, nel suo disordine, coglie la possibilità di un gesto di disobbedienza e di dubbio, non solo di terrore e dolore morale; coglie le potenzialità per un nuovo inizio.
L’evento Resistenza inaugura la propria procedura di verità[11] proprio a partire dalla messa in scacco di quel «dispositivo in grado di produrre un’identificazione senza residui tra la mente del singolo e i proclami del regime»[12]. La riattivazione di un pensiero in grado di far rapporto sulla realtà della situazione presente – in grado cioè di metterne in evidenza le condizioni di possibilità altre rispetto a quelle dell’ordine fascista – è ciò che permette al futuro partigiano di «rischiare di rischiare»[13] e di procedere nel proprio percorso di fedeltà a quell’evento che originariamente l’ha «colto e rotto»[14]. La Resistenza si presenta quindi come il perdurare in un processo che continuamente chiama alla conferma di una frattura nella coscienza individuale, che continuamente obbliga ad una scelta e al suo riconoscimento in un orizzonte politico, in una soggettività politica. La lotta partigiana, nella sua durezza, è dubbio germinativo in tensione dialettica con la propria cifra paralizzante, con l’esposizione alla sofferenza e alla morte inflitta e subita:
Il nemico stesso ci aveva educato alla morte, ci aveva consegnato, scarnito e solitario, il suo più cupo impulso. Egli era rimasto al di là, vestito da soldato, con i suoi gradi e i suoi distintivi. Scriveva assiduamente alla famiglia lontana, come potevamo accertarci catturando i suoi corrieri, conservava gelosamente nelle tasche della divisa, che frugavamo dopo la sua morte, tutt’una vita regolare di ossequio alla società, dov’era nato e cresciuto: certificati militari, promozioni, immagini o medaglie dei santi, forse le stesse che gli avevano dato la madre o la fidanzata perché lo proteggessero, era rimasto anche nella guerra al riparo dal dubbio, corretto e disciplinato, anche nelle rappresaglie, quando giungeva sul posto, sapendo già quante case doveva distruggere, quanti civili fucilare. Per ciò poteva uccidere con tanta facilità. L’odio che l’aveva portato fino a quel punto giaceva in lui come sommerso da un solido strato di indifferenza e di disprezzo: sembrava essersene liberato, dando a noi tutto il suo peso, attribuendoci quegli inumani lineamenti che erano in lui celati dalla maschera del soldato. La nostra peggiore condanna, tanto più avvertita quanto maggiore era la responsabilità del comando: espiare anche per lui, invidiargli, senza avere il coraggio di confessarlo, quelle stesse apparenze di uomo normale, ossia soggetto a una serie logica e continua di convenienza, che erano state distrutte in noi. Mai più uomini come gli altri, mai più capaci di godere la purezza di un affetto o la serenità del riposo[15].
Emerge qui un’ulteriore accezione della categoria di anabasi che informa il venire alla presenza del partigianato. Il soggetto resistente si trova infatti gettato nel proprio destino, ha deposto la maschera del soldato e volontariamente reciso tutti i nessi che lo rimandano alla vecchia società; si trova legato alla ruvidezza delle determinazioni necessitanti e, proprio in forza della riflessione su tale legatura[16], deve inventare il proprio risalire, deve diventare ciò che l’uomo è nella sua ultima essenza, deve rifondare il proprio stesso statuto d’esistenza:
si è questa guerra sviluppata subito e nella coscienza universale e nei fatti come decisiva non di un modo qualsiasi d’esistere ma dell’esistenza stessa di uomini singoli e di popoli e razze, della esistenza insomma dell’uomo nell’esercizio libero del suo pensiero e del suo lavoro, che è la sua vita. […] Questa, se mai altra, è la guerra onde può attendersi l’uomo, secondo l’antico detto, fabbro della propria fortuna, l’individuo esperto di tanto male e ansioso finalmente del bene, l’individuo sì, che, superstite dell’eccidio, solo con la sua libera vita, fatta giustizia del nemico, riconosce intorno a sé negli altri superstiti i compagni e con quelli imprende la via […][17].
Come l’anabasi greca non può essere un semplice ritorno, in quanto la derelizione della situazione ha portato i soldati allo smarrimento di qualsiasi orientamento precedente, così il partigiano, dopo aver riconosciuto attorno a sé i «compagni», dà origine ad una nuova via. È però sprovvisto della sicurezza che vi sia «ancora un mondo diverso nel quale si poteva ritornare»[18]. L’anabasi consiste infatti in un’invenzione del proprio cammino deficitaria della conferma di essere un reale ritorno: «è la libera invenzione di un’erranza che sarà stata un ritorno, un ritorno che, prima dell’erranza, non esisteva come strada-di-ritorno»[19].
Ciò che fa del significante «anabasi» un possibile supporto per la meditazione dell’evento Resistenza sta nella sua capacità di intenzionare il percorso, la strada del ritorno: l’anabasi lascia infatti indecise, nella traslazione indicata, «le parti rispettive dell’invenzione disciplinata e dell’erranza casuale»[20]. Le lascia indecise ma le contempla entrambe. Nella tensione mai chetabile tra questi due termini si situa la genesi stessa della matrice politica della lotta partigiana: il suo originare dal polemos, ma come atto consustanziale al traghettamento verso la polis. La politica nasce infatti come il contrario della violenza, ma trova in quest’ultima ciò che la fonda, la protegge, la amplia[21]. Violenza e politica tagliano i poli di una sintesi disgiuntiva, la prima origina la seconda tramite una derivazione per contrasto. Il partigiano è consapevole di ciò, è consapevole che la fenogliana assolutezza della propria situazione rimanda non solo ad un’esemplarità ma anche ad un’assenza di riferimenti giuridici: costringe appunto ad una invenzione disciplinata, all’invenzione di una disciplina stretta tra la fedeltà alla regola e la fedeltà a se stessi. Una tale, incoativa, disciplina erra, si forgia nell’impatto con le casualità che le si oppongono, incappa in errori (l’erranza incarna qui la sua duplicità semantica), può a tratti cedere alla seduzione della violenza, ma per assumerne infine la necessità come irrevocabile pertugio verso la nascita di un nuovo ordine politico, verso una libertà che sappia emanciparsi, dandole forma e autolimitandola, dalla rottura immanente e drammatica della liberazione[22].
Da qui il terrore del partigiano di perdere ciò che più lo differenzia dal nemico: la pratica consapevole della violenza; ovvero la percezione chiara e distinta dell’impossibilità di una sua gestione naturalizzata e autolegittimantesi, della necessità di un suo doloroso e angosciato inserimento in un orizzonte di fini obiettivati dalle determinazioni storiche:
Quel peso di male che grava sugli uomini del Dritto, quel peso che grava su tutti noi, e che si sfoga in spari, in nemici uccisi, è lo stesso che fa sparare anche i fascisti, che li porta a uccidere con la stessa speranza di purificazione, di riscatto. Ma allora c’è la storia. C’è che noi, nella storia, siamo dalla parte del riscatto, loro dall’altra. Da noi, niente va perduto, nessun gesto, nessuno sparo, pure uguale al loro, m’intendi? Uguale al loro, va perduto, tutto servirà se non a liberare noi a liberare i nostri figli, a costruire un’umanità senza più rabbia, serena, in cui si possa non essere cattivi. L’altra è la parte dei gesti perduti, degli inutili furori, perduti e inutili anche se vincessero, perché non fanno storia, non servono a liberare ma a ripetere e perpetuare quel furore e quell’odio, finché dopo altri venti o cento o mille anni si tornerebbe così, noi e loro, a combattere con lo stesso odio anonimo negli occhi e pur sempre, forse senza saperlo, noi per redimercene, loro per restarne schiavi. Questo è il significato della lotta; il significato vero, totale, al di là dei vari significati ufficiali. Una spinta di riscatto umano, elementare, anonimo, da tutte le nostre umiliazioni […][23].
La storia, intesa qui come palcoscenico sul quale il soggetto esperisce la propria epifania, la propria piena manifestazione, è intessuta di vettori pubblici e politici, quelli della grande storia per l’appunto, e di dimensioni esistenziali, intime, di questioni private, come affermano sia Fenoglio sia lo stesso Calvino: «Domani sarà una grande battaglia. Kim è sereno. “A, bi, ci”, dirà. Continua a pensare: ti amo, Adriana. Questo, nient’altro che questo, è la storia»[24].
Una differenza minima sembra contraddistinguere la parusia del partigiano da quella del fascista:
Ferriera mugola nella barba: – Quindi, lo spirito dei nostri… e quello della brigata nera… la stessa cosa? … – La stessa cosa, intendi cosa voglio dire, la stessa cosa… – Kim s’è fermato e indica con un dito come se tenesse il segno leggendo; – la stessa cosa ma tutto il contrario. Perché qui si è nel giusto, là nello sbagliato. Qui si risolve qualcosa, là ci si ribadisce la catena[25].
Una differenza minima la cui logica operativa si costruisce su una duplicità di gesto: è atto differenziale e differenziante[26]. La distinzione tra partigiano e fascista, special modo se colta nella coessenzialità della violenza, è infinitesimale, ma, proprio in forza di questa sua natura apparentemente impercettibile, è dirimente ed irriducibile. È una differenza simile a quella individuata da Alain Badiou[27] nel Quadrato bianco su sfondo bianco di Malevič (1918): un atto sottrattivo radicale nel quale si inventa un contenuto massimo nel luogo stesso della differenza minima; proprio là dove non c’è quasi nulla che contraddistingua l’oggetto «quadrato» dallo sfondo rispetto al quale si staglia. L’opera di Malevič «è una proposta di pensiero che contrappone la differenza minima alla distruzione massima»[28]; parimenti, il partigiano sembra assumere un tale pensiero elevandosi dalla situazione di minorità – dalla trappola alla quale l’oppressore l’ha inchiodato[29] – attraverso un gesto minimale ma incommensurabile come quello della gestione della violenza verso un fine di liberazione o, ancor meglio, verso la costituzione di una nuova forma di politica.
Elemento necessario ad un gesto di tale irriducibile radicalità è una modifica nelle stesse qualità ottiche attraverso le quali il soggetto resistente guarda il proprio tempo, il proprio spazio. La Resistenza impone al soggetto di essere contemporaneo alla propria epoca, di sfidarne lo sguardo oscuro[30]. Contestualmente, gli permette di trovare una nuova tessitura simbolica all’interno dell’omogeneità del proprio spazio, gli permette di scoprirlo costellato di luoghi, di «immagini dialettiche»[31] che tracciano i contorni di un paesaggio[32]. Tutto ciò è frutto di uno sguardo diplopico[33] in grado di sovraimprimere spazio e tempo con trasfigurazioni di senso latrici di un nuovo rapporto tra soggetto ed oggetto, all’interno del quale pensare diversamente la situazione presente e scorgervi, quindi, delle possibilità di cambiamento.
In questa metafora ottica si può forse individuare la maggiore compossibilità rintracciabile tra esperienza resistenziale ed esperienza filosofica. Il resistere inizia con un cambiare lo sguardo, storcendo e piegando gli occhi[34] per riuscire a scorgere nella necessità l’«adesso» carico di futuro e libertà; filosofare è sforzo del concetto, calibratura del rapporto soggetto-oggetto, è il dispiegamento ad un tempo soggettivo e obiettivo della coscienza riflettente[35]. Entrambi i gesti presuppongono un’estroflessione metariflessiva, una mediatezza del pensiero radicale. Resistere non è aderire al registro dell’opinione, ma cambiare lo sguardo sulla scia della rottura evenemenziale accorsa sia al proprio presente sia alla propria soggettività. La filosofia non è punto di vista, non è Weltanschauung, ma articolazione di uno sguardo nuovo in grado di mettere in luce le costrizioni che l’apparenza misconosce, in grado di «rimettersi veramente alla cosa, e non al bisogno ideologico»[36].

Il concetto di anabasi permette infine un’ultima ripartenza interpretativa. Un tale nuovo inizio è custodito nella poetica di Paul Celan, il poeta che forse più di tutti ha cercato di pensare il XX secolo, di misurarne l’abissalità, a partire dalla rigenerazione delle sue stesse possibilità e capacità rappresentative. Anche per Celan si tratta quindi di un risalire, di un inizio che è anche ritorno, di un’Anabasis (1963) dopo Auschwitz:
Scrittura minuta fra i muri, questo
impervio-vero
Salire e Ritornare
nel futuro dal cuore lucente.
Laggiù.
Diga
di sillabe, color
mare, protesta lontano
nell’Insolcato.
Poi:
spalliera di boe,
boe d’affanno,
con riflessi di respiro, saltellanti,
istantaneamente belli –:
suoni di luminose campane –: (dum-,
dun-, un-,
unde suspirat
cor),
sfrenati, riscattati,
nostri.
Realtà visibile, udibile,
parola liberata, rizzata
a tenda:
Insieme[37].
La poesia si apre negando qualsiasi gesto di eloquenza; nessuno prende inizialmente parola. Solo una voce in tono minore incrina il silenzio dell’anonimato per tracciare una direzione all’interno di tre rimandi estremamente labili[38]: «scrittura minuta», «impervio-vero», «nel Futuro del cuore lucente».
Una via che si deve aprire nella durezza di un muro, di una frattura materiale, ma che al contempo intravede in se stessa, nella propria impervietà, l’unica possibilità di esistenza e di senso. Inizia così anche l’azione partigiana. Si percepisce come flebile e stentata, ma coglie la propria cifra di verità in una strutturale debolezza: «moriamo nel giusto», affermano moltissime lettere dei condannati a morte nelle carceri fasciste. Una verità che è riflessa, promana dal «cuore lucente» del futuro, ma, al tempo stesso, che è raggiungibile solo tramite un salire che è anche un ritornare. Il gesto del resistere impone infatti una nuova temporalità; scardina il tempo del progresso all’interno del quale l’oppressione totalitaria ha costruito la sintassi della propria azione[39]. È solo in un tempo altro, nel futuro anteriore, che il partigiano può trovare una possibile libertà.
Dove? Nell’«Insolcato», nel deserto, su di un territorio straniante anche quando conosciuto, proprio in quanto investito da uno sguardo che gli dona l’aleatorietà dell’incontro con l’alterità. La montagna e la città sono luoghi familiari che si sovraimprimono di un senso nuovo: il senso dato dall’evento in atto, dalla sua eccedenza significante, dal suo portato di verità. In una tale situazione, solo l’incontro con l’alterità, con le «boe d’affanno» e «luminose campane», permette al soggetto di non smarrirsi e di trovare riscatto, di condividere un «nostri». Qui, nell’«Insieme» che chiude i versi di Celan, sta l’essenza dell’impegno partigiano. L’anabasi non può terminare come gesto individuale: insorge nella coscienza singolare, ma richiede contemporaneamente un orizzonte di riconoscimento. Non si cristallizza però in un «noi» costruito sulla logica e l’identità dell’io. La frattura originante, avvenuta nell’individuo in concomitanza con la scelta resistenziale, prosegue anche al suo esterno come un’«esperienza di avventura individuale in rotta col passato che […] si consolida nell’impresa di una nuova organizzazione di uomini» [40]: nasce quindi l’in-separato, un noi che veicola la propria «disparità immanente»[41] e trova, nell’insieme, la «parola liberata». L’anabasi, nella sua ultima accezione, si concretizza quindi in una nuova parola: è ritorno, riflettuto e straniato, sulla parola precedentemente reificata. L’anabasi è lavorio, trasfigurazione sul e del significante. È riconnettere le parole con significati e con oggetti nuovi – con la «cosa», chioserebbe Adorno –, è ridar loro una nuova capacità fonetica e semantica: è recuperare l’esausto significante «patria» e chiamare «Gruppi di azione patriottica» le bande partigiane cittadine.
L’anabasi individua così la propria traiettoria, ritrova la parola dietro la quale un nuovo «insieme» può proteggersi e nell’erranza manifestarsi (la parola «rizzata a tenda» di Celan): il reduce di Russia, e con lui decine di migliaia di donne e uomini d’Europa, hanno trovato nella Resistenza un nuovo orizzonte all’interno del quale testimoniare la propria scelta; un orizzonte dove delineare la tensione etica rispetto alla quale piegare e foggiare la propria esistenza, la propria antropologia. Un’antropologia che non poggia, infatti, su una soggettività costitutiva; bensì si plasma e si educa, in ogni singola scelta, nella medesima sostanza umana che il partigiano condivide con il fascista. Il resistente smette di essere fascista – non nasce diverso dal fascista – quando sceglie di scegliere di non essere più tale. E qui sta l’elemento pratico, e non ontologico, della sua antropologia.
note
[1] I. Calvino, «Introduzione», in Xenophon, Anabasis, a cura di F. Ferrari, Rizzoli, Milano 2008, p. 8.
[2] Ivi, p. 9.
[3] Ivi, p. 8.
[4] Ibidem.
[5] Ivi, p. 8.
[6] Cfr. C. Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza, Bollati Boringhieri, Torino 2006, pp. 23-41.
[7] N. Revelli, La guerra dei poveri, Einaudi, Torino 1962, p. 143; pagina di diario del 12 ottobre 1943.
[8] W. Benjamin, Per la critica della violenza, in Id., Angelus Novus. Saggi e frammenti, Einaudi, a cura di R. Solmi, Torino 1995, p. 28.
[9] W. Benjamin, Sul concetto di storia, tr. it. G. Bonola, M. Ranchetti, Einaudi, Torino 1997, p. 57.
[10] Cfr. G. Agamben, Categorie italiane. Studi di poetica e di letteratura, Laterza, Roma-Bari 2010, pp. 100-101.
[11] Cfr. A. Badiou, Manifesto per la filosofia, tr. it. F. Elfante, Cronopio, Napoli 2008, pp. 33-40.
[12] S. Forti, «Introduzione», in Id. (a cura di), La filosofia di fronte all’estremo. Totalitarismo e riflessione filosofica, Einaudi, Torino 2004, p. XI.
[13] A. Badiou, Metapolitica, tr. it. M. Bruzzese, Cronopio, Napoli 2001, p. 24.
[14] Id., L’etica. Saggio sulla coscienza del Male, tr. it. C. Pozzana, Pratiche Editrice, Parma 1994, p. 45.
[15] R. Battaglia, Un uomo, un partigiano, il Mulino, Bologna 2004 (1945¹), p. 113.
[16] Cfr. C. Luporini, Filosofi vecchi e nuovi, Editori Riuniti, Roma 1981, pp. 59-63.
[17] C. Dionisotti, Prospettive e concetti della guerra. L’individuo, in Id., Scritti sul fascismo e sulla Resistenza, Einaudi, Torino 2008, pp. 86-89. Frammento autografo databile all’inverno del 1944.
[18] Battaglia, Un uomo, un partigiano, cit., p. 114.
[19] A. Badiou, Il secolo, tr. it. V. Verdiani, Feltrinelli, Milano 2006, p. 98.
[20] Ibidem.
[21] Cfr. R. Esposito, L’origine della politica. Hannah Arendt o Simone Weil?, Donzelli, Roma 1996, cit., p. 44 – 45.
[22] Cfr. H. Arendt, Sulla rivoluzione, tr. it. M. Magrini, Einaudi, Torino 2006, p. 29.
[23] I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, Einaudi, Torino 2002, p. 147.
[24] Ivi, p. 153.
[25] Ivi, pp. 146-147.
[26] Cfr. Badiou, Il secolo, cit., p. 72.
[27] Cfr. ivi, pp. 71-73.
[28] Ivi, p. 72.
[29] Cfr. P. Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino 1991, p. 14.
[30] Cfr. O. Mandel’štam, Il secolo, in Id., Poesie 1921-1925, tr. it. S. Vitale, Guanda, Parma 1976, p. 37.
[31] W. Benjamin, I “Passages” di Parigi, in Id., Opere complete, a cura di E. Ganni, tr. it. G. Russo, Einaudi, Torino 2000, vol. IX, p. 516.
[32] Cfr. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, cit., p. 10.
[33] Cfr. A. Zanzotto, Diplopie, sovrimpressioni (1945-1995), in Id., Sovrimpressioni, Mondadori, Milano 2001, pp. 37-38.
[34] Cfr. Fenoglio, Una questione privata, in Id., Romanzi e racconti, Einaudi, Torino 2001, p. 1124.
[35] Cfr. T.W. Adorno, Terminologia filosofica, tr. it. A. Solmi, Einaudi, Torino 2007, pp. 125-126.
[36] Ivi, p. 115.
[37] P. Celan, Anabasis, in Id., Poesie, a cura di G. Bevilacqua, Mondadori, Milano 2001, pp. 439-441.
[38] Cfr. Badiou, Il secolo, cit., p. 110. Alla sottile lettura della poesia di Celan qui offerta da Badiou si farà riferimento costante nel prosieguo del testo.
[39] Cfr. Benjamin, Sul concetto di storia, cit., p. 45.
[40] C. Dionisotti, Letteratura «partigiana», “Aretusa”, n. 17-18 (1946), p. 157.
[41] Badiou, Il secolo, cit., p. 112.

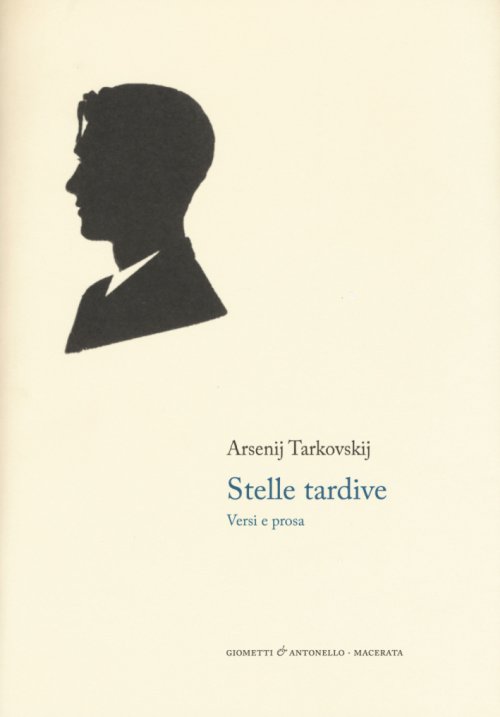
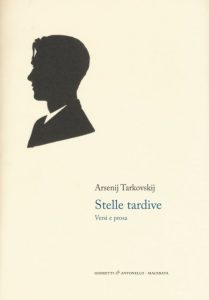


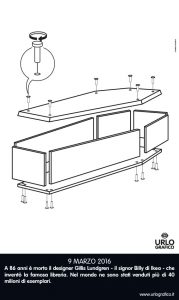




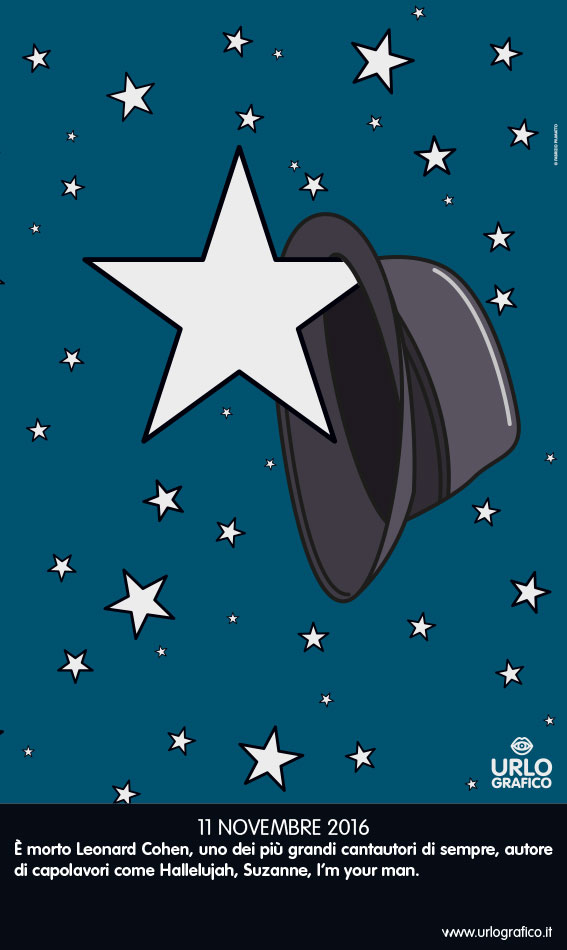




 Ex cinema Cristal, con il tetto spuntato, a Lalehzar, Teheran.
Ex cinema Cristal, con il tetto spuntato, a Lalehzar, Teheran. Quel che resta delle luci della ribalta, Lalehzar, Teheran.
Quel che resta delle luci della ribalta, Lalehzar, Teheran. Una locandina che mi sembrava un po’ kitsch, vicino al Cinema Pardis Gholak, Nord Est di Teheran.
Una locandina che mi sembrava un po’ kitsch, vicino al Cinema Pardis Gholak, Nord Est di Teheran.
 Il Cinema Africa (ex Cinema Atlantic), Teheran, ma potrebbe essere Piazza Bologna a Roma.
Il Cinema Africa (ex Cinema Atlantic), Teheran, ma potrebbe essere Piazza Bologna a Roma. Scheletro dell’ex cinema Metropolis, lampadari e motorini con il parabrezza, Lalehzar, Teheran.
Scheletro dell’ex cinema Metropolis, lampadari e motorini con il parabrezza, Lalehzar, Teheran. Sala vuota nel Multisala Cineplex, Kourosh Complex, Teheran.
Sala vuota nel Multisala Cineplex, Kourosh Complex, Teheran. Una foto qualunque (e anche un po’ sfocata) scattata attraversando la strada, da un cavalcavia di Enghelab, a Nord di Lalehzar, Teheran.
Una foto qualunque (e anche un po’ sfocata) scattata attraversando la strada, da un cavalcavia di Enghelab, a Nord di Lalehzar, Teheran.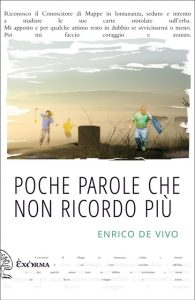

 di Francesca Fiorletta
di Francesca Fiorletta


 La prima volta che ti ho mollato è stata per andare al Burger King.
La prima volta che ti ho mollato è stata per andare al Burger King.





 di Edoardo Zambelli
di Edoardo Zambelli