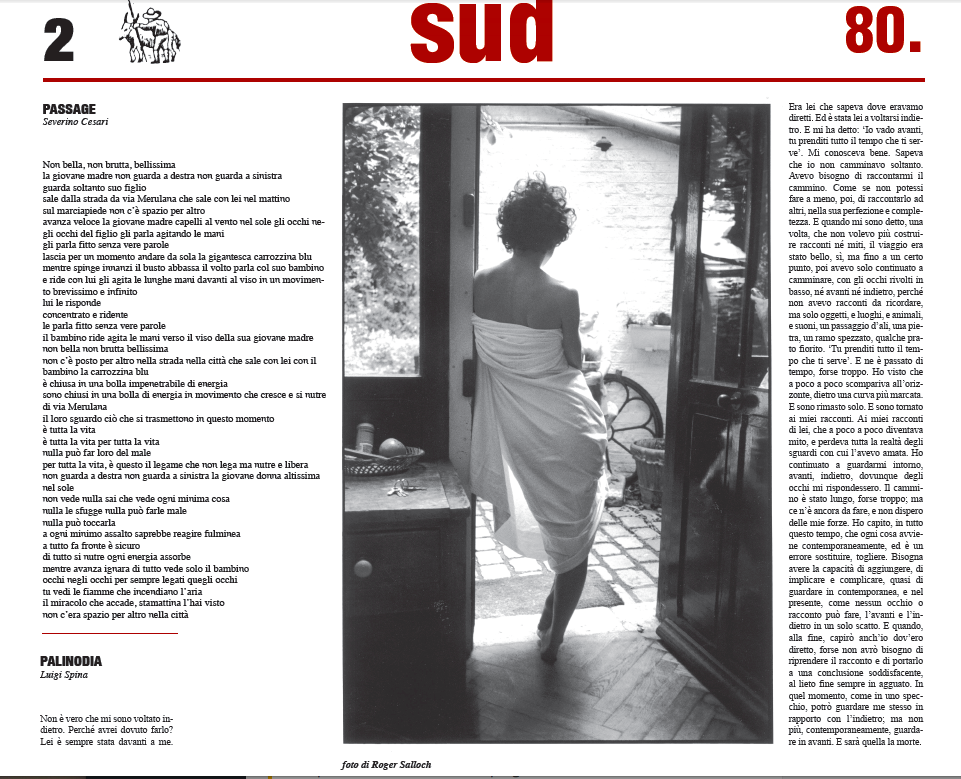trad. in esametri di Daniele Ventre
Hermes tu celebra, Musa, il figlio di Zeus e di Maia,
lui che governa il Cillene e l’Arcadia ricca di greggi,
messo dei numi immortali, veloce, che Maia onorata,
ninfa graziosa di trecce congiuntasi a Zeus in amplesso,
già partorì: rifuggendo la schiera dei numi beati
ella abitava l’ombrata caverna in cui venne con lei,
ninfa graziosa di trecce, il Crònide in seno alla notte,
all’insaputa di numi immortali e genti mortali,
quando calò dolce sonno a Hera la bianca di braccia.
Come però si compì il piano di Zeus, di quel grande,
come per lei in mezzo al cielo il decimo mese fu sorto,
e lo condusse alla luce, avvennero casi ammirandi:
ebbe quel figlio che ha vie molteplici, vario d’astuzie,
un razziatore, un predone di buoi, condottiero di sogni,
spia nella notte, che viola le porte, e che presto doveva
fra gli immortali, fra i numi, adempiere gesta gloriose.
Nato all’aurora, a metà giornata suonava la cetra,
prese al tramonto le vacche d’Apollo infallibile arciere;
Maia sovrana nel quarto del mese a lui diede la vita.
Egli balzato che fu dal materno grembo immortale,
non se ne stette già più nella sacra culla a dormire,
anzi, disceso d’un balzo, cercò delle vacche d’Apollo,
attraversata la soglia dell’antro elevato di vòlte.
Ma vide là una testuggine e n’ebbe infinita delizia,
quella testuggine Ermete per primo la rese canora,
quando si fece a lui incontro alle porte della dimora,
e si pasceva dinanzi alle case d’erba fiorente,
lenta avanzando coi piedi: il veloce figlio di Zeus,
scorta che l’ebbe, sorrise e subito disse parola:
“Eccolo un segno per me giovevole, né lo disprezzo;
ehi, danzatrice d’aspetto amabile, scorta al banchetto,
apparizione gioiosa: come hai, tu che vivi sui monti,
questo grazioso trastullo, testuggine, il guscio screziato?
Ora ti prendo e ti porto a casa: un guadagno sarai,
non mancherò di onorarti; sarai tu il mio primo trofeo.
Meglio restarsene dentro, poiché c’è pericolo in strada.
Tu dal malocchio oneroso di pene offrirai protezione,
mentre vivrai: spanderai, se muori, un bellissimo canto”.
Sì, così disse e frattanto la prese con ambe le mani,
quindi entrò in casa di nuovo, portando il gentile trastullo.
E rovesciata che l’ebbe, con lama di ferro canuto
ecco che estrasse il midollo della tartaruga montana.
Poi, come quando trascorre veloce un pensiero nel petto
d’uomo sul quale le angosce si vanno abbattendo continue,
o come quando dagli occhi balenano a un lampo gli sguardi,
sì, così Hermes glorioso alla voce univa l’azione.
Quindi a misura tagliò, poi confisse canne di giunco,
schiusi dei fori sul dorso, in quel guscio di tartaruga.
Poi la coperse d’intorno d’un cuoio di bue, con sapienza,
e vi applicò le due braccia e sopra ambedue fissò il ponte
e sette corde vi tese, di pecora, ben accordate.
Come ebbe tutto compiuto, creato il gentile trastullo,
con armonia lo saggiò con il plettro, sotto quel tocco
rese un mirabile suono; e il dio cominciava un bel canto
all’improvviso -e si mise alla prova, come i ragazzi,
gli adolescenti, scherzando si pungono in giorni di festa-,
canto sul Crònide Zeus e Maia calzari-leggiadri,
come i due s’erano prima uniti in amplesso amoroso,
e rievocava così la sua stirpe chiara di nome:
poi esaltava le ancelle, quel fulgido albergo di ninfa,
e così i tripodi in casa nonché i numerosi lebeti.
Questo cantava e ben altro però meditava nel cuore.
Ecco che infine tornò alla sacra culla, a riporvi
dentro la cetra leggera; e desideroso di carni
ad esplorare lasciò la sala odorosa d’essenze,
concepì in cuore un inganno astuto di quelli che i ladri,
i grassatori, dipanano in grembo alla notte nerigna.
Sotto la terra calava e giù nell’oceano il Sole
con i cavalli e con tutto il carro, e fu allora che Hermes
giunse di corsa alle selve di Pieria ammantate dall’ombra,
dove hanno stazzi le vacche eterne dei numi beati,
pascolano per i prati amabili, incontaminati.
Ecco che il figlio di Maia, Occhio-acuto Uccisore d’Argo,
ne trafugò dalla mandria cinquanta, di vacche mugghianti,
lungo contorti cammini le spinse per plaghe sabbiose,
ma rovesciando le impronte, e non scordò l’arte d’inganno,
con l’invertire gli zoccoli, indietro le zampe anteriori,
le posteriori davanti, e lui procedeva di faccia.
Subito sopra la sabbia marina si fece calzari
quali mai prima altri vide o pensò, stupendo artefatto,
ed intrecciò tamerici con i ramoscelli di mirto.
Dopo che li ebbe annodati in fascio di florida fronda,
senza fatica si strinse ai piedi i leggeri calzari,
pur con le foglie che lui, il glorioso Uccisore d’Argo,
colse dal suolo di Pieria a celare il proprio cammino,
e ripercorse i suoi passi, affrettando il lungo ritorno.
Mentre badava alla vite fiorente un anziano lo vide
muovere al piano passando in Onchesto letto di prati:
dunque a lui disse per primo il figlio di Maia gloriosa:
“Vecchio che zappi le viti, curvandoti con le tue spalle,
sì, molto vino otterrai, quando tutte il frutto daranno:
dunque tu vedi e sii cieco, ascolta e però resta sordo,
taci, così che non debba tu stesso poi perderci il tuo”.
Come ebbe detto incitò le vacche dai colli possenti.
Molte montagne ammantate dell’ombra e vallate echeggianti
e praterie tutte in fiore attraversò Hermes glorioso.
Era trascorsa la nera e divina notte, sua amica,
per la più parte, era presso a spuntare l’alba operosa:
era da poco in vedetta salita la splendida Luna,
lei, figlia nata a Pallante, al Megamedeide sovrano,
quando all’Alfeo, a quel fiume, il valido figlio di Zeus
trasse le vacche di fronte spaziosa d’Apollo il Radioso.
Giunsero indomite dentro gli stazzi elevati di vòlte,
fino agli abbeveratoi, davanti a un bellissimo prato.
Là, dopoch’ebbe pasciute con erba le vacche mugghianti,
dentro lo stazzo raccolte insieme le radunò tutte,
sì che brucassero il loto e il cipero nella rugiada,
quindi ammassò molta legna e produsse l’arte del fuoco.
Prese un germoglio stupendo di lauro e stringendolo in pugno
lo scorticò con il ferro, e ne spirò ardore avvampante:
Hermes per primo svelò la via di far ardere il fuoco.
Molta ne prese di legna essiccata e dura e la mise
dentro una fossa profonda, in copia, e rifulse la fiamma.
Come nel fuoco avvampò la forza di Efesto glorioso,
ecco che trascinò fuori giovenche ondeggianti e mugghianti,
due, lì vicino alla fiamma: immenso vigore era in lui
ed ambedue le gettò a terra ansimanti sul dorso;
poi si chinò, le girò, e le trapassò dentro i colli;
opera ad opera aggiunse, tagliò carne opima di grasso;
quindi infilata che l’ebbe su spiedi di legno, la cosse,
carne al contempo e filetti di pregio e così nero sangue
dentro le viscere chiuso, che giacquero là sulla terra.
Ma i loro cuoi li lasciò appesi a una rupe svettante,
dove si trovano ancora adesso passato gran tempo
da quegli eventi, diuturna età senza fine. Ma allora
Hermes dall’animo lieto dispose quell’opera opima
su un levigato macigno e ne fece dodici parti
da sorteggiare; a ciascuna abbinò un onore perfetto.
Desiderò quella carne di vittime Hermes glorioso:
dolce com’era il profumo, per quanto egli fosse immortale,
lo seduceva: e però non cedé il suo animo altero,
anche se molto bramava saziare il suo sacro palato.
Ecco che dunque depose nell’antro elevato di vòlte
grasso nonché molte carni, in fretta al soffito li appese,
segno di nuova razzia; la legna essiccata la prese
e vi bruciò zampe e teste intere all’ardore del fuoco.
E non appena ebbe il nume compiuto ogni rito a dovere,
via i calzari gettò nell’Alfeo dai gorghi d’abisso,
quindi anche estinse la brace e sparse la cenere nera
tutta la notte -e splendeva una bella luce di Luna.
Poi del Cillene raggiunse di nuovo le splendide cime
verso l’aurora, né altri incontrò nel lungo ritorno,
non dei beati, dei numi, e non delle genti mortali,
e non latrarono i cani. Veloce Hermes figlio di Zeus
dal chiavistello passò in obliquo dentro la sala
simile ad una folata autunnale oppure alla nebbia.
Dritto così penetrò nel ricco santuario dell’antro,
venne con passi leggeri, e non ne echeggiò il pavimento.
Se ne tornò nella culla in un attimo Hermes glorioso:
quindi ravvolta la fascia agli omeri, come un bambino
piccolo, se fra le mani avvolge il lenzuolo giocando,
stava, stringendo la bella testuggine con la sinistra.
Ma non sfuggì alla dea madre il dio: ella disse parola:
“Vario d’ingegno- da dove arrivi a quest’ora di notte,
tu? D’impudenza ti ammanti? Ora sì davvero lo temo,
da indissolubili lacci avvinto nei fianchi ben presto
tu varcherai la mia porta per mano del figlio di Leto
o vagolando di mezzo alle forre sarai brigante.
Va’, va’ in malora: tuo padre con te seminò grande angoscia
sia per le genti mortali sia per gli immortali, gli dèi.
Hermes a lei tuttavia con scaltre parole rispose:
“Ah, madre mia, perché mai mi minacci come un bambino
piccolo, che nel suo cuore conosce ben poca furbizia,
tanto è pauroso e tremante ai rimproveri della madre?
Io tuttavia mi darò all’arte che sia la migliore,
per sostentare me e te in eterno: già, tutt’e due
non senza doni, non senza mai suppliche fra gli immortali
certo non continueremo qui a starcene come tu imponi.
Meglio incontrarsi coi numi immortali giorno per giorno
fra la ricchezza il benessere e il lusso, piuttosto che al chiuso
starsi in un antro offuscato di fumi; in materia d’onore
ascenderò anche io allo stesso rango di Apollo.
Se non me lo concedesse mio padre, ecco allora che io
m’ingegnerò, riuscirò, mi farò signore dei ladri.
E se mi desse la caccia il figlio di Leto gloriosa
credo gliene incoglierà perfino maggiore sciagura.
Già, me n’andrò fino a Pito e penetrerò nel gran tempio:
là quei suoi tripodi in copia, bellissimi, e insieme i lebeti
trafugherò e il suo oro, gran copia di lucido ferro,
e molte vesti non meno, e tu lo vedrai, se vorrai”.
Queste parole così scambiavano l’uno con l’altra,
lui, quel rampollo di Zeus che ha l’egida e Maia sovrana.
E mattutina l’Aurora portando ai mortali la luce
sorse da Oceano gorgo d’abisso: ecco allora che Apollo
giunse in cammino ad Onchesto, l’amabile sacro recinto
voto a Chi cinge la terra, sonoro: e lì vide l’anziano
curvo badare alla vite fiorente, di fianco alla via.
Primo così gli parlò il figlio di Leto gloriosa:
“Vecchio, che poti i roveti di Onchesto la verde di prati,
giunco fin qui dalla Pieria a cercare le mie giovenche:
sì, sono femmine tutte e tutte di corna ricurve,
della mia mandria; lontano da solo pasceva anche il toro
nero e feroci molossi venivano dietro di lui
quattro, concordi, eguagliabili ad uomini: sono rimasti
loro, i molossi col toro, il che è un prodigio davvero;
sono partite le vacche -da poco era il sole calato-
via da quel pascolo dolce e dal loro morbido prato.
Dimmelo vecchio, tu avanti negli anni, se mai l’hai veduto
l’uomo che con le giovenche andava compiendo il cammino”.
Dunque l’anziano rispose con queste parole e gli disse:
“Caro, è difficile, quel che si può vedere con gli occhi,
tutto ridirlo: il cammino lo compiono molti viandanti,
gli uni con molti malvagi propositi, gli altri con degni
passano: arduo è del resto comprendere come sia ognuno.
Io però qui tutto il giorno e fino al calare del sole
ho dissodato il declivio del colle tenuto a vigneti;
certo non so, ma ho creduto, amico, di scorgere un bimbo
piccolo, e aveva una verga, passava ora a destra ora a manca,
le conduceva a ritroso, le teste a lui vòlte di fronte”.
Disse l’anziano: egli in fretta fu in via, come udì quel racconto.
Scorse un uccello dalle ali distese e all’istante conobbe
che il razziatore era stato il figlio del Cronide Zeus.
Rapidamente avanzò il re Apollo, il figlio di Zeus,
a Pilo chiara di dèi, cercando i suoi buoi gambe-torte,
s’era coperto di nebbia purpurea le ampie sue spalle,
scorse le tracce e parole parlò l’infallibile arciere:
“Ah, gran prodigio davvero è questo che vedo con gli occhi:
tracce ci sono quaggiù di giovenche aguzze di corna,
pure all’indietro ed al prato d’asfòdeli sono rivolte:
queste non sono vestigia d’un uomo e nemmeno di donna
no, né di lupi canuti né d’orsi, né poi di leoni,
né di centauro dal collo crinito saranno, io sospetto:
qui c’è qualcuno che va con rapidi piedi a gran passi,
ecco per via strane impronte di qua, di là ancora più strane”.
Come ebbe detto avanzò il re Apollo, il figlio di Zeus,
e del Cillene raggiunse la cima ammantata di selve
e la caverna dall’ombra profonda, là dove l’eterna
ninfa già diede la vita al figlio del Crònide Zeus.
Ed un profumo gentile il quel monte chiaro di dèi
si diffondeva, brucavano l’erba assai agili armenti.
Dunque laggiù con premura passò dalla soglia di pietra
dentro la cupa caverna Apollo infallibile arciere.
Ma non appena quel figlio di Zeus e di Maia ebbe scorto,
per le giovenche adirato, Apollo infallibile arciere,
si ricoprì delle fasce odorose, e come alla molta
brace del ceppo d’un tronco la cenere intorno fa velo,
Hermes così si celò appena ebbe visto l’arciere.
E ritirò in poco spazio la testa e le mani e i suoi piedi,
bimbo che appena lavato, del sonno soave è in attesa;
era ben sveglio in realtà, sotto il braccio la tartaruga.
Non ignorò, ben conobbe, il figlio di Zeus e di Leto,
sia la bellissima ninfa montana sia il caro suo figlio,
bimbo piccino ammantato però di fallaci apparenze.
Per ogni dove scrutò nel grembo dell’ampia dimora,
tre ripostigli dischiuse, trovata la lucida chiave,
pieni com’erano tutti di nettare e amabile ambrosia;
ed assai oro e non meno argento all’interno giaceva,
e così molte purpuree e candide vesti di ninfa,
quali ne hanno le sacre dimore dei numi beati.
Poi dopoch’ebbe cercati gli anfratti dell’ampia dimora
queste parole rivolse il Letoide ad Hermes glorioso:
“Bimbo che in culla riposi, tu mostramele le giovenche,
presto: ché in breve fra noi ci si sbrigherà in malo modo.
Ti prenderò e getterò nel Tartaro cupo di nebbie,
inesorabile buio e funesto: te non la madre
né il padre tuo condurranno alla luce, sotto la terra
anzi errerai, fra le larve degli uomini dominerai”.
Hermes a lui rispondeva così, con parole d’astuzia:
“Figlio di Leto, perché mi hai detta parola spietata?
Giungi fin qui per cercare le tue campagnole giovenche?
Io non ho visto o saputo, né ho udita parola da un altro;
non te le posso mostrare e premio non posso ottenerne;
e non somiglio ad un uomo robusto, a un predone di buoi.
Questo non è il mio mestiere, io piuttosto d’altro mi curo:
solo del sonno mi curo e del latte della mia mamma,
e di tenermi le fasce addosso e di caldi bagnetti.
Altri non sappia da dove è venuta tanta discordia:
o veramente un prodigio in mezzo agli eterni sarebbe
che oltrepassasse la soglia un bambino nato da poco
con campagnole giovenche: tu ben a sproposito parli.
Ieri son nato, i miei piedi son morbidi, dura è la terra.
Giuro sul capo del padre, se vuoi, giuramento solenne:
sì lo proclamo, di ciò non sono colpevole io,
e non ho visto nemmeno un altro rubarti le vacche,
quali che siano le vacche: soltanto la fama ne ho udita”.
Disse così, fra le palpebre un fitto brillio dardeggiando
coi sopraccigli accennava da un lato e dall’altro scrutando,
e fischiettando insistente, com’è chi ode vana parola.
Con un sorriso gentile Apollo l’arciere gli disse:
“Piccolo mio seduttore imbroglione, certo lo credo
che troppo spesso entrerai nelle ben tenute dimore
in piena notte e farai che più d’uno dorma per terra,
col saccheggiargli la casa in silenzio: tale mi parli!
Molti ne rovinerai di mandriani, gente dei campi,
di fra le balze dei monti, allorché per brama di carni
ti imbatterai nelle mandrie dei buoi, nelle greggi di armenti.
Ora suvvia, tu non dorma il tuo estremo ed ultimo sonno,
giù dalla culla discendi, tu, amico alla notte nerigna.
Anche in futuro l’avrai tale onore fra gli immortali:
tutti i tuoi giorni sarai chiamato il signore dei ladri”.
Disse e poi strinse e afferrò quel bambino, Apollo il radioso.
Ma di proposito allora il potente uccisore d’Argo
già sollevato dal braccio del dio, fece uscire un presagio
servo sfacciato del ventre e sconsiderato messaggio.
Tutto d’un tratto ecco, poi starnutì, e ben l’udì Apollo,
e dalle mani perciò gettò a terra Ermete glorioso,
gli si sedette di fronte, per quanto bramoso di andare,
quindi, pungendolo, a Hermes così si rivolse in parole:
“Animo, piccolo in fasce, tu figlio di Zeus e di Maia:
le troverò, prima o poi, le valide teste di vacche,
anche con questi presagi: tu a me sarai guida per via”.
Disse così: balzò in piedi d’un subito Hermes Cillenio,
svelto s’avviò: ma su entrambe le orecchie premeva le mani
e si avvolgeva le fasce alle spalle e disse parola:
“Dove mi porti, tu, Arciere, fra tutti gli dèi il più furente?
Incollerito così per le vacche tu mi tormenti?
Ah, se morisse la stirpe dei buoi! Poiché certo non io
quelle tue vacche le ho mai rubate, e non altri ho veduto,
quali che siano le vacche: ne sento soltanto la fama.
Rendi giustizia o ricevila ai piedi del Crònide Zeus”.
Poi, non appena ogni nodo discussero punto per punto,
Hermes pastore di greggi e il fulgido figlio di Leto,
con sentimento discorde –e questi parlando verace
no, non a torto teneva in prigione Ermete glorioso,
ma con sue arti nonché con le sue maliose parole
era deciso, il Cillenio, a ingannare l’Arco-d’argento–
e poiché, ricco di ingegno, trovò chi ebbe mille risorse,
tutto d’un tratto ecco, allora, s’avviò attraverso la sabbia,
primo, ma dietro di lui il figlio di Zeus e di Leto.
Subito giunsero al picco d’Olimpo odoroso d’essenze,
essi, i bellissimi figli, dal Crònide padre, da Zeus:
là per entrambi eran posti i due pesi della giustizia.
C’era vocio per l’Olimpo nevoso, e gli eterni, immortali,
si radunavano dopo l’Aurora dal trono tutt’oro.
Vennero allora sia Hermes sia Apollo dall’arco d’argento,
alle ginocchia di Zeus; domandò allo splendido figlio
Zeus che dall’alto rimbomba, e così gli disse parola:
“Preda così dolce al cuore da dove la prendi, Radioso,
un bambinello ora nato che sembra in aspetto un araldo?
Grave questione si pone in mezzo all’accolta di dèi!”
E di rimando gli disse il sovrano Apollo, l’arciere:
“Padre, all’istante udirai racconto non certo da poco,
tu che mi pungi che io sarei il solo avaro di preda!
Questo bambino l’ho visto, lui, l’impareggiato ladrone,
sulle giogaie cillenie (immenso cammino compii),
dileggiatore, quale io fra gli dèi mai altro ho veduto,
no, né fra gli uomini, quanti se n’ha sulla terra predoni.
Lui mi rapì e portò via dal pascolo a sera le vacche
e se ne andò lungo il lido del mare dal vasto fragore,
dritto puntando su Pilo: due specie di tracce, prodigi
tali da averne stupore, le gesta d’un nume superbo.
In direzione del prato d’asfòdelo per le giovenche
nero il terriccio mostrava d’avere serbato le tracce:
egli però, indisturbato e senza mai tracce, né i piedi
mai né le mani moveva in mezzo al sentiero sabbioso;
anzi, covando qualche altra malia, tali vie prodigiose
attraversò, quasi stesse passando su fragili sterpi!
Fino a che poi proseguì in mezzo al sentiero sabbioso
ben facilmente ogni traccia per polveri si palesava:
ma non appena compì quel lungo cammino di sabbia,
presto il cammino dei buoi si fece invisibile, e il suo,
sopra la terra compatta: ma un uomo mortale lo vide,
spingere dritto lì a Pilo le vacche di fronte spaziosa.
Poi, non appena me l’ebbe rinchiuse in un luogo tranquillo,
e scompigliate le tracce per via nell’un verso e nell’altro,
ecco raggiunse la culla, lui, simile a notte nerigna,
l’antro suo cupo di fumi, nel buio, né avrebbe potuto
aquila acuta di sguardo mai scorgerlo: spesso le mani
se le passava sugli occhi, ma intanto covava il suo inganno.
Subito, poi, senza pena così mi si volse in parole:
“Io non ho visto ho saputo, né ho udita parola da un altro,
non te le posso mostrare e premio non posso ottenerne”.
Quindi, com’ebbe parlato così, sedé Apollo il Radioso:
Hermes allora parlò fra gli eterni un’altra parola,
e puntò al Crònide il dito, al sovrano degli dèi tutti:
“Ah padre Zeus, a te sì, io la verità voglio dirla:
già, poiché sono sincero e no, non riesco a mentire.
Egli è venuto da noi, cercando i suoi buoi gambe-torte,
proprio quest’oggi, che il sole veniva da poco sorgendo,
né spettatori né testi fra i numi beati ha additato.
Mi comandò di informarlo, invece, con gran tracotanza,
aspra minaccia mi fece, gettarmi nel Tartaro vasto,
solo perché ha fresco fiore di sua giovinezza gloriosa,
io solo ieri però sono nato (e lui lo sa bene)
e non somiglio ad un uomo violento, a un predone di buoi.
Credimi –e poi vanti bene tu d’essere il caro mio padre–,
non le ho condotte mai in casa le vacche –abbia io buona sorte–
manco la soglia ho passato: con tutta chiarezza lo dico.
Io lo rispetto non poco, il Sole, e così gli altri numi,
do a te il mio affetto e di lui ho timore, e tu lo sai bene
che io non l’ho questa colpa. Farò giuramento solenne:
no, per le porte dei numi immortali adorne di pregio!
E farò un giorno che paghi, costui, il rapimento feroce,
anche se è forte davvero. Tu ai giovani dona sostegno!”
Sì così disse, ammiccante, il Cillenio uccisore d’Argo,
e si teneva le fasce sul braccio né mai le lasciava.
Zeus rise forte, mirando il bimbo dai loschi consigli,
che perorava sui buoi con abilità, con sapienza.
Poi comandò che ambedue, avendo concordia nel cuore,
le ritrovassero, ed Hermes il messo facesse da guida,
e palesasse anche il luogo con limpidità di intenzioni,
dove egli aveva celato le valide teste dei bovi.
Accennò il Crònide e a lui obbediva il fulgido Ermete:
lo piegò in fretta la mente di Zeus che dell’egida è cinto.
E con premura quei due bellissimi figli di Zeus
giunsero a Pilo arenosa, nei pressi del guado d’Alfeo;
vennero nelle campagne e alla reggia d’alto soffitto,
dove era stata alloggiata la mandria nel tempo notturno.
Hermes entrato che fu là in quella rocciosa caverna,
ne ricondusse alla luce le valide teste dei buoi.
Mentre guardava discosto, il Letoide vide le pelli
sopra la rupe scoscesa, al che chiese a Ermete glorioso:
“Ingannatore, come hai potuto scannare due vacche,
tu così piccolo e nato da poco? E davvero io, sì, io
paventerò la tua forza, in futuro: non ti bisogna
crescere ancora per molto, o Cillenio, figlio di Maia”.
Disse così, e di sua mano con vimini lacci crudeli
gli avviticchiò; ma ai suoi piedi piantarono in terra radici
subito, come propaggini, avvoltesi l’una sull’altra
ben facilmente e d’intorno a tutti quei buoi campagnoli,
per il volere di Ermete dall’animo astuto. Ma Apollo
se ne stupì, nel mirarli. E il potente uccisore d’Argo,
ecco, guardava di sghembo al suolo, era teso a celare
lo sfavillio del suo sguardo. Placò l’infallibile arciere
figlio glorioso di Leto, a sua voglia, ben facilmente,
forte qual era davvero. Tentò con il plettro la lira
retta dal braccio sinistro, ogni accordo: e sotto quel tocco
quella echeggiò prodigiosa, e sorrise Apollo il Radioso,
se ne allegrò, lo raggiunse nel cuore l’amabile trillo
della divina armonia, desiderio dolce gli prese
l’animo, nell’ascoltarla: suonò amabilmente la lira
pieno d’audacia, lui, il figlio di Maia –e ad Apollo il Radioso
stava vicino, a sinistra; suonò nota arguta, all’istante
prese a spiegare il suo canto, si udì la sua amabile voce
e celebrava gli dèi immortali e buia la terra,
come in principio sian nati, che Moira ebbe in sorte ciascuno.
Ma fra gli dèi da principio onorò col canto Memoria,
madre di Muse, colei che ebbe in sorte il figlio di Maia:
quindi a partire dal rango e da come nacque, ciascuno
degli immortali onorò lo splendido figlio di Zeus,
tutto con ordine disse, suonò stretta in braccio la lira.
E penetrò conturbante la brama nel petto di Apollo:
questi, spiegando la voce, a lui disse alate parole:
“Morte-di-buoi, traffichino ribaldo e compagno al banchetto,
hai meditato quest’arte che è pari a cinquanta giovenchi.
Credo che in pace in futuro si dirimerà la contesa.
Figlio di Maia, che hai vie molteplici, dimmi ora questo,
se dalla nascita segue te l’opera meravigliosa,
se fra gli eterni qualcuno, qualcuno fra genti mortali
diede a te il dono stupendo e ti ispirò il canto divino.
Miracolosa è la voce che sento, un effato di dèi,
tale che no, io non credo che uno fra gli uomini l’abbia
né qualche nume immortale fra quanti hanno case in Olimpo,
fuori di te, te, briccone, te, figlio di Zeus e di Maia.
Quale artificio, che musa di canti invincibili è questa,
quale n’è il mezzo? Può certo al contempo tutti e tre i beni
coglierli, sia l’allegria, sia l’amore, sia il sonno soave
E quanto a me, mi accompagno insieme alle Muse d’Olimpo,
cui stanno a cuore le danze e la via stupenda del canto,
e la fiorente armonia, l’amabile trillo dei flauti:
pure null’altro finora ebbi tanto caro nel cuore,
fra quante prove graziose in feste di giovani s’hanno:
figlio di Zeus, io t’ammiro per come gentile tu suoni.
Ora, poiché pur essendo bambino hai gloriosi pensieri,
siedi, mio caro, e dà ascolto nell’animo a quelli più anziani.
Gloria di certo così scenderà fra i numi immortali
sopra te stesso e tua madre: in tutta chiarezza ti dico
per questo mio giavellotto in corniolo, certo, sì io
fra gli immortali porrò te a guida gloriosa e felice
ti darò doni stupendi, non t’ingannerò, fino in fondo”.
Hermes allora così gli rispose accorte parole:
“Scaltre domande, tu, Arciere, mi poni: ecco allora che io
non ti potrei mai negare d’accedere a questa mia arte.
Oggi la conoscerai: ma tutto sai bene in cuor tuo.
Figlio di Zeus, siedi in trono da principe degli immortali,
tanto sèi nobile e forte, e t’ha caro Zeus il sapiente,
per ogni santo diritto, e ti porse doni stupendi
e privilegi: tu ascolti responsi da voce di Zeus,
come raccontano, Arciere: da Zeus ogni oracolo nasce.
Di questi beni so anch’io, buon amico, quanto sei ricco.
Anche da solo potresti conoscere quello che brami.
Ma se il tuo animo è caldo d’apprendere suono di cetra,
modula il suono e la voce e di questa gioia gioisci,
abbila dunque da me: ma tu, caro, accordami gloria.
Spandi bel canto reggendo in mano l’arguta compagna
che belle gesta sa bene per ordine come narrarle.
Portala tu d’ora in poi tranquillo al banchetto fiorente,
e nell’amabile danza, e al festino chiaro di glorie,
per l’allegria della notte e del giorno. A quello che poi
con la sapienza dell’arte la interroghi fattosi esperto,
essa nel cuore parlando ispira ogni nota gentile,
se la si modulerà con dolce perizia, abilmente,
ché dallo sforzo dolente rifugge. Per quello che invece
come inesperto con furia la interroghi sin dal principio
ecco che strimpellerà le sue note a vuoto nel vento.
Anche da solo potresti conoscere quello che brami.
Pure io a te voglio darla, o splendido figlio di Zeus:
Ma nel frattempo su monte e piana che alleva cavalli
io per i pascoli, Arciere, andrò con i buoi campagnoli.
Là, congiungendosi ai tori, avranno ampia prole le vacche,
alla rinfusa, sia maschi sia femmine: non ti bisogna
incollerirti all’eccesso, per quanto guadagno tu brami”.
Detto così, gliela porse e l’accolse Apollo il Radioso,
quindi donò volentieri a Ermete la sferza lucente,
gli consegnò le sue mandrie, e ben lieto il figlio di Maia
l’ebbe: ma presa la cetra, il sovrano Apollo, l’arciere
splendido figlio di Leto, tentò con il plettro la lira
retta dal braccio sinistro, ogni accordo: e sotto quel tocco
quella echeggiò prodigiosa, e il dio le intonava il bel canto.
Ecco che allora le vacche quei due le condussero al prato
chiaro di dèi; poi di nuovo, bellissimi figli di Zeus,
mossero rapidi i piedi, rivolti all’Olimpo nevoso,
e li allietava la lira; e fu lieto Zeus il sapiente,
e in amicizia li strinse ambedue. Per parte sua Hermes
sempre al Letoide serbò il suo affetto, come tuttora:
segno ne sia che la cetra la offrì all’infallibile arciere,
dono bramato, e da esperto la regge egli in braccio e la suona.
Hermes però fabbricò poi l’arte d’un’altra dottrina:
escogitò l’armonia risonante della siringa.
Ecco che allora il Letoide ad Hermes rivolse parola:
“Figlio di Maia, ho timore, o nunzio dal mobile ingegno,
che tu mi rubi la cetra e l’arco pieghevole a un tempo:
tu questo onore hai da Zeus, che fra gli uomini insegnerai
l’opera del commerciare, su terra nutrice di molti.
Se solo osassi tu farmi il gran giuramento dei numi,
o con un cenno del capo, o sull’acqua truce di Stige,
ecco, ogni gesto che ho caro nell’animo mio compiresti”.
Subito il figlio di Maia promise ed un cenno gli diede
che non avrebbe rubato da ciò che l’Arciere possiede,
e non ne avrebbe violata la solida casa; al che Apollo,
figlio di Leto gli diede un cenno di patto e amicizia,
che non avrebbe alcun altro più caro fra i numi immortali,
no, nessun dio, né un eroe del seme di Zeus: “E un perfetto
patto di numi immortali io stabilirò, più di tutti
certo nell’animo mio e onorato: e a te darò poi
questa bellissima verga di prosperità, di ricchezza,
aurea, triplice, che ti difenderà in sicurezza
con l’adempire ogni legge di fatti nonché di parole
giuste, ogni cosa che affermo di apprendere, voce di Zeus.
Ma il vaticinio che chiedi, mio ottimo alunno di Zeus,
non è volere di dèi che lo apprenda tu né alcun altro
degli immortali: lo sa la mente di Zeus: però io
per lealtà diedi cenno, giurai giuramento tremendo,
che tranne me nessun altro fra i numi di stirpe immortale
conoscerà mai il consiglio di Zeus dal pensiero sottile.
Dunque, fratello di sangue, Aurea-verga, non mi pregare,
tu, di svelarli, gli effati che pensa Zeus ampio-veggente.
Uno fra gli uomini io colpirò, e aiuterò un altro,
molto sviando le stirpi degli uomini non invidiate.
Della mia voce così si potrà giovare chi giunga
a divinare per voce e voli d’uccelli perfetti;
lo aiuterà la mia voce, non ingannerò mai costui.
Quello però che si fondi su uccelli di vano presagio
e chi vorrà contro il mio pensiero indagare il responso
nostro e saperne di più degli dèi che vivono sempre,
credo farà vana strada, ma io avrò preso i suoi doni.
E ti dirò un’altra cosa, o figlio di Maia gloriosa,
nato da Zeus cinto d’egida, o nume veloce fra i numi:
certe onorate creature, sorelle di sangue, ci sono,
vergini, delle loro ali veloci esse vanno superbe,
tre: hanno sempre la fronte cosparsa di bianca farina,
in cavità del Parnaso posseggono loro dimore,
stanno in disparte, maestre d’oracoli, che fra le vacche
io, da fanciullo, imparai: né mio padre a loro ha pensato.
E da quei luoghi così volando da un lato e dall’altro,
hanno pastura dai favi, s’avvera ogni loro responso.
Quando il furore le invade, ove mangino miele biondo,
vogliono, la verità, rivelarla ben volentieri:
se tuttavia sono prive del cibo soave dei numi,
ecco che mentono allora e girano l’una sull’altra.
Io d’ora in poi te le dono, tu interrogale con chiarezza,
reca letizia al tuo cuore, e se incontri un uomo mortale,
spesso costui sentirà la tua voce ove abbia fortuna.
Prendile, figlio di Maia: i buoi campagnoli ondeggianti
curali, insieme ai cavalli, ai muli costanti al lavoro”.
Ecco che allora promise Zeus Crònide e diede il suo cenno
che sui feroci leoni e i verri di candide zanne
e sopra i cani e le greggi, che terra spaziosa alimenta,
e sopra tutti gli armenti imperasse Ermete glorioso,
e che lui solo restasse il perfetto nunzio dell’Ade,
che, pur se dio che non dona, a lui non darà scarso premio.
Sì, così Apollo sovrano ebbe caro il figlio di Maia
dandogli piena amicizia, e il Crònide rese a lui grazie.
Egli è compagno di tutti i mortali e degli immortali;
ben poche volte è d’aiuto e infinite volte seduce
lungo la notte nerigna le stirpi di genti mortali.
Ecco che io ti saluto, o figlio di Zeus e di Maia,
e mi ricordo di te e così d’un’altra canzone.






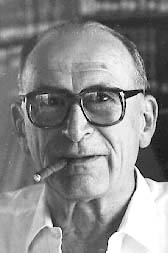
 All’età di quattordici anni il nonno usava portarmi con sé e il suo asino nella casa di campagna della nostra famiglia, ché vi dormissimo e l’indomani raccogliessimo le olive. L’asino del nonno si chiamava Notte.
All’età di quattordici anni il nonno usava portarmi con sé e il suo asino nella casa di campagna della nostra famiglia, ché vi dormissimo e l’indomani raccogliessimo le olive. L’asino del nonno si chiamava Notte.