di Nadia Agustoni
Gli anni 70 lo sport la politica.
Intervista a Monica Giorgi
Perché parlare di anni 70, sport e politica? Cosa hanno in comune queste tre parole? All’apparenza nulla, ma negli anni 90 durante i bombardamenti sulla Serbia le stelle dello sport di quel paese, in quel momento impegnate in Italia, ci hanno ricordato che nessuno vive su un pianeta così isolato e fortunato da rimanere immune dalla vita, dagli eventi, dalla storia. La memoria va anche ad altri avvenimenti, dal pugno alzato dagli atleti neri alle olimpiadi di Città del Messico nel 1968, alle lontane olimpiadi di Berlino nel 1936, quando Hitler lasciò lo stadio per non stringere la mano a Jesse Owens. Tornando al tema cui accennavo, dico subito, che da tanto pensavo di condividere con Monica Giorgi, tennista, anarchica, femminista, scrittrice, alcune riflessioni. Ne è mancata l’occasione dal vivo per ora, ma questa intervista è un primo approccio a un possibile scambio di idee. In passato ci siamo già confrontate, da punti distanti. In comune abbiamo l’amore per il tennis, l’anarchia, il femminismo, la parola. Partiamo da qualcosa di simile per approdare a mondi diversi. Le mie domande tuttavia, non vertono sulla diversità del nostro cammino. Sono domande rivolte a Monica Giorgi perché ci racconti qualcosa del suo percorso che ritengo sia interessante.
N.A. A questa conversazione ho pensato a lungo. Ogni volta avevo troppe domande da farti, ma nessuna molto chiara. Prevaleva la voglia di parlare a ruota libera, di chiederti mille cose. Ad esempio mi incuriosisce la tua carriera di tennista, con risultati ragguardevoli e sul lato opposto, ammesso però sia opposto, il tuo impegno politico e poi i tuoi studi su Simone Weil e Clarice Lispector, il femminismo e molto altro.
M.G. Sì, tennis e studio appaiono due versanti opposti, ma in pratica non sono stati inconciliabili. Quasi distrattamente li ho vissuti come il riflesso di un di più. L’esercizio dell’uno migliorava la prestazione dell’altro. Tennis e studio, che considero molto vicini all’impegno politico e in rapporto all’esserci-starci nel mondo, mi hanno aiutato molto nella vita, materialmente e spiritualmente. Cura del corpo e cura dell’anima mi si sono rivelate esigenze imprescindibili per dare senso alla mia vita e, al contempo, ordinarlo nelle contingenze dell’esistenza, anche se l’una e l’altra le ho praticate con una certa discontinuità per tempo dedicato. Tempo però che non ho mai mancato di prestare ad entrambe. Ancor oggi, sulla soglia dei 70 anni, sento la necessità di fare esercizio fisico per rifocillarmi dalla fatica mentale e per ricompormi, con l’attenzione riservata agli studi, nell’equilibrio del corpo. Non vorrei dare un’impressione sbagliata, di misurare cioè la cosa con il bilancino per programmarla sistematicamente. Mi ci abbandono, quando ne sento il bisogno, lo assecondo…
Sono diventata una tennista professionista per caso fortuito e per necessità materiale. Mio padre era uno sportivo di passione; praticava il tennis, il canottaggio, il calcio, amava la pesca; non poteva non trasmettere la sua passione alle figlie, prima alle maggiori e poi a me anche tramite loro. Ho avuto così la fortuna di ereditare una passione alla terza potenza. Poi alla passione si sono aggiunte la voglia di competere e il bisogno di misurarmi. Subentrò di conseguenza una certa professionalità riconosciuta dalla Federazione, dagli sponsor di allora, per i successi nei tornei, nei campionati. Figurati! il tenore dei ricavi si basava sul risparmio dai rimborsi spese, sulla generosità di qualche magnate con la passione per il tennis, sulla rivendita di racchette avute in omaggio… Quel che conta, però, è che il tennis mi ha permesso di mantenermi agli studi, aiutare mia madre e di sopravvivere divertendomi. Ho viaggiato in quasi tutto il mondo, ho visitato luoghi lontani, conosciuto persone “di tutte le razze” – come si dice in livornese quando si vuole esaltare benevolmente le differenze umane di ogni sorta – con cui mi sono confrontata e che mi hanno arricchito più, dico io, di un contratto da 100 milioni di dollari. Mi sono arrangiata con il tennis e con il tennis ho preso la vita con filosofia… alla lettera.
N.A. Allora parto dalla fine, dal tuo libro su Simone Weil La clown di Dio, uscito per Zero in Condotta l’anno scorso. Le avevi già dedicato un dossier apparso con A rivista anarchica, ed ora questo lavoro. Ne ho tratto l’impressione che ti interessi molto di Weil l’approccio alla religione, una spiritualità la sua ancorata alla vita reale e nello stesso tempo capace di riflettere su Dio libera da costrizioni. Parliamo di una donna che stava tra gli operai, tra gli scioperanti, tra gli anarchici nella guerra di Spagna del 1936, ma che solo pochi anni prima aveva insegnato filosofia a giovani studentesse prendendole molto sul serio, impartendo loro lezioni di una qualità invidiabile. Un’intellettuale che non sottovalutava nulla e nessuno. Tu sottolinei il suo essere ironica, scherzosa anche, da lì credo il titolo che hai scelto. Vuoi dire qualcosa?
M.G. La clown di dio! È la sortita di un’amica, un’imprevedibile esclamazione uscita per bocca di lei durante le nostre appassionate e coinvolgenti discussioni su Simone Weil. Ho detto su, ma in fondo sento di dir meglio, con Simone Weil Non ho scelto il titolo, è il titolo che mi ha scelta, perché quell’espressione mi fece sonoramente scoppiare a ridere. Era qualcosa di vero, dunque. “È troppo bella – incalzai – bisogna scriverne”. E così mi presi la briga di farlo, sentii la cosa come un obbligo, man mano che la scrittura procedeva.
“Intellettuale” mi sembra un termine riduttivo nel definire Simone Weil Come tu accenni, è certo un’intellettuale sui generis, e direi piuttosto un’intellettuale-outsider, una filosofa straordinaria che della filosofia fa “cosa esclusivamente in atto e in pratica”, come si legge nei Quaderni.
Detto altrimenti, è a partire dall’esperienza concreta che lei realizza pensiero teorico.
“Se non avessi fatto quelle cose, non potrei dire queste cose”, precisa Simone a chi le rimproverava quelle particolari stranezze, o idiosincrasie che generalmente sono ritenute ininfluenti, se non addirittura ingombranti, per lo status di filosofa da accademia, all’importanza, alla bellezza e alla profondità dei suoi pensieri e dei suoi scritti che viene riconosciuta dagli stessi contemporanei secondo i quali lei “chiedeva la luna”.
Fisiognomica della grazia è il capitoletto attraverso cui ho cercato di trascrivere l’ironia e la scherzosità della sua figura, un po’ imbranata e al contempo divertita (basta osservare alcune istantanee, come quelle che la ritraggono miliziana nella colonna Durruti), accostandole alla mente divina di cui lei era, anzi si rivela, mediazione vivente.
Sì, come tu sottolinei, del pensiero di Simone Weil mi intriga la dimensione religiosa, non schiacciata in nessuna delle chiese istituite, totalitarie secondo il regime dogmatico dell’ “anathema sit”.
Una nota dei Quaderni e una lettera al fratello, per quel che ne so, riconoscono alla vena mistica, che è data scorgere in seno ad ogni religione positiva e rivelata, (la mistica è sempre stata guardata con sospetto dai poteri istituzionali, quando non atrocemente e criminalmente perseguitata come eresia), l’essenza stessa del discorso religioso inteso alla lettera, ossia come religio, cosa che raccoglie, riunisce in ordine simbolico, le differenti espressioni dell’umana dimensione: spirituale e materiale, reale e soprannaturale a partire, uscire da sé, senza delega di rappresentazione. Insomma qualcosa ben oltre la tolleranza e ben al di qua dei regimi di verità assoluta, qualcosa d’altro che non si risolve nel dialogo interreligioso, ma mira alla ricerca e all’espressione di un linguaggio in cui possa riconoscersi ogni fede, compresa l’atea.
In realtà, proprio per me atea, nutrita o, per meglio dire alla luce odierna, malnutrita nel e dal linguaggio materialistico della seconda metà del secolo scorso, che è anche fine millennio, tutto ciò che era in sentore di chiesa e di religione veniva considerato qualcosa di cui sbarazzarsi per essere “politicamente corretti”…Eppure è stata proprio la reticenza verso la religione che mi ha spinto a comprendere ciò che non mi tornava leggendo S.W…
Sai?, la famosa asserzione marxiana ”la religione è l’oppio dei popoli” la ritrovai capovolta in quel capolavoro, per senso realistico e aspirazione ad altro, che è Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale. Il termine rivoluzione – si legge – così vago ed abusato, così privo di riflessione che chiunque può metterci il significato che più gli aggrada, spinge l’autrice, nel più ampio contesto di analisi critica del materialismo storico, assunto nel linguaggio marxista leninista quale dottrina in grado di spiegare ogni cosa, e non semplicemente un metodo di indagine sulla realtà politico-sociale, la conduce, dicevo, a proseguire il discorso affermando ”…non la religione, ma la rivoluzione è l’oppio dei popoli”. Ecco, questo è stato un passaggio cruciale nello studio appassionato e per il riconoscimento di autorità che riservo agli scritti di vita e di pensiero lasciatici da questa favolosa filosofa.
E ciò che non mi tornava è divenuto il punto di leva per sollevare lo sguardo “anarchico”, senza cancellarne la potenza ideale, in una prospettiva altra, non ristretta, per esempio, al principio sloganistico Né Dio né Stato. Da che dio si è parlati quando non se ne vuol neppure sentir parlare? Quale stato ingombra la mente quando essa non riesce a prescinderne sviluppando ragionamenti contro lo stato?
Non sono domande retoriche, sono domande che sto ponendo anche a me stessa, domande che necessitano risposta sollecitando altre domande.
Sfumature anarchiche in Simone Weil, il dossier pubblicato con A, Rivista anarchica è stato il testo di un pretesto, il bisogno cioè di ri-leggere la tradizione del pensiero anarchico alla luce del corpo testuale di una filosofa donna, che procede non per dimostrare la validità ideologica di un’opinione, ma per ricercare e ripensare, senza rete di salvataggio, un pur minimo precipitato di verità inaudita.
N.A. I progetti di Weil, dal lavoro in fabbrica al viaggio in Germania all’avvento di Hitler, fino alla Spagna della guerra civile, hanno dato esiti di pensiero su cui riflettiamo ancora oggi. Tu metti in evidenza il suo dare corpo, dall’esilio londinese, all’idea di una squadra di infermiere ausiliarie addestrate per andare in prima linea a prestare soccorso a tutti i feriti. De Gaulle neanche volle prenderlo in considerazione. Forse vi traspare un fastidioso senso di onnipotenza femminile e in più quel battersi contro il male si, ma vedere anche altre efferatezze. Alla fine le donne fecero molto per la resistenza e in tante combatterono e finirono nei campi di concentramento. Strategie sempre diverse; scelte che poi dopo la guerra sono confluite in percorsi anche originali, ma quasi sempre marginali. Devo dire comunque, dopo aver ripreso la lettura di Don Lorenzo Milani e per esperienza, che proprio la marginalità consente la libertà maggiore e dei buoni risultati.
M.G. L’agire in marginalità può sortire un senso di libertà più intenso di quello che è forse avvertibile quando si è costretti ad agire sulla scia di un sistema già detto e già visto, autoreferente. I “buoni” risultati, l’efficacia dell’azione per quanto di “nuovo” e di inaspettato mette al mondo procedono, secondo la lezione weiliana che sento di poter cogliere, dalla traversia di bilanciarsi in contesto avendo presente necessità e libertà. Sia per l’impegno politico e sindacale – che non poteva esprimersi se non con l’esperienza diretta del lavoro in fabbrica, condividendo cioè, accanto agli operai, la condizione di esistenza di chi lavora(va) alla catena di montaggio -; sia per l’adesione alla guerra civile in Spagna, Simone Weil ha esplicitamente dichiarato di voler stare nei “ranghi, nelle retrovie”, rifiutando categoricamente qualsiasi posto di prestigio, di alto grado gerarchico. La marginalità in Simone Weil è declinata nella forza dell’umiltà per amore del mondo e, senza dubbio, non si profila con tratti di irresponsabilità in fatto di impegno e radicalità di pensiero. Piuttosto che di marginalità fuori contesto, (lei ha vissuto i tempi del periodo prebellico e nel culmine della seconda guerra mondiale con tale intensità di partecipazione per cui Nadia Fusini l’ha nominata “La guerriera”), parlerei di audacia che affronta il male terreno non con la presunzione di portare il bene perché si ritiene esente dal male; la leggo in una sorta di forza della fragilità lo attraversa in pieno, proprio come “il peggior male” che rimanda, in controsenso, “ il bene più grande”. Il progetto di una formazione di infermiere di prima linea, per il quale si prese della pazza da De Gaulle, intende spiazzare lo sguardo, con la semplice persistenza di un qualche servizio di umanità nel punto culminante della ferocia, dalla scena della forza eroica, militarista e militarizzata. Quella delle armi che decretano: “Morte tua, vita mia”.
Lei si sentiva in un esilio insopportabile quando si trovava in America – aveva dovuto mettere in salvo i genitori in seguito all’occupazione nazista di Parigi e all’instaurazione del governo di Vichy, affrontando un viaggio che l’avrebbe tenuta lontana dalla Francia, dal “territorio del diavolo” che era anche il luogo vivo della resistenza e della lotta. All’amico e compagno di studi Maurice Schumann, esponente di alto grado nei quadri di France Libre a Londra, diretto collaboratore di De Gaulle, scrisse una lettera in cui si raccomandava di non lasciarla morire di dolore, e di consentirle almeno di raggiungere Londra. Cosa che ottenne (fu impiegata come redattrice negli uffici dell’interno di France Libre) ma che non le bastava. Da lì infatti sperava e chiese ripetutamente di essere mandata in Francia per un’azione di sabotaggio… sabotaggio d’amore, è proprio il caso di dire. In poche parole si sentiva in esilio, sradicata, per usare un termine a lei caro, quando era fuori dal contesto dove le cose del mondo bisognava affrontarle davvero, senza vie di mezzo, dove l’obbedienza al tempo che è dato vivere non rimandava ad altro momento la necessità di agire, ora e qui.
L’onnipotenza femminile, che tu avverti fastidiosa, forse è la stessa avvertita dai suoi diretti superiori: -Butti fuori tutto, la invitava Closon, poi avrà il tempo di pensare alle cose serie-. Quali fossero per lui le cose serie, non lo dice… si possono supporre serie quelle cose utili per decidere le cariche di potere da assumere nella fase costituente e nell’ambito istituzionale del periodo postbellico?… Se si pensa che l’attualità di Simone Weil, testimoniata oggi dal rigoglioso fiorire di studi, di scoperte e di riscoperte, di riedizioni o editi ex novo delle sue carte è “profeticamente” rilevata proprio in quelle cose “da buttar fuori” che sono Gli scritti di Londra appunto, tra i quali emerge il testo che Camus volle pubblicare nella collana ”Espoir” di Gallimard, La prima radice (in essa sono presi in considerazione i bisogni dell’anima e gli obblighi verso gli esseri umani, non gli interessi di supremazia economico-militare degli stati vincitori), allora “la fastidiosa onnipotenza femminile” ha le sue ragion d’essere nel conflitto simbolico dei sessi, malcelato in più uomini che in donne sotto il velo ipocrita del normale buon senso e del sano realismo della ragion di stato. Ragion di stato per l’affermazione della quale, più uomini che donne, hanno rimosso quel poco-tanto di vero, di bene e di giusto che è pur sempre alla portata umana.
N.A. Il tuo rapporto con la scrittura quanto è implicato col pensiero della differenza di cui ti senti parte?
M.G. Molto, per un motivo a due punte. Essermi avvicinata a questo pensiero frequentando donne che lo andavano esprimendo al tempo in cui vivevo la scrittura, se scrivevo, ricercando la coincidenza con idee già date, nel mio caso quelle anarchiche, mi ha fatto fare un salto politico e simbolico da dove mi trovavo, avvinta da quella considerazione sulla scrittura. Mi sono resa conto di praticarla in uno stato di finzione; quella convinzione sulla scrittura non era e non esprime un pensiero pensante, ma si dimostra un esercizio utile, nel migliore dei casi, ad esprimere opinioni, a confermare e/o criticare ideologicamente, cioè pensare e scrivere per refutare, dato che la soluzione è già posta in partenza. L’altra punta di implicazione tra scrittura e pensiero della differenza è un interminabile lavorio di scambio tra il pensiero teso a dar voce al libero senso della differenza sessuale e la ricerca di parole autentiche. È un lavoro di scrittura senza fine, non una ricerca tecnica buona per tutte le occasioni. Scrittura dunque in quanto pratica di sé a prescindere da sé, scrittura che, per una sorta di imperfetto rimando analogico, non ha da essere se non poetante…
N.A. Cosa significa per te un’altra figura di scrittrice, Clarice Lispector, su cui hai fatto la tesi?
M.G. Clarice Lispector ebbe a dire: “…letteratura è detestabile, è fuori dall’atto di scrivere…”. Questa citazione precisa quanto ho cercato di dire maldestramente prima; l’ho posta all’inizio della mia tesi, come una specie di dedica. A chi? Alla scrittura, beninteso.
Ebbi la fortuna di leggere intorno alla seconda metà degli anni 80 L’ora della stella. Mi commosse, nel senso letterale dell’espressione. Mi toccò, mi stupì e ne piansi; mi sentii radicata in qualcosa di così vero a cui non sapevo dare nome.
Lessi poi La passione secondo G.H.. Non trovai nulla di quanto solitamente mi aspettavo dalla lettura di un romanzo: lo svolgimento cronologico di una trama schematizzata secondo il genere, l’unità di tempo, di luogo, di azione, l’opinione moralistica dell’autore verso i comportamenti dei personaggi, la risoluzione del plot narrativo, una conclusione, ecc.ecc. Niente di tutto ciò, scoprii invece una scrittura epifanica. Capii poco o nulla di quello che lì era scritto. Ma c’era scritto quello che non capivo, quello che l’ego non capisce e per cui vale la pena continuare a starci sulle pagine scritte. C’era scritto qualcosa di estremamente prezioso. L’ho continuato a leggere come un “vademecum” senza precetti: un “vade cum altero” di una storia d’amore senza fine.
N.A. Monica tu ti dici ancora anarchica. Il pensiero anarchico è spesso travisato, ma ci sono di fatto varie correnti e tanti “cani sciolti”, come dicevamo un tempo. Negli anni 70 il tuo impegno politico era in campo libertario e non violento prima ancora che femminista. Ne parleresti spiegando come lo conciliavi con lo sport che praticavi?
M.G. L’impegno politico è scaturito dai tempi in cui mi è stato dato di vivere. La criminalizzazione tout-court degli anarchici riguardo ai tragici eventi del 12 dicembre 1969 mi spinse, sull’onda di una controinformazione che metteva a nudo evidenze sconcertanti e inoppugnabili verità di fatto (l’assassinio-suicidio del ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli), per essere considerata una strage di stato, a conoscere di persona anarchici e anarchiche e a frequentare i luoghi di discussione e di lotta del movimento.
I l “mio” ’68, però, è stato il ’77 e del femminismo mi prese non tanto la vena emancipazionista dell’uguaglianza con gli uomini, bensì l’anima della libertà femminile che affermava: il privato è politico. Fu un’asserzione dirompente da cui prese origine il femminismo italiano della differenza. Come ho cercato di spiegare all’inizio di questa nostra conversazione, non mi ponevo il problema di essere in sintonia tra un ambito e l’altro; sport e impegno politico.
N.A. Come altri volevi un mondo migliore, ma ci fu quella vicenda del carcere e ti ha cambiato immagino.
M.G. Non c’è stato nessun rinnegamento in seguito alla ⇨ vicenda del carcere. Le istituzioni totali, carcere compreso, sono state l’ambito in cui il mio impegno politico si è manifestato intensamente negli anni 70. Da Niente più sbarre – il collettivo che si era costituito a Livorno per denunciare, diciamo eufemisticamente, i soprusi e le violenze subite dai detenuti, molti dei quali erano o si definivano detenuti politici – l’esperienza si prolungò con l’andare dietro le sbarre. Da quell’esperienza ho imparato molto. Nel bene e nel male come ogni esperienza anche quella mi ha dato qualcosa in più e qualcosa in meno di quanto l’immaginazione un po’ esaltata mi aveva lasciato credere, con le implicite aspettative fantasmatiche, appunto. Nessun pentimento, credimi. Il guadagno ricavato da quella vicenda lo esprimo in questi termini: il mondo non cambia se non cambia il proprio rapporto con il mondo.
N.A. In Sud Africa durante un torneo scendesti in campo con una maglietta particolare: piedi bianchi e neri sovrapposti come di due che facessero l’amore. La reazione del pubblico fu negativa e così ci fu una protesta della federazione sudafricana con conseguenze al ritorno in Italia. Ma vorrei chiederti visto che erano presenti campioni come Arthur Ashe e Evonne Goolagong se puoi dirci come venivano trattati loro e se pur essendo ammessi al torneo erano però isolati o invece no. Hai avuto l’impressione di essere stata la sola ad essere infastidita da quel pensate clima di segregazione?

M.G. ⇨ Evonne Goolagong era la numero uno e Arthur Ashe tra i primi tre del mondo e su questo riscontro gli altri giocatori li rispettavano e su questo dato di fatto erano conformemente trattati dagli organizzatori di ogni torneo a cui loro partecipavano, qualunque fosse il paese dove la competizione si svolgeva.

All’open di Johannesburg fu Arthur Ashe a rifiutare l’invito della Federazione sudafricana per protesta contro il regime razzista del paese. La Goolagong, in quanto componente della squadra australiana, si limitò a giocare la Federation’s Cup che si svolse la settimana successiva al torneo. Non posso dire diversamente per quanto era dato vedere in ambito pubblico; ma vai a sapere cosa passava nel privato…
 Il pesante clima di segregazione lo riscontrai nelle strade e nell’ambiente familiare delle abitazioni dove le giocatrici, me compresa, erano ospiti gradite e ambite; lo riconobbi dalle scritte che stigmatizzavano l’uso dei gabinetti per bianchi e neri; nella proibizione per la gente di colore di salire sui mezzi pubblici a disposizione dei soli bianchi; nel divieto assoluto per un essere umano dalla pelle nera di trascorrere la notte sotto lo stesso tetto di un essere umano dalla pelle bianca; dal modo di trattare i domestici neri tutto-fare-sempre-obbedire-niente-parlare nelle case dei ricchi.
Il pesante clima di segregazione lo riscontrai nelle strade e nell’ambiente familiare delle abitazioni dove le giocatrici, me compresa, erano ospiti gradite e ambite; lo riconobbi dalle scritte che stigmatizzavano l’uso dei gabinetti per bianchi e neri; nella proibizione per la gente di colore di salire sui mezzi pubblici a disposizione dei soli bianchi; nel divieto assoluto per un essere umano dalla pelle nera di trascorrere la notte sotto lo stesso tetto di un essere umano dalla pelle bianca; dal modo di trattare i domestici neri tutto-fare-sempre-obbedire-niente-parlare nelle case dei ricchi.
 La storia della maglietta la pensai e me la preparai prima di partire. Sapevo che il centrale di Johannesburg aveva un settore degli spalti riservato ai Black Peoples, una vera e propria gabbia con tanto di recinto e mi promisi di presentarmi con il messaggio d’amore dipinto in bianco e nero sulla maglietta. Il caso volle che per sorteggio la squadra italiana di Federation’s Cup dovesse incontrare al primo turno quella australiana e con ciò l’assegnazione del campo centrale per la disputa degli incontri. Non mi lasciai certo sfuggire la fortunata coincidenza di poter indossare la maglietta e rivolgere direttamente con un saluto al pubblico del settore black, prima di iniziare l’incontro con la giocatrice aborigena che, per forza o per amore, si accingeva a giocare nel Sudafrica dell’apartheid.
La storia della maglietta la pensai e me la preparai prima di partire. Sapevo che il centrale di Johannesburg aveva un settore degli spalti riservato ai Black Peoples, una vera e propria gabbia con tanto di recinto e mi promisi di presentarmi con il messaggio d’amore dipinto in bianco e nero sulla maglietta. Il caso volle che per sorteggio la squadra italiana di Federation’s Cup dovesse incontrare al primo turno quella australiana e con ciò l’assegnazione del campo centrale per la disputa degli incontri. Non mi lasciai certo sfuggire la fortunata coincidenza di poter indossare la maglietta e rivolgere direttamente con un saluto al pubblico del settore black, prima di iniziare l’incontro con la giocatrice aborigena che, per forza o per amore, si accingeva a giocare nel Sudafrica dell’apartheid.
Non so precisarti se la contenuta esclamazione di un Oh! che percepii da tutto il pubblico avesse avuto un timbro di disappunto, mi sembrò di meraviglia. Ma quello che mi rimprovero, e a cui allora non pensai neppure, è che forse avevo messo in imbarazzo proprio quelle persone a “favore” delle quali stavo manifestando. Ma la cosa è andata così e se così è andata è così che doveva andare, con tutti i ma, i se e le relative conseguenze, anche quelle disciplinari.
N.A. Nel 2012 ha fatto parlare di sé una giovane tennista Laura Robson, indossando agli Australian Open un nastrino tra i capelli dei colori dell’arcobaleno in solidarietà gay friendly. Eppure si ha l’impressione che ormai prevalga sempre lo spettacolo. Grandi rischi in quel circuito privilegiato non sembra ne corra nessuno.
M.G. Si, l’impressione che hai l’ho riscontrata anch’io ai miei tempi. Difficile uscire dal proprio tornaconto… Mi viene in mente la scelta opportunistica dei dirigenti e dei giocatori italiani a disputare e vincere – per la prima e finora unica volta – la finale di Coppa Davis in Cile (qualificatosi perché la squadra australiana o quella statunitense, non ricordo, si era ritirata dalla semifinale per protesta), proprio all’indomani dell’uccisone di Allende per mano dei generali golpisti capeggiati da Pinochet. Ma come tu stessa riporti non mancano mai del tutto, anche all’interno del più assodato ambiente conformista esempi di rottura, di crepature che lo rimettono in discussione. Poi vai a sapere quando il cuore è puro? Forse nell’amore che non ci corrisponde, in quell’amore che sbrigativamente diciamo illecito…
N.A. Viaggiavi, vedevi il mondo, partecipavi ai grandi tornei dello Slam ma come vivevi quell’ambiente? Era diverso da come appare oggi o in germe c’era già questa competitività sfrenata? A volte ha avuto risvolti tremendi; penso al caso delle tenniste bambine, Andrea Jager e Jennifer Capriati e poi al caso di Monica Seles. Ecco la Seles per esempio ha saputo riprendere in mano la sua vita e reagire anche alla paura del dopo attentato. Le ci è voluto tempo. Andrea invece si è fatta suora dopo avere raccontato le violenze del padre che quando non vinceva la riempiva di botte. Nè le donne sono state le sole a subire coercizioni; Andre Agassi non ebbe un buon rapporto col padre padrone.
M.G. Lo vivevo con una certa estraneità: per esempio non ho mai partecipato alle feste di gala di Wimblendon o alle ufficialità di qualsiasi altro torneo; me la svignavo sempre con qualche scusa. Vedi il mio difetto di essere un po’ orsa, lupa nella steppa, è anche la mia idiosincrasia: non sentirmi mai del tutto a mio agio negli ambienti sociali rappresentativi, anche in quelli connotati con un’etichetta politica. Sono anarchica per natura prima di esserlo per appartenenza ideale. L’ambiente del tennis era per me il campo da tennis. Non mi sono mancate tuttavia le amicizie; per esempio quella con Lea Pericoli, impensabile se si tiene conto delle diversità di carattere, di storie personali, di ambizioni, di percezioni della realtà che intercorrono tra noi due, ma è proprio lì, nella diversità che può nascere l’amicizia, lì dove non te l’aspetti…

Il tennis, come ti ho detto, mi è stato trasmesso dalla passione che mio padre aveva per lo sport. Considerava lo sport una scuola per imparare ad accettare nella vita le dure sconfitte più che a raggiungere facili vittorie. Ricordo il suo ammonimento: non importa se perdi, l’importante è che tu abbia giocato bene e abbia dato fino in fondo tutto quello che potevi. Insomma, mi insegnava ad essere generosa. Sicuramente gli devo la convinzione che il guadagno sta già nella spesa.
Lo so che i rapporti con il proprio padre e la propria madre sortiscono nei figli e nelle figlie reazioni e recriminazioni del tutto singolari, ma mi sembra ingiusto riconoscere soltanto la parte dolorosa e di duro sacrificio di un’esperienza, sentirsi vittime pur avendo raggiunto successi che consentono evidenti privilegi.
L’incremento odierno della competitività nel circuito tennistico, imparagonabile all’agonismo dilettante che si viveva ai miei tempi, credo sia dovuta ad un incremento direttamente proporzionale all’espansione mediatica, pubblicitaria, in definitiva al giro d’affari, di denaro e di potere che ruota intorno allo sport in genere e al tennis in particolare. Non ho il polso per valutare dal di dentro cos’altro passi in altri termini.
N.A. Tra le campionesse in campo avevi un modello? E chi hai ammirato di più nel tempo? Gianni Clerici parla di te come di un’indimenticabile attaccante.
M.G. Maria Esterita Bueno, la campionessa brasiliana che, fin dagli anni ’50, impresse al tennis non solo femminile ma anche maschile, il serve and volley.
Per la determinazione e la forza di non cedere fino all’ultimo punto, Lea Pericoli.
Mi difendevo dal pesante, soprattutto per me che ero mingherlina, gioco da fondo campo, attaccando a rete. Cercavo di rubare il tempo all’avversaria, di romperle il ritmo, sfruttavo la mia velocità di corsa e di slancio, unita all’effetto sorpresa: le avversarie non si aspettavano tanto ardimento. Insomma, potrei parafrasare con una sortita mutuata dalla mistica: “dov’era il mio meno, nacque il mio meglio”…
N.A. Cosa ti fa impugnare ancora la racchetta? E se posso chiederlo così, in coda, non soffri mai di nostalgia?
M.G. Il piacere di giocare, se la mia provata schiena me lo permette. No, non soffro di nostalgia colma di rimpianto. Ma di nostalgia felice sì, ne godo ancora.




 a cura di Kate Willman
a cura di Kate Willman


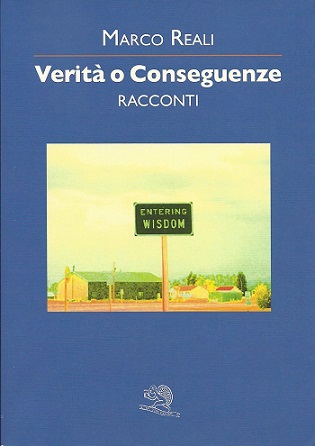

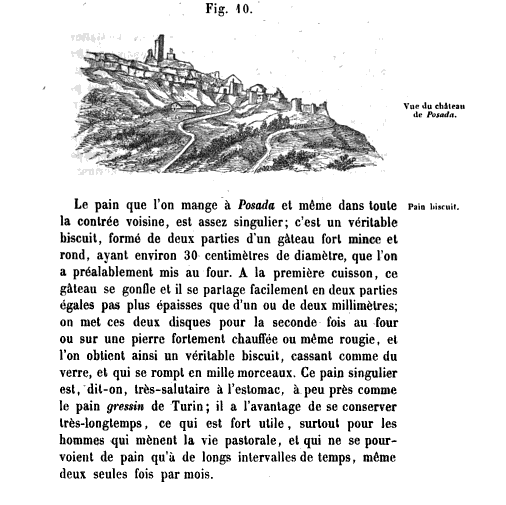



 Nel duemilatrentacinque la Terra potrà riconoscere sulla propria groppa una sola enorme città: Metropoli. Sarà essa il solo ganglio della poststoria, il solo confine alle lande desolate che s’apriranno maestose quando tutto sarà azzerato, quando nel cielo, perpetuamente crollante di piogge, starà crocefisso, come una misera “palla incolore”, “il sole artico del mondo pietrificato”.
Nel duemilatrentacinque la Terra potrà riconoscere sulla propria groppa una sola enorme città: Metropoli. Sarà essa il solo ganglio della poststoria, il solo confine alle lande desolate che s’apriranno maestose quando tutto sarà azzerato, quando nel cielo, perpetuamente crollante di piogge, starà crocefisso, come una misera “palla incolore”, “il sole artico del mondo pietrificato”.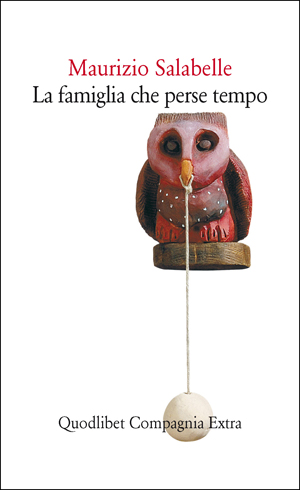 di Marisa Salabelle
di Marisa Salabelle
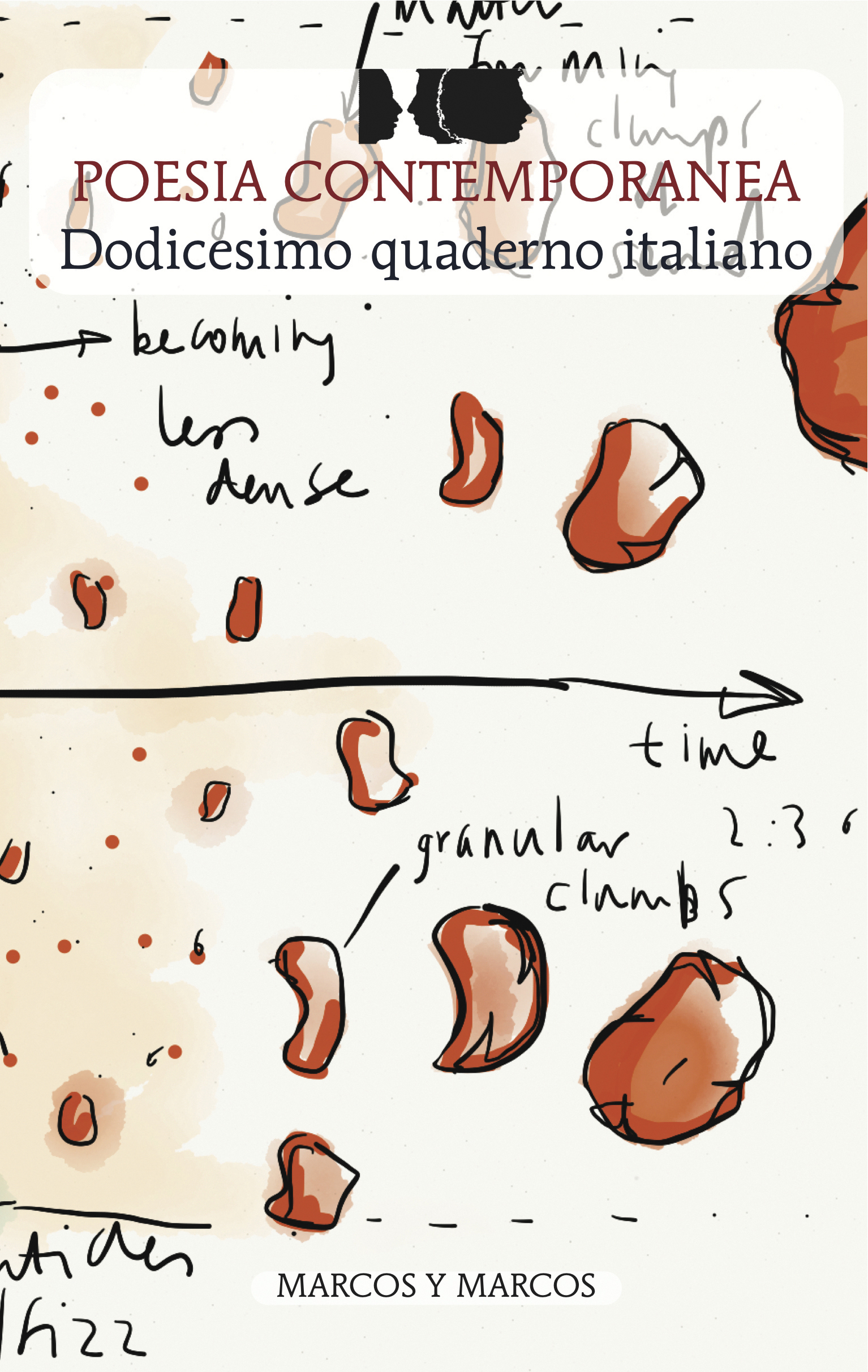
 di Francesca Fiorletta
di Francesca Fiorletta 
 di Federico Pevere
di Federico Pevere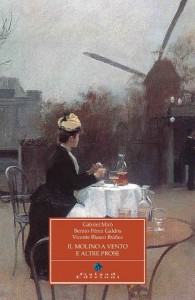
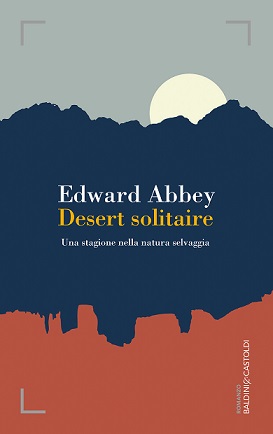
 di Mariasole Ariot
di Mariasole Ariot