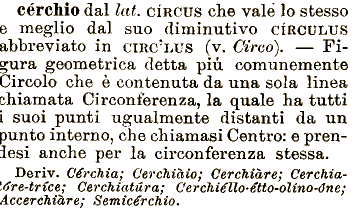(Ricevo e volentieri pubblico questo testo – espressione del comune sentire di un gruppo di lavoro di studiosi di differenti discipline storiche – che è stato redatto con il contributo di Roberto Alciati, Leonardo Ambasciano, Luca Arcari, Sergio Botta, Francesco Cassata, Cristiana Facchini, Enrico Manera, Emiliano Rubens Urciuoli. G.B.)
(Ricevo e volentieri pubblico questo testo – espressione del comune sentire di un gruppo di lavoro di studiosi di differenti discipline storiche – che è stato redatto con il contributo di Roberto Alciati, Leonardo Ambasciano, Luca Arcari, Sergio Botta, Francesco Cassata, Cristiana Facchini, Enrico Manera, Emiliano Rubens Urciuoli. G.B.)
Ma qui vale attirare l’attenzione anche sull’opera distruttrice che l’ebraismo, così come secondo le disposizioni dei “Protocolli”, ha effettuata nel campo propriamente culturale, protetto dai tabù della Scienza, dell’Arte, del Pensiero. E’ ebreo Freud, la cui teoria s’intende a ridurre la vita interiore ad istinti e forze inconscie, o a convenzioni e repressioni; lo è Einstein, col quale è venuto di moda il “relativismo”; […] lo è lo Stirner, il padre dell’anarchismo integrale e lo sono Debussy […], Schönberg e Mahler, principali esponenti di una musica della decadenza. Ebreo è Tzara, creatore del dadaismo, limite estremo della disgregazione della cosidetta arte d’avanguardia, e così sono ebrei Reinach e molti esponenti della cosidetta scuola sociologica, cui è propria una degradante interpretazione delle antiche religioni.
Julius Evola, Introduzione a I “Protocolli” dei “Savi Anziani” di Sion, (terza edizione, 26°- 35° migliaio), La Vita Italiana, Roma 1938 (datata settembre 1937), pp. XXV-XXVI
Stanno accadendo alcune cose in un contesto molto specifico della cultura italiana, apparentemente marginale e poco rilevante, che sono però sintomatiche e forse paradigmatiche di alcuni processi culturali in corso nella nostra società.
In una lettera redatta in inglese e inviata alle mailing list della European Association for the Study of Religion (EASR), sigla che include il gotha della storia delle religioni europea, un professore italiano, vicepresidente di quella stessa associazione e membro del consiglio direttivo dell’organizzazione federata italiana (SISR), pubblicizza un convegno dedicato all’«eredità» culturale di un noto esoterista, fascista e propagandista antisemita italiano del secolo scorso: Julius Evola (1898-1974). Nel testo della mail si accredita Evola come studioso di calibro, autore di pubblicazioni notevoli nel campo della storia delle religioni, e si invita alla rivalutazione del suo lavoro senza animosità né pregiudizi, per assegnargli finalmente il posto che merita nella storia della storiografia. L’intento dichiarato è quello di riabilitare accademicamente e scientificamente le opere dedicate alle religioni e al religioso di un pensatore fascista.
Per comprendere il tipo di operazione che si è svolta a Roma il 29 novembre scorso, è utile fornire qualche informazione sul contesto in cui si è celebrato il convegno. Patrocinato da un folto gruppo di logge massoniche, l’incontro è organizzato da un centro studi sulle «scienze ermetiche» che nella sua «mission», improntata alla tolleranza universale e a un umanesimo spiritualizzante, menziona per ben due volte l’intento di affratellare le diverse «razze umane». La presentazione del convegno è affidata a un cerimoniere dai titoli altisonanti che si diffonde sul valore culturale del pensiero evoliano «a prescindere dai suoi presunti [sic] orientamenti politici, più o meno condivisibili [sic]». L’opacità di questa breve e retorica contestualizzazione della figura di Evola nella storia italiana risulta evidente al lettore esperto. Last but not least, il convegno è organizzato in collaborazione con la Fondazione Julius Evola, un ente notoriamente lontano dall’interrogazione critica del pensiero dell’eroe cui è dedicata.
Intendiamoci: in un regime democratico e liberale un’operazione del genere è legittima, nella misura in cui, entro i limiti di legge, chiunque può studiare ciò che vuole e organizzare simposi anche stravaganti. In questo caso, un problema serio di opportunità si pone, però, se tra i relatori figurano diversi docenti di discipline differenti che insegnano nelle università italiane. Non per nulla l’iniziativa, pubblicizzata nell’ambito degli studi religionistici, ha scatenato un putiferio presso la comunità scientifica internazionale informata dell’evento. L’autore di un importante volume sullo studio della religione in ambito accademico sotto il fascismo interbellico ha immediatamente risposto censurando una riabilitazione mascherata da interesse storico-storiografico, additandone la continuità con alcuni passati tentativi “alchemici” di filtraggio dello studioso serio dall’ideologo fascista e antisemita e richiamando al carattere esausto (oltre che molesto) di questo genere di iniziative.
Altre mail sono seguite, più o meno ostili all’iniziativa: alcune, tra cui un paio provenienti da studiosi di fama e calibro mondiali, gridano apertamente allo scandalo, altre cercano di gettare acqua sul fuoco, altre ancora mostrano di condividere l’atteggiamento metodologico difensivo per cui si tratta di saper distinguere il valore (scientifico e culturale) dell’opera dall’eventuale disvalore dell’uomo. Il parallelo apologetico, prevedibile quanto ormai logoro, con le vicissitudine politiche di Martin Heidegger e Carl Schmitt è stato puntualmente utilizzato dall’estensore della lettera iniziale.
Lo scambio epistolare elettronico si fa a questo punto articolato e complesso, ma la questione che ci sentiamo di sollevare concerne la situazione storico-culturale in cui questo episodio si inscrive e di cui è al tempo stesso sintomo e paradigma. Durante il lungo ventennio berlusconiano, nell’accademia italiana si sono aperte le porte della redenzione al pensiero pseudoscientifico, pseudostoriografico e antimodernista: un processo sottilmente revanscista che ha accompagnato le ben più crasse riabilitazioni promosse o tollerate dai governi di centro-destra. In pratica, ciò che prima non poteva essere messo per iscritto perché svergognatamente ideologico, è stato possibile dirlo e farlo passare come rispettabile risultato di una volenterosa pratica storiografica. Nella storia delle religioni italiana si è assistito così all’ingresso prepotente di ogni sorta di infiltrazione metafisica, filoesoterica e perennialista: una paradossale reazione contro quell’unica accademia europea che aveva da sempre coerentemente sviluppato ed espresso i corretti anticorpi storicisti contro le prospettive ermeneutico-fenomenologiche destrorse, irradiantisi dalla figura controversa di uno studioso pur importante e significativo come il romeno Mircea Eliade.
Ma torniamo all’oggetto dello scandalo. Chi è Julius Evola?
Nato a Roma nel 1898, ha una educazione filosofica ed estetica tipica per il periodo e un’attività giovanile di pittura dadaista. Ufficiale nella Grande guerra, è turbato dai cambiamenti dovuti all’impatto della società di massa su quello che restava dell’ancien régime europeo. Nel dopoguerra arriva l’“illuminazione” con la scoperta di uno spiritualismo di marca indoeuropea che si associa alla speculazione filosofica del più spinto irrazionalismo tedesco. In Teoria e fenomenologia dell’individuo assoluto, 1927-1930 compaiono gli elementi caratteristici del suo pensiero: una sintesi di metafisica ottocentesca, esoterismo e spiritualismo. Frequenta circoli mistico-magici, collabora con riviste del settore («Ultra», «Ignis», «Atanor»). Interessato al fascismo italiano e alla romanità, ne critica la vicinanza con il cattolicesimo (1928, Imperialismo pagano), per poi fondare la rivista «La Torre», votata a un fascismo eroico e aristocratico. Apprezzato in Germania, Evola non farà breccia nella profana, essoterica e provinciale mentalità fascista, per poi venire riscoperto dal neofascismo esoterico post-bellico.
Per tutti gli anni trenta si dedica a ricerche sul mondo dei simboli, sullo spiritualismo, sull’alchimia e pubblica su riviste del fascismo intransigente e antisemita («La Vita Italiana» e «Il Regime Fascista») articoli legati a una visione del mondo antiborghese e cavalleresca. Nel 1934 pubblica Rivolta contro il mondo moderno, nel 1937 Il mito del sangue, nel 1941 Sintesi di dottrina della razza. Nel 1938 in Romania incontra, ammirato, Corneliu Codreanu, leader della Guardia di ferro, il movimento paramilitare fascista cristiano integralista, violentemente antisemita, dedicato all’arcangelo Michele.
Dopo la scoppio della guerra chiede di partire volontario a combattere contro l’Unione sovietica, ma non viene arruolato. Nel 1943, in Germania, sarebbe tra i pochi italiani che ricevono Mussolini liberato dal Gran Sasso. Collaboratore del Sichereitsdienst (SD), il servizio di sicurezza delle SS, aderisce alla RSI su posizioni aristocratiche e reazionarie. Vive le ultime fasi della guerra come lo scontro dei custodi della “Tradizione” e dello “Spirito” occidentale contro le forze materialiste e corrotte delle odiate democrazie europee e dei partigiani attivi nei movimenti di liberazione.
In seguito a un bombardamento su Vienna rimane paralizzato agli arti inferiori. Tornato a Roma trova lo spirito legionario per sostenere ideologicamente i movimenti della destra italiana con il testo Orientamenti (1950), pubblicato sulla rivista Imperium. Nei documenti giudiziari è indicato come il “padre spirituale” del gruppo che sotto il nome di Far (Fasci di azione rivoluzionaria-Legione nera) nei primi anni cinquanta mette a segno attentati dinamitardi nella capitale: tra i personaggi coinvolti figurano noti rappresentanti dell’Msi. Il 1953 è l’anno del fondamentale Gli uomini e le rovine, in cui trovano posto i consolidati concetti di tradizione, gerarchia e diseguaglianza. Di fronte a una modernità che erode le fondamenta e distrugge l’ordine sociale, il credo politico esposto consiste nella restaurazione di un ordine tradizionale e gerarchico per mano del soldato politico in piedi tra le rovine del mondo occidentale. Dopo Cavalcare la tigre (1961), nel 1963 pubblica Il Fascismo visto dalla Destra, in cui attribuisce al fascismo il merito di aver rivitalizzato antichi simboli e di aver teorizzato un nuovo tipo di uomo. A partire dal 1968 verrà venerato da giovani discepoli, che riconoscono in lui un “Maestro” (e che ne sono ancora oggi i divulgatori). Nel 1974, dopo ulteriori difficoltà cardiache, muore a Roma.
Dopo la morte, Evola è rimasto punto di riferimento costante per tutte le realtà della destra radicale. Nel 1998 il suo centenario è stato riccamente celebrato dall’intera destra italiana: libri, mostre, convegni, centinaia di pagine web sono a lui dedicati. È un autore di culto anche per l’euroasiatismo ed è di interesse per alcuni ambienti di fondamentalismo islamico.
Tutto questo è, in estrema sintesi, l’Evola uomo, pensatore e mito politico che un certo bipolarismo metodologico, ricorrente nelle scienze umane, vorrebbe separare dallo studioso di religione/i con il cordone sanitario della bibliografia promossa, citata, edita e riedita in genere dagli stessi impresari del suo successo. Ma chi è l’Evola storico delle religioni?
Nella sua opera si trovano soggetti e principi espressi dal perennialismo esoterico di René Guénon (cicli storici, crisi della modernità, simbolismo) che appaiono estremizzati e politicizzati in direzione di un differenza qualitativa tra mondo moderno e mondo tradizionale. Quest’ultimo è caratterizzato dalla dimensione spirituale: come tale non è affrontabile con i concetti validi nel consueto spazio-tempo e dunque non può essere adeguatamente studiato con il metodo storico. Laddove autorevoli storici delle idee sostengono che il pensiero evoliano non abbia prodotto nulla di significativo in termini di conoscenza e guadagno scientifici, chi ne raccoglie l’eredità invece esalta il valore delle varie monografie su argomenti come ermetismo, tantra, buddhismo, taoismo, alchimia, Sacro Graal.
Ora, Evola certamente conosceva la vasta produzione letteraria in materia tra ‘800 e ‘900. Nella sua opera si trovano continui riferimenti ai miti di una età aurea, di una “Tradizione” primordiale, di Iperborea, di Atlantide e in particolare di una civiltà nordica portatrice di una superiore spiritualità “maschile” e “solare”, contrapposta a tratti “femminili” e “lunari” di rango inferiore. La spiritualità nordica è per lui espressione della razza “aria”, aristocratica e guerriera, «dello spirito», un argomento che si affianca all’esaltazione di un modello sapienziale “eroico”: da qui il valore sacrale degli archetipi e dell’azione, la centralità degli aspetti magici del reale e il fascino per i presunti poteri paranormali esperibili dai più “elevati” spiritualmente.
Tali dati relativi a un sapere ermetico ed erudito non avevano pertinenza storico-storiografica rispetto ai criteri standard dei termini: si tratta piuttosto di veri e propri “materiali mitologici”, su cui la storia della storiografia ha effettivamente e legittimamente molto da dire e da indagare, per mettere in luce i pregiudizi ideologici e gli interessi pratici degli autori che se ne occupavano, come su Evola è stato fatto da studi storici solidi e documentati, non suscettibili di fascinazione per l’oggetto della loro ricerca. Il punto che intendiamo sottolineare è che proprio nei lavori dell’Evola “storico delle religioni” si produce – a detta dei suoi stessi apologeti – una “rottura di livello” sul piano ermeneutico, che non può essere accettata senza problemi da chi non ne condivida i presupposti metafisici. Evola deve essere cioè considerato a partire da un “neo-paganesimo” teorizzato, creduto e, per così dire, “praticato”. I suoi lavori tradiscono infatti una chiara intenzione pragmatica, cioè una funzione indistinguibile dalla riflessione politica e dal razzismo nel segno della rivoluzione conservatrice. Sono appunto quegli studi che, violando i principi elementari dell’epistemologia scientifica dell’antropologia e della storia, ne hanno fatto un punto di riferimento per il neofascismo e le destre radicali; e da questo punto di vista è noto come la teoria evoliana dell’azione abbia influenzato i protagonisti dell’eversione “nera” nella storia politica italiana.
Come tutto questo, se anche fosse possibile prescindere dal nazismo e dall’antisemitismo di Evola, sia compatibile con uno studio scientifico della religione, è davvero per noi un mistero. Non lo è invece il fatto che la storia delle religioni italiana attraversa da anni una profonda crisi, teorica e metodologica: zavorrata da simili ipoteche – responsabili di un tentativo di indottrinamento all’apprezzamento del paranormale, del sovrannaturale e persino delle ideologie di destra estremista – la ricerca accademica in chiave localistica e antiscientifica ha raggiunto livelli di retroguardia allarmanti.
Se torniamo al nostro scambio di lettere iniziale e lo prendiamo come segnale di un incendio, vediamo ora chiaramente che qui è in corso un tentativo di ammantare di rispettabilità scientifica uno dei principali esponenti del fascismo e dell’antisemitismo del secondo dopoguerra da parte di docenti delle università di stato, alcuni dei quali sono anche rappresentanti di importanti associazioni di settore e tradiscono rapporti di promiscuità intellettuale con controverse figure dell’estrema destra nostrana. Questi intellettuali, che come tutti gli accademici sono anche responsabili dell’avanzamento delle carriere e dell’accreditamento di giovani ricercatori, insegnano, fanno didattica, propagano idee: formano cervelli e persone. In quanto studiosi, crediamo che l’università sia costituita in primo luogo dalle comunità di ricerca che vi lavorano e dagli studenti che la popolano, pagano le rette e meritano di accedere a un sapere critico, intellettualmente onesto, fondato scientificamente ed epistemologicamente, ancorato ai valori costituzionali e antifascisti della Repubblica italiana.
A fronte di tutto questo, riteniamo che l’episodio che viene qui raccontato sia molto grave e tale da sollecitare il mondo accademico italiano, in primis i docenti afferenti al settore disciplinare direttamente coinvolto, a prendere posizione con sollecitudine e forza, perché l’istituzione universitaria non risulti più compromessa con iniziative para-scientifiche di analoga ambiguità.
 Non riesco ad uscire da questo disordine. Un laccio mi tiene stretto al ricordo.
Non riesco ad uscire da questo disordine. Un laccio mi tiene stretto al ricordo.




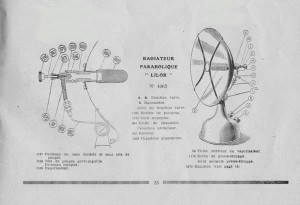






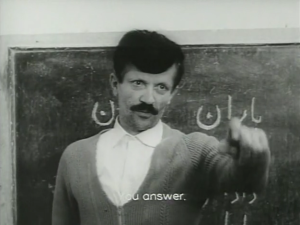





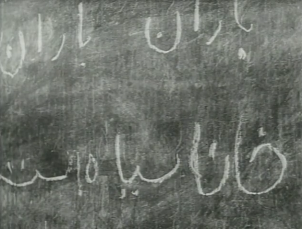










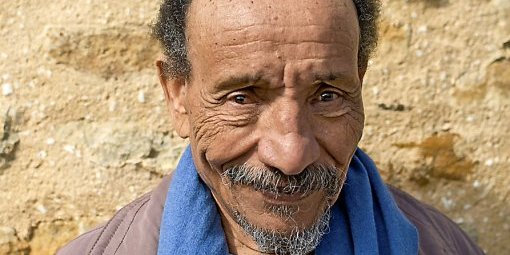


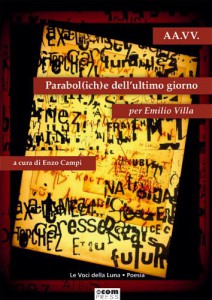 serata di
serata di