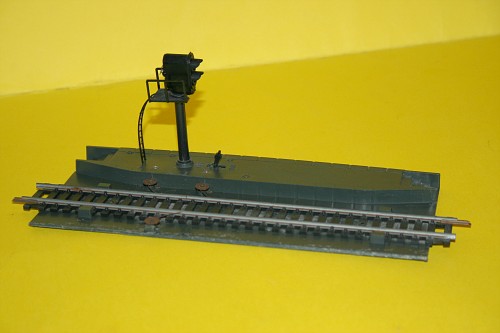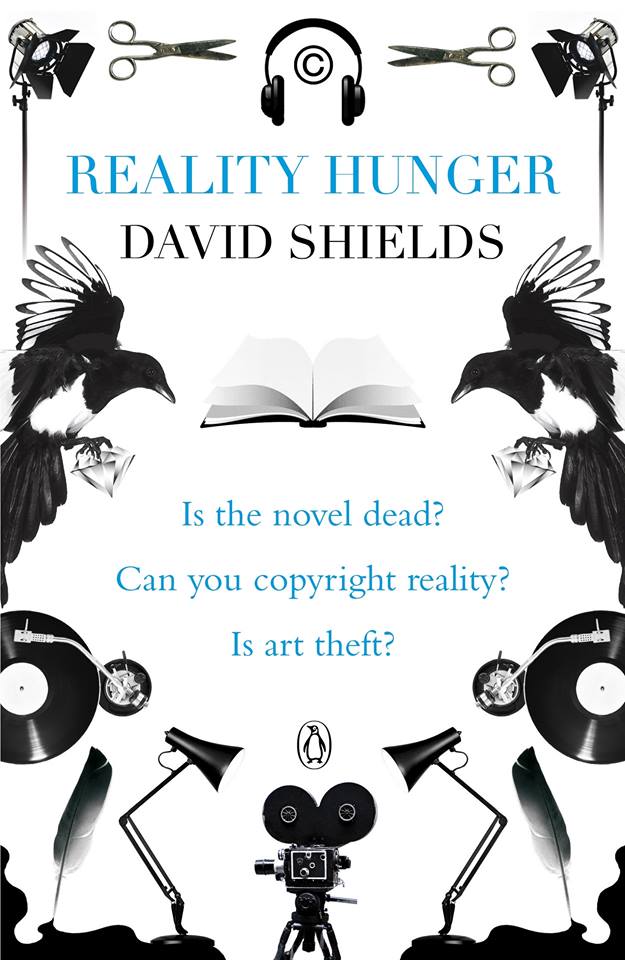di Giorgio Mascitelli
Nell’incantevole località marittima nella quale ho soggiornato recentemente campeggiavano manifesti annunzianti perentoriamente una grigliata danzante prevista sia per il sabato sia per la domenica nella piazza del paese esclusivamente a base di musica e carni italiane. Devo confessare che mi ha trattenuto dal parteciparvi tutta una serie di ragioni, la più importante delle quali è il fatto che il sabato e la domenica in questione erano quelli immediatamente precedenti al mio arrivo, tuttavia il titolo del manifesto, recante la scritta a lettere cubitali ‘italian music’ in inglese, mi ha colpito. Scartata subito l’ipotesi che il manifesto si rivolgesse ai turisti stranieri, pure presenti, perché il testo anche nelle sue parti informative era scritto esclusivamente nella nostra lingua, sono restato alquanto sorpreso di una scelta simile. Certo la differenza tra italiano e inglese in questa espressione è veramente minimale, due a e un’inversione dell’ordine delle parole, e dunque comprensibile anche all’italofono più digiuno della lingua di Shakespeare, ma era per me sorprendente che si fosse sentito il bisogno dell’inglese per un’iniziativa che faceva leva sull’orgoglio nazionale, sia pure nelle forme relativamente innocue di tipo musicale e alimentare.
In realtà questa mia sorpresa non aveva ragione d’essere ed era tutt’al più un sintomo del mio perenne disadattamento: infatti gli organizzatori non avevano altra scelta che usare l’inglese. Solo un titolo in inglese poteva testimoniare che la manifestazione sarebbe stato un evento a tutto tondo del mondo contemporaneo e non un’attardata esibizione provinciale di cose ormai superate dal pericoloso sapore di papaveri e papere o di Marianne che vanno nelle campagne; solo così il turista desideroso di assaporare carni nostrane e tetragono alle musiche barbare avrebbe partecipato con la necessaria convinzione alla festa e con la confortevole sicurezza che fosse qualcosa di ben organizzato e serio. Insomma nell’era della globalizzazione qualsiasi contenuto per essere recepito favorevolmente deve rispettare determinati standard globali. Ciò naturalmente non toglie che esista quella contraddizione che ha fatto nascere in me il sentimento di sorpresa, anzi direi che questa contraddizione non riguarda solo gli organizzatori di feste di paese, ma anche tutti i settori della produzione culturale e artistica. Naturalmente quando si parla di campi della cultura più articolati simbolicamente questa contraddizione prende forme più complesse e certo non riconducibili con evidenza immediata a quella palese opposizione tra messaggio italiano e medium inglese o meglio globale del manifesto.
Proprio la globalizzazione, nonostante gli ultimi quindici anni di guerre violenze crisi ne abbiano minato l’immagine ottimistica tipica degli anni novanta, resta la principale leva simbolica della cultura contemporanea. La globalizzazione in quanto agente simbolico pone a ogni artista, a ogni scrittore e a ogni operatore culturale del nostro tempo una domanda subdola che suona così: “cosa hai fatto per essere globale?”. La domanda è subdola perché sembra suggerire che siano possibili varie gradazioni di risposte ( “ho fatto abbastanza”, “ho fatto qualcosa”, “non ho fatto molto, però in quella circostanza..” e così via), mentre effettivamente quella domanda contempla solo due risposte: tutto o nulla.
In verità nessuno può dare seriamente la risposta nulla perché i tempi non sono maturi, il pubblico non capirebbe e lo sventato che la desse si troverebbe nello spazio di un mattino retrocesso a poeta ufficiale della bocciofila dietro casa. Coloro che non hanno fatto nulla possono solo rispondere alla maniera dei somari a scuola che hanno trascorso il pomeriggio al parco anziché a fare i compiti “non sono stato bene, mi giustifico prof” oppure “non sapevo che ci fossero compiti per oggi”. L’ordine simbolico della globalizzazione è severo con i suoi fannulloni, ma anche chi ha fatto tutto porta la sua croce: innanzi tutto perché quel tutto non è mai abbastanza e in secondo luogo perché ci si accorge dopo un po’ che per aver fatto tutto per essere globali si finisce col non fare altre cose.
Non si tratta di dire chi ha ragione o chi è migliore, anche perché alla domanda che pone la globalizzazione non sempre si riesce a rispondere in maniera consapevole essendo una domanda subdola. Certo l’ordine simbolico della globalizzazione premia con la sua meritocrazia chi più si impegna nella sua diffusione, ma credo che questo non si possa definire in alcun modo qualcosa di nuovo sotto il sole, piuttosto è più interessante sottolineare la fondamentale unicità degli standard a cui tutti sono sottoposti.
Si può ipotizzare che l’ordine simbolico della globalizzazione nella problematica soggettiva dello scrittore o dell’artista agisca come una prevalenza simbolica di uno spazio che si vuole uniforme su un tempo sentito come irregolare e non lineare che procede per sbalzi. Il premio a sua volta simbolico di questa lotta contro quella che per comodità potremmo chiamare il peso della storicità è un sentimento di piena appartenenza al proprio tempo, una sorta di perfetta contemporaneità. Il problema è che questo sentimento di pienezza è a sua volta un inganno perché impedisce di cogliere certi tipi di sfumature che sono irrinunciabili nell’elaborazione di un senso simbolico dell’esperienza, che credo resti lo scopo dell’attività letteraria e artistica.
Ad esempio, per prendere in considerazione un’opera giustamente rinomata nel quadro della cultura internazionale, nel romanzo Le correzioni di Jonathan Franzen assistiamo a un autentico capolavoro di finezza nell’analisi dei sentimenti dei personaggi e della rappresentazione dei loro rapporti. Improvvisamente questa finezza in occasione dell’episodio di un viaggio del protagonista in Lituania cede il posto a una rozzezza caricaturale nella rappresentazione del paese quasi da pittoresco giornalistico. Ecco nello scarto tra il cesello della vicenda personale e la mannaia di una rappresentazione della Lituania ignara della sua storia si trova il prezzo pagato all’ordine simbolico della globalizzazione. Non si tratta certo di un errore letterario di un autore così scaltrito né di stigmatizzarlo moralisticamente, cosa sciocca e inutile, ma di rilevare che ciò che è estraneo all’ordine simbolico della globalizzazione può sussistere solo nella forma del pittoresco, ridicolo in questo caso, cioè in una forma letterariamente riduttiva o addirittura non letteraria.
Il problema che sollevo qui non è di tipo politico prescrittivo: occorrerebbe cioè una letteratura impegnata storicamente e politicamente al posto di una intimistica ( al contrario a me piace la letteratura intimistica e decadente, mentre penso che sia nella vita che si debba avere, per quel poco che i tempi concedono, un impegno storicamente consapevole); al contrario è un problema squisitamente estetico nel senso etimologico della parola. L’ordine simbolico della globalizzazione contempla solo alcuni elementi della realtà e nel contempo si autorappresenta come la totalità del contemporaneo o meglio, come ho già scritto, del qui e ora. Si tratta di una rappresentazione ideologica nel senso marxiano della parola ossia di un discorso volutamente incompleto, di un’autorappresentazione che lascia fuori molti tratti fondanti. E si sa quanto l’ideologia nuoccia alla produzione artistica e letteraria.
Ciò che tra l’altro resta fuori dall’ordine simbolico è proprio la percezione della storicità dell’esperienza umana e colui che l’avverte, non necessariamente in maniera progressiva o ottimistica, ma anche in chiave negativa o pessimistica, finisce proprio per non fare nulla per essere globale, naturalmente nel senso che a questa parola viene dato dall’ordine simbolico della globalizzazione così come essa è effettivamente oggi e non come potrebbe o dovrebbe essere. E’ un’esperienza frustrante quella del fannullone della globalizzazione perchè appunto gli viene negato perfino lo spazio simbolico del contestatore o del dissidente: egli è solo uno che si attarda su cose passate, come la storia, invece di godere dei vantaggi e delle possibilità pressoché infinite offerti dalle nuove tecnologie materiali e mentali.. E’ una condizione frustrante, ma dalla frustrazione talvolta nascono i fiori.




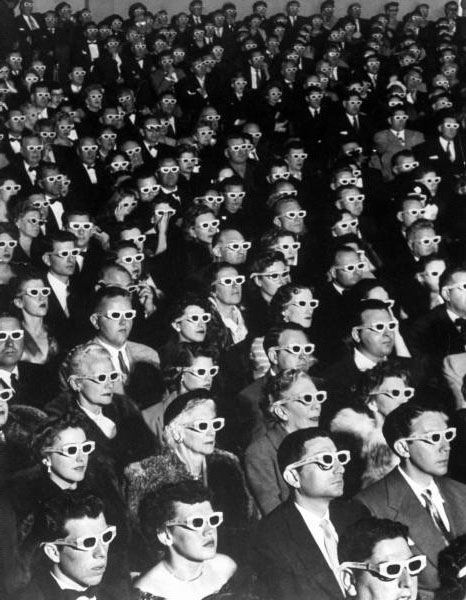
 La vita procede nonostante la crepa aperta sul limitare dell’estate: il tredicenne Edo, protagonista di Strategie per arredare il vuoto, esordio di Paolo Marino (già finalista al Premio Calvino e ora in libreria per Mondadori, pp. 227, euro 17) ha perduto i genitori e, com’è naturale in questi casi, la famiglia apre grandi ali per contenere il dolore e per offrire al ragazzo una nuova casa, quella di zia Selma e di zio Dante. Ma Edo con tenace pacatezza rifiuta, “preferirei di no” glossa, e fa spazio al silenzio che aggira spiegazioni e formule. Non è un atto della volontà presente a se stessa, come fu di Cosimo che per fuggire il piatto di lumache rampò sull’elce senza più discendervi; del Barone esprime l’insofferenza, non più viva ma catatonica, priva di spinte a uscirne; Edo, barricandosi, lascia fuori le parole eccessive e inutili dei parenti, l’esperienza del mondo, degli amici, la vita.
La vita procede nonostante la crepa aperta sul limitare dell’estate: il tredicenne Edo, protagonista di Strategie per arredare il vuoto, esordio di Paolo Marino (già finalista al Premio Calvino e ora in libreria per Mondadori, pp. 227, euro 17) ha perduto i genitori e, com’è naturale in questi casi, la famiglia apre grandi ali per contenere il dolore e per offrire al ragazzo una nuova casa, quella di zia Selma e di zio Dante. Ma Edo con tenace pacatezza rifiuta, “preferirei di no” glossa, e fa spazio al silenzio che aggira spiegazioni e formule. Non è un atto della volontà presente a se stessa, come fu di Cosimo che per fuggire il piatto di lumache rampò sull’elce senza più discendervi; del Barone esprime l’insofferenza, non più viva ma catatonica, priva di spinte a uscirne; Edo, barricandosi, lascia fuori le parole eccessive e inutili dei parenti, l’esperienza del mondo, degli amici, la vita.
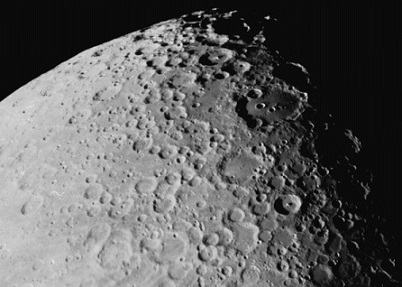






![da Les beaux draps (1941) trad. Giovanni Raboni e Daniele Gorret, in Mea Culpa. La bella rogna, Milano, Ugo Guanda, Milano 1982, 201 p. [coll. Biblioteca della Fenice, 44]](https://www.nazioneindiana.com/wp-content/2014/08/cèline-2.jpg)
![da Les beaux draps (1941) trad. Giovanni Raboni e Daniele Gorret, in Mea Culpa. La bella rogna, Milano, Ugo Guanda, Milano 1982, 201 p. [coll. Biblioteca della Fenice, 44]](https://www.nazioneindiana.com/wp-content/2014/08/céline.jpg)