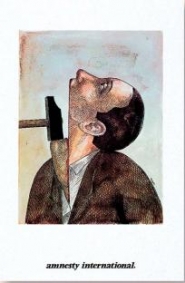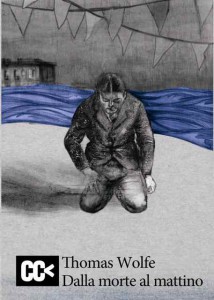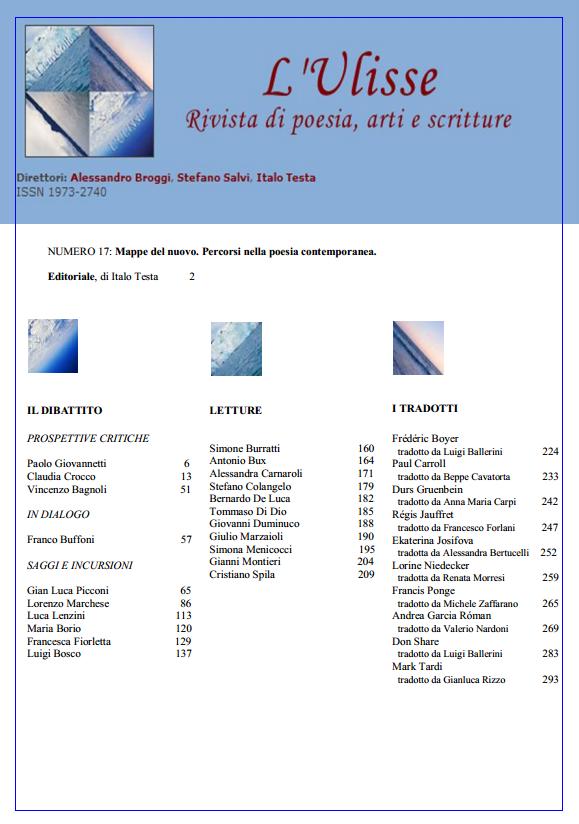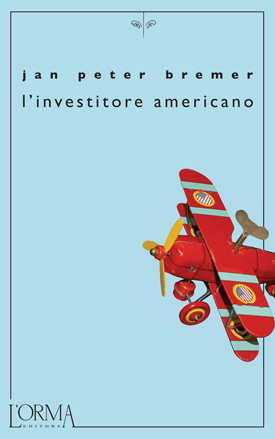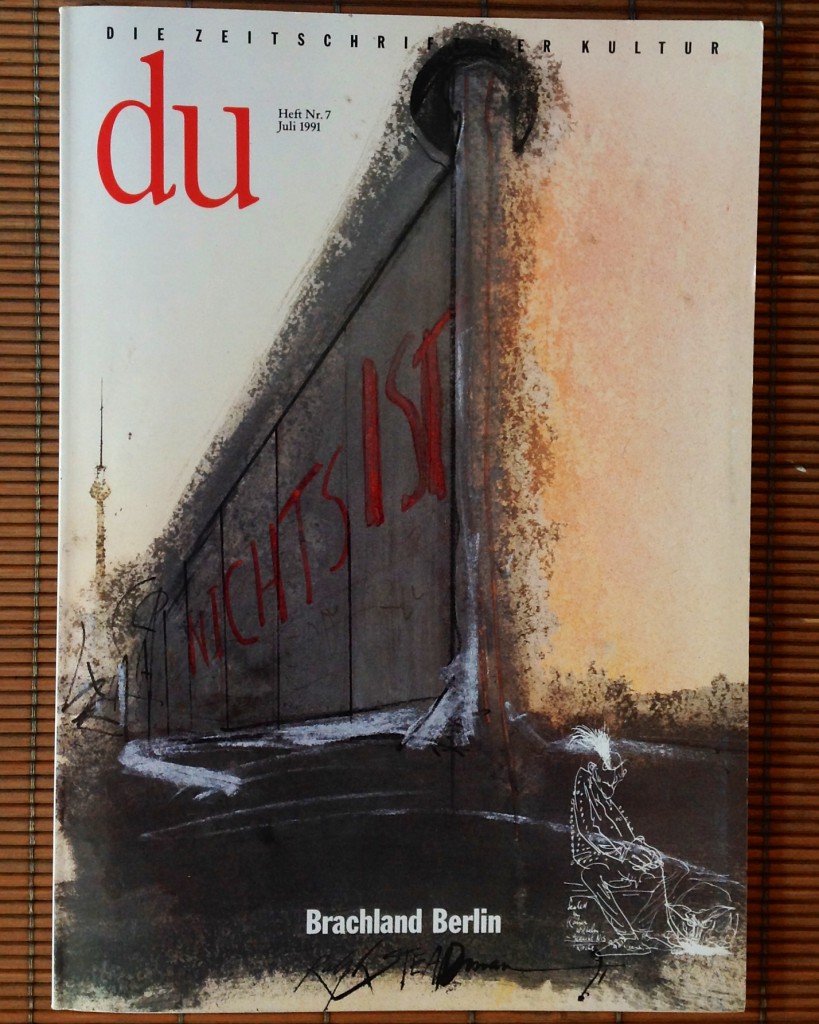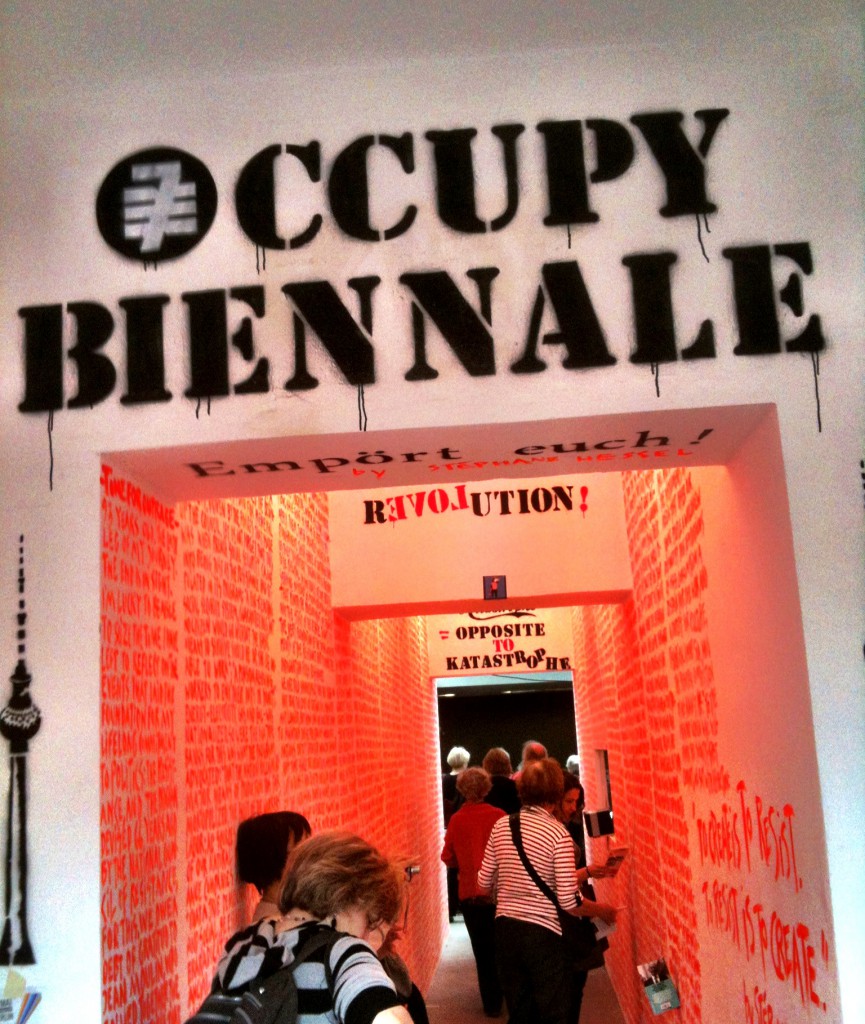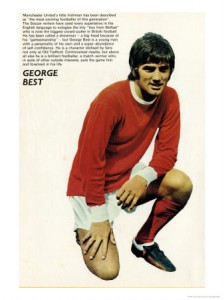di Enrico Calamai
(Igiaba Scego ci inoltra il testo dell’intervento di Enrico Calamai alla conferenza stampa che si è tenuta ieri, 10 luglio 2014, alla Camera. Calamai – ex diplomatico, durante gli anni dell’ultima dittatura argentina console a Buenos Aires, dove salvò centinaia di persone, e in seguito tra i fondatori del Comitato per la promozione e la protezione dei diritti umani – è membro del Comitato “Giustizia per i nuovi desaparecidos” che, durante la conferenza stampa, ha presentato un appello per la convocazione di un Tribunale Internazionale di opinione sui crimini perpetrati sulla pelle dei migranti viaggiatori. Qui potete leggere il testo integrale dell’appello: http://habeshia.blogspot.it. E questa è la mail del comitato: nuovidesaparecidos@gmail.com.)
E’ un fatto che negli ultimi settant’anni la comunità degli Stati ha elaborato un corpus giuridico in materia di promozione e tutela dei diritti umani, che è andato acquistando peso sempre maggiore nell’ambito del diritto internazionale. Ma è altresì un fatto che gli stessi Stati, nel loro elefantiaco funzionamento quotidiano, continuano a calpestarli. Ciò vale anche per le cosiddette democrazie avanzate del mondo occidentale e per la stessa Italia. E’ quanto accade, da troppo ormai, nei confronti di richiedenti asilo e migranti che, non dimentichiamolo, hanno anch’essi pieno titolo al rispetto dei loro diritti fondamentali e, in particolare, del diritto alla vita.
Furono gli albanesi i primi a subire increduli quel mix di astuzia, pregiudizio e forza che sarebbe culminato nell’affondamento di un loro barcone, con tutto il carico di umanità dolente, ad opera di una nave della nostra marina militare.
Ma sarebbe provenuta dal sud del mondo, attraverso l’altra sponda del Mediterraneo, mentre Bush senior vagheggiava di un nuovo ordine mondiale, la spinta che continuamente si rinnova e ancora spaventa l’Europa opulenta del nuovo millennio, al punto di farle annoverare l’immigrazione clandestina tra le principali minacce da cui difendersi, nell’ambito della politica di sicurezza comune. Ed è difficile, quando sono in alto mare o in mezzo al deserto, distinguere gli immigrati dai richiedenti asilo.
Intendiamoci, gli Stati hanno il dovere di difendere frontiere, coste e acque territoriali, specie in congiunture come quella attuale, caratterizzata da venti di guerra in Medio Oriente e ai confini dell’ex Unione Sovietica, hanno il diritto di dotarsi di leggi finalizzate al controllo dell’immigrazione, così come di stabilire accordi bilaterali con paesi di dubbia democraticità.
Da un punto di vista formale, senza entrare in questa sede nel merito dei singoli contenuti, ciascuna di queste attività normative o pattizie è lecita. Il problema sta nelle ricadute sui non cittadini che tali attività vengono ad avere nel loro insieme, quando a svolgerle di concerto sono tutti i soggetti regionali. Stiamo parlando dell’operato – anche omissivo – degli Stati europei, della stessa Unione Europea e della stessa NATO, da una parte, degli Stati africani di attraversamento, dall’altra. E, per contro, della difficoltà per un’opinione pubblica tuttora delimitata da confini nazionali, di arrivare a ricostruire il quadro complessivo.
Stiamo parlando di un combinato disposto che ha fatto del Mediterraneo e dello stesso deserto che ormai possiamo considerare come gravitante intorno, un immenso vallo, non dissimile nella sostanza dalla terra di nessuno che divideva le opposte trincee del fronte durante la I guerra mondiale, protetto da filo spinato, mine e spuntoni di ferro, per massimizzare il numero dei morti ad ogni tentativo di attraversamento. Ed è l’invalicabilità di questo argine che frantuma le ondate di disperati alla ricerca di una qualunque via di fuga, a costringerli a mettersi nelle mani degli scafisti, anzi, e dobbiamo dirlo con forza, è tutto questo che produce il lavoro sporco degli scafisti.
Non possiamo non dirci che è estremamente improbabile che un barcone possa sfuggire ai controlli incrociati continuamente in atto da parte di aerei, droni, satelliti, elicotteri, sofisticate apparecchiature radar, ecc. e che lo stesso accada per i gruppi che si avventurano nella traversata del deserto nella speranza di raggiungere il Mediterraneo. Non possiamo non dirci che esiste la possibilità almeno che vengano inquadrati, seguiti fin dall’inizio e lasciati a percorrere fino in fondo il loro calvario, nell’ambito di una strategia di deterrenza finalizzata a decimarne il numero, nell’impossibilità di sradicare del tutto il fenomeno.
La logica di quello che nei fatti è un aberrante dumping di vite umane sembra essere: ne colpisci uno, ne educhi cento o mille. Ma il fatto sorprendente è che anche se ne colpisci cento, continuano a tentare di arrivare perché privi di alternative, in fuga come sono da dittature, terrorismo, catastrofi ecologiche e miseria estrema e crisi troppo spesso da noi stessi provocate. E allora, ecco che il fronte viene spinto sempre più in là, fino a renderli impercettibili nella tragedia del loro respingimento, dispersi nell’ambiente, impensabili e inesistenti perché quod non est in actis, non est in mundo.
Sono, in una parola, i nuovi desaparecidos, e il riferimento non è retorico e nemmeno polemico, è tecnico e fattuale perché la desaparición è una modalità di sterminio di massa, gestita in maniera che l’opinione pubblica non riesca a prenderne coscienza, o possa almeno dire di non sapere.
Ci dicono, adesso, che con Frontex e con Mare Nostrum vengono tutti salvati, e ben venga, ma non possiamo più illuderci, non possiamo più accettare che torni ad affiorare la sinusoide delle vittime con titoli come quelli apparsi in questi giorni: “Naufraga gommone, 70 dispersi” oppure “Nella barca a Pozzallo 45 morti”.
C’è, in tutto questo, qualcosa che rientra nella categoria dell’intollerabilità del diritto ingiusto, secondo la formula elaborata dal giurista tedesco Radbruch al termine della II guerra mondiale. Lo ha detto di recente, d’altronde, il nostro presidente del Consiglio: “l’Europa non può salvare le banche e lasciar morire madri e bambini”. Il che ammonta a riconoscere l’esistenza di responsabilità, salvo scaricarle sulle spalle altrui.
Di fronte a ventimila morti a noi sembra sia il caso di parlare di crimini di lesa umanità e, come cittadini italiani, ci aspettiamo altro che battute auto assolutorie all’inizio del semestre di presidenza europea. Con questo documento chiediamo al nostro Governo di intraprendere i passi necessari a smantellare la situazione di fatto e di diritto che è causa di tali crimini. E ci proponiamo di portare avanti un’attività d’inchiesta, affinché le eventuali responsabilità di quanto finora accaduto vadano chiarite e perseguite, con quella che dovrebbe essere l’unica, vera arma della civiltà: il diritto.
Chiediamo l’aiuto della stampa più qualificata per abbattere il muro di gomma dell’inconsapevolezza dell’opinione pubblica e avviare fin da subito un percorso di verità e giustizia. Dobbiamo interrompere questa catena infame, porre al più presto fine a un meccanismo che costantemente rimescola vittime e benessere, trasformandoci in collettività subalterna e silenziosa di una democrazia, che non può essere altro che forma vuota ove non accompagnata da autentico rispetto dei diritti umani.