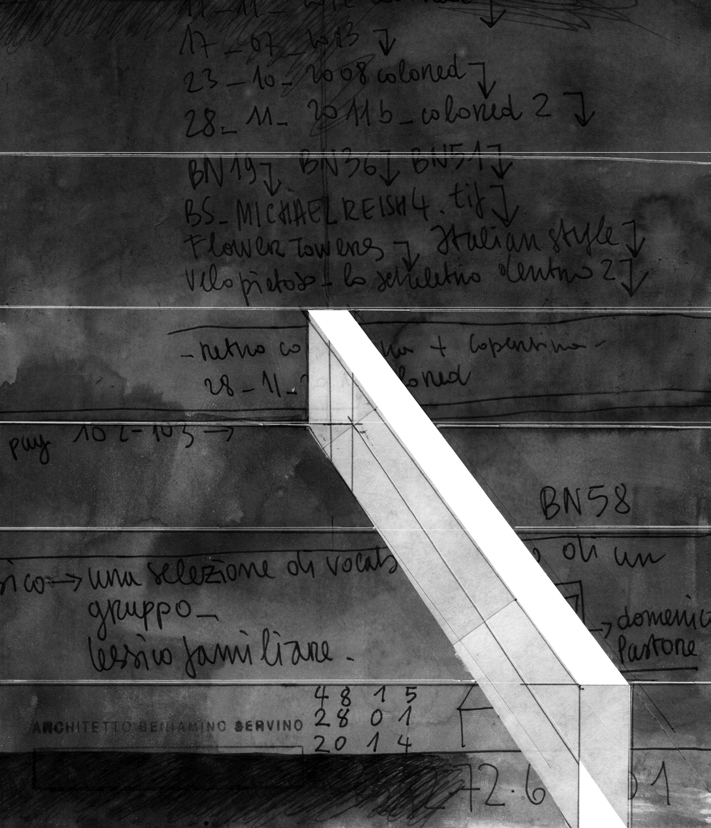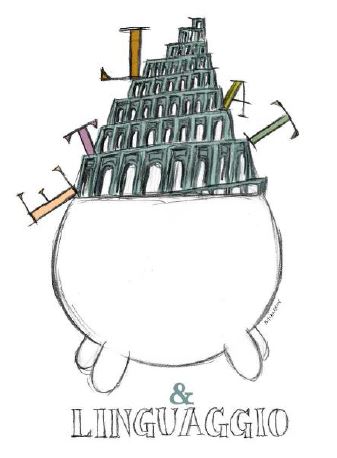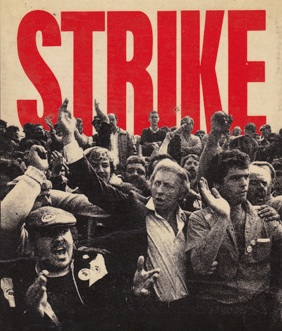Quando penso a Maria
di
Ivan Ruccione
Camminavo verso casa, poi all’altezza del niente mi sono fermato.
Piedi poggiati saldamente a terra, la testa chissà dove. Attorno a me l’aria fredda, la notte. La sequela di luminarie appese ai pali della luce, la strada ghiacciata che luccica come lo strascico di un abito da sera. Il campo brullo che riposa per accogliere la semina del granoturco. Un cane, che ha sentito il crick e crock dei miei passi sulla patina di neve raggelata, mi abbaia contro. Vigevano, in tutta la sua dannazione. Il mondo. Che senso ha tutto questo? Niente, nessun senso. E quando non vedo niente, mi fermo. Mi perdo. Ecco perché non vado mai da nessuna parte.
E mi sorprendo che esista un cervello, dentro la scatola. Che sia per altro lui a decidere. A dire fai questo, fai quello. A dire incazzati, piangi, gioisci. Ama, odia. Crea, uccidi. Se vuoi dimenticarmi per qualche ora: bevi; drogati; dormi. Se vuoi sfruttarmi: leggi.
Bello o brutto che importa, se sono schiavo fin dalla nascita; che importa lo specchio? Schiavo di una cosa così vicina, così intrinseca, ma che mai vedrò o toccherò in vita mia.
Non riesco a toccarlo ma ce l’ho. Paradossale. È mio, di mia proprietà, a tutti gli effetti, e nessuno, legalmente, può violare tale diritto umano.
Magari se decido di donare gli organi, alla mia morte, potrò privarmene. Ma difficilmente un bravo medico mi espianterà il cervello; difficilmente ne avrà bisogno, per aiutare il prossimo. Sarebbe un folle, dico io. Sarebbe come trapiantare un tumore dopo aver tolto un altro tumore.
Arrivato nel bilocale preso in affitto, ho salutato Maria. Maria è la mia ragazza. Non conviviamo ma è quasi come se lo fosse. Ho eluso in qualche modo le chiacchiere che avrebbe voluto intavolare e le ho detto che non stavo bene, che volevo ficcarmi subito a letto.
Maria abbassa lo sguardo e mi segue in camera. Si spoglia dei vestiti, fa passare le spalline del reggiseno sotto le braccia. Lo slaccia, se lo sfila. Lo butta sulla sedia, si china a prendere dal cassetto la camicia da notte mostrandomi un didietro perfettamente disegnato dal tessuto del perizoma, poi si fa scivolare addosso la camicia da notte. La guardo, con grande ammirazione. Guardo i capelli castani chiari e ondulati caderle sulle spalle, le mani che poi li spostano da un lato.
Maria si avvicina, scopre dalle lenzuola la sua parte di letto e si stende. Adagia la testa sulla mia spalla. Con la mano mi carezza il petto, sale a sfiorare il collo. Poi scende nuovamente sul petto, sul ventre. Più giù, mi sfiora l’inguine. Il pene. Lui niente, io niente. Le bacio la fronte.
Lenta e stanca come la lacrima che mi sta scendendo, Maria si volta per darmi le spalle. Poi tira le coperte fin sopra la testa. Solo un ciuffo di capelli, esce.
Quando si addormenta, la scopro un poco. Guardandola rannicchiata, la penso bambina. Penso alla gioia dei suoi genitori di vederla, carezzarla. Persone squisite, i suoi vecchi. Penso che una creatura nata da tanto amore, altro non poteva che dare tanto amore.
La abbraccio forte.
Mi ama, Maria. E io? Com’è possibile che io non sia più capace di amarla?
Poi penso di avere una testa di cazzo poiché nato da un amore del cazzo.
Ne sono sicuro. Gli aspiranti bambini sono molto sensibili.
Il mattino dopo mi sveglio con gran fatica.
Sento l’acciottolio delle stoviglie nel lavandino, Maria che chiude gli sportelli dei mobili facendo un casino del cavolo. Se c’è una cosa che odio è quando le persone aprono ante, porte e robe del genere e le chiudono facendo un casino del cavolo. Perché quelle persone, di norma, sono le stesse che quando escono dalla tua vita poi fanno lo stesso casino: dopo averti aperto il petto come se fosse una finestra, lo richiudono di colpo quando vedono che piove di sbieco. Sole, sole, vorrebbero sempre il sole, ma non pensano affatto che il troppo sole secca la vita.
Però di Maria non posso dire niente di male. Anzi. Sono mesi che va in giro bagnata fradicia.
In cucina la saluto. Lei mi sorride compiaciuta della colazione che mi ha preparato: latte di soia e caffè, biscottini biologici, marmellata biologica su margarina biologica su pane di kamut biologico; un dito di sciroppo alle erbe depurative diluito in un bicchiere d’acqua. Insomma, un buffet di diavolerie per vegani.
– Grazie amore. Era davvero buonissima la colazione, – le ho detto prima di uscire.
Poi ho abbassato in fretta le tapparelle e chiuso le finestre. Ho infilato il cappotto e le ho detto di muoversi sennò avrei fatto tardi al lavoro.
– Le bacche di Goji, – dice, avanzando con un cucchiaio raso di bacche di Goji. – Amore, non le prendi le bacche di Goji?
– Santo Cielo, devo per forza?
– Ma se sono buonissime! – dice.
Buonissime un corno.
– Ho male cane a un dente qui in fondo, guarda, – mento, slargando la bocca con le dita.
– Su, non fare storie, – dice. – Fa’ il bravo almeno oggi che è il tuo compleanno.
– Che cavolo di giorno è oggi? -. Faccio il finto tonto.
Vado a controllare sul calendario di Elvis appeso in corridoio.
– Che pirla, è vero!
Ma è da qualche anno, ormai, che non festeggio più il mio compleanno. Dalla mattina in cui scoppiò un litigio tra i miei genitori, l’ennesimo per via di mio fratello Simone. Simone ha un ritardo cognitivo grave. Ha diciassette anni ma è come se ne avesse sette. Sapete, non è facile essere genitori e fratelli di un ragazzo disabile. Umiliazioni, frustrazioni, limitazioni, tristezza e rabbia che si accumulano di giorno in giorno non possono che tendere i nervi al limite dell’esaurimento.
Quella mattina ricordo che Simone aveva puntato i piedi per non andare a scuola. Vattelappesca cosa gli passasse nel cervello, ma non ne voleva sapere. Aveva iniziato a urlare, a dare in escandescenza; mia madre tentava di tranquillizzarlo invano prima che, in soggiorno, distrusse i vetri del mobile porta-tv, accanto alla libreria, scagliandoci contro le scarpe che stava per calzare. Mio padre andò su tutte le furie, iniziò a ruggire contro mia madre. La colpevolizzò di non provvedere alla nuova terapia farmacologica che la neuropsichiatra infantile aveva disposto. Non è che mio padre avesse torto, perché gli psicofarmaci che prendeva Simone non andavano più bene, siccome ormai entrava nell’adolescenza. E da una parte capivo anche mia madre che non voleva bombardare suo figlio con farmaci nettamente più pesanti rispetto a quelli somministrati nell’età infantile. Insomma, una grossa patata bollente.
Non mi ricordo le parole esatte, perché quando sentivo che iniziavano a litigare a quel modo io prendevo Simone e lo portavo in camera nostra, e attaccavo la musica ad alto volume. Però, quella mattina, tra il silenzio di una canzone e l’altra, ricordo di aver sentito un calcio al frigorifero, la macchina da cucire con cui mia madre stava rammendando dei panni schiantarsi a terra, e mio padre che urlava:
– Quello là che non lo cercavamo è uscito normale, questo che lo abbiamo cercato per mesi è uscito scemo!
Ci rimuginai su per tutto il giorno.
Dopo cena, mentre mamma lavava i piatti e papà e Simone erano sul divano, chiesi chiarimenti a riguardo. Non potevo sopportare che io fossi stato concepito senza volerlo. Mia madre, imbarazzata, mi spiegò fingendo un tono di leggerezza che non si trattava di una cosa così grave, insomma, che erano molto giovani e tutto quanto, si frequentavano da poco tempo, e in quel momento non è che pensassero di sposarsi. Figuriamoci cercare un figlio.
No, non potevo sopportarla questa cosa.
Il giorno dopo frugai in tutti i cassetti e gli armadi in cerca di prove. Sapevo per certo che mia madre teneva in una certa scatola tutte le stupidaggini di regali e lettere che mio padre le aveva donato quando erano giovani per corteggiarla, intortarla, scoparla; come volete. Non so perché, ma ero sicuro che lì dentro avrei trovato qualcosa. Infatti, in mezzo a tutte quelle cialtronerie di collane, bigliettini, eccetera, trovai delle lettere di mio padre, quello schifoso, in cui scriveva che non se la sentiva in quel momento di diventare padre, appunto. Che mia madre avrebbe dovuto abortire. Conseguentemente a un intuibile “No” secco della donna, una proposta di matrimonio giocoforza.
La notte, nel mio letto, non facevo altro che pensarci. Volevo dormirci sopra ma non ci riuscivo proprio. Seguitavo a pensare a tutte le cure riservatemi in passato, all’affetto ricevuto, ai gesti premurosi.
Pensavo a mio padre a bordo campo che mi incitava mentre inseguivo il pallone da calcio come un deficiente, come una gallina dietro una serpe. Un deficiente che segnava un goal e si arrampicava sulla rete di recinzione per farsi abbracciare. Mi pareva di sentire le sue carezze viscide come quel liquido seminale non desiderato. Mi sentivo tra i capelli litri di sperma marcio. Avrei preferito correre dentro una fica senza arrivare a quelle cose a forma di uovo al tegamino, oppure essere abbandonato dentro un preservativo lungo una strada di campagna. Oppure scivolare giù pel lavandino e fare amicizia coi topi. Oppure strisciare tra le gengive usurate di una puttana. Eppure ci buttano in questo cazzo di mondo senza chiederci il consenso.
Mi pensavo attaccato ai seni di mamma e sentivo in bocca come l’acido del latte andato a male. Sembrava davvero di sentirlo, quel saporaccio, tanto che mi voltai e sputai per terra, tra il letto mio e quello di mio fratello.
Decisi categoricamente che il giorno seguente avrei fatto le valigie e me ne sarei andato di casa. Sarei andato in un’agenzia immobiliare e avrei cercato un appartamento in affitto, e fin quando non lo avessi trovato, avrei piuttosto dormito in un bed & breakfast del cazzo.
Poi mi alzai e mi sistemai al fianco di Simone. Lo svegliai e mi feci abbracciare.