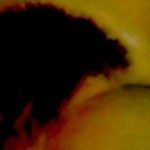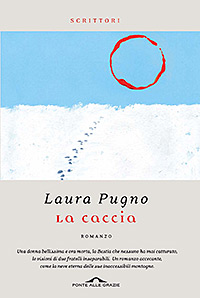di Renata Morresi
Sono appena tornata dai funerali di Civitanova, Marche, Italia. L’ho saputo proprio all’ultimo, dopo due giorni in giro fuori, senza connessione, non capisco perché nessuno m’abbia telefonato per dirmelo, un messaggio, niente. L’ho saputo solo sabato, nel primo pomeriggio, mentre me ne sto ancora in pigiama a trafficare davanti al computer. Prima m’imbatto in questo status di Eleonora – siamo in classe insieme nello stesso corso, nella speranza di trovare uno straccio di lavoro reale – :
Ecco, io ieri sera mi sono allungata sul divano, pensando di lasciarmi alle spalle la prima parte di un qualcosa che dentro di me so essere un’ennesima sanguisuga attaccata sulla pelle di gente perbene. Ecco, io sul quel divano ho preso il telecomando, ho acceso la televisione e mi ha travolto il silenzio di una silenziosa disperazione, quella che ti fa credere che essere perbene sia una maledizione, quella che ti fa pensare che magari c’è un altro posto in cui nessuno potrà calpestarti mai più.
Bevo il mio caffè e non capisco, mi piace e non capisco, funziona un po’ così su Facebook, arriva sempre prima la pelle e a volte solo quella. “Mi piace”, e passo oltre. Dopo due minuti Alessandra mi tagga a una manciata di suoi versi, una poesia agile e stretta, che fa scivolare veloce il cursore, un solo verso più lungo, repentino: “oggi muoiono in tre a Civitanova”. Si vede che una cosa non capìta passa, ma la somma di due cose non capite e uguali smuove. Figuriamoci tre.
Dopo un secondo sono su Google News. Dopo un secondo infilo i jeans e il giubbetto. Dopo un secondo sono in macchina che scendo verso la costa. Sto andando ai funerali, non so bene perché, a che titolo, secondo quale fede, cosa cerco, cosa offro, ma dentro la testa sto già scrivendo questo. Sto guidando, sto guardando, sto scrivendo di queste cose attorno. Eccola la primavera marchigiana, mezzo sole e mezzo freddo, le molte strade che la rigano da est a ovest, quasi tutte lasciate a metà a ridosso dei monti azzurri, riasfaltate quando passa un papa per i santuari qua intorno, di qua e di là i campi a rotazione, scacchi di terra che alternano grano, granturco, barbabietole, girasole, i campi fotovoltaici, i vivai, e più vai verso il mare, le zone industriali, i capannoni abbandonati, le enormi scritte Vendesi sui pacchiani centri commerciali mai finiti, le sale scommesse e le villette a schiera, dove in ogni cucina per decenni le donne cucivano tomaie per le fabbrichette della zona, la miriade di piccole ditte e officine dismesse, la mega-villa di Della Valle qui a due passi. Appena arrivi in una nuova cittadina t’accolgono le rotonde affittate ai grandi marchi, coi loro insulsi logo-monumenti. Una caterva di cartelloni pubblicitari t’annuncia una animazione che vedrai solo nei motorini. Giro a destra, poi a sinistra, sono sul lungomare, con le lunghe file di palme straprotette da giunte comunali di ogni colore, per creare quell’effetto caraibico che pare piaccia tanto alla famiglia-tipo in vacanza. Eccomi qui, in questo ex-borgo marinaro, ex-centro del boom della scarpa, ex-salottino buono dei modaioli, dove all’ultimo giro il movimento 5 stelle ha stravinto. Questa è la riviera Adriatica, coi lounge bar fichetti e a pochi metri le prostitute sulla statale, le vetrine stilose in centro, che cambiano gestione una volta l’anno, i Suv parcheggiati sul marciapiede, i pescatori a rezzaglio alla foce del fiume, i capannelli di badanti ai giardinetti, i pakistani che giocano a cricket al primo spiazzo che riescono a trovare, quelli di Forza Nuova ad attaccare manifesti. Non è né Nord, né Sud, e ha grossomodo i difetti e le virtù di entrambi, con la goffa scontrosità e la grezza vitalità di ogni provincia, con l’improvvisazione e il tira’ a campa’ di tutta Italia.
Sto per arrivare in piazza, alla chiesa dei funerali, non c’è tanto traffico e trovo subito posto e allora mi prende un magone, la paura che la città non sia venuta, che non saremo che quattro gatti, che la solitudine abbia infettato tutti e non importi a nessuno di questa cosa pazzesca: di essere soli anche se non in uno, di essere succubi non solo in coppia, di essere impotenti in così tanti, una famiglia di tre che s’ammazza. Penso e cammino e quasi corro per fare più in fretta e tre mi sembra un numero così enorme, tre persone adulte che si siedono a tavola ogni giorno e il loro tavolo si squaglia, tutto quello che li unisce e separa si squaglia, e si scivolano addosso, l’uno sull’altro fino a essere uno stesso corpo, e poi uno stesso posto vuoto, il corpo affondato nella solitudine nera, nera, nera. Solo lei mangia.
Giro l’angolo finalmente, la città è venuta, la piazza è piena. Adesso rallento, mi sento un po’ storta e ridicola, sono arrivata di corsa, sono arrivata tardi, vado più piano e giro lenta in mezzo alla folla, e non solo perché so che non entrerò nella chiesa che oramai è troppo piena, ma perché voglio sentire, ho la stupida fame di sapere cosa si sta dicendo la gente. E cosa vuoi che si dicano, che è una tragedia, che ogni giorno ne muore un altro, che il comune doveva sapere, doveva intervenire, che è uno schifo, c’è chi dorme col cane nel letto, chi va alla messa ogni giorno, che mio nonno operaio andava a roma a fare le lotte, che nessuno ha mosso un dito, che i delinquenti non si suicidano mai, che il sindaco s’è portato a casa i rom e noi adesso, che i grillini però, che è colpa della banca, è colpa di equitalia, che è perché loro non hanno chiesto, che perché loro si vergognavano, che è una vergogna, che vergogna, vergogna, vergogna, assassini, assassini, assassini – quando escono gli amministratori locali – omicidio di stato, e, alla fine, uccido un politico! uccido un politico!
La cosa più strana che ho sentito è questa: È che non avevano figli – e questa frase mi sembra così assurda, così vera. Mi illumina d’un tratto sul nostro nuovo proletariato, su un’Italia che ha affondato la borghesia senza liberarsi del borghesismo, un paese dove non avere figli non solo è, come volevano i tradizionalisti, contro natura, ma è anche, quando invecchi, fatale.
Adesso sto sulla soglia della chiesa, scivolata su un fianco del portale d’ingresso. I carabinieri si sono girati verso l’interno per la benedizione. La messa è finita, la gente s’addensa per uscire, ma non c’è calca, solo una gran confusione di voci, tra chi parla sommessamente, chi parlotta nervosamente, chi piange. Si fa silenzio quando una signora bionda raggiunge il microfono, a leggere un messaggio che le amiche hanno scritto ad Anna Maria Sopranzi: Ti ricorderemo che leggevi il giornale sul tuo terrazzino, ricorderemo il tuo sorriso buono. Non eri tu a doverti vergognare della tua povertà.
Sono parole semplici, quelle sulla bontà. Sono, dicono i cinici, le parole di rito pronunciate sempre ai funerali. Ma come fai a non credere alla bontà di queste persone, tre che si organizzano insieme per tirare a campare, non sanno chiedere aiuto ai servizi sociali, ma uno si fa un orticello, uno, lasciato a piedi dal fallimento della ditta, s’arrabatta a cercare lavori, a pagare debiti e arretrati, una pensa all’affitto con la pensioncina da artigiana, come fai a non crederci? a questi pensionati indigenti, a questi licenziati dal presente, al loro esodo da ogni diritto? a una coppia di sessantenni che lascia un biglietto ai vicini con su scritto “scusateci”? a un fratello che capisce d’un tratto di essere solo e non ha un’esitazione, va dritto giù al porto? a un uomo che a quelli che accorrono e s’arrampicano sugli scogli e gli gridano “fermati”, “nuota”, con la mano fa cenno di no, che vuole morire? Ah, lo so, lo so, sto scrivendo con tutto questo pathos e mi scordo di dire che così sta facendo l’Italia, un paese che per anni invece di protestare, resistere e pretendere diritti e rispetto, s’è lasciato affondare.
O forse, forse non è anche questa disobbedienza civile?
Sono in mezzo alla folla e non vedo più niente, mi alzo sulle punte e scorgo solo le telecamere alte sulle braccia dritte degli operatori, inquadrano qualcuno là in mezzo, c’è chi dice il sindaco, chi la presidente Boldrini. Che diritto avete di stare qui, urla qualcuno. Escono le bare, tutti applaudono. C’è una signora semplice vicino a me, continua a parlare da sola, perché applaudite, bisogna piangere, perché applaudite, bisogna piangere. Un altro, sottovoce: ci vuole un grande forza, un grande coraggio. Penso che voglia dire che occorre grande forza per tirare avanti, farsi coraggio per vivere, ma ora che lo scrivo non ne sono più così certa. Vorrei dire qualcosa anch’io, ma sarei solo un’altra voce.
*
Sono tornata a casa, davanti ho una poesia di Massimo Gezzi, “Sul molo di Civitanova”.
A un certo punto dice:
Non è mai finita, penso mentre guardo
i tuoi capelli rovistati dal grecale
finché non muore tutto
c’è speranza di risolverlo il dilemma
che mette il segno uguale tra vita
e non vita, in quest’angolo di porto occidentale
che ogni volta è se stesso ma insieme
è anche altrove, e per caso non coincide
con il luogo dove gli uomini
vendono tutto per fame
Mentre la leggo mi pare incredibile che questi versi di qualche anno fa traccino così bene la geografia della disperazione di oggi: il salto veloce tra vita e non vita, il caso che gira e fa di questo luogo un altrove, quello degli ultimi. Sono i versi di un giovane uomo, pieno di sentimento del mondo, sì, del suo dolore, ma anche di fede.
Di lì a poco tornerò in rete, riscriverò a Eleonora:
Ciao, sono appena uscita dal funerale, ovvero, non sono mai entrata visto che la chiesa traboccava di gente – gente in lacrime, gente incredula, gente arrabbiata, e tanti hanno urlato, sì, molti urlavano anche contro, e a stare insieme, ho notato, l’urlo, lo sfogo, persino il pianto vengono meglio, liberano veramente – ma come liberarsi dalla solitudine quando sei solo, dalla disperazione quando sei disperata, quella è la cosa difficile davvero, tanto da sembrare, a volte, addirittura eroica. Non so bene cosa mi ha portato qui, di certo non la fede, d’istinto mi viene da dire la fede in questa gente semplice, come dicevi tu, semplicemente perbene.