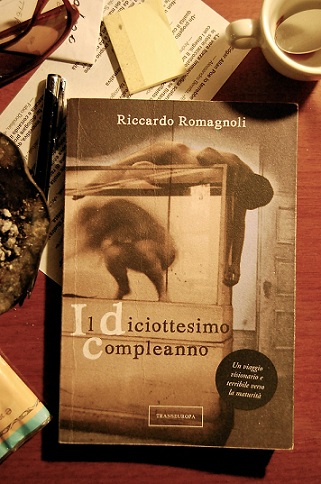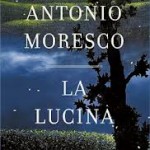di Francesco Filia
Si scrive veramente con l’inchiostro o con il sangue? Che rapporto c’è tra vita e scrittura? Tra esistenza e parola ? Queste domande attraversano l’intera esistenza di Pierre Drieu La Rochelle (13 gennaio 1893 – 15 marzo 1945) fino al suicidio, avvenuto in una casa di campagna, nei pressi di Parigi, alla fine della guerra che lui, collaborazionista, ha interamente percorso dalla parte sbagliata e da cui trae le estreme conseguenze, senza cadere nel melodramma del pentimento. Ma ridurre la fine di Drieu al dato storico sociologico, che pur è presente, di una sconfitta politica, sarebbe non comprendere il cuore del suo percorso artistico e intellettuale. Nella sua opera si agitano e si mostrano, nella loro terribile limpidezza, le questioni che dilaniano la vita di ogni uomo, lo sappia o no. Può essere concepita la vita senza la distruzione? O, meglio, senza l’autodistruzione? Ha senso continuare a vivere oltre la soglia fatidica della giovinezza, sopravviverle? Tradire ciò che si è stati anche solo per un attimo? “Da ragazzo ho giurato a me stesso di rimanere fedele alla mia giovinezza: un giorno ho cercato di mantenere la parola.”
La figura di Drieu è una delle più affascinanti, non solo della letteratura francese, ma anche di tutto il primo novecento, soprattutto per queste domande definitive e inaggirabili, in cui, il fascino dello scrittore e del dandy ammalato di delicatezza si alimentano l’un l’altro, lasciando sempre un che di irrisolto che fa ritornare a leggerlo nuovamente. Forse Drieu come scrittore è incompiuto, perché avrebbe voluto essere scrittore di un solo libro, il libro perfetto, indelebile, “Rimbaud, Lautréamont. Beati gli uomini dai pochi libri: non hanno avuto il tempo di confessarsi, di addomesticarsi ripetendosi” . Invece ha continuato a scrivere, a confessarsi , fino a due giorni prima del suicidio, lasciandoci un ultimo grande testo incompiuto Memorie di Dirk Raspe , biografia romanzata di Vincent Van Gogh, in cui, nell’affinità con il grande pittore olandese, Drieu coglie il cuore di ogni destino artistico, quello di farsi “divorare dalla visione” dell’irrealtà, ossia, da quell’Oltre immanente a ogni cosa che fonda già da sempre quello che noi, per nostra comodità e stoltezza, chiamiamo realtà. Ma la figura di Drieu pone una domanda ancora più inquietante: che senso dare alla nostra vita quando questa, rapita una volta e per sempre dall’atrocità del vero e del bello, inizia a tradirci? Perché per Drieu la vita è degna solo del suo apice e non della decadenza, che pur le è costitutiva e che lui, come gran parte dei suoi personaggi, attraversa sino in fondo. La vita va vissuta nella sua irripetibile selvatichezza, a questa intuizione e non da altro si deve, forse, far risalire le sue scelte politiche scandalose . Il dramma di Drieu e di molti dei personaggi dei suoi libri, che non coincidono mai del tutto con l’autore, è segnato da una doppia impossibilità, quella di esistere autenticamente e di arrendersi al quotidiano, o, se resa c’è, è nelle sue forme più abbiette e autolesionistiche, come estremo gesto di rivolta, folle, patetica e disperata, che però non chiede pietà ma ha l’ambizione, attraverso l’ultimo estremo gesto, di lasciare “una macchia indelebile” su chi resta . Perché quel che conta è solo l’amore, l’ardore dell’esistenza che si sporge oltre se stessa e quando questo slancio vitale si esaurisce, l’amore – e le donne che non si lasciano afferrare, trattenere e anzi sembrano stringere in un assedio che pretende la resa della procreazione – diventa forma vuota, maschera mortuaria e dunque tutto si trasforma in vuoto, in thanatos, in un lento finire che ha solo due vie d’uscita, morire o sopravvivere a se stessi.
Dal confronto tra due opposte possibilità, una richiamante l’altra, nascono pagine tra le più belle dell’intera opera di Drieu, i capitoli di Fuoco fatuo in cui Alain, il protagonista, si confronta, passeggiando per i boulevard di Parigi, con l’amico di un tempo Dubourg, che, a differenza sua, ha accettato il “ritmo elementare della vita”, il caldo rassicurante della quotidianità, simboleggiato dal ventre della moglie che lo accoglie ogni sera nel letto o dall’amore per l’archeologia egizia, amore necrofilo, ma che permette di trovare un interesse per sopravvivere. Dubourg non può salvare Alain, non può distoglierlo dal suo proposito, perché in fondo anche lui sa che sta barando con se stesso (“Dubourg capiva che l’occasione per salvare Alain gli era sfuggita. Si diceva che se fosse veramente sicuro di se stesso, si sarebbe gettato su Alain con brutalità, insultandolo, mettendolo a nudo. Gli avrebbe gridato: ‘Sei mediocre, accetta la tua mediocrità. Rimani a livello che la natura ti ha assegnato. Sei un uomo: per la tua semplice umanità sei, per gli altri, ancora inestimabile'”) . Alain, con la sua sola presenza, mostra le cose per quel che sono, eppure anche Alain sa che in Dubourg c’è l’altro se stesso deformato; è come se i due vecchi amici guardassero nell’altro se stessi in uno specchio e vedessero la strada non presa. In Alain c’è già il distacco di chi si sente finito, in Dubourg il cruccio di chi sopravvivrà, in entrambi le braci sempre più tiepide di un amore per la vita che non ha più di che alimentarsi.
Del suicidio, il tema dei temi nell’opera e nella vita di Drieu, è fin troppo facile parlarne male, giudicarlo come un atto frutto di una qualsivoglia disperazione, vile o un atto contro Dio, come lo giudicano le religioni, ma invece in esso sono in gioco la libertà e il destino. Drieu coglie un aspetto del gesto estremo che nessun atteggiamento strettamente moraleggiante potrà cogliere. Nella possibilità dell’autodistruzione irrompe la questione del sacro, del patto sancito da ogni uomo per il solo fatto di esser nato. Patto sancito con cosa? Come nominare quella forza che ci fa stare al mondo, come corrispondere all’enigma che siamo? Ecco che nella possibilità ultima che la morte evoca e che il suicidio anticipa, irrompe l’alterità, l’estraneità radicale che, per contrasto, ci riguarda più da vicino, fino a toglierci il fiato, fino a toglierci la vita. Alterità che si fa gesto in noi nella vertigine dell’auto distruzione e in tale gesto è raccolto, per un attimo che si fa soglia irrevocabile, tutto ciò che quel singolo uomo è stato, è e, in maniera tragicamente paradossale, sarà ancora per un istante: altezza e bassezza, autocommiserazione e disprezzo di sé, amore immedicabile per la vita e disgusto dei giorni che si ripetono sempre uguali, lucido delirio autarchico (“La vita non andava abbastanza in fretta per me, io l’accelero. La corda si allentava, io la tendo. Sono un uomo. Sono padrone della mia pelle, lo dimostro.”) e estrema consapevolezza dell’impossibilità di bastare a se stessi (“Ma in fondo a te stesso ti credi un delicato. Quanto a me, lo credo, non posso non crederlo. Avrei voluto piacere alla gente, ma mi manca qualcosa. E, in fondo, questo qualcosa mi disgusterebbe.”) e, infine, sapere di non poter uscire dalla propria radicale solitudine e che, per un’inezia o per un vizio, per un piacere unico e irripetibile, diventa un percorso verso la perfezione del morire (“Ebbene, ora l’ho capito, la solitudine è il cammino del suicidio o almeno il cammino della morte. Nella solitudine assoluta si prova un piacere unico, superiore a ogni altro, per il mondo e per la vita; è il solo modo per gustare fino in fondo un fiore, un albero, una nuvola, gli animali, gli uomini, anche quando passano lontano da noi, e le donne; ma è la china lungo la quale ci si perde”) . La via della bellezza è la via della morte, in questa equazione sembra riecheggiare la sapienza platonica del Simposio, del Fedone e del Fedro. Dove, però, a differenza di Platone, la psicagogia non porta ad una anabasi salvifica, ma ad una catabasi della Disperazione, non ritrovare se stessi, ma perdersi in maniera definitiva nell’indistinto della morte, come unico modo autentico di essere fedeli all’errore che si è, perdersi nel nero abbagliante del nulla ( vorrei rientrare nella notte senza stelle, nella notte senza dei, la notte che non ha mai portato il giorno nel suo seno, che non ha mai aspirato al giorno, che ha mai prodotto il giorno, la notte, immobile, muta, intatta, la notte che non è mai esistita e non esisterà mai. Così sia . In questo senso il suicidio per Drieu è il rito, nel senso forte del termine, che ci inizia all’enigma dell’esistenza e del mondo, al suo fondo buio, a quel qualcosa che si nasconde dietro a ciò che noi nominiamo nulla e che non si dà in altro modo possibile. L’auto-distruzione fino al gesto estremo, non solo e non tanto come un atto di disperazione, quindi, ma come punto d’arrivo di una logica implacabile, compimento della vera Disperazione strutturale che noi siamo, che non si accontenta del rimorso, della tristezza o del melodramma del ‘se avessi’, ma arriva sino allo strappo finale, lì dove si spezza il nesso tra parola pensiero ed essere, dove la parola si ritrae o, al massimo, arriva postuma e dove, se riesce a dire qualcosa di essenziale, non ha la pretesa di salvare ciò che non può essere salvato .
“Egli è convinto di credere al nulla, pensa di abbandonarsi al nulla, ma sotto questa parola negativa, sotto questa parola approssimativa, sotto questa parola limite c’è qualcosa che gli resta nascosto” . In questi passaggi, rivelatori del pensiero e del vero sentire di Drieu, sembra quasi delinearsi una filosofia neoplatonica, una teologia negativa, il Mónos di cui parla Plotino a cui si può giungere solamente superando la dualità del divenire in una forma di mistica negativa, nel caso di Drieu non ascendente ma discendente e nichilistica . Questa deriva consapevole di Drieu è testimoniata dal diario e dall’ultimo suo libro pubblicato in vita, I cani di paglia , libro di rara sottigliezza analitica e di una bellezza livida, che prende il titolo da una frase del Daodejing di Laozi posta in epigrafe , in cui la crudeltà dell’esistenza è connaturata alla condizione umana, che sembra essere un esperimento del destino in mano a forze sconosciute dove ognuno – il collaborazionista, il traditore, il comunista, il gollista – in situazioni limite, come quelle della Francia occupata dai nazisti, fa i conti tragicamente con ciò che è, con il carattere che lo abita, che lo possiede, al di là di ciò che vorrebbe essere, al di là della sua volontà .
Drieu alla fine dei suoi giorni sente il fascino di un pensiero originario che lo possa liberare dal carcere dell’esistenza e, di volta in volta, questa liberazione si presenta sotto forme diverse, dalla filosofia neoplatonica alla sapienza evangelica, dalla mistica alla teologia negativa, dai Veda all’Upanishad e al Taoismo, vie che però, al di là delle intenzioni dello stesso Drieu, non potranno mai essere abbracciate da lui, letterato fino al midollo , che ha riversato tutto il suo sangue nell’inchiostro della scrittura, scrittura che non potrà mai contenerlo tutto nonostante il suo amore per la terra, per ogni singolo dettaglio e che, però, alla fine si mostrerà incapace dell’ultima parola che possa dire ciò che parola non è. C’è un’ombra che cade tra la parola e la cosa, è questo il limite disperante di ogni gesto letterario. Drieu quindi è uno scrittore incompiuto non per una sua mancanza soggettiva d’artista, ma perché quel che egli vuole dire si ritrae definitivamente dalla parola, cede il passo a quel che non potrà mai essere nominato. E proprio per la sua radicale alterità e quindi sacralità, più sacro di qualsiasi dio, il nulla o ciò che attraverso esso è, richiede un rito, l’ultimo e il solo, che però non ha il conforto della ripetizione ma l’indicibile vertigine dell’irripetibilità, del mai più, del per sempre .
L’ek-stasi di un delicato, cioè di colui che coglie l’intima violenza e bellezza dello stare al mondo, in un’epoca senza dèi è il suicidio. Il perdersi oltre la dispersione dell’esistenza, l’uscire fuori di sé nel tutto infinito (“L’infinito crea il finito e rimpiange l’infinito.”) ed è al tempo stesso fare i conti per la prima e ultima volta con le cose – attraverso un gesto, questo sì veramente politico – con la muta barriera inscalfibile che le avvolge e che ci avvolge. Fare i conti con la nostra costitutiva sconfitta. “Una pistola è solida, è d’acciaio. È una cosa. Scontrarsi, finalmente, con le cose”. (Pierre Drieu La Rochelle, Fuoco fatuo, cit., p. 115)