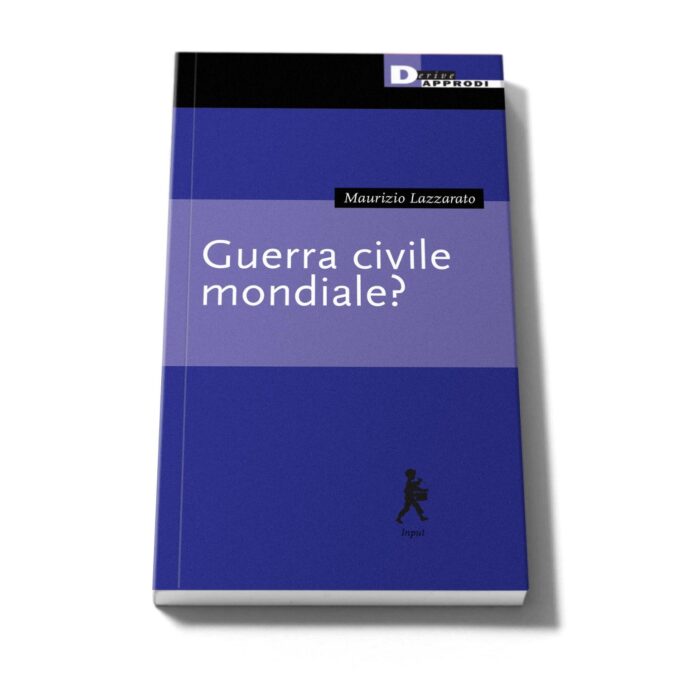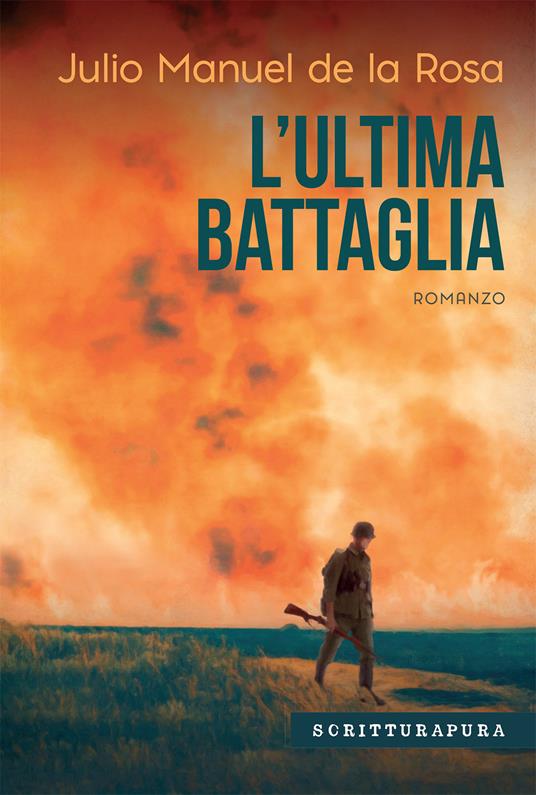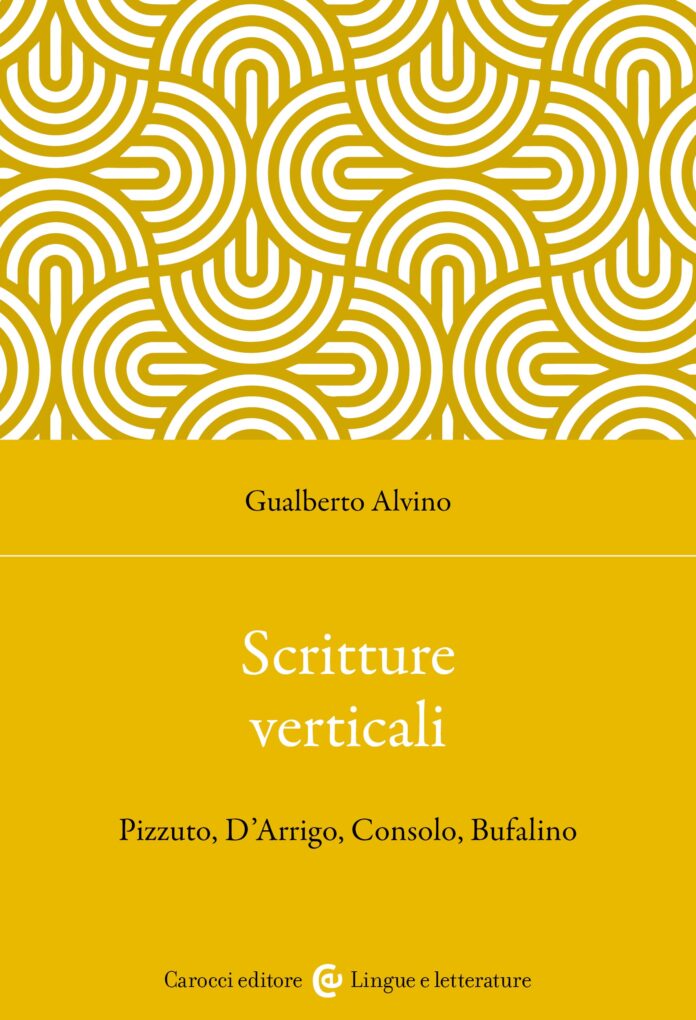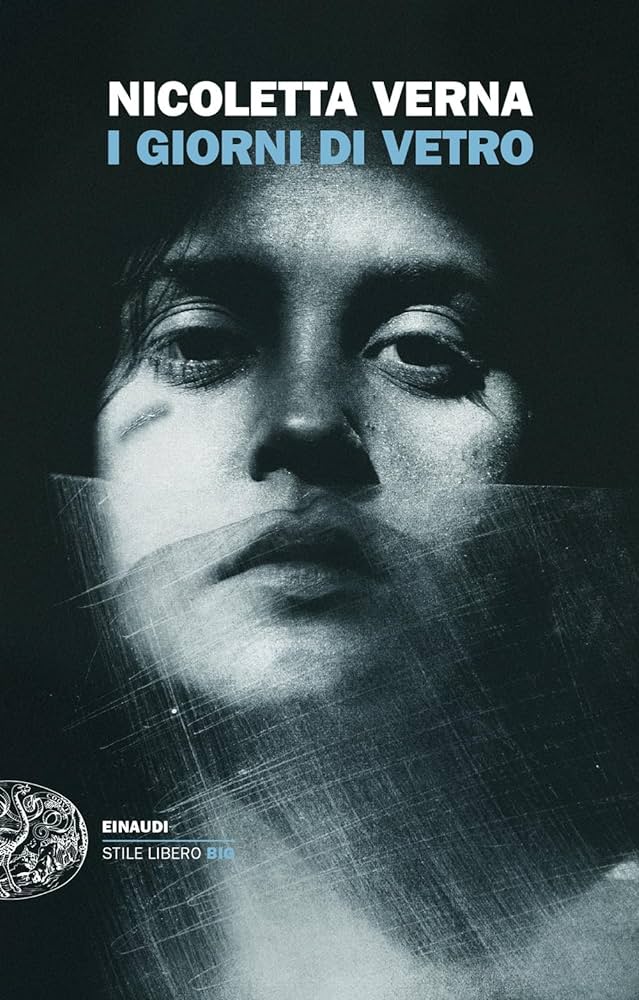di Daniele Ventre

Di scuole, tendenze, antologie e volumi miscellanei di poesia geograficamente connotati, sono pieni i più remoti angoli dello spazio letterario nazionale, fra scuole liguri, poeti lucani e piccole lineette lombarde. Sbaglierebbe chi dal titolo Napolesia, primo volume sui poeti “legati a Napoli per nascita e/o formazione” curato da Ferdinando Tricarico e Costanzo Ioni (Bertoni 2024), volesse inferire, più o meno in buona fede, di trovarsi di fronte a testi e autori connotati da uno specifico (e fin troppo riconoscibile) idioletto territoriale.
Il problema che si è posto sin dall’inizio ai due curatori è stato, come loro stessi dichiarano, distinguere fra l’autore di versi che è napoletano e quello che fa il napoletano: in termini più limpidi, fra l’atteggiamento di un autore che si serve di un certo tipo di immagine della città -e non necessariamente del dialetto- allo scopo di costruire un prevedibile ethos identitario, in negativo o in positivo, e la dimensione strutturale di una poetica le cui motivazioni profonde sono strettamente legate al contesto di provenienza, che si tratti di radici e ambiti squisitamente culturali, o di fattori lato sensu storici e antropologici, ma i cui effetti e obbiettivi si muovono in regioni dell’esistenza e del linguaggio ben più diffuse e pervasive.
In dettaglio, che cosa troverà il lettore di questa raccolta miscellanea e che cosa non potrà invece reperirvi, a onta delle sue ipotetiche attese su un’idea preconcetta di napolitudine/napoletanità, termini foneticamente sgradevoli sin nella loro stessa articolazione, e in più culturalmente nati logori? Secondo una linea argomentativa alla Giovanni Papini avvocato del diavolo, cominceremo da ciò che non vi troverà,.
Anzitutto non vi si troverà l’esorcismo forzato dell’identità cittadina, drappeggiato magari degli anglismi à la page nel gergo a-topico e anti-topico della globalizzazione, come non vi apparirà il dialetto nella sua dimensione oleografica -se talora se ne indovini l’eco, la si intuirà dietro le cortine della sintassi dei differenti discorsi poetici, e se barbarismo qui si legge, è necessità di linguaggi che lo impone; non vi si ostenterà l’ignoranza deliberata dell’identità antica, come non vi comparirà la sua forzata e stucchevole rievocazione; non vi si scorgerà il compiacimento del degrado, né tampoco il suo bolso e finto contraltare, l’affettazione della volontà di riscatto; non vi si manifesterà l’angoscia del nostos, che si tratti di tropismo urbano negativo o positivo verso il ritorno, da migrante costretto o da reduce poco convinto. I poeti raccolti nel volumetto non presteranno il fianco alla stigmatizzazione da parte delle bulle e dei pupi ringhio-mormoranti tra la fauna della capitale dei cinghiali; non soddisferanno il napoli-nobilissimo borghese panciuto ipertradizionalista in traccia di duchi minimi e liberi bovi più o meno pii, né tantomeno il dòtto sub-municipale in cui è radicata la convinzione che per essere consanguinei di Platone, abbeverati alle sorgive di Pegaso, bastino un paio di etimi grecizzanti un po’ arruggini dalla centralizzazione delle vocali viaggianti al termine della voce; nemmeno chi scambia verso per slogan, poesia per comizio, attualità per estetica, o esige dall’arte verbale la versione inurbata della paesologia e dei buoni sentimenti, ne uscirà gratificato, se dio vuole. In breve, chi per maligna ricerca di conferme di torpido pregiudizio, o peggio, per sete delle non buone cose di pessimo gusto dell’una o dell’altra forma dell’oleografia, dalle terre assaje luntane alla indignatio civile da post-martire di un 1799 mai davvero compreso, si accostasse a Napolesia in cerca del consueto ciarpame, ne rimarrà amaramente deluso, poiché l’opera in versi (o in qualcosa di simile a) accetta e perdona senz’altro, come da vecchio adagio baudelairiano, lettori interiormente ipocriti, non sleali.
Au contraire, in ciascuno degli autori di Napolesia i campi di forza dei significanti legati al retroterra cittadino agiscono da sottinteso e sotteso insieme universo, in cui ogni singolo messaggio poetico è funzione di specifici valori di verità espressiva, che tuttavia in quell’insieme universo non si confinano, ponendosi piuttosto (e sarebbe assurdo, se così non fosse) come esperienze comunicative ed estetiche il cui destinatario non ha dove e quando definiti. Questa duplice natura, radice storica legata a un luogo ben preciso, intenzione comunicativa non locale, non localizzata e non localizzabile, è il denominatore comune di tutti gli autori che nel libro figurano. L’aver reperito in ognuno di essi la condivisione di questo status bifronte, di un hic poetico che è anche potenzialmente, e proprio per le sue specifiche origini, un ubicumque ontologico (ma sarebbe interpretazione deviante definire questo aspetto dei testi di Napolesia un mero tratto di glocalismo), è stato il criterio ispiratore delle scelte del libro, senza nulla voler togliere a chi, all’uscita del scondo volume ancora in corso di assestamento, se ne ritrovasse escluso, considerando che nel tempo dei censimenti dei poeti-legione e delle mega-antologie totali, ma spesso nulli-comprensive, non esiste scelta criticamente affidabile e valida che non dichiari in partenza limiti cronotopici e termini criteriali: limiti e termini che Ioni e Tricarico non mancano di precisare nella loro sintetica prefazione.
Le tensioni dialettiche fra i vari discorsi poetici collazionati identificano un campionario di soluzioni e ricerche stilistiche in cui si possono grosso modo individuare in questi termini i distinti e gli opposti: la polarità tra innovazione e tradizione formale, voluta arkhaiología e liquefazione ipermoderna, corpo fonico-ritmico e suo degré zéro; la connessa alternativa, variamente declinata, fra strutture semiologiche vincolate e flusso comunicativo (l’una e l’altra opzione non sempre corrispondenti in modo meccanico a scelte neometriche e forme atonali o di prosa in prosa); un ampio ventaglio di trattamenti dell’io autoriale, fra sua dissimulazione, suo depotenziamento (“borsa per la spesa”, parafrasando l’ultima Antonella Anedda), suo slittamento temporale, storico, sua delocalizzazione, obliterazione, disseminazione percettiva o occultamento; il connesso articolarsi dei giunti fra tempo esistenziale, tempo della storia, memoria, coscienza e proiezione-progettazione.
Così i testi di Viola Amarelli, organizzati talora in sistemi strofici di versi atonali, talora in prosa, occasionalmente in versi liberi di tessitura più compatta, si collocano a metà strada fra la struttura poematica disseminata e la maniera breve. Fra le partiture di stil life e Altamira, si riconoscono unità più piccole di dimensione talora quasi epigrammatica, che mostrano un notevole fenomeno di asimmetria fra forma aperta, atonale appunto, e rigore di strutture semiologiche, centrate su nuclei nominali e solidi Leitwörter, e sostanzialmente centripete (“…a clessidra, a esagono, a dna doppia elica e barra…”), con immagini correlativi oggettivi al limite della kenning (“Nell’erba si srotola la biscia/fonovisiva anch’ella”); altre volte il discorso poetico si dipana in un flusso di coscienza rievocativa, quasi sciamanica (le due strofe lunghe finali di Altamira, a cui segue, dislocato, un blocco di prosa ritmica), una archeologia degli epistemi e delle esistenze umane a una sotto-trama di natura meta-poetica; più concentrata la forma delle ballate, l’ultima delle quali si presenta secca e netta come un referto clinico, ma al tempo stesso si culla in un ritmo cantilenante, da nenia, ninna nanna, definitiva, scandita da battute ternarie. Le stesse battute ternarie ritmano, con ricorsività ancor più pronunciata, la prosa finale, secondo una tecnica che questa poetessa coltiva da tempo e ha condotto a perfezione nelle sue più riuscite raccolte: bastino a titolo di esempio alcune sezioni de Le nudecrude cose e altre faccende, fra le opere che più ci hanno colpiti di questa autrice, che sentiamo assai vicina, e a cui altre volte abbiamo dedicato specifiche e individue analisi. È, quest’ultimo, un testo particolarmente illuminante. Idealmente può collegarsi all’atmosfera di scavo preistorico-esistenziale di Altamira, ma la visione dell’uomo arcaico in tempi glaciali è di ambigua collocazione cronotopica, potendosi tranquillamente inserire tanto nelle più cupe brume glaciali del Wurm III, quanto in un futuro, ipotetico e distopico, inverno post-atomico. Questa ambiguità di localizzazione in rapporto alle frecce del tempo storico (e nel caso specifico pre- e post-istorico), sgranatura e porosità del diaframma passato-presente tanto più palese quanto più precise sono le immagini di rimemorazione, è peraltro un tema di fondo di molti autori del volume, e avremo modo di tornarci alla fine.
Su una lunghezza d’onda formale totalmente opposta si colloca invece Mariano Bàino, che offre sei poesie di struttura caratteristica, mutuata dall’ultimo Toti Scialoja: sei testi, articolati ciascuno in due strofe pentastiche, costituite di cinque esametri ritmici, armonizzati per lo più di un ottonario e di un novenario, o al più di un settenario e di un novenario, ma spesso liberalizzati dall’andamento dattilico tradizionale, come già accadeva per Scialoja in Costellazioni. Bàino esordisce qui con la dissoluzione dell’io non solo autoriale (“ma io è un altro lo sai e indosso una fronte solcata”) e dal connesso senso di sofferenza storica, di una storia non magistra, ma carnefice (“il secolo breve scontato lungamente”), in inexacta o sulla propria posa; prosegue, sulla stessa linea tematica di disgregazione del centro coscienziale (“nel cervello si forma come un essere senz’anima”), con immagini da carcere di Piranesi (nel calabozo); evolve, nella dimensione immaginativa centrata sul sogno dell’altro su se stesso, non sensa ironizzazioni di secondo e terzo grado di ormai antichi echi orfici campaniani (chimera insulsa -spazio onirico); si fa asserzione della morte del mito del senso storico (“c’era una volta il lontano profumo chiamato domani/il progresso sotto gli occhi, ma le fughe è chiaro finiscono”), con richiamo interno a un’opera precedente (la prosa aperta, misti-genere, di In nessuna Patagonia); si assesta sull’ironizzazione della consuetudine in thanksgiving (con in esergo un’ominosa dedica a Guillaume Le Blanc, decostruttore della dimensione normativa occidentale, delle sue torsioni improprie e dei suoi risvolti deformi; uno spazio metapoetico si definisce apertamente nell’ultimo componimento esametrico, della bellezza, dialogando, il cui interlocutore e dedicatario è il pittore Gaetano Di Riso, artista di Lettere nella cui produzione forme installative e figurative convivono, così che sembra di assistere allo strutturarsi, per anamorfosi, un’ars poetica indita, relativa al dibattito fra installazione e performance nella poesia come tale. Nelle poesie esametriche di Baino si coglie l’usuale, fraterna cifra espressiva tesa fra rigore formale e liberalizzazione ironica del ritmo, pensiero forte che rinuncia a sé stesso in nome della presa di coscienza del limite.
Una cifra tematica e stilistica altrettanto personale e di estrema limpidezza e autenticità si avverte nei tre testi di Fabio Barissano, le cui selezione lessicale definisce un dettato stilistico di estrema immediatezza, in cui lemmi di uso comune appaiono gravidi di connotazioni metafisiche: si tratta, però di una metafisica in cui l’esistente, condensato in enti-immagini-icone (e “immagine” che “nella mano… aperta/… splende debolmente” o si inceppa nei suoi “incaiampi” è parola chiave nei versi), si trama di equivocità così che l’entelékheia-enérgheia descrive una traiettoria non coesa con la sua dýnamis (“…sul davanzale/il fiore confuta la gemma/ dà alla terra uno schema di fantasmi”; “… il tempo che eccede alle rondini/ fallisce anche il verso/il sangue errante nelle ginestre”) e la “fede” (non necessariamente una fede religiosa in senso stretto, ma semplicemente quella che Santayana chiamava la “fede animale” nella solidità dell’esistente) è prospettiva esistenziale sistematicamente in forse. La forma di Barissano, una forma aperta, versolibera, si colloca in una dimensione intermedia fra il ventaglio delle soluzioni neometriche e il verso atonale; i versi assumono senz’altro una propria individualità ritmica, in cui non sono impossibili, ancorché minoritari, gli endecasillabi, regolari e non, le loro derivazioni (decasillabi irregolari e doppi quinari) e le loro segmentazioni secondarie (ottonari, settenari, quinari), in una sorta di circulata armonia la cui simplicitas è corrispettivo timbrico dello stile, sintonizzato sul fine tuning di un monolinguismo estremamente nitido, teso a conformarsi a una norma estrema di autenticità e di chiarezza compositiva, tanto che forse non è del tutto fuori luogo ravvisarvi echi di new sincerity.
Un pronunciato polimorfismo, fra prosa ritmica pseudo-narrativa e forma versale, si presenta nei testi di Emanuele Canzaniello. La sua prima lunga lassa di prosa si connota per un insistito impulso di futurizione (almeno in otto frasi su dieci, per più del cinquanta per cento del testo, il sintagma verbale è costituito da futuri di senso predittivo-conativo. In effetti ognuno dei sette capoversi della lassa si struttura secondo un ritmo interno, quasi metronomico, fra enuncianzione futuribile e più statiche clausole nominali, o al più semplici frasi con presente gnomico; occasionalmente il preterito si offre nel contesto del paragone fra tempi ed epoche. Di fatto la freccia del tempo narrativo vi si congloba e la strana forma di eterno ritorno che si prospetta obbedisce più che altro alla trama di una presentificazione cosmica. Il trattamento anomalo del tempo è da decenni un tratto ricorrente nello sperimentalismo poetico e narrativo contemporaneo; nella prosa in prosa di Canzaniello, il risultato è in effetti la contemplazione della chenosi (“…quando solleveremo il velo… vedremo ancora il vuoto”). Una struttura simile si dipana nella monostrofa di versi atonali che segue la lassa di prosa. In effetti, i cola e i colaria della monostrofa sono continuazione ritmica della prosa che li precede, ma in essa si attua una diversa scansione del tempo, fra infiniti e clausole nominali, presente gnomico e passato prossimo con valore resultativo. Gli altri testi di Canzaniello mostrano tematiche metaletterarie, che a una lettura superficiale sembrano esulare dai temi dei primi due più lunghi componimenti, quello prosastico e quello versale. A ben vedere, tuttavia, l’obliterazione del segno e la dimensione esistenziale dell’autore autentico (gli altri, compiaciuti di sé sono “uomini di mondo”), l’autore posto al bivio fra annientamento e proiezione verso il lettore (pubblicazione), sono perfettamente consoni all’idea di chenosi, che si invera nell’ultima lassa di prosa. Leitmotiv e trait d’union dei diversi testi di Canzaniello, nucleo chiave strettamente legato alla costellazione concettuale aspirazione-trascendenza-sogno-scoperta-delusione-ripiegamento-chenosi, è l’evocazione continua, diretta e indiretta, dell’America, dalla prima prosa, con la sua rimemorazione-futurizione dell’avvistamento di Rodrigo de Triana, alla lassa prosastica conclusiva, in cui si assiste all’epifania dello svuotamento del segno e del senso. L’intero percorso che Canzaniello ha delineato è così incentrato su una teologia chenotica del sogno dell’Occidente, ipostatizzato nella vanificazione della frontiera, che si rivela orizzonte vuoto e illusorio, e dell’espansione verso un nuovo mondo, che si rivela permeato della stessa insignificanza dell’antico. Da questo punto di vista, la visione di Canzaniello assume gli inopinati tratti di una versione post hoc delle profezie senecane sulla scoperta di nuovi continenti. Nello stesso tempo, l’idea dell’inautenticità del progresso, a fronte del sostanziale erramento verso l’insignificabile e il collasso della storia, richiamano alla lontana l’ultimo Heidegger, quello di Zeit und Sein.
Su un’altra linea, connessa esteriormente con certe dinamiche compositive ereditate dalle neo-avanguardie, si muove Floriana Coppola, i cui testi si iniziano, in due casi su tre, con l’uso anomalo, sanguinetiano, dei due punti incipitari, quasi che i versi si presentino a chiosa esplicativa dell’inarticolato. Il primo momento di questa chiosa è rappresentato da un blocco di versi atonali in cui il tema della necessità della scrittura: il presente “scrive”, “scrivo” -ripetuto due volte- e il participio “scritta” trama di insistito poliptoto ogni snodo del discorso poetico, accompagnandosi alla rappresentazione della corporeità come faticosa omeostasi (marcata da verbi di suono duro, in rima, quasi paronomasici: “arroccata”, “aggrappata”). La costruzione incerta dell’individualità su una corporeità dai contorni liquidi, sfocati, ha la sua naturale eco, nel transito alla dualità apparente del secondo testo, in cui la dimensione relazionale (“a due a due per strada”) si dipana fra serialità dell’incontro (“numeri pari appaiati e benedetti…” con reiterato in triplice anafora il termine chiave “numeri”, inquietante richiamo a distopie degne di un Zamjatin) e condivisione effimera, virtuale, da social media, di post-verità più o meno presentabili (“dacci oggi la nostra bolla quotidiana”). Conclude la terna di scena di dissoluzione in cui inizialmente balena una presenza animale, “scimmia sulle spalle”, affioramento del rimosso atavismo evolutivo e materializzazione di un incubo à la Füssli, a completare la definizione di un quadro esistenziale in cui la vita è corporeità ibrida, un cyborg organato di prostesi virtuale e biologia autofagica.
Due nuclei tematici sono invece ricorrenti nell’opera di Carmine De Falco, già in opere pregresse, come Le meduse di Dohrn: il dispatrio, con quanto vi si collega, dal tema delle culture migranti, oltre che del migrante in sé, e l’etica del viandante, e in un senso più ampio, la poesia civile, nella sua forma più limpida ed esteticamente valida. Così in Sovietico red blues (del 2020), che già nel titolo che evoca l’illusione della fine del conflitto est-ovest propria della fine del secolo scorso e degli anni zero del secolo attuale, si delinea invece il quadro della rivolta soffocata dalla brutale repressione di Lukashenko, in un contesto che presagisce l’attuale invasione dell’Ucraina, così che il tema del dispatrio si declina nella sua forma più cruda, quella della “patria” espropriata, aliena, resa straniera dal tacco di ferro delle democrature che sempre più perdono connotati di democrazie. In Passaporto potere, una poesia la cui struttura formale, dominata da battute trocaiche e giambiche, risuona come il tinnito di una filastrocca, il tema del dispatrio si combina con la dimensione repressiva che lo Stato tardo-moderno sovranista assume, facendo del controllo dell’accesso e della frontiera, del ricostruirsi delle barriere, il totem a cui sacrificare i destini degli individui, con totale indifferenza verso la loro integrità fisica. È questa una vera e propria requisitoria in versi in cui le battute trocaiche e il martellamento dei cluster consonantici si fa tanto più duro, quanto più feroce è il senso del messaggio: citeremo banalmente, a titolo di esempio, la strofa conclusiva: “Passaporto stracciatutto/che di botto senza colpo/ scuoia colto nello scotto/ di uno scolo tutto torto./ Passaloco, passafuoco, tutto storto Passamorto”. L’autore di questi versi, che più spesso frequenta il verso libero e atonale e talora la prosa ritmica, o una sua personale versione di prosa in prosa, ha qui ingaggiato un vero tour de force metrico verbale, che lo impegna su due fronti: sul piano delle poetiche del ritmo, ridare vitalità al martellamento dell’ottonario regolare, sgretolato dall’usura tardo-romantica, sul piano concreto dell’articolazione ritmica, riuscire a incatenare il messaggio in ottosillabi che sono perfette tetrapodie trocaiche, con quattro accenti per ogni verso (due deboli, di prima e quinta, e due forti, di terza e settima), per non parlare dell’ossessività degli omeoteleuti. La catena parlata così ingabbiata è perfetto rispecchiamento dell’uomo odierno, incatenato a confini e burocrazie in proliferazione amiloidotica sul mondo. Lo specimen delle tematiche centrali nella poetica di De Falco si completa nella prosa Estate nuova, in cui pur sullo sfondo della tematica primaria della permanenza a Kastrup, nei dintorni di Copenhagen, si allude in modo ambiguo, a un clima in mutazione, che rende alieno all’uomo stesso il pianeta che lo ha creato e che l’uomo sta dis-creando.
Una linea di carattere narrativo, da romanzo in versi à la Pagliarani, seguono i versi di Fing ovvero il ricordo del lavoro (con sottotitolo “da un racconto incompiuto”) di Bernardo De Luca, la cui forma espressiva si materializza in un verso libero di andamento logaedico che si potrebbe talora definire endecasillaboide (soprattutto nel secondo dei componimenti, Pensieri di Fing nel dopopranzo); protagonista di questo racconto esistenzialmente incompiuto è Fing, ipostatizzazione di figura paterna, il cui nome riecheggia la filastrocca per bambini in esergo (Daddy finger, daddy finger, where are you? “Papà dito, papà dito, dove sèi?”), ma nello stesso tempo è richiamato, etimologicamente, nel verbo “fingere” che compare al terzultimo verso di Fing faccia bianca, mio padre: “so che finge, mente per preservarmi”. La rete di questi elementi chiave del testo è ricca di suggestioni: Fing, il daddy finger, il “papà dito” monco, che ha perso un dito a quattro anni, e finge per preservare il figlio, voce narrante, è portatore inconscio della rete etimologica che lega il verbo fingere e l’inglese finger, venuti dalla medesima ascendenza linguistica, una radice *dhing– che si ritrova nel greco thingánō “toccare, trattare, plasmare”. “Fing faccia bianca, mio padre” è costrutto letterario in cui confluiscono materiali esperienziali (non necessariamente autobiografici) dell’autore, ma vi si intuiscono, a partire dai giochi linguistici anche altre componenti. Col suo dito perso a quattro anni, è un homo faber incompiuto; è immagine ricorrente della teologia orientale l’idea che le hypostáseis, le persone della trinità, come Padre e Figlio, sono individuate e coessenziali come le dita di una mano; tale immagine permea, come archetipo, nel dialetto siciliano riflesso nei Malavoglia, per cui i membri di una famiglia sono come le dita di una mano, un immagine che De Luca, acuto italianista, ha avuto in qualche modo presente. Il papà-dito monco è indirizzario di una preghiera laica post mortem del figlio: è implicito correlativo di una dimensione relazionale tronca, in cui si intreccia l’idea tradizionale secondo cui pater semper culturalis: ma se il padre è sempre culturale, i Bernardo De Luca ci rappresenta l’allegoria di un padre finzionale, una civiltà, i cui valori sono difese bucate. Non porose: semplicemente tarlate, piene di brecce, non efficaci.
Una diversa tendenza, la sistematica allusione al linguaggio scientifico, acquisito come metafora diffusa della struttura dell’esistenza, è tipico dei testi di Basi, di Paola Di Gennaro, che dipana la sua arte verbale in strofe-calligrammi, visivamente disposte a formare una doppia elica di DNA. L’allusione metaforica al destino esistenziale come determinazione genetica è ormai un idiom della comunicazione contemporanea. Per l’opera di Paola Di Gennaro si potrebbe parlare di ipogramma, non fosse che il disegno (-piano architettonico) in cui le parole si dispongono, non sparasse l’idea in faccia al lettore con folgorante evidenza. Le Basi, intese in tutte le loro accezioni, scientifiche (basi dell’acido desossiribonucleoico: adenina, guanina, citosina e timina), e ordinarie (enti base del paesaggio intramondano in Apbau fra erramento e deiezione), costituiscono le componenti essenziali, casualmente aggregate, di un esistente complesso, con la sua dimensione esperienziale frammentaria. In una prospettiva analoga si collocano i testi di Nel neon. Tessitrice della trama versale e prosastica degli specimina di quest’ultima silloge è la luce, nel paesaggio della città: luce “intorno alle case, sul mare/sui bordi del vulcano”. La luce esterna fa da contrappunto alle ombre dentro le case, ombre persone mosse a neon spenti, protagoniste di un’implicita école du sans régard. Nei versi di questo che stiamo citando, è che il primo dei due componimenti di Nel neon proposti, assistiamo ancora una volta a una essenziale definizione di poesia: nel flusso di luce-informazione-presenza in fuga del mondo, spostato verso il rosso dell’annullamento, la parola poetica è l’occhio che si chiude, perché luce e parola, per breve tempo, permangano.
Un esempio estremo di consapevole cortocircuitazione del tempo storico, del tempo esistenziale e della freccia del tempo fisico-esistentivo si scopre nell’opera di Bruno Di Pietro, che da sempre, nei suoi più riusciti poemetti storico-lirici, si riveste di personae historicae loquentes come di eteronimi pessoiani. All’atmosfera e ai temi del poemetto Impero (2017) appartengono, direttamente e indirettamente, Caligola e il poeta Scipione, Claudio e la balbuzie, “Abolirò le tasse”, Galeno; a un nuovo momento della produzione, ma a un tema di antica frequentazione, legato all’atmosfera di Elea e del pensiero meridiano/magno-greco, appartengono gli ultimi tre testi, a partire da “Quando verrà il passato” – In limine. I personaggi di Impero, legati alla memoria gibboniana del declino e della caduta di Roma, lasciano intuire, nel tipico linguaggio allusivo di Di Pietro, l’aura storica delle epoche di origine, ma proiettano al tempo stesso la loro eco nel tempo presente, che si tratti del sinistro umorismo cannibale di Caligola, o della politica finanziaria estrosa di Nerone, o della resa di Galeno a Palermo. (indicata col nome fenicio di Balarm), di fronte ai ripetuti scoppi di peste del III sec. Ma mentre la temperie dei versi legati al mondo dell’impero suggerisce, almeno in parte, con voluta ambiguità, un’orientazione subliminale, se non un orientamento palese, verso la poesia civile, una forma innovativa, non neo-orfica, non neo-lirica, di intimismo è propria delle poesie incentrate sulla figura di Parmenide e sulla sua lotta filosofica con il divenire, a cui inopinatamente parrebbe convertirsi. Si tratta però di un essere diveniente/divenire persistente, che congela il tempo in un eterno presente progressivo (“io invecchio”).
I quattro testi in versi atonali (le due lasse di Appunti di solitudine e Libertà, a cui seguono Àsana e Altare), e le lasse di prosa da Respirare nel vuoto, proposti da Francesco Filia, sembrano suggerire che l’autore sia entrato in una fase significativamente innovativa della sua produzione, al di là del suo riconoscibile marchio di fabbrica, costituito da uno stile volutamente prosastico, quasi confidenziale. Centrale è nei quattro brevi nuclei di versi il tema ricorrente del “ricominciare”, di una ripartenza esistenziale, culturale, antropoligica, storica e last but not least letteraria, al di là dello scrutare perverso degli “occhi folli della storia”. Si accompagna a questo nucleo essenziale la possibilità di una sorta di permanenza residuale, momentanea (“calcoli quello che tra questi momenti potrebbe sopravvivere”), in cui ogni singolo individuo potrebbe essere variabile impazzita, nelle anse del caos, di un minimo di ordine e di decenza. Altra è l’atmosfera concitata, rapinosa, della prosa di Respirare nel vuoto, la cui trama è centrata, ancora una volta, sull’implosione della storia, sull’avvertimento della catastrofe che l’attuale situazione internazionale sembra lasciar presagire (“Gli annali si svuotano e il cappio della storia si fa sempre più stretto e ti avvolge il collo che si gonfia e soffoca”). Filia declina il tema della fine della storia in termini del tutto opposti all’ingenuo e fallimentare ottimismo di un Fukuyama. Già la psicologia aveva intuito l’illusorietà di questa idea, poiché per ogni individuo la storia finisce nel suo oggi, a cui si sentiva destinato, per pregiudizio di conferma. Nella visione di Filia, la fine della storia è l’estinzione, un responso da spiegazione pessimistica del paradosso di Fermi.
Ironizzazione della forma sonetto e ripresa del sonetto atonale è in Vincenzo Frungillo, i cui versi si dispongono idealmente in due quartine e due terzine (con la sola eccezione dei distici di E quei visi rivolti al segreto. La misura dell’endecasillabo è spesso sfrangiata da marcati fenomeni di anacrusi e sincope, così che in realtà i versi di questi sonetti oscillano fra le sei e le quindici sillabe; anche il sistema delle rime è volutamente scardinato, riposizionandosi gli omeoteleuti (rime, assonanze, consonanze) in collocazioni espressive non normate. Il percorso di Frungillo si muove “in una città mobile e bipolare… insieme di seme e corruzione”. L’io lirico è in questi versi slittato in direzione di una focalizzazione esterna, di una terza persona, di una illeità sistematica, proiettata nella memoria come struttura dell’identità (“ricorda la passeggiata con il padre”). La parvenza del mondo (nel senso forte del termine, del suo Urphänomen) è in questi sonetti tramati di ricordanze un dato di partenza, a cui la parola si accompagna creando una sorta di problema del terzo uomo e di sinolo-soluzione enunciato in forma di poetica (“Anche se insignificante il mondo appare,/con uguale gravità arriva la parola/come se la voce e la materia nuda/ fossero una cosa nuova, una terza figura”). Lo “spiraglio”, la vita intesa come “una rosa che si apre nel buio/ quando si stringono gli occhi e la luce”, sono due motivi strettamente collegati a questa presentificazione del ricordo: è un motivo che, accanto all’erosione della membrana che separa presente e passato, storia ed esistente, ricorre talora, anche se meno comune, nei poeti di questa antologia (un’immagine simile è in Paola Di Gennaro). Si rinvengono occasionalmente in ipogramma nei sonetti atonali di Frungillo, ma sono palesi nell’ultimo (“le donne contadine segnano il passaggio”), degli echi rilkeiani, da Sonetti a Orfeo e da Elegie duinesi (“la creatura dell’aperto”) il tema della morte del maschio festeggiato dalle “donne contadine”; campeggia in questo sonetto, dalla forma versale più aperta, il concetto dell’eterno come “passaggio” in quanto guarigione dal ricordo, che è invece tema dominante dei primi tre sonetti qui proposti. Il tema è peraltro anticipato già nella poesia in distici E quei visi rivolti nel segreto, la cui sententia finale (“… la dove si spezza lo scenario// e resta la visione del mondo/ vergine e intatto sul fondo”) suona ai nostri orecchi in responsione con quella dell’ultimo sonetto (“[sposi eterni, occhi negli occhi…] / restano immortali sotto lo sguardo dei canti”). Nel procedere dei testi di Frungillo, per quanto le poesie proposte da ogni poeta in quest’antologia non siano sempre contigue nell’opera del medesimo, si intuisce una visione metafisica in cui l’Altro, una sorta di “divina indifferenza” non del tutto malevola, si innesca al naufragio del quotidiano e della sua meccanica del ricordo.
Tappe di un Lentissimo viaggio propone invece Carmen Gallo. Il tema del viaggio in Italia come specchio di un percorso nella geografia esistenziale della penisola, fra degrado e ripresa, non è nuovo (si potrebbe citare la sua versione comico-realistica del Gran Tour di Tricarico come ultimissimo esempio). Propria del diaro di viaggio di Carmen Gallo è la dinamica del flusso di coscienza, in cui i frammenti esperienziali si susseguono per andamento associativo, o per mero richiamo dovuto all’affioramento percettivo (la “voce della radio” di Prea). Si potrebbe evocare una dimensione a metà fra i condensati di tempo memoria di una piccola Recherche e i pensieri in libertà della Penelope-Molly Bloom joyciana -una Penelope assai anomala, lei stessa in viaggio, e con uno stream of consciousness duale, che coinvolge il compagno del cammino. Ogni tappa del viaggio assume, in parallelo al flusso di coscienza, anzi tramite il flusso in sé, una struttura narrativa e situazionale, incentrata a volte su un personaggio in focalizzazione esterna (Bari, con la sua turista tedesca). L’ultimo dei componimenti, Calabria, è in effetti un inizio di nostos (“riprendiamo la strada di casa”) in corrispondenza oppositiva con Prea: “la neve in Calabria” fa da contrappunto agli indizi descrittivi di Prea che indicano, in provincia di Cuneo, la presenza di un caldo rovente (“l’asfalto di luglio in autostrada”, la “lamina calda dello sportello”). In sottofondo la radio, accesa in Prea, e spenta alla fine di Calabria. Questo sistema di responsioni duali e di rimpalli di impressioni, intrecciato con la Ringkomposition, lascia intuire una più marcata evoluzione della poesia di Carmen Gallo verso una struttura poematica disseminata, vera e propria narrazione in versi.
Una forte presa di posizione neometrica, archeologica in tutti i sensi ricavabili dall’etimo greco del termine, arkhé, connota l’inconfondibile impronta espressiva di Mimmo Grasso. La sua canzone, il dreyt rien, pubblicata in tiratura limitata nel 2014, fu dedicata a suo tempo al compianto Aldo Masullo. Come da titolo franco-provenzale, il puro nulla come chenosi del fondamento (un tema che molti poeti dell’antologia condividono, non fosse per influsso, sul territorio culturale della città, di irrinunciabili punti di riferimento, come Masullo stesso) è al centro di questa canzone di endecasillabi e settenari, il cui schema (abCabCcdeeFgG, coboletta di congedo atipica XyY), procede con il rigore dell’enunciazione filosofica di una sorta di scolastica del non essere. Appare qui il motivo del pensare ad occhi “chiusi/elusi”, un elemento che sembra ricorrente in alcuni dei nostri autori, ma qui l’immagine ha senso tutt’affatto diverso, legata com’è alla negazione del rapporto fra logos-giudizio-pensiero ed essere: se “da un cane cieco il non detto è guidato”, il silenzio necessario di fronte a ogni inesprimibile metafisico (come da lezione del primo Wittgenstein) è abbinato a una strutturale incapacità dell’uomo ad attingere le verità profonde, restrostanti, dietro le quinte della sua esperienza. La meditazione “ad occhi chiusi” (vero e proprio sintagma-rima) diviene così forma di una auto-coscienza che è quasi buddhisticamente, svuotamento -un fattore, l’influsso diretto o indiretto del buddhismo, sia esso abbracciato o meno come esperienza filosofica e religiosa, che si rinviene altrove, in poeti come Roberto Carifi, e per cui Mimmo Grasso è accomunabile, sia pur in minima parte, a Viola Amarelli. Come nella tradizione della poesia di tema mistico o metafisico, si dispiegano nei versi immagini liminari, al confine fra sensorio e tema figurale: “l’allodola si prende/ con lo specchio e Narciso/ con l’acqua… Accompagnano queste immagini gli elementi di una lingua estrema, in cui i giochi di risegmentazione atipica (ripresi in certo modo dal linguaggio filosofico) inseguono gli sfarfallii e le sbavature dell’esistente che non si lascia contemplare: “la trinità pensiero-corpo-azione”, “il cancello/ del fu-ora-è-allora…”, con evidente richiamo al tema dell’adiaforia del tempo, che declinata in varie forme ricorre come fil rouge in molti dei poeti dell’antologia. La mistica della chenosi culmina, nell’ossimorica “chora/ del non luogo” , spazialità di ciò che non ha determinazione spaziale, rivelando che il non essere è (esistenzialmente) la “scorza” dell’io cosciente, “che canta il nulla per non stare solo”, seguendo il ritmo di un alternanza coessenziale e anagrammatica “metro-morte”, una volta assodato che, per negativa alétheia di gorgiana memoria incrociata con il paradosso di Epimenide, “il niente/ niente dicendo dice il vero e mente”, così che l’intera canzone si palesa in fine come un inno all’indecidibilità dell’atto di essere.
Di sapore nettamente più materico sono i testi di Daphne Grieco, il cui primo testo, Λαγκάδα (come il centro marittimo nell’isola di Chio), segue la ciclicità del biologico staccando con versi fonicamente acuminati come lama di bisturi le componenti più grezze dell’aggregato vital-materiale, marcate con geminazioni, paronomasie, anadiplosi: “sasso su sasso…”, “ossa su ossa”, “orbite vuote/ come orbite e basta”, “perso il nome persa l’essenza”, “pietra su pietra… / tibia su tibia”; il “nome” come demarcatore ontologico nel ciclo, ne segna l’alpha e l’omega, dal nome perso alla “prima festa del nome”; un tema simile è in Domenica, dove la decostruzione e ricostruzione del biologico, condensata nel correlativo oggettivo delle carni del pranzo domenicale, si fa riflessione dell’essenza della vita come processo autofagico intimamente conflittuale e decompositivo; Domenica è fra l’altro uno dei pochi pezzi in cui il dialetto appare, come proverbio popolare (quanne se magne, se cumbatte/ cu a morte), in quanto ovvio elemento di caratterizzazione (della figura del nonno), ma soprattutto come forma cruda dell’espressione della matericità brutale nella sua realtà più truce (cibo-morte). Di altro tenore gli altri due testi, il più semplice Lasciatemi qua e l’assai articolato e oscuro Didyme o Apparizione Salina. Lasciatemi qua ha il voluto sapore di una poesia selvaggia, di quelle in cui una mano ancora incerta sopperisce all’anomalia permanente del verso libero offrendo come surrogato di ricorsività formale l’uso di uno stico-ritornello a inizio strofa: nelle due strofe si articola l’allegoria antica del timoniere e della nave, ma il timoniere è il singolo esserci (altro qui non rappresenta l’io lirico, che in genere in Daphne Grieco appare come voce decentrata, quasi da narratore interno decentrato) sul mare delle possibilità, avvertite come mero rischio, senza possibilità di governare la nave. Ne emerge una visione dell’esistenza e del reale che si potrebbe identificare, in modo grossolano, come una sorta di bio-pessimismo, i cui capisaldi sono essenzialmente: 1) autofagia del biologico; 2) ciclicità cieca (come di una samsara puramente intra-fisica, senza orizzonti di redenzione o superamento); 3) rischiosità strutturale e indecidibilità dell’esistere (tematicamente affine, ma non del tutto contiguo, all’analogo nucleo concettuale del dreyt rien di Mimmo Grasso). Questa dimensione esistenziale ambigua e distruttiva si arricchische di un’ulteriore componente nelle più inquietanti immagini di Didyme: simbolo di una rete di attrazione, pulsione, distruzione, è qui il femminile che ne è protagonista, aracnide Arianna-aragna-Didyme, argyroneta aquatica che si sommozza in agguato, pelle salata abbandonata dal sole, comparata in analogia al cappero salato, frutto amaro dell’inganno dell’estate “ancestrale happy hour”.
Estremamente ricca e complessa appare sin dal primo impatto la struttura formale del messaggio poetico di Giuseppe Andrea Liberti. Le terzine versolibere rimate di Assemblea si incentrano sul parallelismo stilistico e tematico fra “rapporti di produzione” e “rapporti di riproduzione”, con allusione a una prospettiva marxiana che nei versi di Liberti traspare diffusamente, e che qui collega, frommianamente, essere, avere e arte di amare. Mekbuda (il cui titolo allude al nome arabo della stella zeta dei Gemelli) scava ancora più in profondità in quella che viene chiamata, nella sua lingua di origine, “die materialistische Anschauung der Geschichte”, la visione materialistica della storia; le due strofe, di andamento giambico-logaedico, strutturate in modo da mimare alla lontana una quasi responsione strofica, si oppongono per temi e linguaggio: in dialetto la prima, evocando la crassa dimensione del degrado (simbolo ne è il kobrètt, eroina tagliata male, residuale e a buon mercato, responsabile di fenomeni violenti di crisi di astinenza); la seconda, fra linguaggio allusivo e tedesco del Capitale veicola la riflessione sull’esistente e le sue condizioni oggettive. Sulla stessa linea è Mebsuta (ε Geminorum), testo ricco di auto-ironia, o forse più precisamente di auto-sarcasmo (“sentirsi chiamare/ coso zecca e in culo al doppio nome/ misura di settenario”), con allusione al comune insulto internautico odierno, “zecca comunista”, indirizzato a chiunque, avendo una visione della società umana anche solo di poco più civile del cannibalismo alimentare legalizzato, sia sospetto di pericolose inclinazioni di sinistra. I due testi intitolati alle due stelle dei gemelli sono allusive di una doppia natura dell’autore e della realtà che l’autore riflette e da cui la coscienza dell’autore proviene: lingua regionale e linguaggio filosofico, doppio nome e tematica del doppio, ambiguità e doppiezza del linguaggio, con giochi di segmentazione e pseudo-univerbazione (fo gli amen. A me i fogli). La poetica che emerge da questi versi si incentra, essenzialmente, su un assestamento del senso intorno alla realtà del mondo concreto: “distiguere il grano dal loglio mondano/ e indcare e tracciare le forme dell’infinito:/ quella non è una stella è un aeroplano/ quella è la Grande Nube di Magellano” (versi conclusivi di Dorado). Implicita a questa poetica è la tensione etica di un assestamento valoriale che passa attraverso una rettificazione dei nomi e un aggiustamento percettivo. Di temperie diversa è Stanze del Belvedere, in cui Liberti si serve con estremo nitore dell’endecasillabo sciolto, aggregato in tre lasse isostiche di venti versi. L’endecasillabo di Liberti, quando usato in serie continua come metro sillabico normato, non mostra i tipici malvezzi formali di molta poesia sillabica di fine Novecento inizio ventesimo secolo: per esempio, la sgradevole metaritmisi dell’endecasillabo regolare con l’endecasillabo rolliano (doppio quinario a primo membro sdrucciolo, senza nemmeno la sinalefe interna a ridosso di cesura); unica lieve pecca è l’accento di quarta caricato sulla proposizione in proclisi al v. 58. La dimensione urbana di San Giorgio a Cremano, in questi endecasillabi, viene inquadrata con rigore realistico e ideale pari al rigore formale, quasi che l’incasellamento della forma possa arginare il degrado, in un mondo in cui “non c’è nulla che possa dirsi alieno/all’abuso”. Di sapore epigrammatico sono invece Esami al Secondigliano (in cui la confusa citazione ungarettiana di uno studente “la morte/ si vive/ scontando” si trasforma in intuizione esistenziale) e Meteo, in cui l’immagine di un ambiente arrostito nelle “Malebolge” estive diviene riflesso e causa del malessere sociale.
Un analoga ricerca formale, un analogo plurilinguismo, anche se con altri strumenti, connota da un po’ più di tempo anagrafico i versi di Eugenio Lucrezi (alcuni dei quali già diffusi tramite Nazione Indiana): gli endecasillabi di Ave Bernhard! (ispirato ad Ave Virgilio, Carme, di Bernhard, la cui figura ritorna più volte in questi versi che sono, di fatto lacerti strofici disseminati di un poemetto) in cui ossessivo ritorna il Leitwort “morte” con tutti i suoi etimi e le sue deformazioni (la “rimorte”, il “rimorto” -non più risorto- sul Golgota); i versi liberi, la cui cellula di base è un settenario con sincopi e anacrusi, talora allargato fino al decasillabo, e intervallato da due endecasillabi, della monostrofa di Brüderlichen Schwachsinn, di tono surreale, da mondo alla rovescia, dominato dalla dinamica del non ascolto fra “un brulicare di seppellitori”; la monostrofa di Crossroads, di versi liberi di andamento giambico (endecasillabi con anacrusi), dai toni metafisici coloriti di ironizzazione del trascendente (“di là per sordi,/ mentre nell’aldiquà c’è un gran frastuono”), lo sperimentalismo à la Sovente, nell’uso del latino (che anche lo stilatore di questi stringati referti critici condivide) in Distinguere la tenebra dalla tenebra, in cui le dittologie e le geminazioni (et nigro et rubro… et nigro et nigro) ricalcano questa dialettica di suddistinzione e ricompattamento dell’oscurità (mutatis oculis ad unum), accompagnandola con giochi verbali che ritroviamo analoghi anche nelle poesie italiane (i poliptoti, mutat… mutatis, le parechesi, paretimologie e paronomasie: spectros in spiritus, feles/ in aves felina/ voce aves) e suggerendo sul piano prosodico, fra le sequenze inerziali di cretici e trochei, altre unità ritmiche, come il dodrans (mutatis oculis, spectros in spiritus _ _, _UU_) -il che dimostra una padronanza notevole della lingua antica; di questa poesia Lucrezi propone un’auto-versione (alla Emilio Villa con il greco di Τὰ Θήβῃσι τείχη), Bernhard finge con un doppio stilo, in cui si mescolano italiano regionale (“orecchie appizzate” = erectis auribus, un quasi-virgilianismo [~Aen. I, 152]) e letterario; di questa lassa, incentrata sugli uccelli felini, quasi-arpie o garguglie, o meglio ancora, gatti-angeli (come si chiarisce in finis: poiché l’umanità, secondo Bernhard, è deviazione dall’essere perfetto, il gatto, “il sovramondo di un mondo malefatto/ pullula di felini con le ali”), è sviluppo la successiva, Abbiatevi le grazie e i miagolii; il Virgilio in versione Bernhard accompagna il lettore di questi versi in una nuova Comedia, connotata, come si è accennato prima, da un marcato plurilinguismo, che in Paint it, black, si manifesta come mescidanza fra italiano moderno e medievale. Nell’insieme, la fase della produzione di Lucrezi riecheggia in parte l’iper-sperimentalismo linguistico e formale del gruppo ’93, di cui si riconosce l’influsso. A una logica non lontana da questo influsso appartiene anche l’evocazione di Napoli come funzione cognitiva: così in Grip, anglismo in cui si legge la radice germanica del dialettismo “ingrippo” di cui si chiarisce che a Napoli “è l’insolvenza/ del fatto, lo squagliamento/ del senso”. Come spesso accade negli autori di versi, il senso profondo di una poetica è nel dettaglio: in questa breve coppia di cobolette di endecasillabi inframmezzati da versi più brevi (settenario, ottonario, trisillabo), si chiarisce la connessione profonda fra la poesia di Lucrezi e l’universo cittadino: lo squagliamento del senso e l’insolvenza del fatto impongono la proliferazione dei significanti e della loro organizzazione e struttura, un elemento di fondo degli autori di Napolesia, su cui dovremo tornare.
Un dettato più uniforme dal punto di vista stilistico mostra Giovanna Marmo, la cui estrema complessità si nasconde dietro l’apparente simplicitas lessicale e formale. La poetica della Marmo punta, soprattutto, sulla densità simbolica di immagini di natura quasi visionaria, onirica, in cui gli oggetti evocati sono sottoposti a una torsione contestuale estrema, quanto a restrizioni semantico-sintattiche, e sul piano reale, ontico-relazionali, vale a dire, nel loro concreto disporsi nell’esperienza comune. L’enunciazione metapoetica dell’incipit di Anche altre zone esprime in forma ossimorica e paradossale la natura ambigua dell’opera in versi, la volontà di identificarsi obbiettivandosi nell’atto espressivo di pertinentizzazione (“il nome mi ha chiamato”), di non esaurirsi in chiacchiera (“non parlerò”), o di implodere nell’assenza implicita nella scrittura/cartolina postale: “Non voglio che le parole siano/ inchiostro sulla carta.” L’intero testo si presenta come una paradossale ipostatizzazione dell’agire retico in versi come di un teatro imploso, in cui la persona loquens segmentata non riesce a ricostituire appieno l’intero. Il motivo è colto da un’altra angolazione in Una piega sulle labbra, in cui il tema centrale è l’erramento implicito nella funzione specifica del linguaggio, il narrare. La deviazione del referente è strutturale (“divagare sempre”); il palco esistenziale di ogni atto di essere come esternazione-recitazione-interpretazione è una monade, da cui vettori di informazione deformata, come per un orizzonte degli eventi o una singolarità, si dipartono deviati senza incontrarsi. L’individuo, e l’individuo che si esprime in versi più di ogni altro, si pone qui come una singolarità interpretativa in una dimensione che ignora ogni sensata freccia del tempo direzionata a partire da un inizio. Corollario dell’incertezza della freccia del tempo e della deviazione informativa legata alle singolarità interpretative degli individui, è l’identificazione fra il palcoscenico della parola (e della parola poetante in genere) e l’universo come palco dell’esistenza, luogo in cui i coni di luce deformati e limitati dalla loro velocità, creano un riflesso, un vero e proprio doppio ontologico, di ogni individuo, che è così da sé scisso, temporalmente sfalsato, ontologicamente falsato. Il palco-universo, in cui la parola si perde nel vuoto, è così “abbandonato” intrinsecamente senza vita, coperto delle tracce delle macerie degli esistenti che furono.
I versi liberi (ma vi si riconoscono combinazioni di unità metriche ben ravvisabili, come l’esametro barbaro e l’endecasillabo che chiudono, sentence-couplet da sonetto scespiriano esploso, Ulivi e Pretesti), variamente rimati, di Francesca Martuscelli abitano invece il terreno minato della tematica amorosa sublimata in simbolo, collocata nell’intreccio di una molteplicità di rimetaforizzazioni, esistenziali e conoscitive. La forma espressiva scelta da questa autrice dialoga, volutamente, con il parlato ordinario (si pensi all’incipit “anche l’occhio reclama la sua parte” in A me i tuoi occhi), aggregandone gli idiomatismi così da ricontestualizzarli e caricarli di significazione, secondo il più tipico processo di straniamento; ciò che rende nuovo questo lusus è l’intersezione tematica delle metafore cristallizzate degli idioletti: per es., rimanendo al primo dei testi, “occhio” – “punto di vista” [alla Merleau Ponty] – “reciproco abisso riflesso” [metafora platonica dell’occhio/intelletto del dialogante, che si specchia in un altro occhio intelletto e in un’altra psykhé per conoscere sé stesso], e si potrebbe continuare ancora a lungo. Allo stesso modo Gli ulivi indugiano in un descrittivismo di tono volutamente basso, da nenia fiabesca, per poi far emergere un sistema di retro-significati, legati alla struttura entagled, reticolare, ramificata, del cosmo (e viene in mente, extra Neapolim, L’arbulu nostru di Cinà): una struttura tradizionalmente ad albero, plurivoca, unitaria, persistente, in barba ai rizomi-cloni di deleuziano-guattariana mal-metaforizzante memoria, da filosofi maldestri in fatto di botanica. Così Pretesti, che con il suo esordio (“adoro”) sembra mantenersi al livello del linguaggio da conversazione ordinaria fra donne gentili, finisce per evocare, attraverso la rete di etimologie e di rimandi, il tema, metapoetico del prae-textum, dell’orlo, del contorno della trama, storyboard universale, ma anche pre-testo, implicita premessa della tessitura della parola, fino ad arrivare alla rivelazione in explicit: “Tendimi le tue mani fino a disegnarmi un vestito,/ pretesto è essere insieme trama e ordito”: il pretesto diventa toga praetexta; il richiamo alla toga pretesta della raffigurazione tradizionale del Cristo, nella chiusa di questa monostrofa diviene un invito a venerare il corpo, venerazione del corpo che si fa testo e tessitura di relazione. Di qui, nell’ultimo testo, l’idea della relazione come nuovo alfabeto, nuovo sistema mimico-segnico per costruire un tessuto trans-corporeo: non è perciò un caso che l’ultimo dei testi della Martuscelli presenti un ritorno ossessivo di quelli che potremmo chiamare verba permeandi: “permeabile”, “pervadersi”, “trasparente”. La parola in versi si fa qui filastrocca, linga da pappo e dindi, considerando che il lusus amorum scivola oltre i confini delle trame verbali, in alto come in basso.
I versi di Marco Melillo rivelano invece una natura engagée sul piano storico-politico e metaletterario; una linea tematica meno evidente è legata invece a meditazioni intimistico-esistenziali. I due temi si intersecano nel primo componimento (il dio che si favoleggia non è cielo) in cui la negazione del trascendente si coniuga alla denuncia del furor bellicista mutatosi in ridicolo e vampiresco tifo internautico. Il secondo dei testi (vieni dal mare ché placa burrasca) in cui sembra leggere un allusione al caso di cronaca del bambino migrante affogato, come simbolo di una tragedia epocale di odissee senza ritorno (“se fossi l’ultimo ti pianterebbero/ un sasso già qui, sul fondo nero”). L’insignificanza del gesto letterario (scrittura-ricezione) nella sua fugacità (“Nessuno ricorderà ciò che hai scritto” in Ti basta una cosa semplice) e nell’indifferenza del contesto sociale (Per uno che ne leggesse) è l’altra componente del disincanto di Melillo, a cui fa da sfondo la città come campo illusorio di aggregazione umana (Ci si illude che di un luogo). Nuclei tematici più centrati su un io lirico debole si leggono nei versi di Sono invecchiati i miei soli autunnali, c’è una favolosa luce accesa, Ti ho mentito ma non so mentire. A unificare questi diversi filoni della poesia di Melillo, un fattore strutturale, la forma dell’io lirico come punto di vista laterale rispetto al referente, anche quando è referente a sé stesso, anche perché si tratta di un io ontologicamente “bucato” o preda dello stesso divenire in declivio dell’intorno, e due fattori di carattere stilistico e formale, anzitutto un monolinguismo lirico rigoroso, in secondo luogo il ritmo di sottofondo, marcato da portanti ritmiche ben riconoscibili anche sotto l’apparente omogeneità del verso libero: la pentapodia giambica approssimativa dell’endecasillabo si sgrana in ipermetri o in novenari giambici (il dio che si favoleggia…); altre volte la battuta di fondo è l’ottonario che si sgrana, per anacrusi ancora in novenari giambici o si spezza in quaternari/quinari (“Ci si illude anche in un luogo/ di passaggio…” “C’è una favolosa luce accesa/ lungo il bordo delle cose”), forma che riemerge addirittura dall’ode à la Chiabrera; i versi di “Sono invecchiati i miei soli autunnali” mostrano invece battute dattiliche o anapestiche, che dall’endecasillabo di 4a 7a e 10a sillaba dilaga al dodecasillabo per poi collassare in ottonari dattilici, novenari regolari e decasillabi, con a volte curiosi effetti di ipermetro (“Forse l’amore non dura – che/ questa pazienza di crescere soli”). Questa peculiare sensibilità ritmica si manifesta così in una reinvenzione delle forme tradizionali, dissimulate nelle forme aperte. Tale reinvenzione è palese anche negli elementi residuali di metrica verticale (senhals rimici), a volte interni, vere e proprie rime al mezzo, a volte disposte in modo tale da rasentare la ripresa di forme tardo-arcadiche (come si è accennato per C’è una favolosa luce accesa): tale complesso di scelte strutturali, ardue da mantenere senza ricadere in una forma chiusa imperfetta e senza scivolare nelle forme semi-selvagge di versoliberismo e atonalismo, è la cifra espressiva della poetica di Melillo, sulla falsariga dell’ironizzazione-depotenziamento della lirica come genere e della sua tradizionale egoità letteraria.
Più marcato l’intimismo di Melania Panico, in cui la riemersione di un io lirico residuale si manifesta come punto di vista, regione cosciente e luogo geometrico di un flusso esperienziale, che però si ammanta di “reticenza al dirti eccomi”. “Eccomi” “vedimi” (l’abramico hineni) è la prima allocuzione di un “io” di fronte a un “tu” assoluto. Il cosiddetto tu lirico, altrettanto rilevante, è di fatto, per chi si esprime in versi, un “tu” assoluto (chiunque possa essere storicamente in concreto, dal compagno di simposio degli antichi a un amante). Il primo dei testi che Melania Panico presenta è, in apparenza, incentrato su una tematica amorosa: ma la relazione è, potenzialmente, la stessa della poesia con il suo fruitore. La dimensione di Erinnerung, di ricordanza, rimemorazione, è l’altro aspetto della produzione della Panico, che innerva tutti i testi da lei proposti per l’antologia: in Da dentro tutto appare crocifisso, questa rimemorazione si fa scavo del sacrificio degli enti all’evoluzione del loro modo di essere percepiti da chi li incontra (“…non sapevamo ancora… ora… so”); in Tutti i porti abbiamo toccato, la rimemorazione diviene il portolano emotivo di una navigazione esistenziale fra sicurezze cercate e delusioni risultanti, fosse anche solo per la morte dell’oggetto di aspettativa (“…porto che pensavamo fosse l’ultimo/ un padre e una madre…), così che il viaggio dell’esistenza non si interrompe. La poesia di Melania Panico ruota così attorno all’insoluto ontologico dello spiegarsi “la fine l’inizio soprattutto l’inizio/ l’attesa…”, prima di naufragare, con la “litania” della parola (in tutte le sue proiezioni verso l’altro, verso il “tu” assoluto, dalla relazione all’espressione letteraria), in una “confusione di sguardi/ un tragitto a vuoto”.
Una tendenza all’imagine anomala, estrema, correlativo oggettivo di dimensioni percettive dirompenti, è in Marisa Papa Ruggiero, le cui foreste di simboli sembrano evocare la testura figurale di una pittura surrealista. Così fra le Rifrazioni dei lampi di luce, fulgurazioni cognitive e coscienziali che feriscono l’occhio della mente, la tigre dell’esistenza, il predatore in agguato dell’Angst si manifesta improvviso. Così Morgana, “guida i passi”, come miraggio e illusione, fra la “magia del caos” e la “fuga d’echi in sfolgorio di note” della realtà. Nel terzo dei testi presenti, l’agglomerato sinestetico che connota la poetica di Marisa Papa Ruggiero culmina nella contemplazione di un giardino lussurioso (giardino da maga Armida), in cui lo slittamento dei sensi si traduce nello smottamento del divenire, con il suo grado di spossessamento. Corrollario di questa esplosione di immagini e del sensorio di cui si fascia l’io autoriale è il dipanarsi di ordigni versali articolati e complessi, con modulazione visiva dello spazio bianco e del corpo fonico degli stichi ritmici all’interno di grandi blocchi strofici.
Una notevole evoluzione mostra la poetica di Antonio Perrone negli inediti de Il pianto dei morti. Al centro delle sue tematiche è ora l’indagine del “male originario” annidato “in casa”, cioè all’interno della quotidianità ordinaria e dei luoghi interiori e fisici che definiscono l’esperienza dell’individuo e il suo centro egoico. Il male si concreta in un “rantolo dentro il palato/ il suono dei morti che piangono/ i vivi”. Il tema del pianto annidato nel buio della casa ricorre anche in nascosta nel seminterrato, come presenza acquattata nella tenebra e inquietante. Particolarmente articolato si fa il discorso poetico nella seconda lassa della silloge, che approfondisce il tema del divenire come disgregazione, già in nuce nel testo che la precede, ed è connesso al nucleo tematico principale, così che in questi versi si viene declinando il debemus morti nos nostraque in una prospettiva dialetticamente rovesciata, in cui i morti piangono in silenzio i vivi, compiangendone, dalle retrovia della quiete della non vita, lo struggimento, il consumarsi, l’entropia ontologica: questo “segreto dei muti”, “mistero dei morti/ che parlano solo al mattino” popola la stessa luce meridiana di fantasmi e ombre, creando nel lettore l’impressione che il nulla come non essere sia rappresentabile in atto e in effetto come una sorta di negativo dell’universo e dell’esistenza. Un interesse a sé rivestono, per gli sperimentalismi formali, le lasse 4 e 5, decostruzioni del sonetto, in cui si riprende la forma dei sonetti atonali; il primo dei due, nei giochi rimici, a volte basati sull’andare a capo della parola spezzata (a causa di troppo osce-/ni pensieri, vv. 4 s.) richiama il Sebastiano Vassalli di Disfaso (e in specie la poesia Le angosce); il secondo è un testo metapoetico, in cui Perrone enuncia in pochi tratti l’ontogenesi del suo esprimersi in versi: 1) rifiuto del dialetto; 2) rifiuto della proscrizione del metro in favore del forzato ricorrere al verso libero o atonale -ma contemporanea decostruzione della forma chiusa; 3) enunciazione del principio che l’essere rotto, come un giocattolo sballottato, ha come sanatura impropria, dislocata, la necessità della forma.
Ironizzazione parodica della vulgata leopardiana, o genericamente romantica, fra operette morali e canti, si legge nei versi di Antonio Pietropaoli: così l’elogio del gelato, dal titolo deutero-sofistico, è di fatto un’operetta morale in stichi atonali, in cui ossessivamente si inscena il dialogo, da delirio a due di Jonesco, fra un Leopardi in crisi di astinenza da sorbetto e un venditore di gelati, che va il verso al venditore di almanacchi di usurata memoria scolastica. Il Leopardi ipotetico dell’Elogio, eteronimo-zimbello e alter ego improprio dell’autore, consegna e demanda al gelataio il compito di rendere meno infelici gli uomini attraverso il suo effimero condensato di piacere. Riflessone cognitiva sulla modernità liquida è invece in Sulle post-verità, un tema piuttosto caro anche all’autore di queste piccole note. Il linguaggio di questi versi si ibrida fra dialetto, lingua ordinaria, tecnicismo e lingua letteraria, o comunque dotta e si trama di parechesi, rime interne, rimpalli fonici e omeoteleuti grammaticali, a partire dalle pseudo-etimologie comiche ricavabili dal prefisso post- che adorna tanto ciarpame teorico del declino tardo-moderno. Questa vena quasi non-sensical, si manifesta ancor più spiccata in Scrivendo, testo metapoetico in cui si assiste alla medesima, ossessiva ricorsività dei moduli usurati della lingua letteraria (“o tu, che scrivendo vai”), con pose stilistiche da pseudo-endecasillabo sciolto di essay in versi.
Il verso si fa sublimazione di sofferenza fisica in Federico Preziosi. Il tema, quasi scespiriano, della primavera mancata (Non è detto che la primavera, Le false primavere) si lega al tema della malattia (“la zona rossa era pandemia/ già molto tempo prima nel mio corpo”) e si annoda strettamente con elementi di riflessione metapoetica, rifratti sulla dimensione fisica (“il caso afflitto/ affila il metro…”). Il secondo dei testi di Preziosi, Il fuoco di Sant’Antonio, si riferisce alla condizione fisica dell’autore in modo patente. Il corpo, come punto di vista, in Preziosi si fa così tronco di dolore (“lo squarcio di pelle/ ancora grama sul ceppo passato/ e incendia il presente”). Gli endecasillabi sciolti di Le false primavere, ritornano su questo tema sublimandolo, decostruendo il corpo nelle sue insicurezze. Sul piano formale la riflessione sulla sofferenza si compine in versi che per lo più seguono unità metriche tradizionali: l’endecasillabo, segnato a volte da dialefi dure, arcaiche, scabro e netto, si alterna per lo più a settenari e segmenti di settenari ipometri o ipermetri. Lo sfasamento occasionale di cadenza sembra mimare nel ritmo l’occasionale instabilità che si rappresenta nel fisico provato dell’autore, così che riflessione sul corpo e corpo sonoro del verso, in Preziosi, si rispecchiano mutuamente.
L’ “indagine di ciò che non si vede” è nell’incipit della prima lassa di versi liberi di andamento trocaico-logaedico in cui si scandisce Wonder Wall di Eleonora Rimolo, il cui titolo evocherebbe di per sé una canzone cult per gli Oasis. Nel contesto della memoria musicale il wonderwall è quasi l’equivalente di un odradek kafkiano: un elemento di realtà la cui presenzialità è certa ma la cui natura è di definizione aperta, così che è alla coscienza demandato il compito di plasmarne la struttura. A questa potenziale allusione interna al titolo si lega forse il senso del primo testo, in cui si delinea una sorta di onto-genesi, nel senso amplificato del termine: l’uomo crea, costruisce la sua esperienza geometrizzando e definendo l’indistinto originario, ciò che non si discerne. Il tema del “prendere/dare forma” costruendo, nel bene e nel male, è centrale in tutti i testi che la Rimolo propone nell’antologia. L’andamento narrativo della terza lassa riassume lo stesso schema di progresso costruttivistico: 1) “avevamo una sola mucca”, trascinata dall’informe dell’alluvione, nel teatro generale delle macerie e della fame; 2) “Oggi siamo quello che abbiamo”, e la creazione di un “argine/ che nasconde la strage agli occhi del futuro”. Se una certa evoluzione del pensiero della sinistra hegelo-marxiana immaginava che l’uomo facesse della natura il suo corpo inorganico, gigantesca prostesi cosmica pienamente risolta nella tecnica, la visione di Wonder Wall in tal senso è pessimistica, non senza ovvie ragioni: l’uomo costruisce solo un’infrastruttura argine, friabile di fronte all’esondazione dell’informe. Il tema di fondo, à rebours, si ritrova anche in Due volte l’anno visita il paese. La presenza ostica, divoratrice, immune da morte, negativa, che ne è protagonista implicita, spinge la persona loquens dell’autrice a invocare, sulla casa, sul paese, il disastro ambientale, che salvi solo poche entità meritevoli: “i gatti immortali, la parrucchiera, / il giovane pasticciere in piedi alle cinque/ del mattino…” Eleonora Rimolo addita così, in una sua personalissima versione dell’antica equivalenza ens-bonum, l’unico valore fondamentale al di là degli argini sociali artefatti e dell’autoritarismo in essi implicito: “la nuda vita che merita/ la vergogna della resistenza”. Il binomio nudità-vergogna, associato a dati di fondazione come “vita” e “resistenza” addita nella loro vulnerabilità assiologica e fisica un implicito imperativo di lotta, protezione e cura.
Una visione di pessimismo trasformativo si trasmette nei versi di Anna Ruotolo: la contemplazione delle sciagure umane (è così disperato il male umano), è segnata dall’impotenza che traspare dall’anafora insistita di “così” (ripetuto nove volte), a sottolineare una catena di correlativi oggettivi variamente distribuiti fra male di vivere e divina indifferenza. Si deve parlare qui di pessimismo trasformativo, e non di banale miserere, poiché l’autrice identifica, al di là del desolato paesaggio cosmico, e della narturale inclinazione discenditiva degli enti, spontanea autoinduzione al naufragio, la presenza di dinamiche compensative, spontaneamente ricostruttive, nel divenire in cui ciò che va distrutto in certo modo si ricrea, e all’infinito ritorna (un certo servizio di porcellana), non fosse il permanere della mortalità (“il giuramento dell’amore eterno. E mortale”). Una struttura semiologica parzialmente simile mostrano i versi de Gli indesiderati, in cui l’autrice interroga un possibile assoluto, alla ricerca di “una preghiera diversa… per tenerci calmi/ meno bestie e meno urlanti…” Questa preghiera, che sembra rispondere alla logica di una fede, è “per i diseredati/ gli indesiderati” (due paronimi quasi in anagramma) riconoscibili in ciascun individuo: si tratta dell’unica via di emancipazione dal degrado ontologico, via senza la quale “la felicità non è né in questa terra né nell’altra”.
Si presentano nella stampa come tre lasse di prosa ritmica occasionalmente rimata, assonante, consonante, tre lasse inscritte in un quadrato, le Betrachtungen di Come una goccia, di Giulia Scuro. La similitudine “ogni pensiero è come una goccia” (un endecasillabo, se si ammette la debole dialefe in cesura, dopo “pensiero” dissimulato nei blocchi prosastici) si ripete, come efimnio, periodicamente, scandendo le prose come sottostruttura strofica. L’insistenza sulla natura liquida del pensiero, che a tutta prima parrebbe quasi un ritorno a Talete, evoca nel contempo la joyciana universalità dell’acqua; nell’insieme, l’intera triade prosastica gioca con le molteplici valenze e connotazioni del termine “liquido”. La fluidità liquidità del pensiero è allo stesso tempo trasparenza della parola (“la parola mescola trasparenze ai significati”), ma anche problematicità del messaggio che si occulta “come per acqua cupa cosa grave”; soprattutto, la dimensione liquida del pensiero è riflesso diretto della modernità liquida, delle sue strutture cognitive fin troppo adattabili, in flusso continuo, senza struttura riconoscibile, senza contorni. È il tema del senso e del segno liquefatti, a cui corrisponde una forma, la prosa, essa stessa “liquida”, contenuta nel recipiente geometrico del bordo della pagina, che insegue il flusso dei dati di esperienza senza incasellarli in strutture chiuse.
Tendenze stilistiche non lontane da una sorta di new sincerity segue Mattia Tarantino. I suoi versi liberi endecasillaboidi, a cui si mescolano endecasillabi e alessandrini, ma anche più brevi segmenti versali di questi ultimi, aggregati in lasse (Mamma cucina. Da lontano una stella, Parlavamo del sogno di Tommaso, Viene in sogno un ariete trasparente, le tre cobolette Per Ginevra, Ascolta, è san Lorenzo, sotto casa), mostrano un dettato lessicale estremamente semplice, ispirato a un tendenziale monolinguismo; sul piano delle tematiche e dei dati esperienziali, Tarantino muove qui da una dimensione di ordinaria quotidianità (“mamma cucina…/ un piatto/ di pasta, un po’ di vino…”; “Ascolta, è San Lorenzo, sotto casa/ passano le ultime automobili…”) mescolata a una realtà metafisica (“Da lontano una stella/ arruginisce il mondo”), a suggerire che l’apparenza fenomenica dell’esperienza comune nasconda, fra i molti punti che non tengono, l’occhieggiamento di un retroterra non fenomenico (“questo è il Regno/ della Luce, l’Ingresso, la Fessura”; “dicono che se ascolti/ attentamente puoi sentire/ da qualche parte come un leggero/ fruscio, qualcosa che striscia:/ è una cometa scivolata giù in silenzio, una stella…”); questo doppio fondo del mondo esperienziale nella sua forma più ordinaria è espressione di una ricerca stilistica che volutamente tende al degré zéro, all’abolizione dell’estremismo espressivo, in una poetica defilata, lontana dall’eccesso decostruttivo. La poetica di Tarantino sembra compiere qui una svolta decisa verso l’idea di fondo che il reale, oggetto e referente del verso, ha una sua solidità, sia pur problematica, dislocata, ed è compito del verso come linea di sutura ricomporre la cicatrice slabbrata che lacera ab origine la compattezza tra il fenomeno più banale e la sua abissale radice.
Vengo da penultimo a parlare, assai sinteticamente, del sottoscritto, Daniele Ventre, come da burocratese di referto -d’obbligo un minimo di understatement, dovendo parlare del mio stesso lavoro per cause di forza maggiore, non essendosi prestato alla bisogna alcun alter ego. Ho presentato qui uno specimen di una mia raccolta, Volubilis, che si inserisce nell’ambito tematico della sovrapposizione dei tempi storici con i tempi attuali. La raccoltina prende nome dall’antica città di Volubile -il cui nome parrebbe derivare dalla parola berbera locale per “oleandro”. La città e il suo limes furono abbandonati all’inizio dell’età tetrarchica, ma questa sorta di Pompei sopravvisse, mantenendo uno stile di vita da impero romano d’occidente per molto tempo dopo il fatidico 476 e lasciandosi assorbire senza scosse dai primi secoldi di dominio arabo. La forma di Volubilis è la caratteristica versificazione iper-neometrica che contraddistingue il sottoscritto da tempo (per alcuni, da troppo tempo) e che è stata impiegata anche nelle traduzioni di Omero, di Virgilio e di alcune poesie degli elegiaci arcaici, per quanto la struttura dell’elegia appaia qui manipolata, volutamente: sequenze di pentametri, distici a rovescio, sequenze di distici chiusi da un esametro, coppie di esametri seguite da un pentametro: si tratta di forme periferiche, di “avanguardia” per l’antico, retro-parodizzazione metrica della contemporanea forma dissolta. Si riflette qui sull’idea della sopravvivenza della civiltà nelle aree laterali, dopo che il centro è collassato (nel suo pro-cedere, cedere in avanti crollando, più che avanzare) per le guerre e gli sconquassi climatici, economici e politici di cui la storia umana è ciclicamente adorna. Tema centrale è quello del limite, del limes, abbandonato, ma poroso, permeabile e del contrattare con quelli che a suo tempo sembrarono barbari (“oltre il caos, si sopravvive al di qua” del confine), riflettendo che la ferocia barbarica è spesso annidata nel centro dell’impero (“non ce ne sono, leoni, li tengono chiusi nel circo”). Corollario di questo abbandono del centro da parte del limes è l’idea che la continuità del mondo civile è affidata non tanto al super-ordine del potere, ma all’infra-ordine del quotidiano (“qui non si celebrano/ feste da circo, né glorie di porfido. Resta l’olivo”).
Residui di una lingua letteraria ironizzata a coprire l’ordinario, come tono comico di falsetto modulato in un mimo semiserio, costituiscono infine la complessa orchestrazione della poetica di Salvatore Violante, la cui produzione va dalla coboletta di settenari (con occasionali anacrusi) atteggiata a parodia ipermorderna di un’aria metastasiana di Non t’avvilire, alla prosa in prosa di Presupposti accennati ai versi, passando per i versi lunghi di A volte, Nuvole in fila, Un fico antico. La gamma di stili di Violante è molteplice: Non t’avvilire richiama, come si diceva, l’odicina anacreontica o l’aria metastasiana perfino nell’uso del troncamento estetico; ma si tratta in parte di un gioco non-sensical, che si palesa negli occasionali giochi di risegmentazione (“ballar con uova/ vira nuova”). Non dissimile è la scelta stilistica propria dei versi lunghi di A volte: li abbiamo definiti versi lunghi, ma in realtà è opportuno precisare che si tratta di versi composti da coppie di endecasillabi, o al più da un endecasillabo e da un verso giambico più breve; l’endecasillabo resta la misura di fondo, anche quando si spezzetta (“s’alzano/come nuvole in ostaggio; calano/gli occhi dietro in fila indiana”) e l’andamento giambico si sposa perfettamente con un tono comico realistico (“Dall’ombra nuda è Gigia che si ostina e scende in strada svelta e che si dona./ Fiorata la gonnella le s’intona, le chiappe sono piene di coraggio”). Parodia nostalgica della lirica tradizionale si nota invece nei versi logaedici/doppi endecasillabi di Nuvole in fila e di Un fico antico. Quest’ultima ci restituisce l’impressione più limpida dello stile di Violante: composta di doppi endecasillabi perfetti, senza sbavature, mostra un equilibrio perfetto sul piano formale, semantico, tematico, circonfondendo il ricordo del vecchio fico di un’aura di lirismo ironico (si pensi a versi come “Dio, quanto quel moo fico mi nutriva e quanti sogni di moderno andare:/ lunatici trasvoli d’astronavi, treni, viandati e sacche di pensieri!”), in cui nostalgia e ironia soffusa formano una mescidanza di toni unica, che non ha molti riscontri nel panorama attuale.
Veniamo ora alle conclusioni, transitorie e parziali, di questa rassegna cursoria, che spero gli interessati trovino onesta. Sul piano formale, la poesia napoletana è attraversata sostanzialmente da una dialettica fra forme decisamente aperte, o aperte, e tendenze neometriche marcate: tale dialettica si accompagna, sul piano stilistico, a una opposizione fra lingua proliferativa e polifonica e monolinguismo, con tutti i gradi intermedi del caso. Una simile duplicità di tendenze riflette, in parte, l’influsso del gruppo ’93 e dintorni (che con Bàino, Cepollaro, Caserza, Voce, Frasca, per citare solo alcuni, e con l’ambito del Baldus avevano un’ampia componente centrata sul capoluogo campano). Mancano, per lo meno nell’ottica di questo volume, che ricordiamo è il primo di due e riflette un approccio parziale, sperimentazioni significative che possano richiamare, almeno alla lontana, l’area dei non-assertivi e della post-poesia di Roma & dintorni (penso ai loro rappresentanti più significativi e fondamentali, come Giovenale e Zaffarano), così che fra la capitale e il grande porto del sud si può a tutta prima, sia pur con tutte le riserve del caso e i dovuti, igienici dubbi, identificare una dialettica fra post-poesia e fede nella parola come atto performativo, perlocutorio, capace, almeno entro certi limiti, di fare qualcosa, come da filosofia analitica. Non di attardamento si tratta, va precisato, con buona pace di alcuni membri del senato e del popolo romano e mediolanense della respublica litterarum, quanto di una presa di posizione resistenziale, fra dubbi interlocutori di una parte troppo cospicua dell’accademia cittadina (dio o chi per lui la riposi) e mancanza di poli editoriali potenti, toccati in sorte, per fortuna di prossimità, alla vecchia guardia cosiddetta linea lombarda. Questa presa di posizione resistenziale della poesia napoletana ha perlomeno, per chiunque si prenda la briga di ascoltare anche il reale, e non solo le prossimità accademico-editoriali, il merito di conservare, finché sarà possibile e in attesa di tempi migliori, un’area laterale incontaminata in cui si preserva un minimo di continuità e riconoscibilità della tradizione poetica e delle sue potenzialità ancora ricchissime. Sul piano dei contenuti, i poeti qui presentati possono riunirsi sotto alcune, ben precise, tendenze, che abbiamo già avuto modo di accennare. Riprenderemo qui due elementi: la sovrapposizione e la conflazione delle membrane storiche e temporali; la dissoluzione/liquefazione della fattualità e del senso. A queste si aggiunga una particolare maniera di trattare l’io della persona loquens, o virata in focalizzazione esterna (con conseguente sviluppo para-narrativo) o semplicemente depotenzianta, dislocata, come spettatore semi-occasionale (io narrante decentrato, fra Encolpio e il dottor Watson) del vissuto proprio e comune. Queste componenti essenziali sono proprie e specifiche della natura di chi ha interagito con l’ambiente urbano di Napoli, per quanto a un occhio superficiale siano aspecifiche. Napoli è una città in cui gli strati storici convivono affiorando e sommergendosi: mura greche di oltre ventiquattro secoli si affiancano a transenne di plastica del malvezzo comunale del presente. È una città in cui i fatti sono liquidi, plasmati dalla chiacchiera o dalla convenienza, più che in altre città euro-mediterranee. È una città dove il senso si fa liquido, il pensiero è liquido (Giulia Scuro), dove “il passato non passa” ed è “indecente che qui non passi nemmeno il presente” (Di Pietro, non qui, ma altrove); dove la nostalgia è ironica (Violante) perché semiseria. Dove i leoni sono chiusi nel circo delle rappresentanze cittadine espropriate ai loro rappresentati. Dove il graffito di Altamira (di cui alla poesia di Viola Amarelli) convive con il migrante “passamorto” dello sgretolamento delle comunità maciullate dalla geopolitca malsana (De Falco). Dove il dialetto è marchio e comunicazione linguisticamente marcata.
Dove il senso “si squaglia” (per parafrasare Lucrezi), i significanti si condensano in strutture complesse, alla ricerca del senso: il principale tratto comune della Napolesia, a fronte della neoplasia (anagramma obbligato) del degrado antropologico diffuso, è la proliferazione dei significati come phàrmaka, medicamenti, sanatori, o almeno palliativi, anche a costo -e ciò vale in specie per quei poeti che si connotano per impegno politico diretto o indiretto- di essere trattati, dalla comunità degradata a livello economico, culturale, accademico, relazionale, come pharmakòi, come capri espiatori ostracizzati, come continuatori impliciti di Ipponatte, in una Graeca urbs che, a onta dell’onanismo identitario di parte della sua preunta élite, solo per breve tempo è stata fortemente greca nel senso che l’immaginario occidentale ancora vagamente attribuisce alla grecità come suo momento fondativo -anzi, nei tempi più recenti della sua longue durée, è stata per lo più bizantina, prima in senso letterale, poi in senso metaforico, ma non meno crudele.
Se un ruolo giocano, nel contesto nazionale, i poeti dell’area campana e di Napoli (una dialettica che andrebbe forse indagata ulteriormente), questo va piuttosto cercato in altri aspetti. Ho già accennato alla possibilità di reperire, nel capoluogo campano e nel suo intorno, una riserva di poetiche e modalità espressive in grado di mantenere in piedi una alternativa rispetto a poetiche più glocalizzate (in buona sostanza, i non assertivi hanno come polo interlocutore gli sperimentalismi d’oltralpe e d’oltreoceano); nello specifico non si tratta di precisare una linea “nazionale” di poetiche (chi scrive queste note, trova l’idea equivoca e nequitosa al solo concepirla); piuttosto, nella poesia di area napoletana si offre uno dei terreni di coltura in cui è forse possibile sondare l’ipotesi che, sul piano globale, la poesia in lingue italiane (anche regionali) sia ancora in grado di porsi come interlocutrice adeguata (non dico assolutamente paritaria), mancando su altri piani (politico ed economico in specie) ogni volontà di perseguire con convinzione obbiettivi di analoga portata nei rispettivi campi: obbiettivi che non siano l’allineamento, l’accodamento, la conformità a parametri non sempre congrui. Nel non allineamento, nel non accomodamento, nella non conformità credo debba rinvenirsi la cifra esteticamente più valida della poesia che in Napoli ha sede, per accidente storico e anagrafico dei suoi portavoce: un tratto, questo non allineamento, che non andrebbe liquidato con troppa leggerezza, poiché forse la lateralità del linguaggio e del pensiero retrostante sono uno dei connotati per cui in effetti, sotto qualunque cielo e in qualunque modulazione verbale, la poesia si identifica.











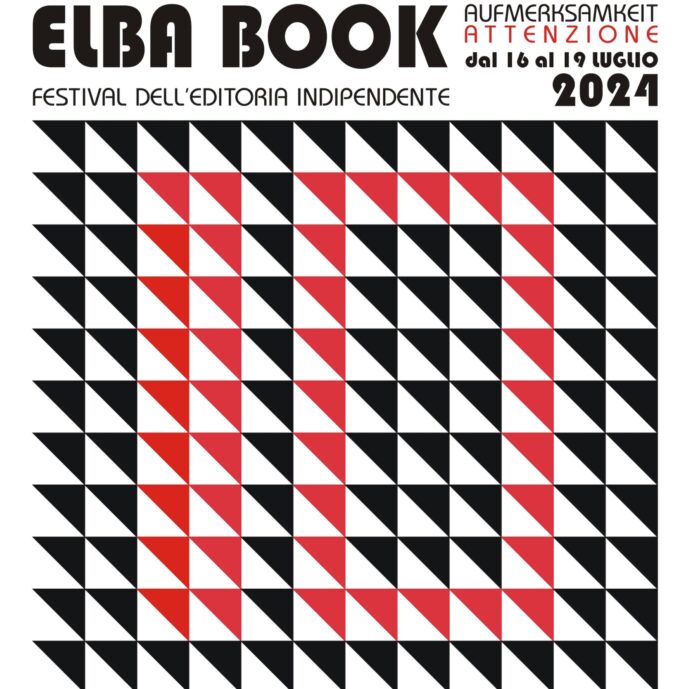
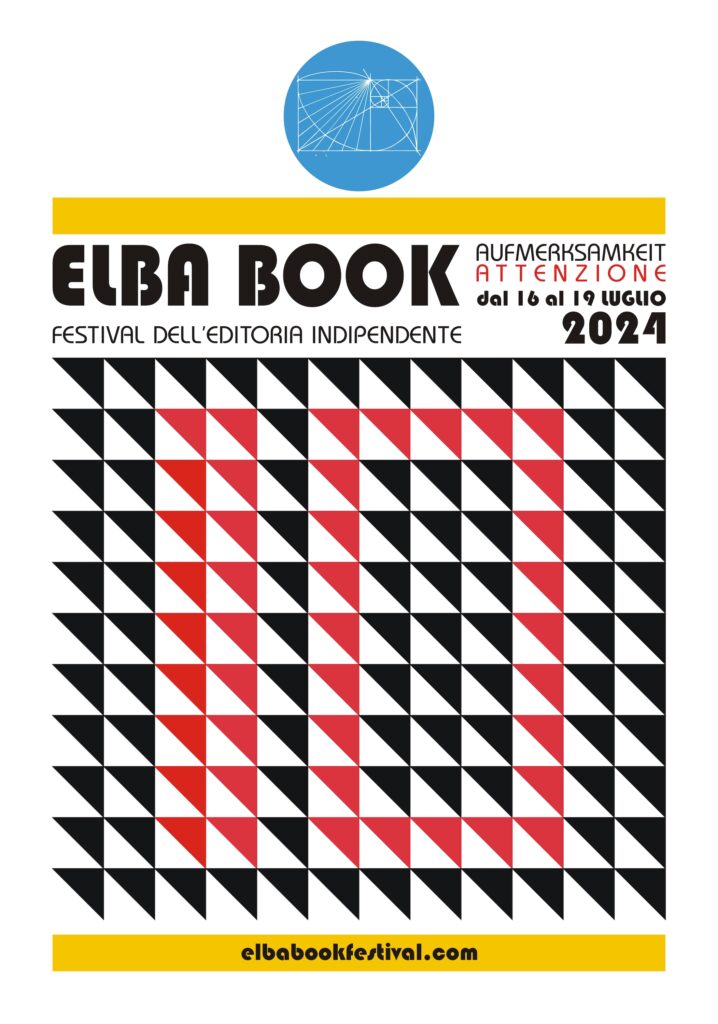

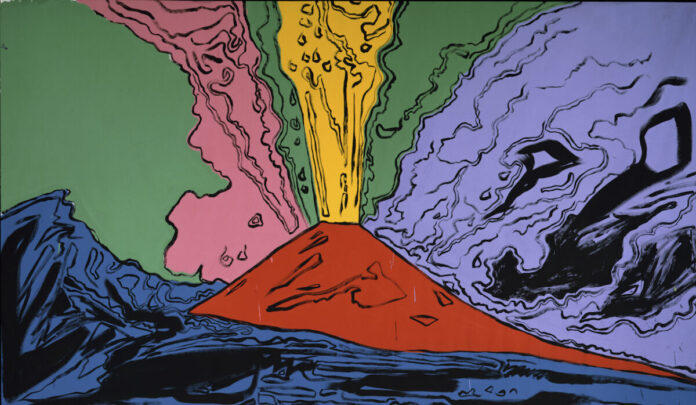

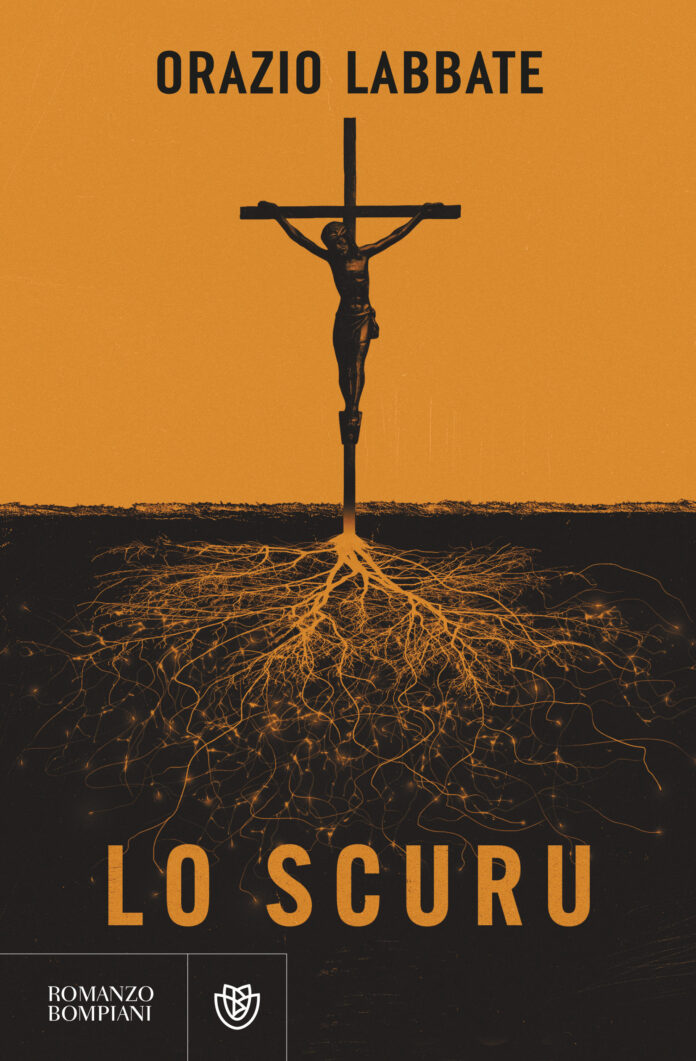
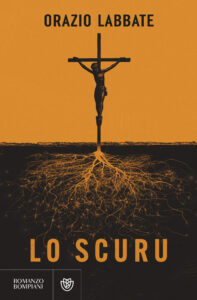


 di
di Ci siamo conosciuti vent’anni fa, poco meno, e all’inizio della mia avventura su Nazione Indiana. C’era stata un’incomprensione legata alla rinascita della rivista Sud, da me fortissimamente voluta e proprio in quegli anni realizzata, ma ne eravamo venuti a capo rapidamente al punto di diventare, poco tempo dopo amici. Ci accomunava l’amore per Anna Maria Ortese e ogni qualvolta ne avessi avuto l’occasione l’ho sempre trascinato con me, come nel caso della pubblicazione numero dell’Atelier du Roman dedicato alla scrittrice o più recentemente per una mia
Ci siamo conosciuti vent’anni fa, poco meno, e all’inizio della mia avventura su Nazione Indiana. C’era stata un’incomprensione legata alla rinascita della rivista Sud, da me fortissimamente voluta e proprio in quegli anni realizzata, ma ne eravamo venuti a capo rapidamente al punto di diventare, poco tempo dopo amici. Ci accomunava l’amore per Anna Maria Ortese e ogni qualvolta ne avessi avuto l’occasione l’ho sempre trascinato con me, come nel caso della pubblicazione numero dell’Atelier du Roman dedicato alla scrittrice o più recentemente per una mia