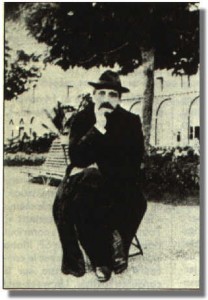Lo strabismo necessario
Cominciamo dalla cosa più bella (uso qui questo termine in senso strettamente filosofico, cioè come punto fulmineo di risalita, di svelamento, del continuo brulichio, sotto e sopra la superficie, del senso). La cosa più bella di Avatar è il suo appellarsi a un unico movimento. Uno scivolamento morbido che ondula la luce e l’aria come la discesa medusea di una piuma, come se fosse un carrello curvilineo, capace non solo di solcare e tratteggiare l’orizzonte, ma di seguire la traiettoria ripidissima del salto nel vuoto e quella senza gravità del volo. La cosa più bella è dunque il suo modo di parlare e di planare, di con-cedere la visione, il modo in cui, semplicemente, consente il vedere.
Questo modo però, non è solo movimento, né solo una sorta di inter-cessione d’autore – la forma in quanto tale, ma la procedura scelta per indagare e scardinare l’automatismo da cui la tecnologia sempre sogna di liberarsi: il vedere, appunto e di nuovo, cioè l’unica vera tecnica, la sola in grado di scindere l’arte dall’artificio, comprendendo e accludendo, nel suo tuffarsi cieco, menomazioni instabilità persistenze.

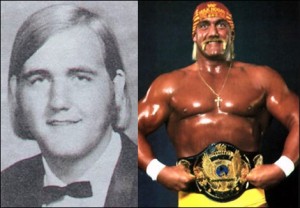


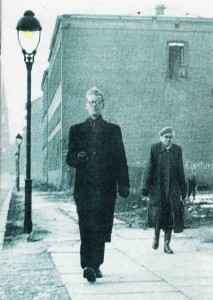




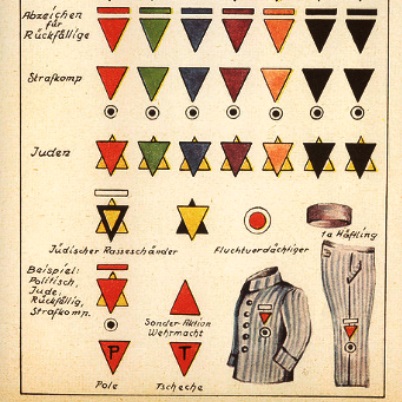
.jpg) Pubblico a partire da oggi e per altri quattro giovedì, gli interventi di poeti italiani sul cinema, raccolti per la manifestazione
Pubblico a partire da oggi e per altri quattro giovedì, gli interventi di poeti italiani sul cinema, raccolti per la manifestazione