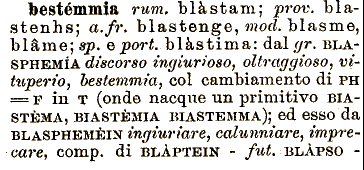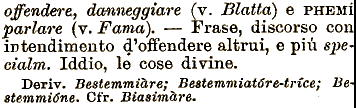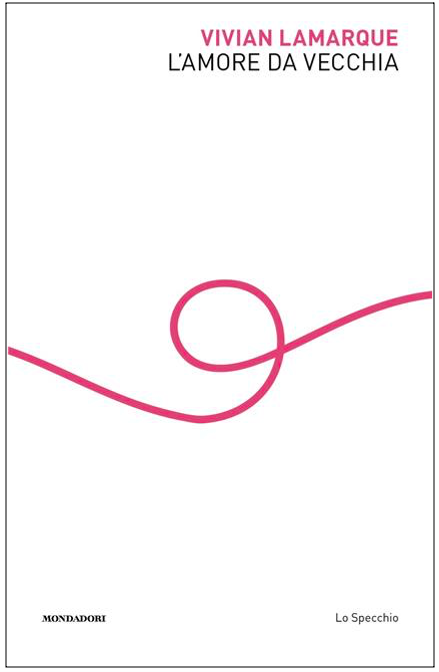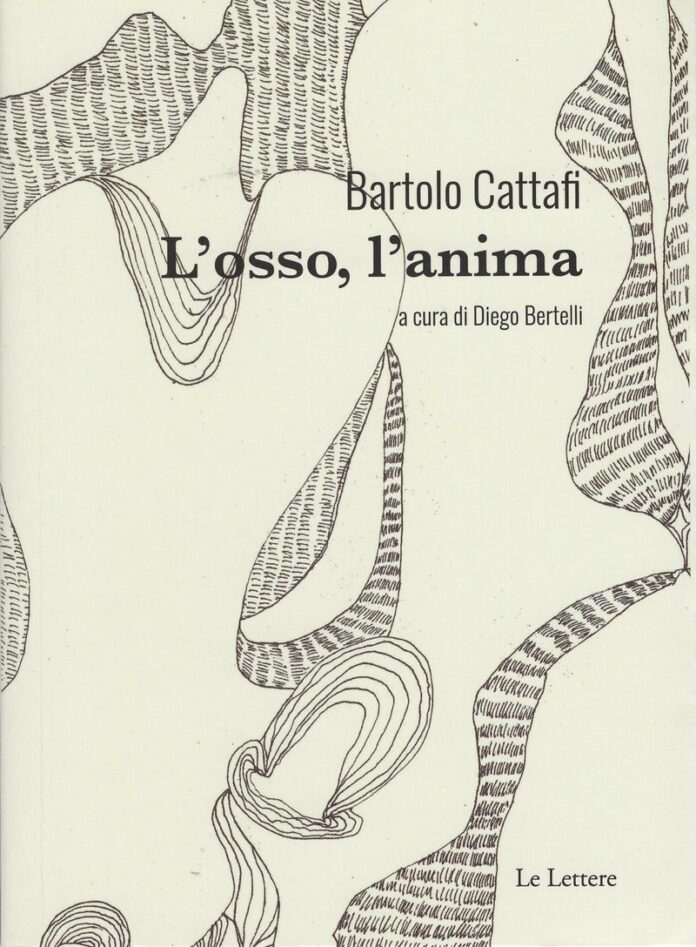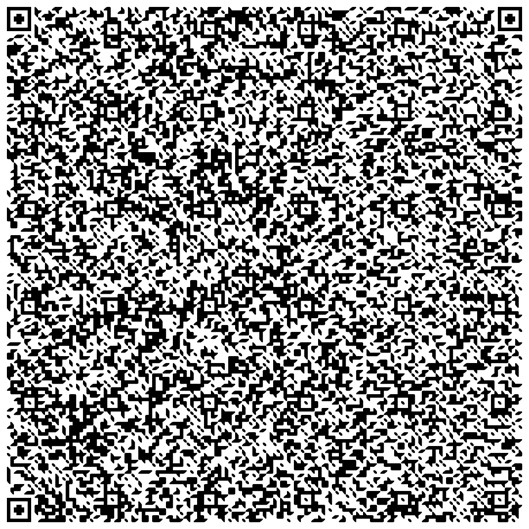di Tarcisio Tarquini
La Testa sembra sospesa nel vuoto e i corpi che ne rappresentano i muscoli e le ossa si protendono in rilievo dando l’impressione di trovarci di fronte a una scultura sorretta da fili invisibili, invece che – come in realtà è – a un dipinto su tavola di pino, dalle dimensioni piuttosto ridotte (59×47), frutto di una geniale intuizione figurativa, di una straordinaria perizia artistica e di un’approfondita conoscenza dell’anatomia umana, assorbita nell’accurato apprendistato delle accademie artistiche napoletana e romana della prima metà dell’Ottocento.
Il titolo del quadro è “Testa anatomica”, ne è autore Filippo Balbi, conosciuto per sua stessa volontà come “pittore storico”, vocato cioè alla composizione di tele e teleri raffiguranti personalità della storia o episodi della secolare vicenda dell’ordine dei monaci certosini, suoi protettori e committenti, che possono ammirarsi, prevalentemente, in alcune grandi basiliche romane e nella piccola chiesa settecentesca della Certosa di Trisulti, alle pendici dei monti Ernici nel comune di Collepardo, in provincia di Frosinone.
“La Testa anatomica” è ora esposta – e lo resterà fino al prossimo 29 ottobre – nel refettorio di questa antica abbazia medievale, prima certosina poi cistercense e oggi tornata nella piena disponibilità dello Stato, dopo l’oscuro interregno di una Fondazione ispirata al fondamentalismo, politico più che religioso, di Steve Bannon e della variegata ciurma dei suoi sodali europei.

La Mostra (Il Corpo e l’Idea. La Testa anatomica di Filippo Balbi), curata dal pittore e storico dell’arte Mario Ritarossi (che del quadro aveva scritto in un saggio del 2006 su “Capitolium Millennio, la rivista d’arte del comune di Roma), promossa e organizzata dall’Associazione Gottifredo di Alatri, ha registrato un successo inaspettato con un flusso incessante di visitatori che scoprono, insieme, un monumento nazionale di rara suggestione e un capolavoro misterioso, un “unicum” nella pittura europea del XIX secolo ma anche nella personale produzione dell’artista che l’ha concepita e composta.
Alcune singolari circostanze hanno gettato una luce imprevista sulla tavola di Balbi, una serie di coincidenze troppo curiose per essere casuali: più realisticamente, forse, il manifestarsi di una congiuntura in cui tutti gli astri benevoli al pittore, quasi a risarcimento suo che in vita non ne aveva mai potuto godere, si fossero allineati creando una corrente ascensionale propizia per riportare lui e la sua opera all’altezza del merito, finalmente riconosciutogli con consenso unanime e in modo definitivo.
Alcune di queste circostanze sono legate a immagini, foto, fotogrammi vaganti captati nell’etere della comunicazione.
La prima è un’immagine televisiva, un servizio sull’apertura al pubblico di un’ala della Galleria degli Uffizi dedicata agli autoritratti degli artisti: in una delle dodici sale in cui si sono volute raccogliere queste pitture (omaggio ai maestri che in esse si sono rappresentati ma anche al Museo al quale sono state affidate, perché se ne celebrasse la gloria di “Memorial” dei più grandi di tutti i tempi) spicca per dimensioni e per la posizione in cui è collocato l’autoritratto di Balbi, ripreso dai telegiornali e da lì scivolato nelle prime pagine di tutti i quotidiani. La figura è la stessa che vediamo in una foto scattatagli da un fotografo di nome Rainaldi nello studio della casa di Alatri, dove il pittore soggiornò dal 1864 fino alla morte avvenuta il 27 settembre del 1890. C’è Balbi con accanto, incorniciata da un cavalletto, la sua Testa anatomica, come se il quadro fosse la sua carta di identità, il segno riconoscibile della sua arte, l’esemplare da tramandare ai posteri e da tenere sempre con sé perché racchiudente l’anima della sua opera.

Un’immagine ancora più pervasiva è un fotogramma del film premiato a Venezia, nello scorso settembre, con il Leone d’oro. La si scopre con stupore, persa dentro un vorticoso mulinello di allucinate citazioni artistiche (tale, per lo meno, è sembrato nel trailer che precede l’uscita italiana del film nel prossimo gennaio). In “Poor Things” di Yorgos Lanthimos, a dilatare l’urlo del sempre straordinario Willem Dafoe nella parte di nuovo Frankenstein costruttore in laboratorio di corpi umani da avviare alla vita, compare per un attimo la Testa anatomica, quella “Testa anatomica” che la Mostra di Trisulti ha riproposto restaurata allo sconcertato godimento di tutti.
Nella storia narrata da Lanthimos si parla della crescita di un corpo non “sincronizzato” con la mente, di una sorta di dolorosa e comica divaricazione che si ricompone alla fine facendo esplodere in tutta la sua totalità la bellezza della protagonista, dal suo creatore nominata Bella, a incidere subito la finalità e l’esito del suo progetto creativo, ma anche la sua tenerezza di padre senza figli.
E, in effetti, la Testa anatomica è una “povera creatura” che è riuscita a ricomporre la sua unità “corpo-mente”, per volontà dell’artista e della proporzione geometrica su cui il quadro è disegnato, scoperta con il lungo studio preparatorio del curatore della Mostra. Rivela così in modo inequivocabile l’allusione a una crisi che solo l’arte riesce a risolvere, riconducendo la tensione del molteplice alla compostezza irenica, astratta e indifferente, dell’unità.
La presenza della “Testa” in un’opera cinematografica, che segnerà l’anno venturo (che è anche quello del centosettantesimo anniversario del dipinto) con i suoi prevedibili successi, suona conferma di una intuizione di cui la Mostra di Trisulti, e del modo in cui essa è stata realizzata, è in un certo senso il risultato. La percezione di un’energia del quadro ancora non spenta e capace, perciò, di generare nuova arte ha portato non solo all’originale e suggestiva collocazione della “tavola” in una nicchia all’interno di una sorta di “camera delle meraviglie” costruita replicando il rapporto tra le sue misure, ma anche alla produzione di nuove opere d’arte da parte di giovani artisti formatisi nella sempre generosa fucina del Conservatorio di Frosinone.

Le opere multimediali da loro installate, infatti, si pongono come fossero un fermento, alimentato da linguaggi d’arte contemporanei, dell’immaginario di Balbi: quella parte che egli ha tenuto congelata, in un angolo della sua attività creativa prima e dopo il biennio cruciale della composizione (1854) e del battesimo all’Esposizione Universale di Parigi (1855) e che, dopo un lungo percorso sotterraneo, sembra oggi essere arrivata ai creatori d’arte delle nuove generazioni che ne hanno riproposto la dirompente modernità.
Insieme con le visioni che passano sui grandi schermi posti nella “camera delle visioni” (dove è ospitata la multimedialità) irrompe, per esempio, dentro gli oculus, rigonfia di tutte le suggestioni provocate da un viaggio compiuto in realtà immersiva e mosso dall’intelligenza artificiale, una lunga teoria di corpi che reclamano la loro autonomia, si staccano dall’universo in cui fluttuano, si avvicinano allo sguardo di chi li osserva, gli protendono la mano e, se sono toccati dalla proiezione di quella dello spettatore che riconoscono umana, pronunciano oscure e inquietanti sentenze prima di dissolversi ancora nel nulla, sconfitte nella loro disperata ricerca di individualità, che resta tutta consegnata a noi chiamati a scuoterci dall’irrigidita dimensione della nostra misera realtà.
È la vittoria postuma di un artista orgoglioso e scontroso che, per vivere, dopo essersi allontanato dalla Roma papalina di cui sentiva l’imminente caduta, fece disegni, ritratti di monsignori, nature morte, pitture murali a olio dalla composizione che ancora nasconde i suoi segreti, e che tutto provò a vendere tranne la “Testa anatomica” che probabilmente gli avrebbe dato da mantenersi con maggiore agio. Preferì portarla con sé, custodita in una solida cassettina di legno, in ogni suo spostamento. Quel quadro, secondo lui non sufficientemente apprezzato a Parigi nel suo esordio internazionale, non apparteneva al presente: doveva essere affidato al futuro.

***
LA MOSTRA
“Il Corpo e l’Idea. La Testa anatomica di Filippo Balbi” è una Mostra dell’Associazione Gottifredo con la collaborazione del Museo di Storia della Medicina dell’Università La Sapienza di Roma, custode del quadro, e grazie alla concessione degli spazi da parte della Direzione dei Musei del Lazio. La curatela è di Mario Ritarossi, la direttrice esecutiva è Silvia Moretti, il comitato scientifico è composto, oltre che dallo stesso curatore, da Maria Conforti, docente e direttrice del Museo di storia della Medicina della Sapienza, Alessandro Aruta, conservatore dello stesso Museo, Marco Bussagli, docente di anatomia artistica dell’Accademia di Belle Arti di Roma.
Il Catalogo è edito dalle edizioni Gottifredo, si può trovare in Mostra o direttamente all’Associazione (0775440105) e sulle maggiori piattaforme di vendita di libri. Contiene saggi di Mario Ritarossi, Alessandro Aruta, Michele Campisi, Ettore Del Greco, Giovanni Fontana, Natalia Gurgone, con appendici di Maria Gabriella Combusti e Sara Sarandrea (l’allestimento), Luca Salvadori (la trama sonora), Valerio Murat (la realtà virtuale), Alba Lisa Mazzocchia (la traduzione tattile), la cura redazionale è di Eugenia Salvadori. Il sito www.mostregottifredo.it
Inaugurata il 5 agosto, resterà aperta fino al 29 ottobre alla Certosa di Trisulti, Sala del Refettorio e Foresteria. La Mostra, a ingresso libero, è un “progetto comunitario” che si è realizzato grazie al lavoro volontario e gratuito dei soci dell’Associazione Gottifredo che vi hanno partecipato coprendo tutte le mansioni, compresa quella della sorveglianza, alle aziende e ai cittadini che lo hanno finanziato con le loro donazioni, agli enti, alle università e alle accademie che hanno concesso il loro patrocinio non oneroso, ma di prestigio, agli studenti e ai docenti delle scuole e degli Istituti di Alta formazione che hanno preso parte alla progettazione e a fasi della realizzazione, agli artigiani e ai professionisti che hanno ideato e operato. La Mostra, a due settimane dalla chiusura, ha registrato oltre quattordicimila visitatori, provenienti da ogni dove e di ogni condizione sociale. Indubbiamente attratti, oltre che dalla vastissima eco dell’iniziativa amplificata da giornali cartacei e su web e dalla segnalazione, con un lungo servizio sul magazine “Art e Dossier” come una delle grandi mostre dell’anno, anche dalla circostanza che si è trattato della prima iniziativa “all’altezza del luogo” dopo la “riconquista” della Certosa all’uso pubblico e alla sua vocazione spirituale e culturale – per breve tempo compromessa da un’illegittima appropriazione – consacrata da una sentenza dei tribunali della nostra Repubblica, per cui tanto si sono prodigate le associazioni – tra cui la Gottifredo organizzatrice della Mostra – oggi riunite nella Rete Trisulti Bene Comune. (T.T)


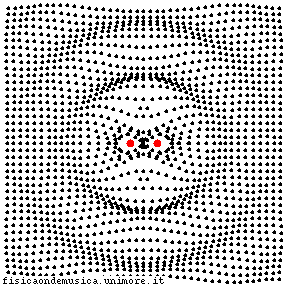

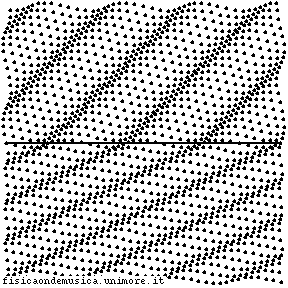
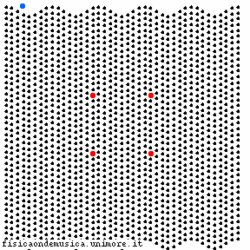
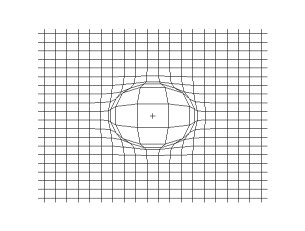

 di Romano A. Fiocchi
di Romano A. Fiocchi










 Fortunatamente, gli architetti già nel primo dopoguerra sapevano ben distinguere il grano dal loglio. C’è una lettera di Franco Albini che lo testimonia con chiarezza (voglio qui ringraziare la Fondazione Albini che me l’ha fatta conoscere). Albini scrive alla sorella Maria, transfuga a Parigi da un decennio e attiva nella resistenza francese. Siamo nel settembre del 1945. Albini racconta come, finita la guerra, ci sia stato un riposizionamento da parte di quegli “inetti” (così li definisce) “che non hanno mai avuto idee per la testa” e che ora riappaiono “a dire che sono perseguitati dal fascismo e a parlare di libertà: tutti parlano di libertà, che è la libertà di fare i propri schifosi interessi.” C’è descritto molto del carattere dell’italiano medio, in questa lettera privata. Il tipico saltare sul carro del vincitore, più realisti del Re. Albini non ci sta e critica “quei tali inetti, che dicono “arte fascista” a quell’arte che è fiorita qui malgrado il fascismo, e che proprio per il suo carattere internazionale dimostra di essere universale, e per niente legata alla politica”. Albini è un architetto “di sinistra” ma non ha problemi a criticare quegli “artisti, che si dicono comunisti, e che dichiarano di fare l’ “arte comunista” che scivolano verso il contenutismo (un quadro che rappresenta Lenin è più bello di uno che rappresenta Mussolini)”. Concludendo con un esempio preciso, che cita proprio il nostro Terragni: “Bisogna battersi ancora molto nel campo critico, e chiarire che l’arte è arte per sue ragioni particolari e non perché abbia o no una destinazione politica: la casa del fascio di Terragni è arte anche se è la casa del fascio, e il grande monumento a Stalin non lo è.”
Fortunatamente, gli architetti già nel primo dopoguerra sapevano ben distinguere il grano dal loglio. C’è una lettera di Franco Albini che lo testimonia con chiarezza (voglio qui ringraziare la Fondazione Albini che me l’ha fatta conoscere). Albini scrive alla sorella Maria, transfuga a Parigi da un decennio e attiva nella resistenza francese. Siamo nel settembre del 1945. Albini racconta come, finita la guerra, ci sia stato un riposizionamento da parte di quegli “inetti” (così li definisce) “che non hanno mai avuto idee per la testa” e che ora riappaiono “a dire che sono perseguitati dal fascismo e a parlare di libertà: tutti parlano di libertà, che è la libertà di fare i propri schifosi interessi.” C’è descritto molto del carattere dell’italiano medio, in questa lettera privata. Il tipico saltare sul carro del vincitore, più realisti del Re. Albini non ci sta e critica “quei tali inetti, che dicono “arte fascista” a quell’arte che è fiorita qui malgrado il fascismo, e che proprio per il suo carattere internazionale dimostra di essere universale, e per niente legata alla politica”. Albini è un architetto “di sinistra” ma non ha problemi a criticare quegli “artisti, che si dicono comunisti, e che dichiarano di fare l’ “arte comunista” che scivolano verso il contenutismo (un quadro che rappresenta Lenin è più bello di uno che rappresenta Mussolini)”. Concludendo con un esempio preciso, che cita proprio il nostro Terragni: “Bisogna battersi ancora molto nel campo critico, e chiarire che l’arte è arte per sue ragioni particolari e non perché abbia o no una destinazione politica: la casa del fascio di Terragni è arte anche se è la casa del fascio, e il grande monumento a Stalin non lo è.” Eppure l’asilo Sant’Elia, l’ultimo capolavoro di un architetto morto troppo giovane, è da ormai un lustro vuoto. I “turisti colti” di passaggio a Como (quelli a cui dovrebbe mirare un comune lungimirante) vengono per visitarlo e si ritrovano davanti a una staccionata raffazzonata e a un edificio abbandonato. Avendo io a Milano l’esempio del Marchiondi Spagliardi, capolavoro del brutalismo di Vittoriano Viganò vincolato dalla Sovrintendenza e abbandonato a se stesso da decenni, so già, purtroppo, come andrà a finire: infiltrazioni, topi, spoliazioni, scrostature, crolli.
Eppure l’asilo Sant’Elia, l’ultimo capolavoro di un architetto morto troppo giovane, è da ormai un lustro vuoto. I “turisti colti” di passaggio a Como (quelli a cui dovrebbe mirare un comune lungimirante) vengono per visitarlo e si ritrovano davanti a una staccionata raffazzonata e a un edificio abbandonato. Avendo io a Milano l’esempio del Marchiondi Spagliardi, capolavoro del brutalismo di Vittoriano Viganò vincolato dalla Sovrintendenza e abbandonato a se stesso da decenni, so già, purtroppo, come andrà a finire: infiltrazioni, topi, spoliazioni, scrostature, crolli.












 Questo è l’unico romanzo scritto da Sylvia Plath. Almeno così risulta, perché il beneficio del dubbio serpeggia. I suoi testi sono stati curati dal marito, il poeta inglese Ted Hughes, il quale ha distrutto molte pagine dei diari perché “non volevo che i figli li leggessero”. Ma forse si parlava anche di lui in termini non proprio edificanti. Probabilmente, nel romanzo, alcuni suoi tratti rivivono nel personaggio di Buddy Willard, che doveva essere il promesso sposo della narratrice, Buddy l’ipocrita. Verso di lui va e viene, come una sorta di Yin Yang (an)affettivo che corre sulle pagine, un sentimento doppio di attrazione e repulsione, che potremmo definire la “cifra” dell’intero testo. Infatti Esther, la brava ragazza bostoniana, efficiente, la prima della classe, quando si trasferisce a New York vive proprio questo dualismo positivista/negativista, che ci accompagna per tutto il romanzo.
Questo è l’unico romanzo scritto da Sylvia Plath. Almeno così risulta, perché il beneficio del dubbio serpeggia. I suoi testi sono stati curati dal marito, il poeta inglese Ted Hughes, il quale ha distrutto molte pagine dei diari perché “non volevo che i figli li leggessero”. Ma forse si parlava anche di lui in termini non proprio edificanti. Probabilmente, nel romanzo, alcuni suoi tratti rivivono nel personaggio di Buddy Willard, che doveva essere il promesso sposo della narratrice, Buddy l’ipocrita. Verso di lui va e viene, come una sorta di Yin Yang (an)affettivo che corre sulle pagine, un sentimento doppio di attrazione e repulsione, che potremmo definire la “cifra” dell’intero testo. Infatti Esther, la brava ragazza bostoniana, efficiente, la prima della classe, quando si trasferisce a New York vive proprio questo dualismo positivista/negativista, che ci accompagna per tutto il romanzo.