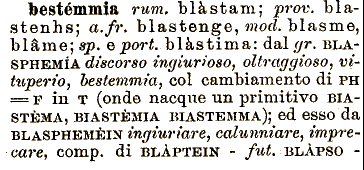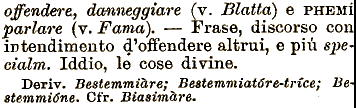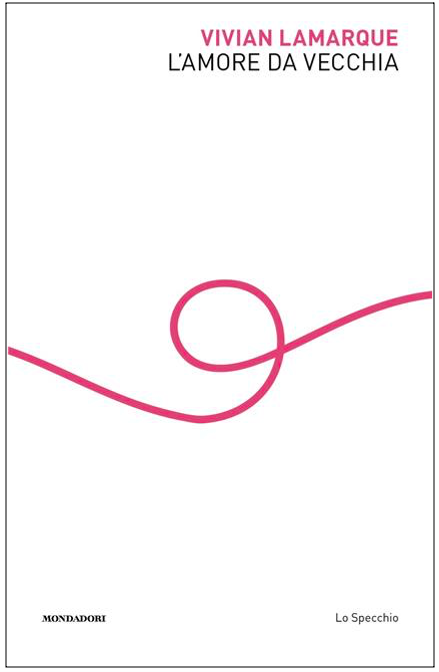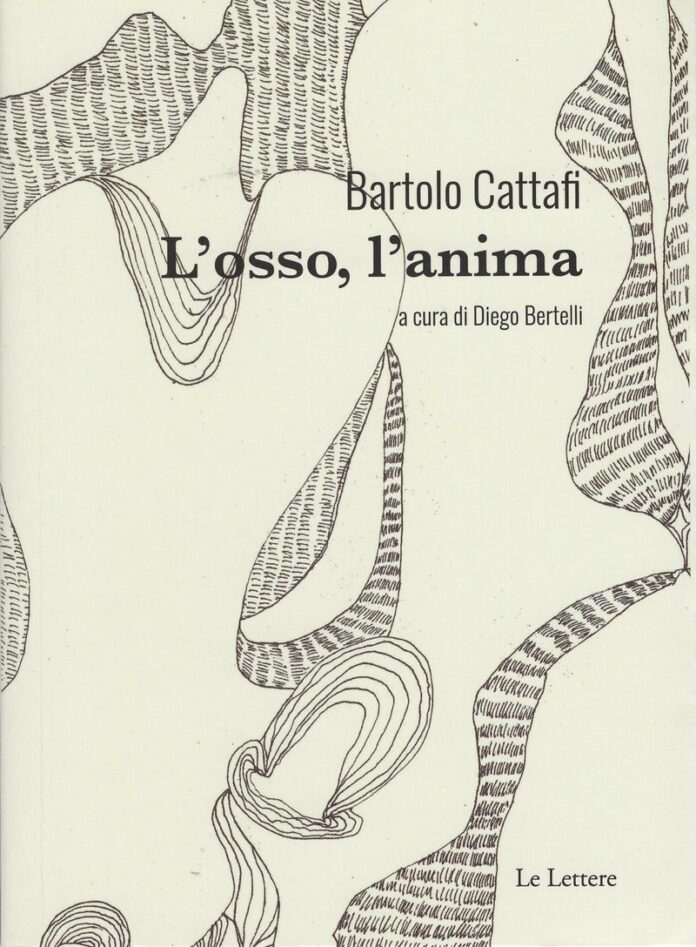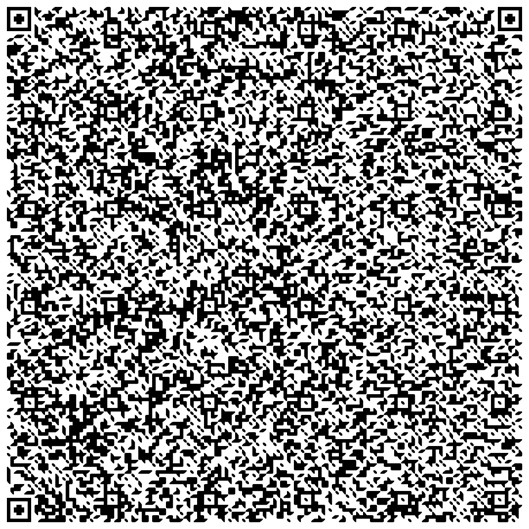Di Andrea Inglese
Un dilagare dell’orrore “senza punti fermi”
Il 9 ottobre, in un articolo apparso sul « Corriere della Sera », Paolo Giordano, noto romanziere, scriveva riguardo all’attacco di Hamas contro Israele, avvenuto due giorni prima: “È uno strano paradosso della nostra epoca: per valutare meglio un evento non conviene più aspettare troppo, conviene quasi, al contrario, affrettarsi e perfino decontestualizzarlo.” Ora, il baratro in cui rischia di piombare Israele, e di far piombare non solo i palestinesi, ma anche tutto il Medio Oriente, l’Europa, e forse il mondo intero, dimostra che questa frase è profondamente sbagliata, ma nello stesso tempo esprime una tentazione che è presente non solo sotto la penna di uno scrittore disinteressato alle astrazioni della geopolitica, ma anche nelle parole e negli atti di dirigenti politici del mondo occidentale. Decontestualizzare, significa semplificare, diminuire i fattori, gli elementi, i dati, le esperienze di cui tener conto, anzi cancellarne una buona parte, e fare in modo che non esistano. L’assurdità di un tale atteggiamento è riscontrabile in un altro passaggio dello stesso articolo di Paolo Giordano, dove si legge: “C’è una storia del conflitto israelo-palestinese che non finisce da settant’anni. Ma ce n’è anche un’altra che è iniziata sabato mattina. Le immagini delle ragazze e delle donne prese in ostaggio sono e resteranno il mio punto fermo di questa nuova storia”. Qui Giordano non fa altro che esprimere, purtroppo, un pio desiderio, ossia il desiderio che in questa storia tra Hamas, i palestinesi, il governo Netanyahu, e gli israeliani, l’orrore si sia fermato con l’azione terroristica e crudele di Hamas il 7 ottobre (almeno 1300 morti e circa 150 ostaggi); ora, in seguito a quell’orrore, si contano – bilancio provvisorio reso pubblico sui media occidentali – già 1900 morti tra gli abitanti di Gaza, di cui 600 sono bambini. Immagini di bambini palestinesi estratti dalle macerie sono state diffuse su giornali e televisioni in questi giorni. Tutti vorremmo che l’orrore trovasse un suo capolinea, una sua immagine finale e insuperabile. Ma in molti casi così non è, e l’immagine dell’orrore dei bombardamenti dell’aviazione israeliana viene ad affiancarsi alle immagini dei militanti di Hamas, che a colpi di mitra o all’arma bianca, avevano ammazzano alcuni giorni prima inermi cittadini israeliani. Se si potesse in qualche modo fissare le immagini del 7 ottobre e non avere che quelle come punto di riferimento, saremmo in grado di confinare l’orrore in uno spazio tempo ben definito: i militanti di Hamas e le loro stragi ingloberebbero tutto il male, tutti i crimini, tutta la violenza irrazionale che ha circolato nei settanta anni di conflitto tra Israele e i palestinesi. Quello che ci dice Paolo Giordano, e che hanno detto innanzitutto dirigenti politici israeliani, seguiti da vari dirigenti politici occidentali, è che dal 7 ottobre il male ha scelto definitivamente il suo campo, e che una nuova storia più chiara, più semplice, si svolgerà: da un lato i cattivi aggressori di Hamas (e un intero popolo che sarà eventualmente una vittima collaterale) e dall’altro le vittime innocenti (il governo e la popolazione di Israele). Solo che questa è una storia che non funziona, non funziona così. Anzi, dobbiamo dirlo: vedere le cose in questo modo, pensare che una situazione di grave e costante instabilità, sia riconducibile a una causa semplice (i terroristi di Hamas), e che la distruzione della causa semplice riporterà la stabilità, è un grave errore, ed è un errore conoscitivo ancor prima che morale. Quando il governo israeliano pensa e dice questo, non sta soltanto cancellando le proprie responsabilità, dimenticando i propri crimini, ma si sta illudendo o, ancora peggio, illude i propri cittadini.
A modo loro, è una storia che gli Stati Uniti hanno raccontato dopo l’11 settembre: ora abbiamo le prove di chi incarna il male nel mondo – i terroristi di Al Qaida – e l’orrore di circa 3000 civili uccisi negli attentati cancella i nostri passati crimini di guerra, come quelli realizzati durante la Prima Guerra del Golfo (bombardamenti sulla popolazione civile). Questa prova, poi, non solo ci assolve retrospettivamente, ma ci permette anche di reagire attraverso una risposta che non ha limiti nell’esercizio della forza. Ma una volta ancora non è tanto l’errore morale a essere il più grave – la volontà di assolversi dai crimini passati, in quanto vittima di un crimine attuale –, ma l’accecamento conoscitivo, che ha provocato, da allora, un accrescimento dei conflitti convenzionali e non convenzionali in tutto il pianeta. Qual è stato uno degli esiti della Seconda Guerra del Golfo durata dal 2003 al 2011? La nascita dello Stato Islamico in territorio iracheno. Vi è intorno a questo nesso rilevante letteratura e documentazione. Quanto alla guerra in Afghanistan, è durata vent’anni, dal 2001 al 2021. Oggi, i Talebani dominano sul territorio, praticando apartheid di genere e repressione del dissenso. Per chi avesse avuto dubbi sull’efficacia della guerra globale al terrorismo lanciata nove anni prima, già nel 2010 la fiumana di documenti segreti dell’esercito e dell’amministrazione, resi pubblici da WikiLeaks e riassunti da grandi testate giornalistiche occidentali, mostrò fino a che punto gli Stati Uniti, anche se fossero stati innocenti prima dell’11 settembre, dopo quella data si stavano macchiando di crimini di guerra realizzati in modo continuativo e senza produrre alcun risultato evidente sul piano militare e politico.
La tentazione di decontestualizzare può essere letta in due modi: o in buona fede (come nel caso di Paolo Giordano): si vuole esorcizzare il trauma, illudendosi di aver circoscritto e messo a distanza il male; o per calcolo cinico – questo riguarda soprattutto i dirigenti politici – si vuole illudere il proprio elettorato, che il male – la fonte dell’instabilità e della violenza – è un bersaglio chiaramente identificabile e del tutto al di fuori di sé, quindi facilmente eliminabile.
.
Quale narrazione possiamo condividere di fronte ad azioni di violenza e crudeltà estrema?
Nei giorni che hanno seguito l’attacco di Hamas contro Israele, ho fatto molta attenzione a capire non solo cosa stava accadendo, ma quali linee di narrazione si sviluppassero intorno agli eventi. Mi sono chiesto, in altre parole, come giornalisti, commentatori, dirigenti politici tentassero di dare senso e rendere intelligibile almeno in parte un evento di eccezionale brutalità e violenza ai limiti dell’insensato. La strage di civili israeliani (e non solo) perpetrata da Hamas in territorio israeliano è stata immediatamente riconosciuta come eccezionale (e quindi per certi versi inverosimile) da tutti i commentatori, dentro e fuori Israele. Diversi i motivi di tale inverosimiglianza: non tanto la barbarie in sé – Hamas aveva già usato in passato il peggiore dei mezzi terroristici: l’attentato alla bomba in mezzo ai civili – ma la modalità dell’attacco (deltaplani a motore), l’altissimo numero di vittime civili e gli errori sia da parte dell’intelligence israeliana prima dell’attacco sia dell’esercito dopo l’attacco. La ferocia dell’atto è stata poi intensificata dalle immagini diffuse dallo stesso Hamas e relative a uccisioni e rapimenti.
Per chi ha vissuto in Francia, e a Parigi in particolare, almeno dal gennaio del 2015 in poi, le immagini di uomini incappucciati che scendono da un furgoncino e sparano sventagliate di mitra su giovani disarmati, suscitano l’eco precisa di un’esperienza comune, quella degli attentati terroristici sul suolo francese: la strage alla sede di Charlie Hebdo e quelle della notte del 13 novembre per le strade di Parigi e al Bataclan.
Tipico dell’attentato terroristico è questa divaricazione tra l’atto e il suo significato, che è vera sia per la vittima diretta (coloro ne sono i bersagli concreti), ma anche per chi ne è la vittima indiretta (i parigini, i francesi che scoprono, attraverso i media, la dinamica dell’evento). Il trauma collettivo nasce innanzitutto da un’eccedenza di ferocia, di violenza gratuita ed estrema, nei confronti di qualsiasi tentativo di attribuire, a quell’atto, un significato, ossia una motivazione. Soprattutto in questo senso si dovrebbe parlare di un’azione “barbara”, ossia di un’azione opaca, che rifiuta di entrare in un discorso di senso, in una narrazione intelligibile.
Si faccia qui attenzione a una distinzione fondamentale. Quando parliamo d’intelligibilità o meno di un’azione, non parliamo di “giustificazione morale” di un’azione, ma innanzitutto di “comprensione narrativa” di essa. È il modo principale che abbiamo per dare senso a un atto, un gesto, un comportamento che, di primo acchito, ci risulta oscuro, immotivato, privo di senso. Faccio un esempio immaginario. Entro in camera di mia figlia, e vedo la foto della sua migliore amica nel cestino della carta straccia. Mia figlia (o qualcun altro) ha fatto una cosa che non capisco. Sarò costretto a chiedere a lei, perché la foto della sua migliore amica si trova in mezzo ai rifiuti di camera sua. Se vorrà rispondermi, se vorrà “spiegarsi”, se vorrà farmi capire il senso del suo atto, dovrà raccontarmi cosa è successo. Questa narrazione potrà essere più o meno lacunosa, ma mi farà capire se non altro che cosa ha spinto mia figlia a fare un tale gesto. Un comportamento inaccettabile della sua amica nei suoi confronti? Un’eccessiva permalosità di mia figlia? Entrambe le cose, combinate assieme?
Situare un’azione in un contesto narrativo non significa per forza “giustificarlo” e concludere, ad esempio, che gettare il ritratto nel cestino era la cosa migliore o giusta da fare, era la cosa che tutti avremmo fatto, se fossimo stati nei panni di mia figlia. Significa, però, sottrarlo alla pura enigmaticità, e comprenderlo come una reazione magari eccessiva, magari sbagliata di una situazione dai contorni chiari.
Torniamo ora agli attacchi di Hamas. Anche quell’evento per singolare, straordinario e terrificante che sia, esige di essere compreso, cioè inserito in un contesto narrativo. Cosa ha fatto Hamas? Sta cercando di liberare la popolazione di Gaza, rompendo gli sbarramenti israeliani? Sta difendendo dei palestinesi sotto attacco da parte di coloni israeliani? Sta ingaggiando uno scontro con i soldati della potenza occupante? Conosciamo purtroppo la risposta: Hamas sta sparando contro delle persone che sono in grandissima maggioranza civili, disarmati, presi di sorpresa. Possiamo chiamare ciò “terrorismo”, possiamo chiamarlo “barbarie”, in ogni caso c’è un linguaggio ampiamente condiviso tra i popoli delle varie nazioni del mondo per definire questo atto, in relazione al contesto in cui è emerso: si tratta di “crimini di guerra”. Il linguaggio in questione è quello del diritto internazionale, che si è concretizzato storicamente in una serie di trattati condivisi da una maggioranza di nazioni, dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 allo Statuto di Roma del 1998.
Uno dei caposaldi del diritto internazionale è che, anche in una guerra, ci sono delle norme che non vanno violate. La guerra, che sia tra popoli o Stati, è di per sé, potremmo dire, quanto di peggiore, di più distruttivo, di più irrazionale, gli esseri umani siano in grado di realizzare. Ciò nonostante le guerre continuano a esistere, e se esistono ciò significa che coloro che vi sono coinvolti – sia per ammazzare che per farsi ammazzare – sono convinti che nel loro caso non ci sia altro da fare, non ci sia soluzione migliore che prendere le armi. Se quindi le società umane non hanno ancora trovato un modo per evitare le guerre, esse si sono seriamente impegnate, in modo coordinato, per poterle almeno regolare.
In tale contesto la norma non sta semplicemente a dirmi ciò che dovrei fare in una data circostanza – anche se sei in guerra, anche se subisci un attacco terroristico, non rispondere commettendo “crimini di guerra” – ma mi aiuta a situare la mia azione, qualunque essa sia, quella sbagliata o corretta. Se non ho norme condivise, se non ho frontiere concettuali, non sono più in grado non solo di sapere se sto agendo bene o male, ma di sapere quello che sto facendo.
Se Israele dimentica i propri passati crimini nei confronti dei Palestinesi (il blocco di Gaza, la colonizzazione continua, l’appropriazione delle risorse idriche, la distruzione delle abitazioni civili, gli ammazzamenti ingiustificati, ecc.) e si accinge a commetterne di nuovi, significa che, nel conflitto con i terroristi di Hamas, azzera il linguaggio comune del diritto internazionale, sui cui si misurano non solo le sue azioni, ma anche quelle di Hamas, e di tutti i testimoni terzi, per riconoscere un unico territorio di confronto: quello della legge del più forte.
Naturalmente Israele è uno Stato sovrano, inoltre è appoggiato – seppure in modo non completamente incondizionato – dagli Stati Uniti, superpotenza mondiale, quindi può decidere a livello di governo, con l’assenso più o meno convinto della popolazione, di praticare questa via: estirpare Hamas costi quello che costi in termini di vittime civili, di diritti umani, ecc. Sono più potente militarmente, e quindi sono certo di poter schiacciare il mio avversario, ossia un partito politico e militare, ammazzandone tutti i membri. Situandosi però del tutto fuori dal diritto internazionale, dalle norme che tentano di regolare i conflitti, Israele ottiene un primo risultato catastrofico. Alla fine neppure le opinioni occidentali meno simpatizzanti per il popolo palestinese riusciranno più a distinguere barbarie da barbarie. Già adesso è difficilissimo distinguere i cittadini inermi uccisi da Hamas dai i cittadini di Gaza, inclusi 600 bambini, morti a causa dei bombardamenti israeliani. Già adesso è difficilissimo non riconoscere l’orrore dell’assedio (né elettricità, né cibo, né acqua). Hamas ne uscirebbe vincitore di fronte all’opinione pubblica mondiale, assimilando Israele a sé sul piano morale (entrambi non conosciamo limiti nel conflitto). Il secondo risultato, anch’esso fallimentare, riguarda l’obiettivo a lungo termine di una tale operazione: anche indebolendo militarmente Hamas, anche mettendolo momentaneamente fuori gioco, la volontà di autodeterminazione del popolo palestinese non sarebbe scalfita. I palestinesi per più di settanta anni hanno resistito con tutti i mezzi – quelli legittimi e quelli illegittimi – all’occupazione israeliana. Non hanno un vero Stato, non possiedono una vera terra, vivono in una condizione d’umiliazione permanente, ma ciò nonostante non se ne sono andati, non si sono dispersi, non hanno negato la loro identità culturale e la loro storia. Israele potrebbe al limite ammazzare tutti i membri di Hamas, e con essi un numero enorme di “vittime collaterali” innocenti, ma non potrà comunque sterminare tutti i palestinesi. Questo gli stessi cittadini israeliani (la maggior parte di essi) alla fine non lo permetterebbero. Quindi, dopo aver commesso una gran quantità di crimini di guerra (se non addirittura di crimini contro l’umanità), Israele si troverebbe ancora con i palestinesi al di là dei muri, e in più con nuovi candidati pronti a rilanciare la faida.
Naturalmente non ho nessun suggerimento “positivo” da dare agli israeliani. Non saprei dire come e cosa fare con Hamas. Come rispondere militarmente all’attacco terroristico del 7 ottobre. Con chi immaginare di avviare negoziati. Potrei dire soltanto: è davvero troppo pericoloso farsi guidare in un conflitto da un partito di estrema destra. Storicamente le politiche di estrema destra non hanno mai prodotto grandi risultati per la pace e la stabilità. È davvero pericoloso mettersi nelle mani di un governo che si è contestato con ostinazione per nove mesi, considerandolo corrotto e antidemocratico. Potrei soltanto dire: non trovate giustificazioni per azzerare una volta ancora e più gravemente le frontiere tracciate dal diritto internazionale. Se lo fate, diventate come Hamas, che in nome delle reali e ingiuste sofferenze del popolo palestinese, cancella tutti i limiti nell’esercizio della violenza. Le regole del diritto internazionale sono fragili e imperfette, ma al di fuori di esse non c’è salvezza: c’è l’abisso della forza bruta, della barbarie, di ciò che può disumanizzarsi indefinitamente.
*
Immagine: Absalon, Cell N° 1, 1992.











 Fortunatamente, gli architetti già nel primo dopoguerra sapevano ben distinguere il grano dal loglio. C’è una lettera di Franco Albini che lo testimonia con chiarezza (voglio qui ringraziare la Fondazione Albini che me l’ha fatta conoscere). Albini scrive alla sorella Maria, transfuga a Parigi da un decennio e attiva nella resistenza francese. Siamo nel settembre del 1945. Albini racconta come, finita la guerra, ci sia stato un riposizionamento da parte di quegli “inetti” (così li definisce) “che non hanno mai avuto idee per la testa” e che ora riappaiono “a dire che sono perseguitati dal fascismo e a parlare di libertà: tutti parlano di libertà, che è la libertà di fare i propri schifosi interessi.” C’è descritto molto del carattere dell’italiano medio, in questa lettera privata. Il tipico saltare sul carro del vincitore, più realisti del Re. Albini non ci sta e critica “quei tali inetti, che dicono “arte fascista” a quell’arte che è fiorita qui malgrado il fascismo, e che proprio per il suo carattere internazionale dimostra di essere universale, e per niente legata alla politica”. Albini è un architetto “di sinistra” ma non ha problemi a criticare quegli “artisti, che si dicono comunisti, e che dichiarano di fare l’ “arte comunista” che scivolano verso il contenutismo (un quadro che rappresenta Lenin è più bello di uno che rappresenta Mussolini)”. Concludendo con un esempio preciso, che cita proprio il nostro Terragni: “Bisogna battersi ancora molto nel campo critico, e chiarire che l’arte è arte per sue ragioni particolari e non perché abbia o no una destinazione politica: la casa del fascio di Terragni è arte anche se è la casa del fascio, e il grande monumento a Stalin non lo è.”
Fortunatamente, gli architetti già nel primo dopoguerra sapevano ben distinguere il grano dal loglio. C’è una lettera di Franco Albini che lo testimonia con chiarezza (voglio qui ringraziare la Fondazione Albini che me l’ha fatta conoscere). Albini scrive alla sorella Maria, transfuga a Parigi da un decennio e attiva nella resistenza francese. Siamo nel settembre del 1945. Albini racconta come, finita la guerra, ci sia stato un riposizionamento da parte di quegli “inetti” (così li definisce) “che non hanno mai avuto idee per la testa” e che ora riappaiono “a dire che sono perseguitati dal fascismo e a parlare di libertà: tutti parlano di libertà, che è la libertà di fare i propri schifosi interessi.” C’è descritto molto del carattere dell’italiano medio, in questa lettera privata. Il tipico saltare sul carro del vincitore, più realisti del Re. Albini non ci sta e critica “quei tali inetti, che dicono “arte fascista” a quell’arte che è fiorita qui malgrado il fascismo, e che proprio per il suo carattere internazionale dimostra di essere universale, e per niente legata alla politica”. Albini è un architetto “di sinistra” ma non ha problemi a criticare quegli “artisti, che si dicono comunisti, e che dichiarano di fare l’ “arte comunista” che scivolano verso il contenutismo (un quadro che rappresenta Lenin è più bello di uno che rappresenta Mussolini)”. Concludendo con un esempio preciso, che cita proprio il nostro Terragni: “Bisogna battersi ancora molto nel campo critico, e chiarire che l’arte è arte per sue ragioni particolari e non perché abbia o no una destinazione politica: la casa del fascio di Terragni è arte anche se è la casa del fascio, e il grande monumento a Stalin non lo è.” Eppure l’asilo Sant’Elia, l’ultimo capolavoro di un architetto morto troppo giovane, è da ormai un lustro vuoto. I “turisti colti” di passaggio a Como (quelli a cui dovrebbe mirare un comune lungimirante) vengono per visitarlo e si ritrovano davanti a una staccionata raffazzonata e a un edificio abbandonato. Avendo io a Milano l’esempio del Marchiondi Spagliardi, capolavoro del brutalismo di Vittoriano Viganò vincolato dalla Sovrintendenza e abbandonato a se stesso da decenni, so già, purtroppo, come andrà a finire: infiltrazioni, topi, spoliazioni, scrostature, crolli.
Eppure l’asilo Sant’Elia, l’ultimo capolavoro di un architetto morto troppo giovane, è da ormai un lustro vuoto. I “turisti colti” di passaggio a Como (quelli a cui dovrebbe mirare un comune lungimirante) vengono per visitarlo e si ritrovano davanti a una staccionata raffazzonata e a un edificio abbandonato. Avendo io a Milano l’esempio del Marchiondi Spagliardi, capolavoro del brutalismo di Vittoriano Viganò vincolato dalla Sovrintendenza e abbandonato a se stesso da decenni, so già, purtroppo, come andrà a finire: infiltrazioni, topi, spoliazioni, scrostature, crolli.












 Questo è l’unico romanzo scritto da Sylvia Plath. Almeno così risulta, perché il beneficio del dubbio serpeggia. I suoi testi sono stati curati dal marito, il poeta inglese Ted Hughes, il quale ha distrutto molte pagine dei diari perché “non volevo che i figli li leggessero”. Ma forse si parlava anche di lui in termini non proprio edificanti. Probabilmente, nel romanzo, alcuni suoi tratti rivivono nel personaggio di Buddy Willard, che doveva essere il promesso sposo della narratrice, Buddy l’ipocrita. Verso di lui va e viene, come una sorta di Yin Yang (an)affettivo che corre sulle pagine, un sentimento doppio di attrazione e repulsione, che potremmo definire la “cifra” dell’intero testo. Infatti Esther, la brava ragazza bostoniana, efficiente, la prima della classe, quando si trasferisce a New York vive proprio questo dualismo positivista/negativista, che ci accompagna per tutto il romanzo.
Questo è l’unico romanzo scritto da Sylvia Plath. Almeno così risulta, perché il beneficio del dubbio serpeggia. I suoi testi sono stati curati dal marito, il poeta inglese Ted Hughes, il quale ha distrutto molte pagine dei diari perché “non volevo che i figli li leggessero”. Ma forse si parlava anche di lui in termini non proprio edificanti. Probabilmente, nel romanzo, alcuni suoi tratti rivivono nel personaggio di Buddy Willard, che doveva essere il promesso sposo della narratrice, Buddy l’ipocrita. Verso di lui va e viene, come una sorta di Yin Yang (an)affettivo che corre sulle pagine, un sentimento doppio di attrazione e repulsione, che potremmo definire la “cifra” dell’intero testo. Infatti Esther, la brava ragazza bostoniana, efficiente, la prima della classe, quando si trasferisce a New York vive proprio questo dualismo positivista/negativista, che ci accompagna per tutto il romanzo.