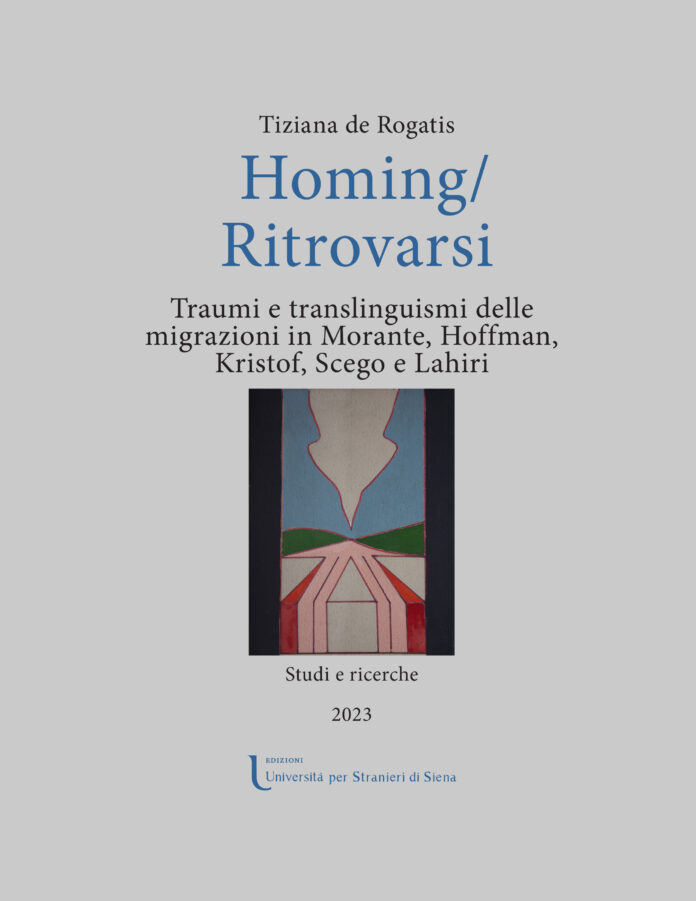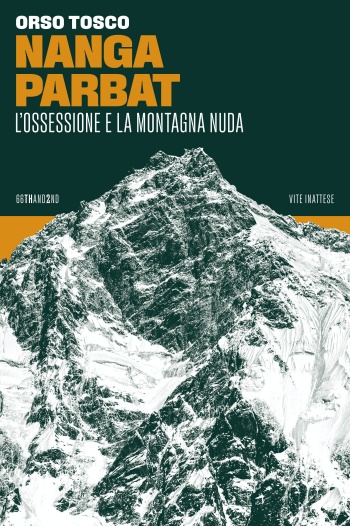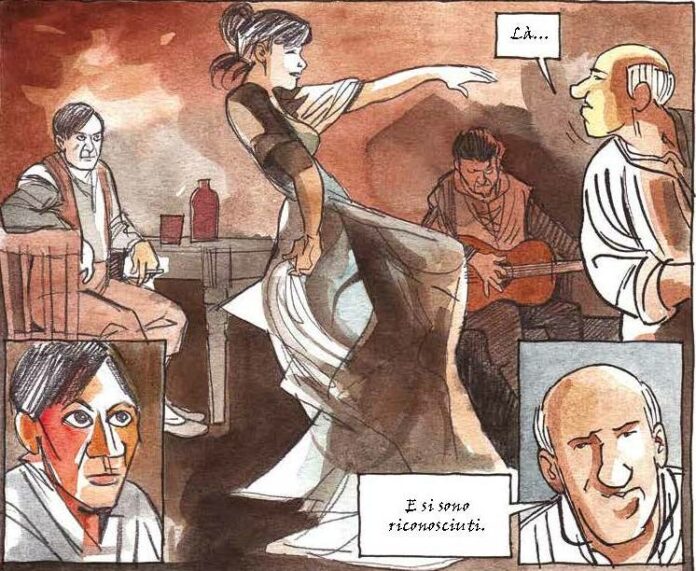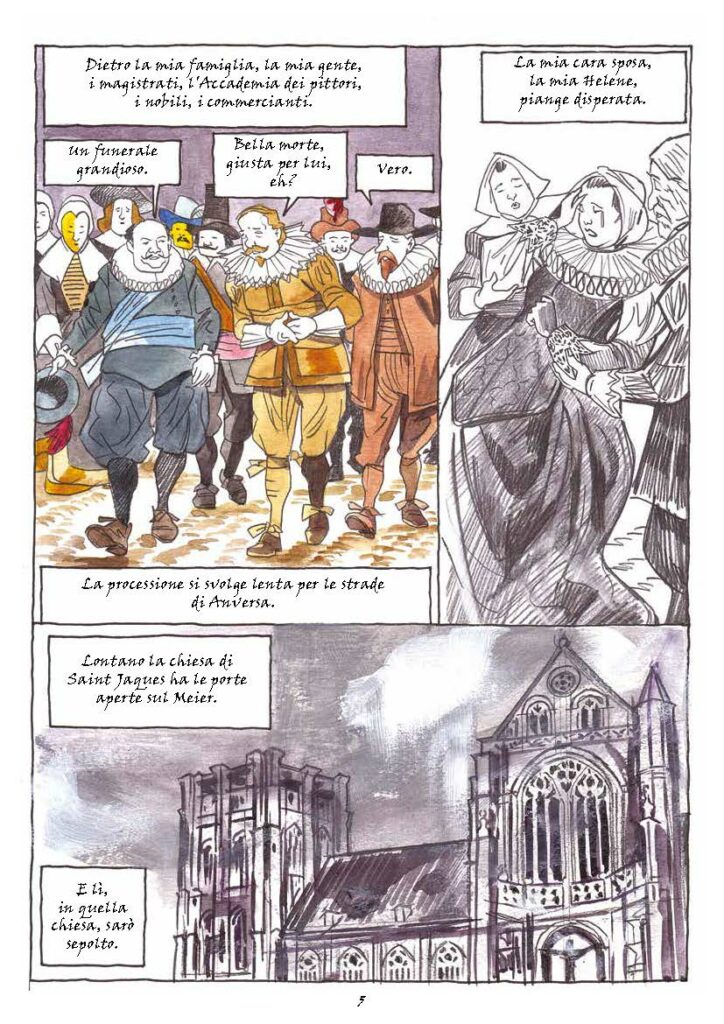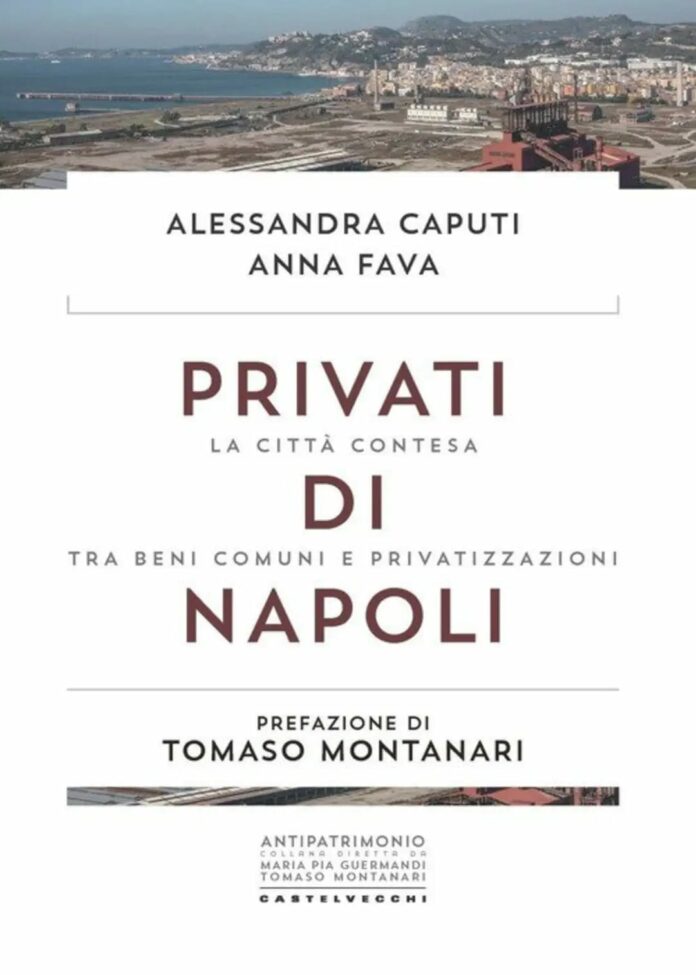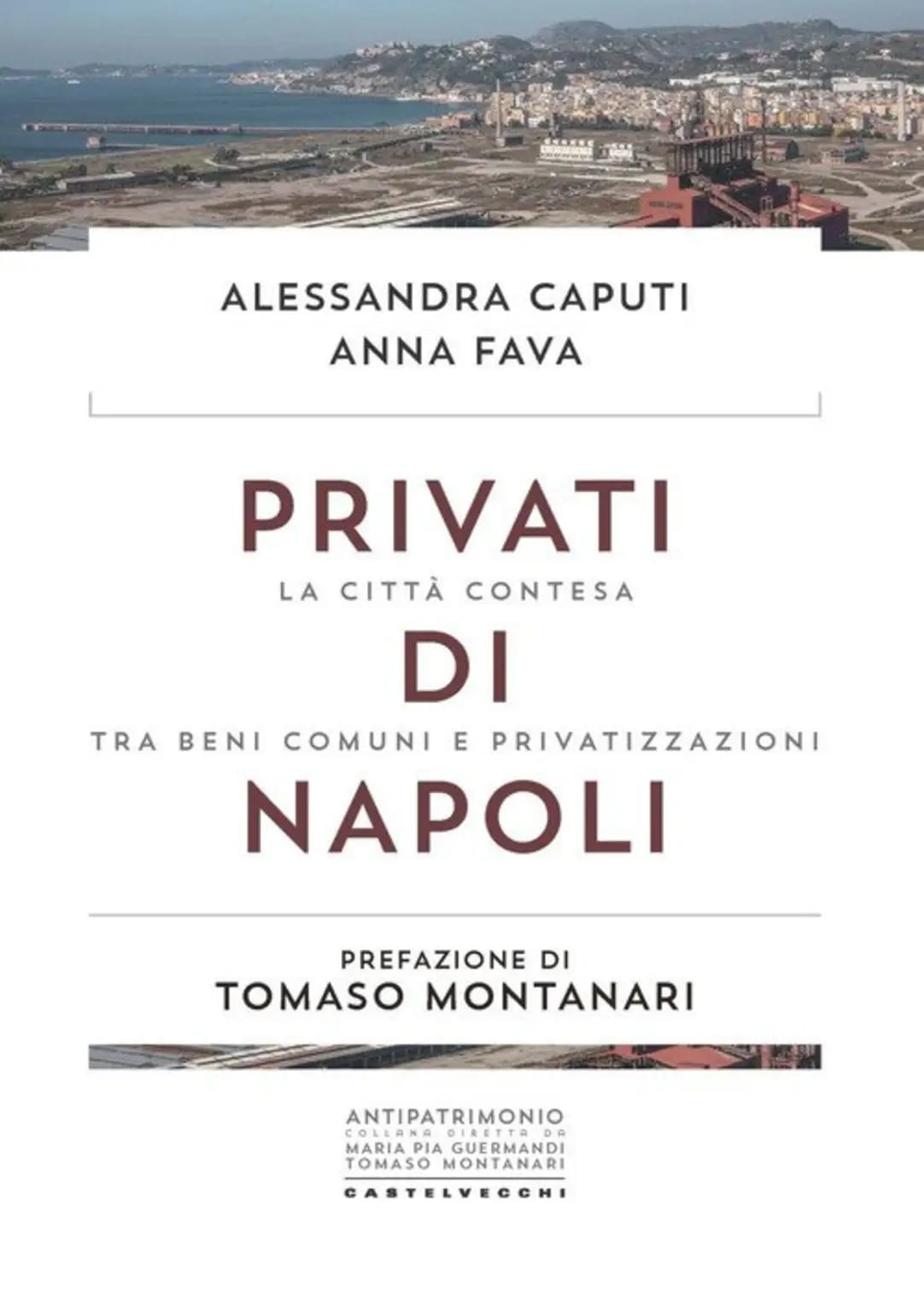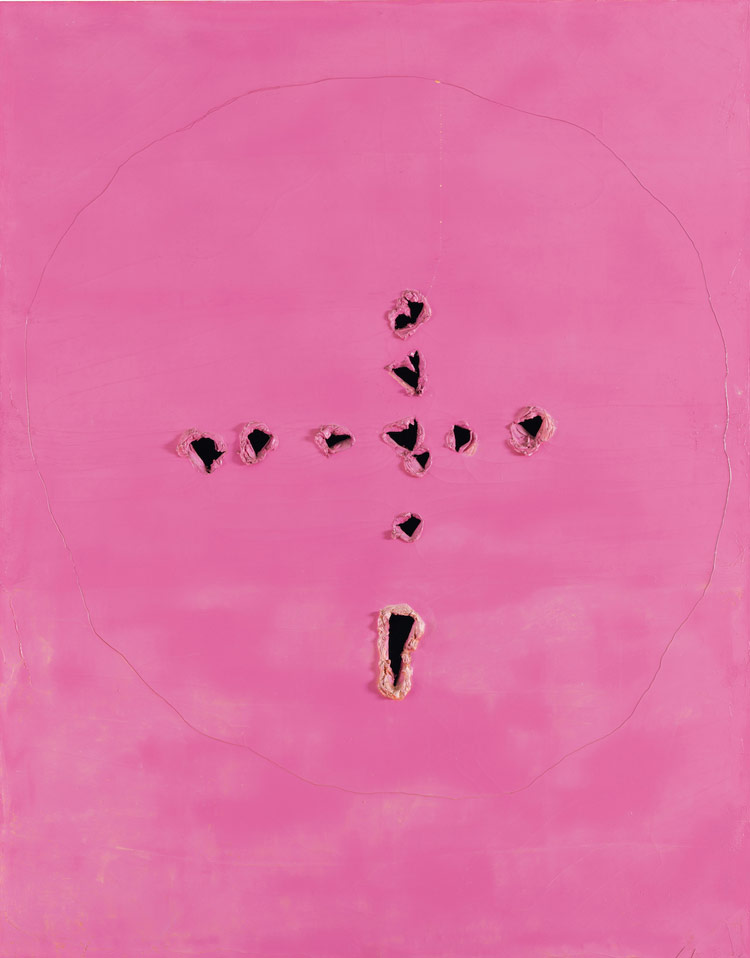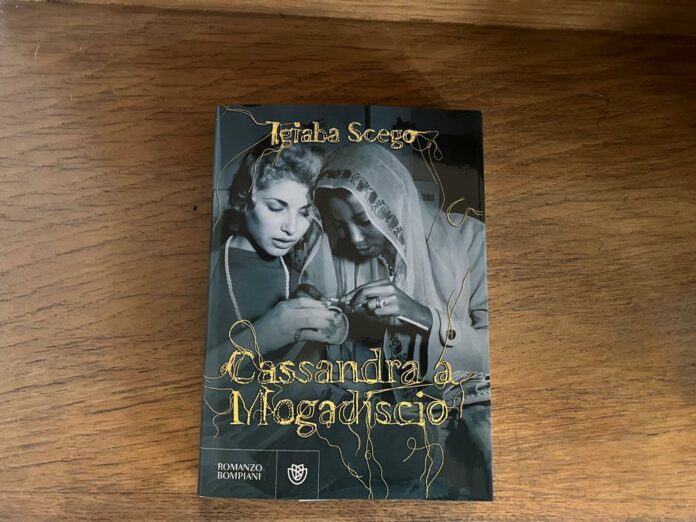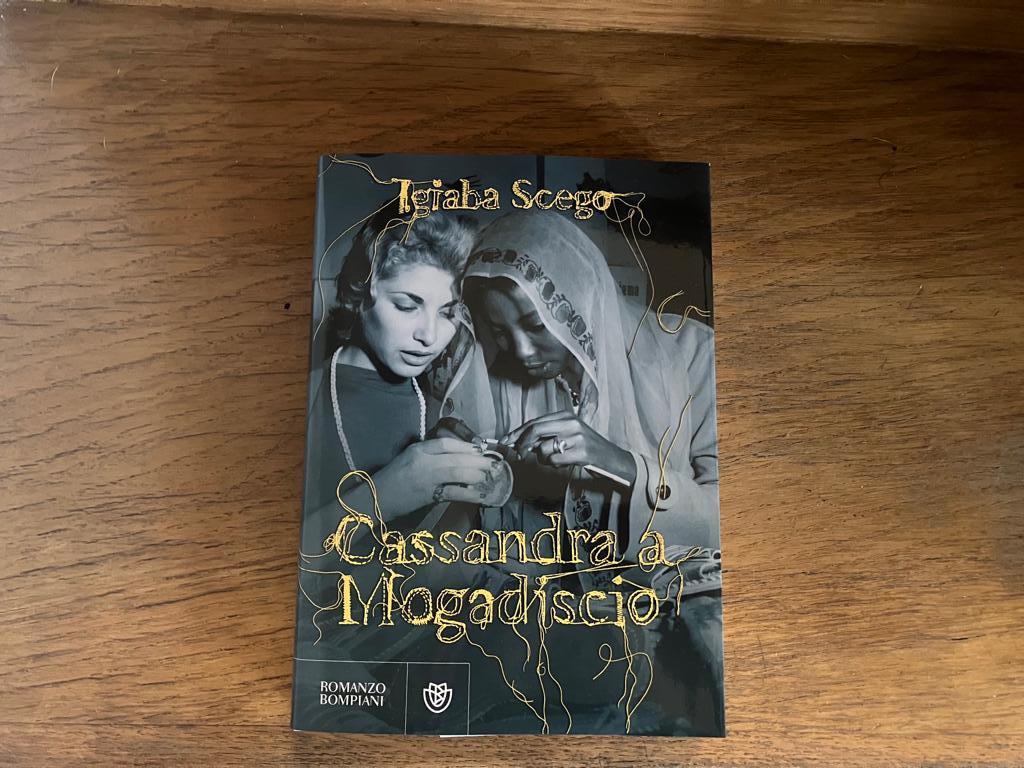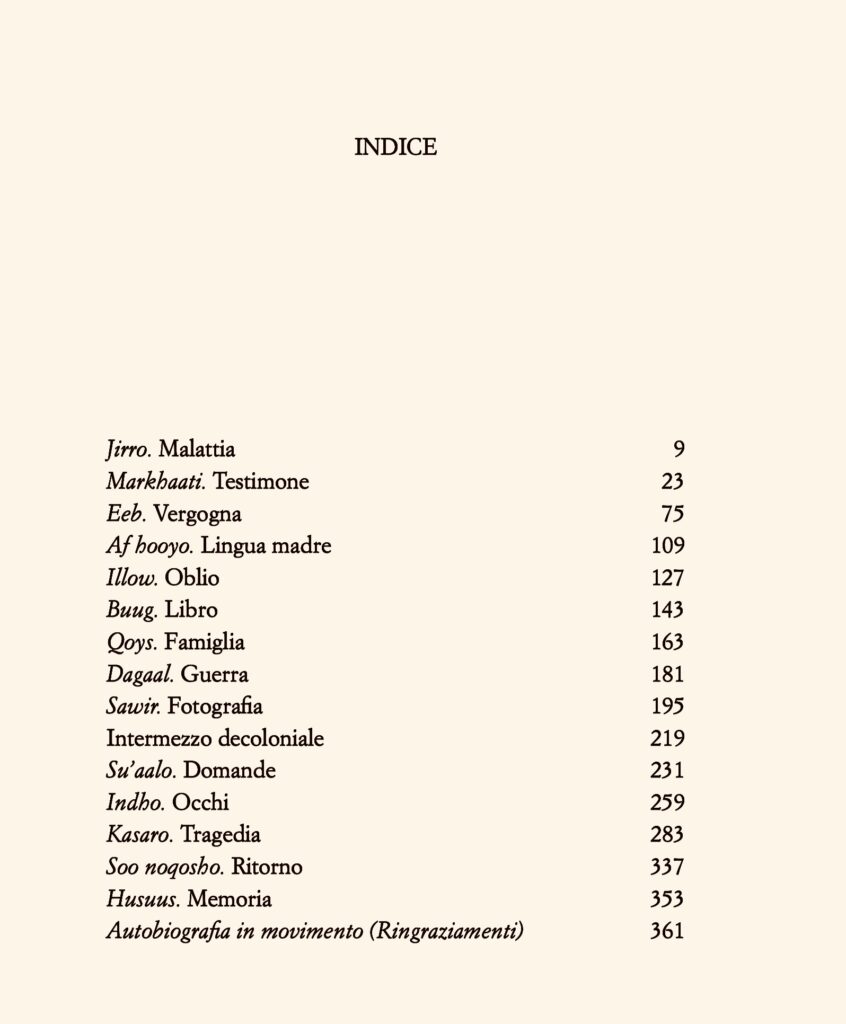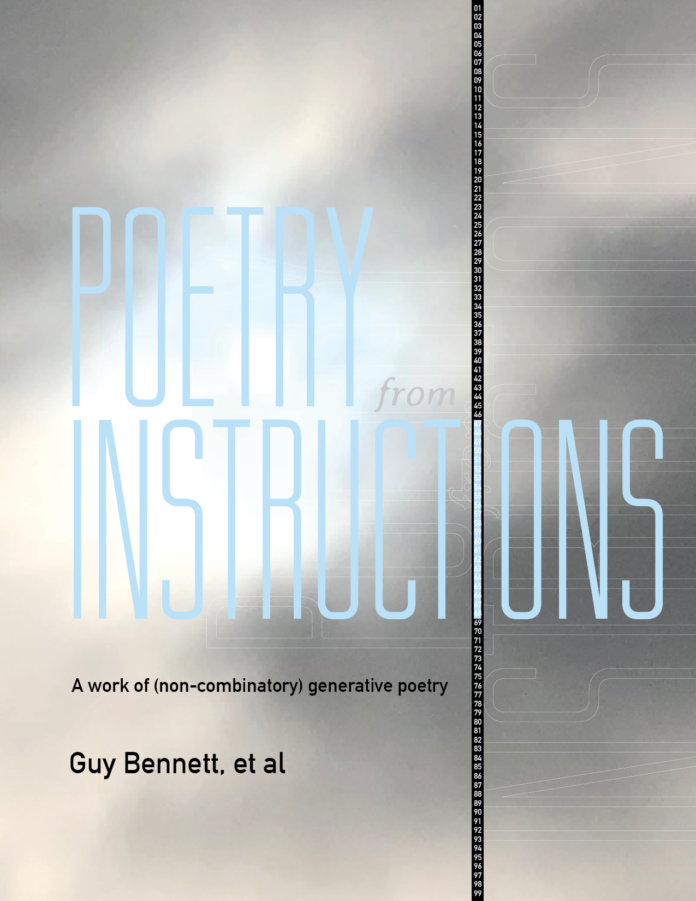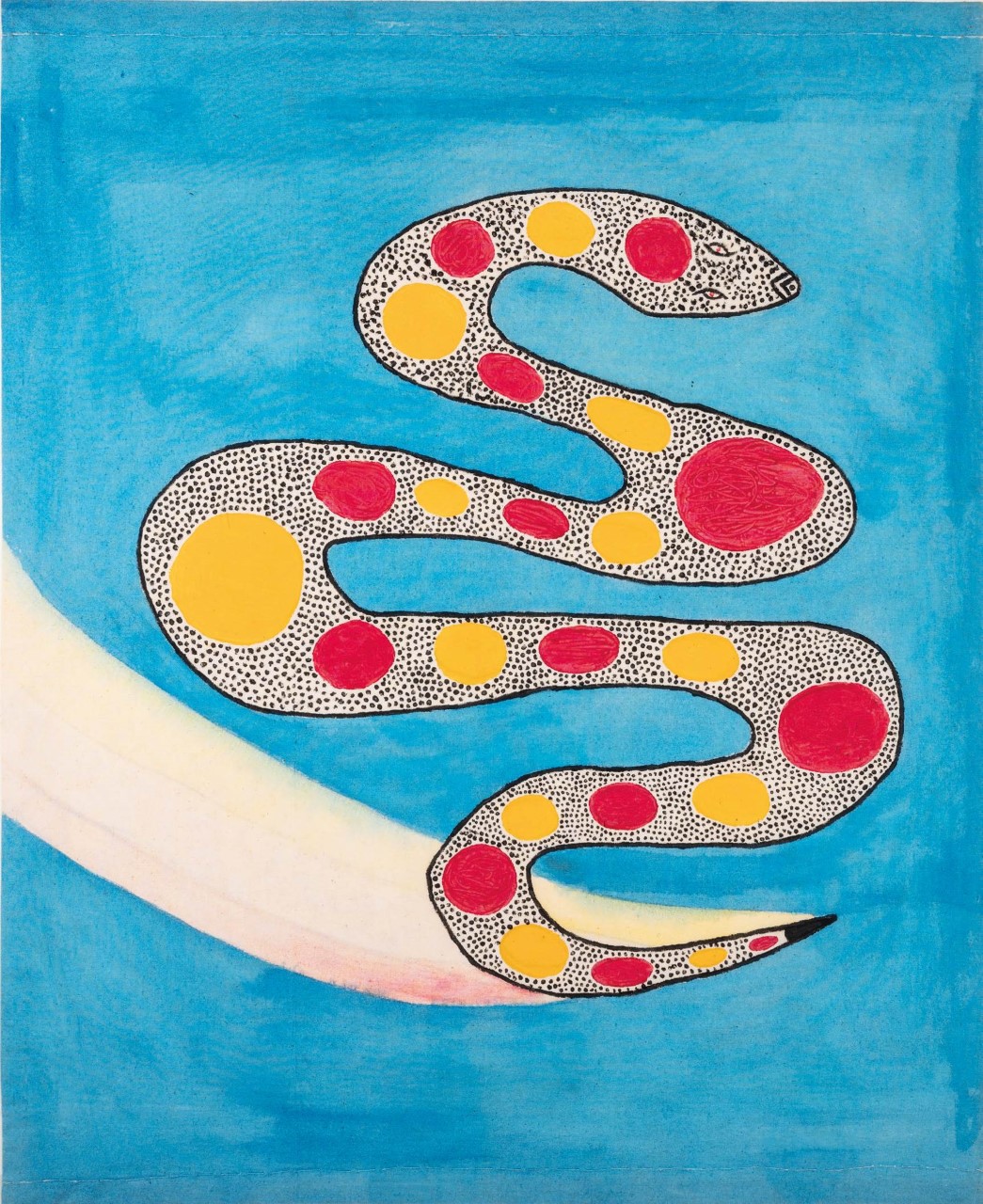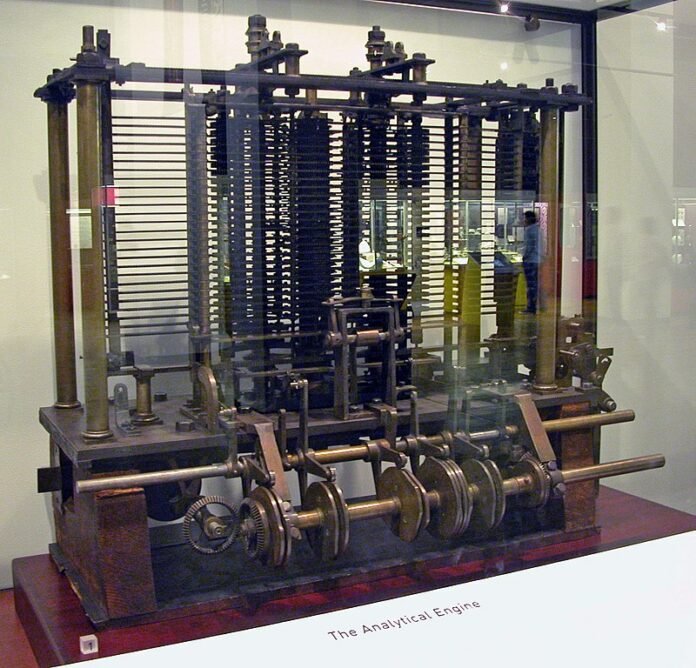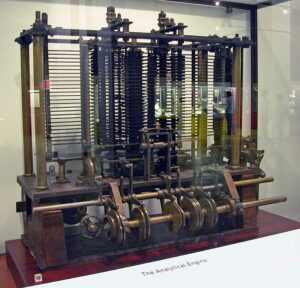di Alberto Pascazio

Odio i vecchi perché sono sopravvissuti a se stessi. Non è una cosa di cui vado fiero, ma non riesco a non vedere in un vecchio il simulacro dell’uomo che era. Una lunga fine indignitosa, insieme umida e secca, pronta per il commosso saluto. Ecco quindi il signor Franco che arranca mentre scendo per le scale. Lo saluto con una cordialità parossistica, per ricordargli che sta per morire, nel caso l’avesse dimenticato. L’incontro mi acciglia; i miei occhi sono già scappati fuori. Mi sento tirato in avanti, come da un elastico, o da un guinzaglio. Questo pensiero occupa gli ultimi sette passi: la vista può sempre scappare più veloce del corpo.
La città mi accoglie con un cielo trasparente, né grigio né azzurro; un’infinita sala operatoria. Scruto i passanti. Finché non ci parlo, sono solo comparse: girato l’angolo, evaporano. Provo a immaginarli tutti sotto i ferri, aggrediti da quella luce immanente, sul marciapiede, sulle strisce, seduti al bar. È la prima operazione di massa. Un’epidemia di delusione e nevrosi ha contaminato il quartiere. Decine di medici rovistano con i bisturi nelle viscere di questi poveretti, si asciugano la fronte col camice, sciamano come api sui corpi, ma ormai è andata. Un arabo in attesa dal barbiere, cui stanno asportando un nodulo di invidia dall’ascella, si accende una sigaretta. Il tabacco mi brucia nell’iride e mi riporta a me stesso. I medici spariscono e le comparse tornano a bere i caffellatte, a parcheggiare le macchine, a berciare di nulla che io sappia.
Doveva essere solo una passeggiata; niente da fare, nessuno da raggiungere. Allora scelgo una direzione e comincio a camminare. Sorpasso gli isolati in numero indefinito. Capita che a un certo punto voglia sdraiarmi per strada. Mi succede abbastanza spesso, una o due volte al mese. Se il lavoro mi affligge più di un po’, se certi ricordi torreggiano, se vedo un gruppo di liceali lunghissime fumare fuori da scuola, gobbe di zaini e a gambe all’aria, ecco che voglio accasciarmi sul viale. Prendere posto in mezzo al marciapiede, accucciolarmi sull’asfalto, trovare il mio rifugio lì dove lo voglio. Immagino di appisolarmi nel caos, come quando da bambino mi addormentavo in spiaggia e il vociare si mescolava al mare: mi aspettava una notte serena. Non lo faccio, neanche stavolta, e mi maledico un attimo dopo: tra la gente che scende da un tram, scorgo un beota che conosco, il Chinazza. Neanche provo a sperare che non mi veda, è praticamente sceso salutandomi. Vorrei avere con me le chiavi di tutti i palazzi della città, per sgattaiolare via dai ladri e dai conoscenti.
«Ué, grand’uomo!». È un simpatico, il Chinazza.
«Chinazza, quanto tempo!»
«Dall’ultima rimpatriata. Come stai?»
«Bene!» le lettere mi rimbalzano in bocca per quanto non le ho pensate. Mi schizzano proprio via, come in un flipper. La bi addirittura mi screpola le labbra. In ufficio dirò che è herpes.
«Dai! Anche io bene». Il cervello gli balbetta… «dovremmo vederci un giorno».
«Lo abbiamo appena fatto.»
«Sei sempre il solito coglione!»
«Chinazza, mi offendi! Sono ogni giorno un coglione diverso».
Farlo ridere funziona sempre. Chinazza si vergogna quando gli scappa da ridere. Cioè scappa letteralmente a ridere di nascosto. Se è all’aperto, va proprio via, si dilegua.
«Allora ti chiamo!»
«Spengo il telefono!» Gli do il turbo per farlo ridere via.
Allontanatosi il maledetto Chinazza, la voglia di sdraiarmi è passata. Sono quindi costretto a ricordarmi di lui. Chinazza fa il giudice di pace. L’ho conosciuto appena arrivato in città, a un corso serale di stand-up comedy. C’erano salatini vecchi, poca birra, da dividere disperatamente nei bicchierini da caffè, e una ragazza dolce in sedia a rotelle, che ogni volta mi mordevo la lingua quando diceva “stand-up”. Al giro di presentazioni, Chinazza aveva cominciato a ridere ancor prima di parlare. E quindi ogni tanto scappava sul posto, ci dava le spalle e si piegava un po’. E noi lì ad aspettarlo, masnada di gonzi, con il sorriso sommesso e tremendo di chi è costretto ad aspettare la battuta dopo le risate di chi sta per farla. Quella di Chinazza, che rivendicava di dirla ogni giorno in tribunale, era “oh, non sono mica qui per giudicarvi”. E giù a ridere da solo, di spalle, come un malato di tisi espettorando.
Gli inutili ricordi di Chinazza mi hanno già teletrasportato in centro. Un buon chilometro di potenziali pensieri elevati e ragionamenti arguti, sprecato a camminare così, per niente. E quanti bei culi non notati. Per la rabbia mi viene fame. Entro in un baretto preimpostato, aperto col franchising della speranza di svoltare, di quelli con due parole nel nome: Sale&Pepe, Dolce&Salato, Break&Go. Dalla faccia del barista, mi accorgo che la speranza l’ha tradito alla prima occasione.
«Buongiorno, vorrei un toast».
«Un toast come?» Buongiorno anche a lei, signor coglione.
«Un toast! Prosciutto e formaggio».
«Non li facciamo. Abbiamo solo il Pastrami Toast e l’Avocado Special». Comincio a simpatizzare per la speranza fedifraga.
«Mi dia pure un Pastrami Toast».
«Da bere?»
«Niente, grazie».
«Sicuro? Il Pastrami Toast è un po’ asciutto». Il tono monocorde mi fa sentire che si sta sinceramente prendendo cura di me.
«In tal caso, prendo una coca zero».
Mi accomodo a un tavolaccio bianco nuovissimo. Spazzo via due briciole col dorso della mano, come valesse meno del palmo, e guardo fuori mentre aspetto il mio pranzo. Un tassista sta scaricando i bagagli giganteschi di due coreani minuscoli, che assistono sull’attenti. Un vistoso concierge di un altro secolo apre loro la porta del Majestic. La coreana zampetta dentro, lui la segue traslando, senza muovere le gambe. Immagino abbia delle ruote a scomparsa. Fantastico sull’uscire in fretta, seguirli nella hall e sedurre lei sfacciatamente. Si schermisce, mi guarda: c’è lui di fianco, uomo italiano, e non capisco quello che dici. Ma non può resistere al mio fascino arruffato. Abbandona il coreano e sale con me nella loro alcova. Facciamo l’amore e lei piange, si dispera, telefona alla mamma. Cosa aveva fatto fino a ora? L’ho scaraventata fuori dalla caverna di Platone e le ho mostrato cosa volesse dire scopare. Il coreano, lì fuori, non protesta nemmeno. Sono leggi di natura. Esco, il mio compito iniziatico è assolto. Torno a mangiare il mio Pastrami Toast, che, oltretutto, non è ancora arrivato. Una vecchia, solo passandomi davanti, mi fa dimenticare la faccia della coreana e sono di nuovo seduto qui. Sento proprio la sedia sotto il culo, gli atomi che si toccano: una sensazione che solo guardare una vecchia può farmi vivere così vividamente. Dietro il bancone, il barista preme sulla piastra del mio toast. Mi chiedo se anche il suo cervello si perda dietro le donne, fantastichi sullo stravolgere loro la vita con una sola scopata, come nessuno, nessuno mai. Mi rispondo di sì, che tutti gli uomini lo pensano. Mi assolvo, come un tossico tra i tossici. Che poi non è neanche il sesso. La mia ossessione, il mio puntiglio, il mio cruccio, è farle innamorare tutte. Pensare che se avessi tempo ed energia infiniti, passerei in rassegna l’intera popolazione femminile e tutte, nessuna esclusa, si perderebbero irrimediabilmente. Le figlie e le madri. Le madri delle loro madri. Le nipoti, le sorelle, le zie. Le vicine di casa, le migliori amiche, le ritardate. Le suore, le farmaciste, le mogli dei mafiosi. È un fantasticare che diventa sublime quando sono accompagnate o qualcosa mi fa capire che lo sono: una telefonata che si chiude con un ti amo annoiato, uno sfondo del telefono in cui accampa il faccione di lui, un anello un tantino più prezioso. E comincio a pensare che basti un mio bacio dietro l’angolo, in un androne, o sulle sponde del metrò, a creare l’abisso sotto i loro piedi, a scatenare le sinapsi e rinnegare tutto, a bagnarsi come donnole al fiume. Ovviamente non è vero. Non sempre. Quasi mai.
Sono ancora le tre del pomeriggio e il panino è finalmente arrivato. Il barista aveva ragione: è denso come una nana bianca e caldo come la superficie del sole. Un compendio di astronomia. Apro la lattina di coca e tiro un sorso. Desiderandone la freschezza, dimentico l’impeto dell’anidride carbonica. In un attimo, mi ritrovo a sputacchiare per prendere respiro. Le goccioline ambrate piovono sul telefono distorcendo la notifica appena apparsa. È il promemoria per la medicina.
Ci siamo lasciati quattro mesi fa e ancora non riesco a eliminarlo. Pigrizia, mi dico.
Pulisco lo schermo con la manica. Il promemoria arriva dopo pranzo, ogni ventiquattro ore: ai tempi del Noi serviva a ricordarle di prendere la medicina, arrivare con un bicchiere d’acqua e aspettare che la buttasse giù. Nulla di grave, ma da prendere ogni giorno. Ai tempi del Me, serve a non staccarmi da Lei, a ricordarmi di soffrire, per sperare ancora un po’. Avevo messo in conto che avremmo potuto lasciarci. Il piano era ben definito: mollare tutto, vendere il vendibile e trasferirmi alle Azzorre. Comprare una casupola, trovare un lavoro manuale, sporco, catartico e mangiare sano. Non imbruttirsi, mettersi in forma, imparare a nuotare. Integrarmi con i locali, diventare uno di loro. Avere un soprannome, addirittura. Essere visto con indifferenza, all’inizio. Scherzato, dopo un po’, e infine accolto nella fredda convivialità dell’isola, segreta e settaria, incomprensibile ai forestieri. Una comunione carbonara che passa per lo più dall’accesso ai prezzi ribassati di cibo e sigarette. Avrei imparato un pessimo portoghese direttamente lì, da un pescatore, e nel frattempo avrei insegnato l’italiano ai miei figli, che avrei amato poco, non essendo nati da Lei. Li avrei fatti con una tedesca bislacca e delusa. Tutto questo avrei fatto, se non fosse stato per la Tari arretrata, che ancora mi incatenava alla città. Quand’è finita davvero, fatalmente, la paura si è trasformata in fatto, scongelando i propositi che tanto avevo lavato e porzionato. Scioltasi la patina di ghiaccio, mi ero accorto che quei propositi non mi andavano affatto, proprio come il petto di pollo dimenticato nel congelatore.
Faccio volare via la notifica con una nocca e la fame mi passa d’un tratto. Al suo posto, caldo come un tuorlo, comincia a germinare l’odio. Sento la prima cellula sdoppiarsi nello stomaco. E poi sdoppiarsi ancora e ancora. Si nutre delle piccole cose, del Chinazza, dei vecchi, del caldo. Tutto ormai può farlo crescere, ma la sua genesi è in quel promemoria. Nella fine di una storia cui credevo di non poter sopravvivere e che invece mi trova qui a provare i piccoli piaceri esattamente come prima, persino il pastrami. È la consapevolezza peggiore: constatare che posso sopravvivere a tutto e che quindi, in fondo, ogni cosa è priva di un senso intrinseco. Ne acquisisce solo se io provo qualcosa a riguardo, in un preciso istante, e quando quella cosa non è più davanti a me, diventa una fotografia, un numero civico, un promemoria sul telefono. Forse per questo odio i vecchi: perché mi somigliano. Cellula dopo cellula, la crisalide dell’odio si trasforma nella farfalla della rabbia. Continua a crescermi dentro, catturando la luce attorno a sé. Dove la porto quando il toast finisce? Al prossimo pasto? Al cinema? Al lago? Il barista mi fissa: devo essere paonazzo. Si avvicina, pulisce le mani sul grembiule, poi ne poggia una sulla mia spalla: «Allora, com’è?». Le dita mi squarciano i vestiti, la pelle e i muscoli, aprendo la strada alla farfalla, che vola via, libera dal giogo della decenza. Apro la bocca per urlargli tutto addosso. Poi, il boato.
I calcinacci mi tengono fermo a terra. Posso alzare la testa solo di un po’ e al costo di un dolore inaffrontabile, come se il collo diventasse una lama telescopica che mi trafigge tutto, prolungandosi fino al coccige. Ci provo per l’istinto, più umano che animale, di capire cosa stia succedendo invece che rifuggire il dolore. Riesco a guardare non più su di mezzo metro rispetto alla terra e per quasi un secondo. Attraverso il fumo nero, scorgo piedi che corrono, scintille e un’auto in fiamme; scarpe, articolazioni e zaini alla moda. Un’AirPod è finita sulla cacca di un cane, come su un cupcake, una voce recita il Padre Nostro, un rivolo di sangue riflette nuvole immacolate e veloci.
Riabbasso la testa, il collo rientra nel suo meccanismo e mi dà tregua. Piagnucolo un po’. Provo a sollevare la schiena per divincolarmi dalle macerie; non ci riesco: urlo. Due voci si liberano dal caos avvicinandosi sempre più. Le sento parlare di me come se non ci fossi: “liberarmi, tirarmi fuori, salvarmi”. Sono lì in mio aiuto, ma stento a voler loro bene. Quando riesco ad alzarmi, e la polvere mi svela come un mago, abbraccio una delle due voci in segno di gratitudine. Così ho imparato a fare. L’altra voce aspetta, col sorriso imbarazzato di chi sa che è stato scelto per puro caso come secondo abbraccio. Eppure il caso vorrà dire qualcosa, se un moribondo appena salvato, io, ti sceglie come seconda voce da abbracciare invece che come prima. E giù di affliggimenti interiori: “sarò brutto? Sarò basso? Sarò schifoso, poco carismatico?” Così ragioniamo tutti. O tutti noi, che viviamo nella grande città. Abbraccio la seconda voce in un attimo, dandole in parte ragione, e mi accorgo di non aver niente di rotto. Ero solo incastrato. Il povero barista, invece, ha la testa fracassata dai mattoni. Poche gocce del suo sangue macchiano la mia scarpa destra. Distolgo lo sguardo ed esco da quel che rimane del bar. In strada, mi colpisce un’allegra macchia di colori, che spicca nel disastro. Sono i vestiti dei due coreani, disseminati dalle valigie esplose. Piumini rigonfi, stivali lucidissimi e borse di pelle dipinta. Loro due, i coreani, giacciono disarticolati poco più in là, ben più tristi e organici.
Noi sopravvissuti ci guardiamo attorno in cerca di sguardi che abbiano capito qualcosa, ma quegli sguardi non ci sono. Una signora pingue scesa in strada in pigiama abbraccia il panico di un uomo in giacca e cravatta. Alle loro spalle, scintilla fumante quel che resta di un missile. Un missile vero, come quelli dei film e dei musei. La livrea grigia, ancora riconoscibile sebbene in parte deflagrata, non rileva segni, scritte o simboli. Qualcuno ha lanciato un missile in pieno centro. Uno: non due o nessuno; e in tempi di pace, una pace lunghissima e depressiva. Davanti a una tale inaspettata tragedia, per un istante infinito, vedo le differenze annullarsi. Una sfaccendata coi rasta si prodiga nel confortare i più impauriti. Un enorme businessman si accuccia e piange di sgomento. Sangue freddo e atterrimento si distribuiscono nei modi più inaspettati, attingendo all’animo profondo di ognuno, celato dagli abiti, dal censo, dal genere, dagli orologi.
Quando il terrore si affievolisce un poco, per strada si eccita una nebulosa di caos. Mi cruccio di non avere uno sguardo divino, poter avere una visione d’insieme, di dovermi invece concentrare su un dettaglio alla volta e lasciarmi sfuggire tutto il resto. Sapere chi risponde ai dolorosi telefoni che vedo carezzare le guance, dove si dirige chi corre via, se fugge solo dal missile o ha una meta precisa, un bambino da abbracciare, una bocca da baciare. Sapere cosa si dicono i capannelli che confabulano confusi, le teorie che accampano, le parole più dette. Leggere nella testa di tutti, senza però impazzire. E in questo lampo di guerra, mi chiedo se sia davvero possibile essere Dio, piuttosto che se esista.
Arrivano le sirene. Prima quelle della vita, poi quelle della legge. Medici e infermieri non si muovono confusamente come nelle mie fantasie mattutine, ma mi sorprendono per rapidità e rigore. Passano in rassegna ogni corpo con una cura razionale che fa male a vederla. Dalle volanti della polizia rotolano giù agenti e ispettori. I primi danno conforto e ristoro alla gente, i secondi cercano risposte. Ne trovano solo una, plebiscitaria: all’improvviso è arrivato il missile. Il missile, appunto. Sta lì come un totem incastrato nell’asfalto. I poliziotti gli girano attorno lentamente, sporgendosi per osservarlo, come una tribù indiana.
Arriva il primo giornalista. Poi un altro. Poi le telecamere. Qualcuno si affida allo smartphone in cerca di una spiegazione: “Un missile ha colpito la città”, “Città bombardata: è guerra?”, “La guerra in città”. Sono i titoli di chi sa ancora poco. Quelli da agenzia stampa. Per capire qualcosa, ci vorrà qualche ora.
I due ispettori si appartano per sfuggire ai giornalisti e discutere tra loro. Uno cammina avanti e indietro con le mani dietro la schiena. L’altro lo ascolta immobile, a braccia conserte. Visti dall’alto disegnano un pendolo; e l’oscillare dei loro pensieri scandisce il passare del tempo. Siamo quasi al crepuscolo, quando arrivano i periti del Genio. Il missile viene così analizzato: alcuni strani aggeggi ne registrano forma, colore, materiali, ma la comparazione con qualsiasi missile presente in commercio non dà risultati. È un missile simile a qualsiasi altro, ma non ne esistono di uguali. La notizia rimpolpa le scarse informazioni dei giornali. Appaiono anche le prime teorie. Guerra all’Europa, terrorismo islamico, un’esercitazione sfuggita di mano. Qualcuno sui social si spinge ad accusare il governo, senza grandi argomentazioni, se non quella di sapere quello che gli altri non sanno.
Arriva anche il primo bollettino: i morti accertati sono quattro. Dopo aver letto la notizia, scelgo il poliziotto meno indaffarato e mi avvicino con discrezione:
«Scusi, posso chiederle un’informazione?» Ha la faccia rotta di stanchezza e il manganello in tiro.
«Dica».
Tentenno un po’: «Si sa chi sono i morti?»
«È un parente? È arrivato adesso?»
«Ero in quel bar quando il missile è arrivato».
«E a che le serve sapere chi sono i morti?»
«Uno di loro era il barista, mi aveva appena servito, e altri due li ho visti in strada un attimo prima. Vorrei sapere chi fosse il quarto…»
«Perché?»
Già, perché? La domanda mi ammutolisce. Comincio a chiedermi se la farfalla della rabbia sia scappata via o sia morta dentro di me. Blatero un “non lo so” sommesso.
«Non posso dirle chi è. Comunque, è proprio qui dietro, davanti al tabacchi».
Alcuni poliziotti fanno così; non ti dicono la cosa che vuoi sapere, ma te ne dicono altre che comunque non potrebbero dirti.
Lo ringrazio e mi avvicino al tabacchi. C’è un corpo coperto alla bell’e meglio. Mentre gli giro intorno, l’ammasso diventa quadridimensionale, distorcendo il tempo e fermandolo, quasi. Quando raggiungo il volto, i muscoli delle gambe mi vibrano come alla fine di una maratona. Devo sporgermi per guardarlo bene. Nascosto, come in un’ultima pudica risata, riconosco il Chinazza. La sua faccia è un buco nero e io ormai ci sono dentro.
L’urlo del poliziotto mi risucchia fuori dall’orizzonte degli eventi. Pensavo fosse impossibile. Mi raggiungono in tre, correndo; lui e i due ispettori. I loro sguardi mi attraversano, immobilizzandomi. Poi, mi immobilizzano davvero.
Ci raggiunge un altro poliziotto, mi fanno salire su un blindato. I poliziotti escono e resto solo con i due ispettori. La panca è freddissima, come la luce del neon che ci colpisce dall’alto. Fuori, tra le barre del finestrino, vedo frenare una berlina nera. È il Presidente del Consiglio. Uno dei due ispettori tira giù una tendina e mi si siede di fianco, accavallando le gambe. L’altro, come prima per strada, cammina da un lato all’altro del vano:
«Allora, perché volevi sapere chi fosse quel poveretto?»
«Non lo so, davvero». Non ho più paura, sono solo stanco.
«A me sembra strano. Collega?» L’altro annuisce, quello riprende:
«A me sembra strano, perché in una tragedia così, uno resta praticamene illeso e rimane sul posto per ore, senza chiamare nessuno, per poi chiedere a un poliziotto quanti morti ci fossero – si ferma davanti a me e si piega per guardarmi negli occhi – e non solo, ma poi sa anche chi sono i morti, tranne uno, e quest’ultimo lo vuole sapere, lo vuole sapere a tutti i costi, tanto da andare a controllare di persona». Fa una pausa, come per recuperare la pazienza: «Allora, ci vuole dire che c’entra lei con questa storia? Perché lei qualcosa c’entra».
Alzo lo sguardo: «Non c’entro niente. Non ho mai visto un missile in vita mia».
«E c’è sempre una prima volta. Perché nessuno qui ci è venuto a chiedere chi fossero i morti. Tranne i giornalisti. È giornalista lei?» Non rispondo.
«E allora, visto che è così curioso, le dico che ci hanno appena comunicato che c’è un altro morto. Vuoi sapere anche questo chi è?» L’ironia della domanda esplode in una curva di accento palermitano. «E io glielo dico, tanto siamo qui per capire, no? È un anziano, sugli ottanta, si chiama Franco Annibali. Ha avuto un attacco cardiaco mezzora fa. Lo conosce? Sa chi è?».
Le parole mi rimbombano in testa. Il sangue mi pulsa nelle tempie. Forse la farfalla è rimasta dentro. Il signor Franco. Il signor Franco, Chinazza, il barista, i coreani. Cinque morti, cinque persone che ho incontrato. Che ho odiato, o concupito, che ho sporcato con i pensieri più violenti e istintuali. Che ho posizionato con cura sull’altare del dolore e sciroppato nella melassa dell’odio. Un odio che ha cominciato a zampillare dalle crepe dei muri, dalle pieghe del divano, dai cassetti, dallo shampoo, dai libri e dalle pentole. E poi fuori, dai marciapiedi, dai tombini, dai tubi di scarico. Da quando te ne sei andata.
«Cos’ha detto?» Il poliziotto si intromette tra me e me.
«Niente, stavo solo pensando».
«No, lei ha detto qualcosa».
L’altro ispettore parla per la prima volta, sbirciando dietro la tendina, come non gli importasse: «Ha detto “sono stato io”. Ecco cos’ha detto».
«Ecco, allora avevo capito bene. E adesso ci racconta finalmente? Ci spiega cosa vuol dire?».
«Sono stato io. Stamattina sono uscito di casa pensando a Lei. Ero triste, arrabbiato. Sarete uomini anche voi. Esseri umani. Ho incontrato il signor Franco sulle scale, abitiamo nello stesso condominio, e puzzava di giacca e di vecchio e l’ho odiato. Poi sono uscito e mi sembrava tutto così insulso. Inutile. Siete inutili anche voi, adesso. Miliardi di miliardi di cose inutili, ogni giorno. Anche oggi. Ho fatto una passeggiata, ho desiderato sparire, sciogliermi dietro l’angolo, come una delle mie comparse. E invece no. Ho incontrato il Chinazza. Ho odiato anche lui, capite? Capite dove voglio arrivare?».
«A dire il vero no, ma continui, ci parli del missile».
«Ho parlato con il Chinazza, non ci vedevamo da tempo. Poi sono arrivato qui e ho ordinato un toast nel bar alla nostra destra. Il barista era insopportabile. Mentre aspettavo il toast, ho visto la coppia di coreani scendere dal taxi per entrare al Majestic. Mi è venuta voglia di scopare. Ho fantasticato su di lei, potete immaginare. Ma anche su di lui, sul farlo soffrire. Li ho odiati, in un certo altro modo. Poi è arrivata la notifica».
L’ispettore mi interrompe, riprende a camminare: «La notifica. Un segnale? I suoi complici. Da dove l’avete sganciato?»
«La notifica è quella della sua medicina. Da quando non c’è più, mi serve a tenermi insieme. A mantenere acceso un flebile segnale elettrico, la radiazione cosmica di fondo di quello che eravamo. Ed è stato quell’impulso a fare infiammare la tanica di odio che mi sbatacchiava nello stomaco. Non capite? Il missile l’ho lanciato io, da quel bar. È la cristalizzazione materica della tragedia. È una lega di acciaio e dolore, piombata dal cielo al mio segnale. Provate ad analizzarlo. Provate! Ci troverete il mio DNA. E forse anche il suo».
Per la prima volta, anche l’altro ispettore volge lo sguardo verso di me. L’altro si ferma di nuovo, è attonito, sgomento: «Il suo di chi?»
«Il suo».
Mi fanno scendere dal blindato. Chiamano un medico, mi indicano, confabulano. Mentre aspetto, il freddo comincia a farsi sentire. Una signora, passandomi di fianco, mi urta leggermente il braccio. La guardo storto, le bofonchio dietro un insulto, sicuro di non farmi sentire. Cosa ho imparato dal missile?