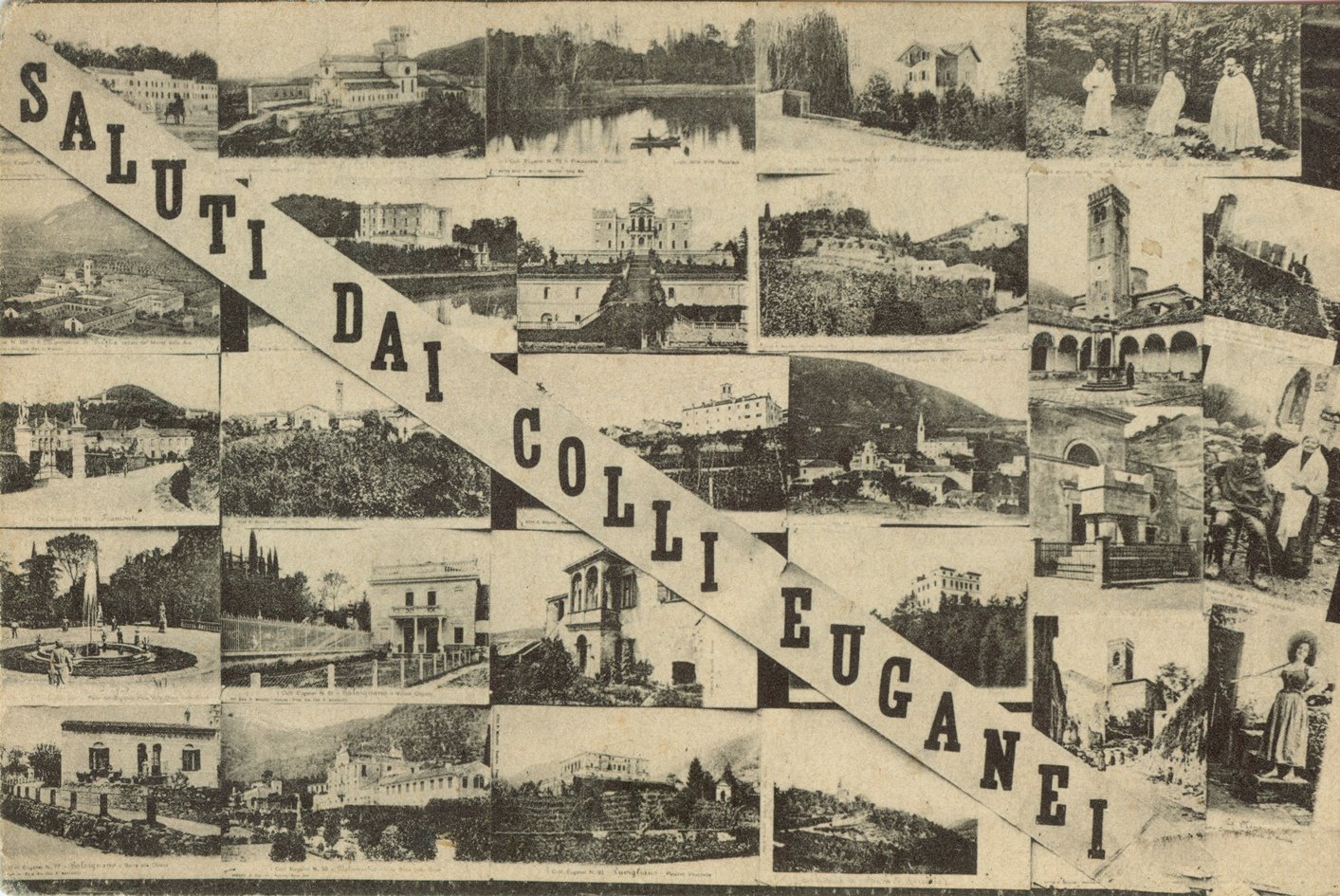Un caro diario di questi anni
Caro Diario,
questo diario è un miracolo. L’ho baciato preso in braccio, vedendolo .
(Era specchio di me o del sé delle altre?). Era vivente.
Le tecnologie malate, anche loro, si sono accanite a ritardare i primi contatti, e poi l’approdo: è tornato a casa, mio come un ulisse. In attesa di ripartire entro le mura di Milano, mi hanno detto.
Un’altra Circe che si frapponeva, la cascata di avvenimenti degli ultimi mesi, mi ha gettata a terra più volte. Come tacere della morte di mio padre, i modi in cui saputolo… e tutto assieme, sangue con lacrime, nella città nativa e nella città presente.
Proprio per questo, ho deciso: che il quaderno mi salvi dalla fibrillazione della cronaca, mi porti con sé mi insegni.
Ho sempre tenuto un diario, più d’uno ai tempi dell’analisi, quando scrivere i sogni sembrava il primo compito del giorno. Oggi mi torna, come messaggero di altre vite, bussa discreto, dice,
Siamo noi – le voci, il tempo attuale, storie della storia, stai in ascolto.
Della sua culla, “dondola una gondola piano nel divenire/ feto di un fiatare breve”, dico in versi.
Il venerdì santo, prima di Pasqua, mio padre è tornato a visitarmi in sogno: dicono sia difficile sognarli subito dopo la loro partenza, se non perché chiamati dal nostro desiderio, e avevo forte il bisogno di incontrarlo; ero ad Istanbul, sul canale del Bosforo, e là mi sono ricordata, lui stava seduto in cucina nella sua casa e mi sorrideva, posando la mano sulla testa di mia figlia, che disegnava. Mentre mi guarda negli occhi, ecco li abbassa, io grido, Ma allora non sei partito affatto, sei ancora qui fra noi, e sei tornato, babbo!
Lui abbassa giù a lato gli occhi e li china, fugge via.
Così, di profilo, come uscendo, è tornato nel silenzio da cui viene.
Mi sveglio, sono scossa nel profondo: penso che sia un dono grandissimo, questa visita. La mattina è già sabato di veglia pasquale, anche se qui cantano i muezzin molte volte al giorno, con una voce che intona i versi del Corano, ma la fede è medesima alla nostra.
Oggi a Milano, sola e satura di domande, mi sono sentita bagnare fino alle radici dalla nudità.
Senza le donne, corale collettivo visibile e di sfondo, la mia vita è più solitaria di anni fa. Esse esistono dentro me, sempre; ma siamo cresciute, dunque niente più arco teso della giovinezza?
Altre cose, fili, testimonianze crude sottili, della vita quotidiana che è voraginosa.
Dai libri, dai blog, da immagini inedite ecco che tornano, in amicizie rare e preziose, patti; silenziose telefonate notturne, rapinose visite, o al cinema.
Gite dove non c’è bisogno di parlare. Perché mi mancano, allora, le stagioni totali?
Non ho accettato le diaspore le dipartite, anche lì il tema della separazione che mi taglia in due…Una me bambina da sgridare, dunque.
Di danze e vite condivise dove abitavamo, dove parlavamo ” di quel tempo o zolla / non più colonizzato/ e dedito a riempire di sé sito, ogni ..silenzio innato” ( scrivo in Estranea canzone), fuori dalla durezza sociale dei deposti patriarcali, dove le distanze appaiono protette.
E quanto dura ancora nei nostri cuori, come ha germogliato.
Oggi ho con me una giovane fanciulla in fiore, che suona clarinetto, disegna che è un incanto, da quando usa le mani; è un torello, si chiama Sara, mia figlia Sarabella come chiamavo lei piccola. Tolsi la h finale, poiché non volevo segnarla con mitologie di sua madre: la storia di noi marrane, probabile e incerta, di terra castigliana, uno dei miti di iniziazione con cui battezzare le nostre innumeri “diversità”. Oggi credo siano nomi universali, buoni per tutte e tutti.
___________
Lavoro, lavoro (Mi piace lavorare)…
Mi piace lavorare”, ehm sì certo che mi piace lavorare, anzi si può dire io dico che non ho fatto altro nella vita, sai quando s’intende che hai cominciato a diciott’anni eh sì, giù di lì, in quell’età della vita in cui gli altri vanno solo a ballare, in giro a divertirsi, pomiciare. Invece, eccoti qui: con la divisa da maestra. Con trenta bambini piccoli da accudire, istruire, intanto fioccano le riunioni, gli extra, non hai più tempo per vivere per studiare, allora che fai, ecco: abbandoni l’università, anzi fai finta che è inevitabile, che lo fai da convinta, e per sei anni, chi ti ha più visto agli esami? Poi continui con gli impegni, ti dici, ma mica deve cambiare del tutto la mia vita solo perché lavoro, no.
E prosegui imperterrita: viaggi, hai il tuo amore a Napoli, bene è durato sette anni, hai le riunioni politiche a Milano, magari leggere riposanti, come in Via Dogana, no? Ci vai e basta, non importa se il fiato ti manca, sia perché si fumano ancora le vecchie Pack, sia perché il giorno dopo, anziché riprenderti dal boccheggiare prendi la cuccetta notturna per Napoli, e via!
Poi, la università la occhieggi sempre, sai che lì vicino c’è Bologna, con i suoi giri universitari chiusi, però ci vai, di relazioni di lavoro tenti di allacciarne, ma solo il sabato e la domenica. Poi pensi: che quella domanda di borsa di studio per Parigi, perché non dovresti farla: per laurearti hai dovuto cadere per davvero, ingessarti, sempre vero, avere l’onore delle aspettative per salute, per potere infilarti dieci mesi a letto, e scrivere scrivere, studiare.
Intanto che lui da là, di Napoli, aspetta che tu lavori sempre, ma pazienza, tu lo sai fare bene, Appena puoi torni al lavoro. Poi le cose fra te e lui iniziano a girare sempre peggio, in breve dopo i sette anni vi siete lasciati, allora tu cosa fai?
Riprendi il treno dei compiti e scadenze, te ne dai sempre di nuove, così ti tieni attiva, lontana dai serpenti che sparlano di te, e fai finta. Di crederle avvincenti, ti ci butti, studi per vincere il concorso direttivo, oramai la china paterna è di seguire, te l’hanno imposto senza tu lo cercassi, le sue orme. E lo fai, ingoiando il mugugno, intanto la leader storica del movimento femminile non ti chiede più perché non vieni a trovarmi, che potrei insegnarti come vincere la borsa di studio a Ginevra.
Però a Milano ci vai, non prima di avere fondato la casa editrice nuova, con la nuova amica e lì pubblichi, anzi fai pubblicare: per primo il fidanzato, così non sbagli a sentirti a pari con la coscienza, che tanto sai che tu conti sempre molto dopo gli altri, poi le scelte agionate: pubblicare Rosselli, Vicinelli eccetera. Ma poi infine te ne vai davvero a Milano, se Dio vuole, perché il concorso l’hai vinto davvero e sei fuori dalle scatole della famiglia, CHE C’HA MESSO TRENT’ANNI A DEMONIZZARTI CONVINCENDOTI CHE NE AVEVA UNA BUONA totalità di ragioni a trovarti una strega, e bruciarti ogni volta che ti rivedeva.
Ci vai, lo vinci, trovi casa, vicino alla Ripa Ticinese, in affitto, anzi affittacamere, da un signore siculo che ti spia in camicia da notte la mattina, quando fai la colazione, prima di andare a fare per l’ultimo anno la maestrina, e poi la direttrice, ma lì i tuoi si sono finalmente decisi a farti acquistare la casa, sennò c’era quell’uomo di mezzo.
Allora nella casa nuova, e tua, con un uomo giusto al fianco, con l’analisi a lato, e con le amiche che scrivono, oppure con te sola, eccoti qui finalmente ad iniziare la tua storia; di vita di donna, nuova, e tua.
Che insegna dirige scrive organizza ma soprattutto che può anche e finalmente scrivere.
L’autorizzazione, A VIVERE AD ESSERE QUELLA CHE VOLEVI.
IL lavoro diventano i lavori, tanti, a milioni, ma a te piace moltiplicare le responsabilità, organizzare creare: eventi soprattutto, relazioni, farli parlare con te, ad alta voce fra di loro, i poeti, gli intellettuali; farsi e farli AMARE, SCONTRARSI, PENSARE, CONTRADDIRSI.
TUTTO QUESTO TI ACCENDE DI PENSIERI NUOVI, e ti stanca anche infinitamente. Poi, cominciano ad entrare in relazione nella tua vita anche loro, le donne tue somiglianti: Eccole là, spuntare come menadi prima del movimento, poi le donne in poesia italiane, come sorelle ginestre, ginecei ambulanti.
Una invenzione pura. Nessuna meno di una artista desidera confrontare la propria SEMPRE DISCUSSA grandezza con le altre, ma tu lo fai ci credi te lo imponi, lo fai credere alle altre.
Sai lo sguardo che affida valorizza la solenne confusione tra questione femminile e lavoro poetico? Bene questo pasticcio sublime ti intrica appassiona, fa sognare e fa correre la mente in quanto aura, atmosfera, rivendicazione dopo una negritudine, rifonda etica, è scum!
Ti fa nascere parole, idee, confini. Ti insegnerà confini.
Anche se è una tra altre, metafora di altre sintesi viventi, di altri destini che si sono incrociati in quel pugno di anni italiani, mani che si toccano sodali, voglia di rompere amnesie. Sole corrente, contro la corrente.
Poi, furono gli anni della onnipotenza a fare da padroni: ideare, organizzare e curare festivals nazionali, chi te lo fece fare? Ma perché ti piaceva da morire, era coniugare il sogno al sogno, la tua vita al fare creare relazioni anche letterarie nuove, o ti illudevi. A partire da te, da dove ti eri trovata a nascere, da quale fianco della vita.
Però, ti dici, è rischioso: sono tante grandezze sovraesposte, non si rischia di confonderle?
Ma è per eccesso del silenzio che le precede, forse. In un universale vero, fianco a fianco sarebbero stati sempre uomini e donne, artiste con artisti.
Ma storceranno il naso diranno, è ghetto, è offensivo. Pretendono dipendono, ti reclamano poi si eclissano, preferiscono la cosa tradizionale, dove c’è autorizzazione normativa, realtà istituzionale, ti sono però devote poi oppositive, poi tradiscono si sentono, loro, di tradire qualcosa che ha a che vedere con l’ordine costituito, il proprio nome e posto riconosciuto, dato. Ma si divertono anche, e te lo dicono scrivono, corrono al pensiero della successiva antologia ed invito, se lo prendono e come, quello spazio a lato, quell’antefatto mai goduto. Delle singole e delle estranee, come le chiamava la Woolf.
Le analisi non mancano, anche se non disegnano una mappa critica soddisfacente, ma non la volevi, ne avevi parlato anche con Porta, niente “alternativa” all’universo letterario, semmai alla parte mancante muta, il pathos che sostiene, le idee corali di un gruppo intellettuale; sei sempre tu però a tenerle a mente, non ti faranno lavorare in gruppo anche perché c’è fuga, già paura, diaspora.
E sul lavoro- lavoro? Perdi la voce, la serenità, ti attaccano dentro e fuori la scuola, sei andata al Costanzo, non dovevi: esibire il tuo status di operatrice donna sola, intellettuale che ama lavorare, ma soltanto nella libertà di non renderne conto,( non sei efficiente e non ti aggiorni sul mestiere, non ti era mai piaciuto fare il burocrate perché non vi eri nata), allora, che fai? Ti dimetti dal ruolo direttivo, nessuno ti aiuta a trovare fughe in posti più rilassanti, dei comandi, ad esempio, fuori dalla “medina” permanente. Ti mancano le conoscenze, le raccomandazioni.
Sogni, incauta di metterti in proprio, sola e calma, a scrivere. Da sola, in casa. Già. Prima che si inventino le figure del free lance.
Come in un racconto della Bachmann, dove la donna che rifiuta il codice di prestazione si fa sorprendere semi addormentata a letto, ma emergendo da continuo sonno si finge in lucido tempismo, di condurre affari “come se” fosse all’esterno, nella realtà, per strada in ufficio, o sotto la pioggia camminando, telefona al suo uomo, impersona la vita normale.
Non volevi soltanto ribellarti però, dopo poco assaporato il letto accidioso, vuoi davvero tuffarti nel regno dei free lance, nel campo della scrittura creativa per farne un lavoro vero. Nell’anno del pre pensionamento ti butti nella disperata ricerca di inventare di trovare, allora; e per tre anni si moltiplicano fioriscono scuole, corsi, seminari dove insegni, dove torni e insegni ancora, poi rilanci: e sempre a leggere e scrivere poesia, piuttosto che l’italiano scritto. Ai futuri laureandi ti lasciano condurre corsi istituzionali.
A volte ti pare sia davvero prestigioso, come fossi una normalmente inserita, non una fuggitiva, un’irregolare, come sei.
E ti lagni, come di ostracismo generazionale, del fatto che non hai più un posto fisso, non l’hai più voluto, ma lo hai pure snobbato ignorando la legge che, di ogni ambiente fa una catena di servitù concrete, se appena esci dal suo giro, ne esci.. Così col posto fisso, con le relazioni non coltivate prima, anche perché la famiglia a furia di anatemi, non ti ha insegnato affatto la pazienza, e l’ambizione, del perseguire un lavoro voluto, e che ti soddisfa, tuo.
Al bando eri, e al bando tu scappavi, circumnavigavi, al massimo trasgredivi, ti credevi libera.
Ad esempio non ti consentono più, dopo che sei andata in pensione, di curare quelle belle dispense sull’insegnamento di poesia tramite le rubriche per la scuola dell’obbligo, che per anni ti avevano appassionato. Le avevi create tu, l’ultimo poeta presentato, alla Fabbri, per i piccoli della scuola dell’obbligo: erano stati tra gli italiani, Vittorio Sereni, ed Antonio Porta..
Poi, la parte più bella viene, quando ti inventi mestieri nuovi, meticciati: come conciliare la retorica o gli incipit e topos della prosa occidentale ai futuri copy, come insegnare ad ingegneri, anziani, studenti, donne, le peculiarità dello scrivere in poesia e in prosa.
Inventi corsi e te li fai pagare, la domanda pareggia la offerta. Circolano idee, sono gli anni ottanta e novanta, iniziali.
A volte pullulano le offerte di lavoro, a volte inesistono. Per mesi non riesci a tirare il fiato, le ore del giorno e delle settimane non ti bastano a respirare, oppure il contrario, vivi in accidia e paranoia, perché nessuno più ti chiama.
Hai soltanto brevi scorci notturni o ritagli sui metro, per scrivere. La vita irregolare la danneggia la incalza con disgrazie, occasioni, raptus. Di nascosto di fretta sotto dettatura, la nascondi fra quarte di copertina e biglietti di metro; la mattina le ritrovi tra le pagine di libri e quaderni le parole, che saltellano come raganelle e non sai come imbrigliarle.
Le fai aspettare. Tasti gli estremi. Ti fermi, pensi di oggettivare.
Oppure pensi che ti eleggeranno amica, in benevolenza a quel vento nuovo, se ti arriva quel vento nuovo, oggi ne era entrato dalla finestra una brezza, hai provato a fermarlo con le mani.
Si è posato, come un passerotto invernale. Ti diceva cose leggere e care.
Come ti avrebbe avvertita, sai stare alla perfezione così, ore ed ore, ne sei condotta dal cerchio di parole. Poi, a sera, altre persone entrano, e sbattono le porte, portano parole cattive e cattivi pensieri, le tensioni il cerchio inutile e malvagio del litigio, maledicente cronico.
I bambini invece hanno un buon odore. E si ricaricano con un nulla. Ti baciano e ti stringono le mani. Ti ispirano la vita, la motivano dal nulla.
Oggi, una mattina come le altre. Mi alzo e prendo il solito caffè, stavolta al ginseng.
Sara è già a scuola, ci è andata col suo papi. Ha dieci anni, quasi, fa la quarta ancora.
In pigiama resterò a lungo perché nessuno, pochi, mi telefonano per i lavori.
Eccoti nella Milano del precariato e dei non luoghi a rimuginare inutili sogni, se in Emilia tu staresti meglio, è chiaro che ci stai meglio, ma per vivere soltanto cioè inspirare luoghi chiese bellezza e natura viva, e curve collinari che non vedi perché nessuno ti accompagna, ma allora ne scrivi, essa ti fa ricordare, respirare passeggiare, nel mondo case come radici sostenere, tua madre intanto è morta, però, sette anni prima, e tua figlia era ancora treenne. Ma era da una vita che la ricostruivi, ora ce l’hai dentro in pace ti ci è entrata, e riposa.
E’ il padre l’osso ottuso ancora, che rimane a testimone del divieto a essere amata ad essere accettata in santa pace. (Mai avuto), non ti puoi illudere che con tutto farai pace, anche se ne avresti un gran bisogno, se ne avresti.
Ma alla metà mattina ecco i planing del giorno prima, del mese prima: inevasi. E le telefonate e l’invio stampa, perché l’hai scordato perché lo rimandi, cosa fanno quei libri buttati da (anni, mesi?) sotto al letto, solo perché non vuoi ( puoi) rispondere, e quei testi ammassati, pronti sì, lo dici tu, né editing né revisione, fuffa di polvere di cacca di gatto che piagnucola in cucina, ma al telefono ci vai pimpante, suadente, la cadenza si fa fresca emiliana, o lombarda, ma sorridi o annuisci, speri chiedi e non trovi o cerchi aspetti ascolti, taci e rimbomba, c’è un tale traffico lì sotto, perché la lamentela cresce allarmante non ce la fai più a dormire, a sedare, a staccare neanche all’alba neppure con le colazioni con latte e biscottini, e sedativi all’inizio dici beh, solo dieci gocce, ma dopo un’ora non le sai più, hai bisogno di spegnere gli interruttori e il rumore là fuori sbatte, motorette e ragazzini con gli orari happy hour ormai perenni da precari della fame, ma tutti trendy tutti per bene e noiosissimi eleganti che se la tirano, solo perché lavorano o ci aspirano ne parlano, ma era così Milano un tempo quando ci arrivasti, no, che non la era: brutalizzata la legge economica che impera e detta una legge sola, Mangia o muori, venditi e bene sei siete un esercito di giovani,variegati schiavi di questo mondo, modo che è solo del lavoro; come il giovane Carletto Marx aveva raccontato, mondo di merci balordamente sì, qua sotto casa mia, solo anoressiche top modelle e top manager ingurgitano gli happy hour del mezzodì di notte, l’happy hour è serale, ma sarà al stessa sbobba di spaghetti scotti e polpettine di cane, mah, chi sa com’è fatta la gente di oggi siamo mutati, eccome, eccoti lì alla finestra a riconciliarti il sonno, perché non se ne cura lui, ma neanche tu ti curi anzi, col vizio di curare tutti eccoti qui a rammendo, a free lance, a tedium vitae, a scartabellare appuntamenti, ma quelli di medici e analisti prevalgono troppo, è di lavoro vero che vorresti vivere.
Quello retribuito, come piaceva al nostro mix errabondo popolo erratico ed ebreo, non è così, ogni giorno lavorare allontana la morte, il tedio e i cattivi pensiero, ora basta.
Aspetta di riordinare meglio gli armadi le librerie, che tanto non lo farai. Da sola, hai detto non ce la fai.
6
Ma sola sei – sempre, anzi più che mai quando ritornano a casa i familiari, allora gridano o corrono, pretendono e tu sei tra il nervoso e inebetito vorresti anche tu l’attenzione, ma la voce che esce è stridula poco credibile, ridono vedendoti col maglione a rovescio e l’aria inochita, ma forse ti stanno chiedendo hai preso quelle brutte pillole per dormire? la casa la figlia i mestieri il telefono la scrittura parcheggiata lì sotto, fra la fuffa arrivare come l’armata a cavallo fare capolino, tu sorridi tieni i due cordless in mano.
Alla sera stai zitta però hai la testa vuota un ronzio al cervello ti appresti a fuggire di nuovo nasconderti, non ti trovano così, nessuno mai.
Solo a notte ti premi sotto al cuore dove pulsa dove non tace dove brilla. Ma è stanchezza o è euforia, è angoscia che cosa è che ti fa sentire l’operaia della casa miniera dove custodisci nascondi menti tradisci taci ti torci le dita perché in nessun posto vorresti essere tranne lì, non ci vorresti ma potresti, le tue idee si accavallano confondono e chiudono ti mancano.
Scappare, lo so. Le donne che non mettevano la testa nel forno volavano dentro ai fiumi all’alba, o si lasciavano appendere come palloncini dopo avere scritto gli ultimi versi col carbone, come sogni. E’ là, da quei balconi, dove appesi calavano i vivi, le loro parole come da palcoscenico come dal suo teatro, ecco la soccorritrice notte, avvistarsi silenziosa, psst, psst, a zampette di gatto passerotti passetti passeggiare dentro al cranio leggeri e innocui, leggeri e innocui, “i sogni i sempreverdi.”
5)All’indomani del venerdì’ di passione prese il coraggio, si cambiò uscì comprò un tailleurino nuovo inforcò gli occhiali si decise: doveva lavorare. Seriamente e fisso, così la figlia i problemi forse per un po’ si fermano. Allora, il planing! Cercalo, poi riciclarsi progettarsi, collocare.
Mi piace lavorare? sì mi piace mi piace.
________________________
Un corpus nuovo di leggi splendide
Leggendarie leggi furono promulgate nelle fortezza sopra Parma, dal giovane marchese Manfredino dei Pallavicino che, appena quindicenne e già denominato“ il pio”, giunto a dimora e reggenza,promulgò subito specialmente le buone leggi per drenare l’acqua dei fiumi e dei laghi sottostanti, tramutandoli in energia.
L’energia veniva fatta discendere dall’alto delle colline bucate dai girasoli,
lungo il corso del torrente verde lucente del Baganza, per poi dividersi nella ruota che di lì a poco si fermava, esaudendo energia infinita in canzoni, di multilingue razze.
Eppure Parma la bella era colpita là lontano, quasi ogni anno da terremoti sempre più frequenti, ed anche il Duomo ne era stato ferito a morte. “La peste nera” poi, com’era stata chiamata, non cessava di chiamare vittime alle sue porte.
Nuove case in sassi e mattoni fiorivano nei borghi, dopo le case in legno e paglia, “l’aria che rende liberi”, parmense, attraeva sempre più gente e la popolazione si moltiplicava.
Il fossato che circondava Cò di ponte oltre il torrente fu allargato fino a barriera Santa Croce, poi si allungò ad est di Barriera Repubblica e a sud, fino a sfiorare Borgo Felino.
Il torrente dove Manfredino Pelavicino aveva amato sostare, nelle prime scorribande giovanili, erano ancora passerelle.
Iniziò così in quel tempo, la leggenda del vento riparatore:
verso sera con lo spirare del vento, la ruota incominciava a girare e spandeva nel corpo della vallata innumeri profumi e calmi, dai campi d’erba medica e di fieno tagliato.
Dalle colline, quelle brevi colline, si annunciava uno schiudersi rantolante e festoso delle case, dalle cinte murarie basse, a cintura.
All’imbrunire, nessuna notizia aveva raggiunto ancora la contrada di Ramorino. Fu così che si propagò la leggenda del vento riparatore (che inutilmente andava) tra città e campagna, ogni giorno in cerca di messaggi pacifici e di sognare rivincite contro la contrada di Parma.
Vento che doveva portare con sé il suo nome, pieno di voci estranee alla guerra, di trovatori di donne e di bambini, in quella lingua dura dei vinti.
“Per creare mi sono distrutto”, affermava volando a bassa quota lo spirito del tempo (dei venti), che muoveva la ruota della macchina mulino,da lui promossa a simbolo del reame.
“E per creare non ho più potuto dipingere: queste campagne, le luci basse giù in pianura, le file bianche di strade divaricate a “u ”, la nebbia porosa piovuta da matrice caliginosa a fontana, che usciva dal buio verso sera, o all’alba.
Ed ora aspetto, aspetto di sapere dalla bocca della gente del paese, nelle donne curve da faticosa cura della prole, con le ciabatte spaiate sotto il tavolo, in quale terra vogliano vivere in che regno, e pace”. Dei loro figli pronti a rubar soldi, a nottate brave sottratte alla cura dei vecchi, intorno al desco serale, e pronti alla truffa, senza potersi aspettare da loro più nulla di buono.
“Sono stato un altro, per molto tempo (dalla nascita e dalla coscienza):
e mi sveglio ora in bocca al ponte, affacciato sul fiume, su questo rudere che stende poi stabilmente la sua ombra e defluisce, dall’alto monito e baluardo, castello di un dio sognato.
Ma la villa lontana mi è sconosciuta, le strade nuove e le malattie senza rimedio. Aspetto dunque, affacciandomi sul ponte, che passi la verità e che io mi ristabilisca sul fittizio.
Così come lavano il mio corpo, dovremmo lavare il destino”.
Per pulizia – pensava – e guardava la villa là lontana, quei bagliori sensuali del divieto.
E in quel momento la villa diventò grande e minacciosa, e dominata da ottuso spirito ferino: la bella Parma, dicevano gli amanti cavalieri della notte.
“La belle!”, chiudeva tardi il dito nel libro, Manfredo, la sera.
Come parlasse di un’amata lasciata a sorpresa. Ma la forza del vento la dileguava e per sempre confidando per lui, ne spostava i confini: dal letto del fiume e nella piccola Ramorano, indicando lo stemma alto come una campanella offuscata. Nel suo nome, la valle scandagliava.
Si ripeteva sempre l’eterno duello tra la città del “crepacuore”, nome dell’antica villa guelfa parmense e la vicina ghibellina Salso.
Come fare volare quelle canzoni allora, recitate e narrate, di volgo in volgo ma non trascritte, se non poteva più trasmetterle, da amanuense musico, dedito alla scrittura?
Un corpus nuovo di leggi splendide
fu pensato da lui nelle notti piene di una luna bianca in chiarore sopra la vallata, un corpus nuovo di leggi splendide per il popolo che doveva riprendere coraggio, e annunciare così umanissime speranze al mondo, fuori dalle fazioni intrise di un’offesa senza più legge umana.
La prima legge, chiamata del cantore naturale, denominava più potente e fortunato, prediletto del sovrano, colui che avesse inventato canzoni somiglianti al mormorare del fiume in correnti.
Cantore della natura, ma in una lingua umana che sapesse imitare alla bisogna il fischio degli uccelli, o il ringhio dei lupi alle porte della villa, o i silenti flauti dei pesci, presi prede dalle correnti del fiume.
La seconda legge, o della misericordia, che la discendenza garantiva nome e patrimonio anche ai figli naturali, ma per eletti meriti di prodigalità, verso poveri o vecchi.
La terza, o dei medicamenta, che giovani e donne potessero rivestirsi in mestieri, sempre nelle contrade del Baganza, Soragna e Busseto, per quei particolari poteri che già possedevano, come quelli di curare e di far tornare a sorridere, di insegnare gli alfabeti in volgare e il cantare, oltre che in chiesa, nella pubblica piazza, e di non esser più denominati streghe o stregoni.
La quarta legge, della guerra all’iniquità, che fossero proibiti e solennemente castigati tutti quegli atti di iniquità palese verso gli inermi e le persone sofferenti, nello spirito o nel corpo.
La quinta, della beneficenza: che il pubblico denaro o le private ricchezze potessero equamente essere distribuite ai poveri, nel grave bisogno seguìto a guerre o carestie, secondo ordine d’età e di povertà, così come già i francescani e altre congreghe avevano praticato.
La sesta legge, o della pace, che la rivalità con Parma ormai cessasse e venisse dichiarata scaduta in eterno.
La settima, o del ravvedimento, che la gloria di Dio si potesse cantarla anche nei quotidiani ed umili mestieri, come espressione del pentimento dei peccati o dei delitti al posto della decapitazione, e come pubblico esempio di virtù.
Con questo decalogo scritto, ancora caldo di penna e con la pena nel suo cuore, sopra il letto sfatto, si addormentava tranquillo dopo le notti insonni, nell’alto del felice castello di Ravarano, il marchese pio Pallavicino detto da tutti, Manfredino il poeta. Il proponimento nato dalla contemplazione dell’oscillare della ruota e dalla visione del vento riparatore, era affidato a quelle amate carte, esili nelle segrete.
La teoria dei quattro elementi non era bastata a giungere in soccorso, ma ricercava figurazioni allegoriche che decantasse il suo sogno, diffondere il bene sulla terra, traducendo dal moto delle ruote nuove leggi terrene.
Forse nel sogno alchemico era celata una legge che parlasse della trasformazione segreta del cuore dell’uomo verso la pace. Ma la visione sempre più cristallizzata gli procurava immagini su immagini e canzoni mute, senza vi si scorgesse il segreto principio della natura duplice dell’uomo, dove corpo e spirito volgono insieme, secondo lo spirare del pensiero.
Fu in quegli anni che, nelle campagne parmigiane si riprese ad udire il grido dei frati flagellanti, poi dei nuovi francescani, “Penitentiagite ! Penitentiagite!” Oh, pentitevi!
Ci sono ruote pensava, che l’acqua fa girare, e questo evento produce preghiera,
che rende stabile l’universo. L’unico compito dell’uomo è di far sì che le ruote continuino a girare, perché se si fermassero e cessasse il loro influsso benefico, l’universo cadrebbe preda del caos.
Se il mistero del verbo fatto carne restava muto, era perché mancava l’esperienza dell’amore con Dio, e quest’esperienza doveva sortire dal dogma trinitario per nuove voci. Tale Guglielma di Boemia, a Milano stava predicando con le stesse parole, senza conoscersi gli uni, le altre.
Cercava nuove liturgie, che il moto della ruota potesse sostituire le preghiere degli umani, poiché essi non erano capaci di salvarsi da soli. E che tali ruote divenissero motivo di raduno e i preghiera.
Fu così che lo si vide divenire vecchio e solo, alla ricerca di un’illuminazione.
Mancavano tre anni alla sua morte, ed egli quietamente la attendeva; e mancavano tre leggi al compimento del decalogo affinché volgesse al fine la sua esistenza nelle tavole del bene, leggi nuove per il popolo in così forte mutazione.
Un corpus solum piccolo e segreto, spinse il pio Manfedi a cercare quei principi di non dividere quello che, dall’anima separato, essa rimane: solamente corpo, e materia. E così gli ultimi, araldici, comandamenti furono un bel giorno stellati a fuoco, davanti agli occhi aperti in pieno giorno, quando sentì afferrarsi al collo da una mano che lo ghermiva in largo giro di vento, e sussurrando piano per mano di lui, scriveva
l’ottava legge, o dell’umiltà: che il cuore stesso dell’essere tragga sua intima ispirazione nel volere essere, non per sé medesimi soltanto, quale volontà di potenza terrena, ma oltre sé nel voler bene all’altro, nell’amarlo a fondo, come precipuo del mistero trinitario, ispirato dall’amor materno femminile, come sarà scritto nello Speculum simplicium animarum, di tale Margherita Porete;
la nona legge, o della semplicità: che non si attenda più a creare società terrene ad alcun fine, là dove il corpo non collabori a specchiare in sé il compito delle anime semplici, e che la costituzione d’ordini sociali si proponga come predicazione e adempimento del Nuovo Regno;
la decima legge, o dell’armonia universale: che dette Società, in Comuni e Corporazioni diventino il crisma dell’armonia stellare conclusasi in Cristo, assumendo su di sé il disegno delle braccia spalancate e quelle del corpo ruotante, poiché tale ruota spinge in basso la concupiscenza del corpo corrotto e dei vizi capitali, e in alto gli aneliti dello spirito alla pace.
Spesso la gente aveva visto passeggiare quasi correndo, a testa bassa sul letto del Baganza, Manfredi e il frate, a mani chiuse dietro la schiena; alzare le mani al cielo, saltando sui suoi piedi con fare giullaresco, e Manfredi trasportato dalla carnalità di lui, sognare del congiungimento tra le gioie corporali e quelle spirituali, già covato negli occhi ma affidato ad albe di canzoni, e preghiere,
che sarebbe vissuto nel “corpus solum” di leggi splendide che ora brulicavano più chiare nella mente
Tragedia nella bufera, ultimo atto.
“ Nella chiesa di Fugazzolo, il 13 gennaio 2002 si sono ricordati quattro ragazzi morti assiderati nell’anno 1921, mentre tornavano alle loro case per trascorrervi il Natale, che smarrirono la strada. Nella notte la bufera non ebbe pietà per loro.
Erano partiti da Ravarano per recarsi a Graiana dove avevano la famiglia, due maschi ed una femmina di 12, 16 e 18 anni ed un cugino di 12 anni.
Giunti in località “la Vecchia” sopra Fugazzolo, morirono nel gelo travolti dalla bufera: era la notte della vigilia di natale e furono ritrovati soltanto il 13 gennaio 1922.
Ora i corpi sono sepolti nel cimitero di Fugazzolo.”
Si dice ancora oggi, nella rinata valle del Baganza, che il vento riparatore, con la morte di Fra Gherardo e una volta abbandonata la ruota a se stessa, avesse mutilato i suoi denti e impedito a sé di girare spingendola poi sotto la terra, come voragine-vortice che, nelle notti di pioggia o di neve attraeva chi ardisse posarvi sopra i piedi, calpestandola.
Sequestrate le leggi, interrotto nella ruota il moto del vento, e bruciati gli ultimi seguaci dell’amato Segalello, la riscoperta di tali leggi sarebbe passata attraverso un evento catartico espiatorio. Nel sacrificio forte, di vite umane e innocenti di fratelli impediti nel raggiungere, la notte della Natività, le loro famiglie.
Si narra anche che, entro la ruota sprofondata dormano ancora, come in sigilli astrali, i quattro amici formando un’aperta stella carnale, a compimento del corpo magico più tardi sognato, e disegnato, da Leonardo da Vinci.
________________________
Nord , sud
Un ramo di limone sì, era stato con un ramo di limone che se n’era tornata al nord, a Milano, dove viveva. Mentre girava la testa e si sporgeva verso il finestrino, per salutarlo e stringergli le mani, ma piangeva, e non poteva inviargli baci con la mano, lui rideva invece, rincorrendo per gioco l’automobile che la portava via, sapeva già come invitarla a quella lunga danza del cuore, cui si accennavano – i primi passi.
Quel ramo invece glielo aveva donato E., un giovane napoletano, dopo tre giorni d’amore improvviso, un’avventura, lei avrebbe pensato per disfarsene subito, mentre commentava con l’amica che glielo aveva presentato, ma scacciava le lacrime.
Aveva così conosciuto Napoli, prima mitica poi carnale, per la prima volta nella vita, “Alta ci accolse Napoli…” aveva aperto un incipit di poesia, scritta anni dopo, “palazzi come chiese sopra giardini…”.
Napoli era anche la patria adottata del cuore, così somigliante agli struggenti colori che scorrevano già negli occhi, fin dall’infanzia, quando sua madre, originaria di Castiglia, ne parlava strozzandosi la voce in lacrime che annegavano silenziose nelle alte pianure del nord, dove a soffiare era la noia indifferente dei giorni, scanditi dai ritmi sonnolenti del lavoro, da orari ricevuti e dal coprirsi dei corpi.
In quei rapidi giorni, tutta una terra mediterranea dorata, pulviscolare e aspra, sonora e ardente di odori fino alla nausea, le era entrata negli occhi; come un’eco forse della Spagna materna, da suoi racconti giovanili e mozzati, sul pericolo da lei vissuto in amori, e addii napoletani.
Ma intanto ora, negli occhi, come un nastro a moviola, lei ripeteva a ritroso t u t t o il rotolo di immagini trattenute che si liberava, si dibatteva, fuoriuscendo all’aperto: da Capodimonte collinare e austera, dove dormivano lei ed E., lussureggiante, calma nelle passeggiate come un monastero, ai Camaldoli boscosi sopra la villa, giù giù fino a Montecalvario, dove appesi sfilavano i vivi.
Il monastero di santa Chiara, masticato nell’ombra, e l’improvviso ritorno al traffico impazzito del Vomero o di Piazza Plebiscito, al planare ampio e scolpito del Maschio Angioino, al mare aperto il dolce e silenziato mare, con le braccia aperte come una madre spalancata.
Dalle pendici verdi e chiare sotto al Vesuvio, alla costa del litorale addensata di vita e luci, un golfo della vita, poi gli antri di Cuma intravisti mentre nasceva il loro gioco, tutto domande e sguardi, fino all’apertura greca del lago di Averno, navigato divorando insieme le fave fresche che lui ti aveva portato nelle mani; poi l’emozione di rovine, in sogno, ad Ercolano e Pompei, e la navigazione a Panza, sotto le sorgenti solforose, per ripartire fino ai fiori bianchi di Procida addormentata sul porticciolo povero, per terminare in coda, dopo le tre pomeridiane, a mangiare pesce fresco a Pozzuoli.
1
Fino alle ultime immagini del rito quasi nuziale, dove tutto sarebbe incendiato, a Capo Miseno, loro due coricati, sugli scogli a contare le navi avvistate, figurarle come navi dei rivoluzionari russi del 1905; e poi la sera, di corsa dopo il primo arreso bacio, a consacrare l’amore nella visione di un film, come stregati riderne incoscienti, sulla didascalia: “Le giovani generazioni sono attratte dallo zucchero”, dove giovani innamorati, e nudi, Pierre Clementi tra i protagonisti, nuotavano si amavano, immersi nella cioccolata.
Un bagno pulviscolare nell’oro, una immersione dei sensi, stordente da fare venire meno la ragione, erano stati quei dieci giorni per gli occhi, per l’udito.
Ed ora passava al cupo dolore della perdita, mentre riandava alla bellezza sfrenata, a quell’allegria vitale colorata, che le teneva aperta la carne e spalancati gli occhi, a batticuore ne bagnava le viscere fino al tremare dei polsi, e le cambiava la voce gli accenti della lingua in sentimento, come la madre spagnola, le aveva insegnato cantandole canzoni, commuovendola.
La catastrofe ora, mentre il paesaggio autostradale, dopo gli ultimi pini marittimi tra il Lazio e la Toscana, cedeva il passo collinare vario ai più severi monti dell’Appennino, e prima di inoltrarsi nella lunga pianura padana, ecco ora – stava per perdere tutto questo, tranne che nelle mani in quel ramo aggrappato a lei, pungente acerba e aspra soledad che si spandeva, nell’abitacolo dell’auto.
L’amica aveva smesso di parlarle, essendosi accorta che non le aveva procurato un’innocua e piacevole ospitalità, ma innescato qualcosa di somigliante al duro viaggio, e ignoto, che ci attende nella prima storia d’amore.
Quindici giorni dopo, quando non aspettava e non chiedeva, non spiava più la luce del telefono, arrivò la prima lettera che chiudeva con un giuramento: “settecento chilometri non basteranno a dividerci, ti amo”; e con le mani, nel lacerare la busta confusa, spaventata anche, si trovava a scuola dove insegnava e aveva lasciato fuori i bambini, in giardino per rileggerla, e baciarla con la bocca, riudire bene le parole, ma era ancora soltanto febbre, un incubo un sogno all’aperto che non si svelava. Lui sarebbe salito dopo una settimana, installandosi a casa sua, di prepotenza e senza più badare a giorno né notte, essi vivendo ed amandosi esclusivamente di notte.
“Nous entrerons aux splendides villes”, era la loro lettura poetica manifesto.
Anche se lei, di giorno, doveva lavorare.
Quando tornava all’una, sempre affaticata dai suoi trenta bambini in età scolare, lo trovava, da poco alzato, che stava cucinando per lei, specialmente baccalà, ma più spesso assorto che filosofava, o le parlava dell’ultimo libro letto, usava prenderli in prestito alla biblioteca comunale della Guanda.
Lei assentiva, vergognandosi della sua vita monotona, meravigliandosi lui non se ne avvedesse.
Abitava sola da anni, dopo che aveva dovuto allontanarsi precocemente dalla famiglia.
2
A volte, quando uscivano a passeggio, lui iniziava a recitarle versi di Fortini, o di Pasolini, e amava deridere i gesti dei suoi conterranei, “il gesto attento, (come le scrisse nelle numerose lettere durante le separazioni), della socialdemocrazia”.
Poiché si sentiva di una razza eletta superiore, ed anche con gli amici parmensi, tendeva a non dare loro troppa confidenza, quando non voleva sedurli subito con lo sfoggio di citazioni e di una esperienza di vita che appariva subito cosmopolita, come quella buona, napoletana, con un’acuta ironia che lei non trovava imbarazzante, anche se un poco snob, leggera, da intellettuale.
Iniziarono i turni crudeli per vedersi, strappati al riposo, alle ferie, a finte malattie.
Spesso, quando non resistevano, si incontravano a Firenze, dandosi appuntamento a S. Maria Novella, più volte, a Roma dove E. era ospite dei brillanti redattori de “Il Male”.
Allora il mondo era continuo viaggio autostradale, ma l’innamoramento richiedeva letti e case più stanziali. Iniziò a mettere le amiche davanti al fatto compiuto di dovere allargare la casa, e le convivenze, fino ad allora femminili, spiegando loro che non poteva che venire a vivere da lei, E., quando saliva a Parma.
I lunghi inverni in cui lei sarebbe discesa a Napoli, erano segnati dalla lotta che intraprendeva contro il freddo, ma non osava parlargliene, o farlo pesare. Riempiva la valigia di ogni tipo di maglioni e collant di lana, e di aspirine. La bronchite la raggiungeva a volte, ma non era importante.
Abitarono a tratti, a Capodimonte, per poi fissarsi a Montesanto, dove lui divideva l’appartamento con un compagno medico, dai gusti raffinati, sottile, olivastro e schivo; la sua fidanzata, pittrice, prese a bene volerla. Ma E. lasciava grandiosi cesti della biancheria da lavare, inevasi, o non ricordava di fare la spesa, si comportava cioè sempre come un gran signore.
Le sue riunioni segrete, nel gruppo dell’autonomia operaia, erano nobilitate da letture colte e raffinate: Kleist, De Quincey, Blake, Foucoult, Derrida, e Nietsche, come si conveniva, allora, alla giovane intellighentia della sinistra.
Peraltro, lei aveva già adocchiato, e da qualche tempo consacrato a sé altre maestre: Luce Irigaray dal folgorante “Speculum”, dopo De Beauvoir, o Julia Kristeva. Ma sotto, preferendo a loro, i poeti, come Dickinson, Rosselli e Vicinelli, in questo scontrandosi con la formazione trontiana e negriana delle amiche di lui, napoletane, dedite a tristi gruppi femministi sul salario al lavoro domestico.
La sera, uscendo all’aria tiepida e satura dei vicoli, non si accorgevano, è vero, di quanto il sogno già si mescolasse, in silenzio, ad imminenti drammi della società civile e della miseria, italiane.
Tracolli di civiltà, dopo che di generazione, sarebbero entrati a forza, senza poterlo noi impedire, nelle esistenze di tutti. La meglio gioventù, o la meglio crudeltà, come fu detto.
3
Spesso ci si sarebbe chiesto chi avrebbe vinto, tra la socialdemocrazie del nord, come lui scherzava, o il respiro ansante e ciclico della terra del sud, dove ci amavamo.
Una mattina vennero a svegliarci, poiché si seppe che Pier Paolo Pasolini era stato ucciso.
Ricordo che dal letto, quasi nudi, lui iniziò a commentarlo agli amici. Cercavamo spiegazioni a tutto, non avremmo certo smesso di farlo in quella terribile mattina.
Era chiaramente un delitto politico, ma era di più, tutti ci colpiva, così sentimmo. Iniziò a recitarne i versi, a spiegarli agli amici. Fummo in lutto a lungo.
Per giorni e giorni non si parlò d’altro. Eravamo turbati.
Anche nei concerti pubblici, tristi avvisaglie di violenza entravano con i motivi musicali, di forza ci svegliavano costringendoci ad alzare il bavero, a chinare il viso, e ripararci dal vento.
Licola, e poi Parco Lambro, a Milano, dove avrei visto e toccato con mano lo spettacolo del rovesciarsi di un concerto nell’orrore, dal paradiso occasionale del lisergico di un popolo di ragazzini, all’alzarsi improvviso di un esercito di guerra fatta con le mani, con la vita, e il sangue.
Scappavamo in costume da bagno, senza capire.
Poi venne la bufera del servizio militare.
Né sapevo con quali guai antichi mi sarei battuta (non ero, non volevo – ancora, essere stirpe di drago).
Prima dell’esilio del servizio militare, tre viaggi ci avrebbero unito.
Nella Lisbona dei garofani, di Otelo De Carvalho, nelle isole Eolie visitate nel suo punto più selvaggio a Filicudi, e sullo Sciliar, in un Natale tristissimo e pieno di presagi per l’imminente partenza.
Il fatto che sempre sud e nord si mescolassero, nei nostri sogni e nella vita come sfondo scenografico alla nostra storia, rendeva difficile, negli iniziali anni della relazione, scommettere quale dei due – luoghi e destino – avrebbe vinto, mi dicevo; perché il corpo tirava verso l’insondato sud del cuore, ma la sua testa era infallibilmente nordica, nel vizio intellettuale.
Dal profilo alla Strinberg, come avrei pensato in notti inquiete, in cui l’aria oracolare e rigida di lui, che spiavo nel sonno, mi incuteva soggezione.
Troppo genio, mi dicevano le amiche, ed io per svincolarmi e mostrare che non ne ero soggiogata, mi ribellavo a parole, e nei fatti, iniziando una serie di contenziosi con lui per scagionarmi dell’essere già rapita e imbambolata, dall’amore.
Il sesso tra noi era quotidiano, e attraversato da fantasiosi, estasiati modi e mondi, i nostri, che dilagando sul presente, gettavano la loro ombra donchisciottesca su ogni piccola cosa.
Una felina e franca, delicata sensualità sembrava ovvia da sempre nostra, e piena del sognare ardente, panico, come la giovinezza vuole.
Un po’ invasati dal guardare in alto, hidalghi sul punto di sbarcare dalla luna o di salpare dal presente, mai abbastanza in fuga, per noi.
L’orgoglio di un’età giovanile che si sarebbe eternizzata nell’epoca, in un’aura collettiva che da sacrale dionisiaca trapassava al duro intransigente della mente, e l’ostracismo delle rispettive famiglie, assenti o ostili, era il rinforzo a coalizzarci verso il cielo, sdegnando forse altri passi, della pietà terrena.
4
Le amiche non ci chiedevano più dove sarebbe andata a finire questa storia: poiché lunga e aggirante, come il serpente della conoscenza, ci avrebbe seguito per l’arco della giovinezza.
La ripresa degli esami universitari, per me, la loro conclusione fino alla laurea, furono slalom nel canyon estenuante di studio e di lavoro, turni notturni, aspettative per salute, e cordate di donne che, in volontaria sorellanza, traversavano intanto come via lattea la mia vita, entrandovi di forza a vivere, comandandomi, insinuandosi e combattendo, come una repubblica indipendente e felice, delirante e legiferante su ogni cosa.
La mia vergogna nel nascondere quando fossi in realtà perduta, e bisognosa d’esserlo, per amore, doveva essere celata. La normalità, una pagina vergognosa.
Simpatie solidali, odio amore e convivenze, vicinanze e ideologie, amori saffici, vissuti come il verbo. Il sud, ancora una volta, mi avrebbe salvato, poiché la prima amica con cui abitai a lungo, e felicemente, era una donna del sud.
Dal pensiero e riserbo passionali, della terra di Puglia. E piena di una dolente e dolce, molto affettiva dignità; ci rispettammo, spontaneamente.
Fu comprensiva della mia condizione solitaria, e in balia del bisogno; insieme, appena i nostri fidanzati si allontanavano, ascoltavamo le musiche preferite, o si andava a concerti, anteprime teatrali, gustando come due studentesse, la libertà di singole e sorelle, senza cedere alla stoltezza.
A Natale con i rispettivi fidanzati, allestivamo un meraviglioso presepe napoletano costruito con veri angioli e pastori in gesso dipinti, del settecento napoletano.
Ci sostenemmo mentre tiravano arie di guerra.
Il servizio militare di lui, puntualmente venne, come un tornado.
Prima nei battaglioni punitivi a Capo Teulada, in isolamento, poi in quelli istriani di Udine, dove lui arrivò, insieme al terremoto. La reazione di E., per non impazzire fu di esasperare la segregazione del tutto: non avremmo più dovuto vederci né sentirci, scriverci o telefonarci, mi annunciò, con la consueta calma. Per non soffrire di contraddizioni, mi disse in un lucido delirio.
Ma io tenevo a lui le mani, contorcendole, e non si uccidono così anche i cavalli?
Quell’enorme, tutto quel fuoco, che ci legava ardeva nella carne e spirito, e niente più sarebbe esistito? Esisteva, ma lui avrebbe, e lo fece, rispedito al mittente: telegrammi le lettere ogni missiva.
Cominciò un lento impazzimento, che da lui a me, avrebbe contagiato.
L’amore che chiedevo, ridivenne rabbia, cocente umiliazione, senso di abbandono, ribellione, senso di angoscia, disperazione.
Gli amici che avrei ripreso a guardare, senza più scelta, luoghi dove aggrapparsi.
Un inverno, tutti capelli come la mia energia presero a cadere, ed io giravo con grandi foulards per nascondermi.
Un mese arrivò dalla Sardegna un pacchettino: conteneva una collana fatta a mano da lui di grandi conchiglie raccolte dal deserto, così sembravano padiglioni di orecchie del mare, cucite con robusto filo doppio bianco e grezzo. Poi uno scialle di lana a scacchi, rosso, blu e bianco.
Così, prima del suo secondo trasferimento a Udine si riannodava il filo, ed io vivevo, ancora.
5
Il disperato bisogno di rivederci, appena mi fu concesso, in una Venezia invernale, disfatta dietro angoli e portoni, al primo tocco, il desiderio nostro che si consumava, mi rendeva incinta.
In solitudine, e sapendo di non avere scelta, avrei abortito a ventitré anni, dall’uomo di cui ero follemente innamorata, ma che rifiutava, come l’ideologia gli predicava, il lavoro.
Mentre l’aspettavo lungo le scale di casa, annunciandolo con gioia unica, in abitino in fiorami di lana pre maman, le mammane erano già al lavoro, con la preparazione al valium, e io no, che non volevo, avrei gridato, accompagnata da un’amica, tutto il tempo.
Un dolore che mi schiacciò.
Tutto quel pozzo di abbandono e di dolore avrei dimenticato, finita questa prova forse, se non fosse iniziato il fatidico settantasette.
Avevamo sgomberato la soffitta, spesso E. saliva a studiare, o a meditare mi diceva, su un abbaino vicino al solaio, e vedeva le rondini fare il loro nido fra i comignoli, sui tetti.
Li disegnava in ghirigori strani, a matita, quei voli che sulla carta tornavano a segnare rotte, rivivere segreta africa, e lontananze. Tornava assorto, muto.
Non dicevamo ogni pensiero, ma si scorgevano come ombre lievi tra le pieghe della fronte.
Il delitto Moro, dopo le prime sparatorie ad altezza d’uomo a Roma, dove fu immortalato il gesto del ragazzino dal volto coperto e dalla P38 stretta in pugno, stava preparandosi, sancendo in me domande tra le più angosciose, sulla follia del labirinto dove era finito, o stava morendo di malattia mortale, il movimento iniziato nel ‘68.
Se tutto era concluso, e non per mano nostra ma fatale, se colpa così grave era stata consumata, perché non ripartire da un’altra, completamente nuova, città?
Provai a rilanciare la sfida: Milano era per me, per scelta di scrittura, che volevo ad ogni costo sganciare oramai dal nero della storia.
Ma per lui era Napoli, radice buia della pancia dove sentiva di dovere tornare come un profeta sconfitto, non ancora sconfessato, per proteggere, così credeva, i più piccoli, i terribili fratelli “indiani metropolitani”. E il castigo della storia attendeva..
Nessuna trattativa sembrò interessargli, il suo volto rimaneva tagliente sconosciuto, nel momento delle scelte, e qualcosa come un ordine duro della mente, me ne impediva l’accesso.
Si consumava lento e inesorabile quel nostro splendido di vita viaggio, dove “ si fecero unghie da inverni e spostamenti”, quando “la Bellezza ci sciolse la testa”.
E. prese ad appassionarsi, negli ultimi anni a letture dadaiste, leggeva molto Pound, volle stilare il manifesto de “la poesia idraulica” preparava mostre di arte povera, e le prime letture poetiche al Circolo Malombra; io, lavoravo per una nascente casa editrice, aperta dalla nuova amica, eventi che ci scoprirono diversie divisi.
Lui, aristocratico, e sperduto nel mondo letterario che non frequentava.
Io, in sordina, ma in attesa di uno sguardo che mi riconoscesse come poeta, lo avrei trovato, più tardi, in Adriano Spatola.
6
Cambiava spesso dimora E, non volendo più pesare sulla convivenza a tre, dove io lo avevo imposto; non legava più con nessun gruppo, se non con un amico alla volta, dove si fermava a dormire.
Si era fatto irritabile, scontroso, e silenzioso.
Mi apostrofava, sempre più spesso, con il dito alzato: Voi, voi che non potete più capire, additando una famiglia fantasmatica sociale alle mie spalle, voi nordici (e già traditori) sembrava accusare.
La passione sessuale si era piegata al vento avverso.
Cominciai a parlargli di un viaggio in America, che mi era stato proposto dall’amica, e che sarebbe coinciso con il mio compleanno dei trent’anni.
Speravo forse di obbligarlo a voltare la testa, dove tirava l’aria del cambiamento ormai avvistato, che vicino a noi toccava, correva. Un viaggio dove avrei letto con l’esattezza di un veggente quale futuro ci attendeva. ( Era stata studiata la tappa iniziale al Naropa University, dove conoscere i fratelli maggiori beatnik, e molto altro).
O di fargli intendere la necessità di una svolta anche fra noi, decidendo di rimetterci insieme ma per costruire qualcos’altro dalle tragiche illusioni cadute, un progetto di vita incentrato anche sulla comune passione per la scrittura.
O il destino, Dio solo sa quale, si sarebbe incaricato di mostrarci.
Ma la passione delle idee, l’ideologica indelebile visione della vita che si era costruito, più forte della vita stessa, gli faceva dire di no, con la testa. No, col cuore.
Non Milano. No ad altre letture del futuro.
Lui, mi chiedeva forse di temporeggiare? Non lo feci.
Due mesi dopo, in volo, dopo altri tristi tradimenti consumati, sentivo che un vento diverso mi chiedeva, nel pensiero e nel cuore, di ripensare la mia vita altrove.
Al trentesimo anno, con presentimento chiaro, avrei rivisto in terra americana le fratellanze i fili della vita, che fino a ieri ci avevano legati a un comune destino, allentarsi sciogliersi volare, via e lasciare affiorare la trama di un’esistenza nuova sconosciuta, poi pur sempre mia.
Il ritorno, nel settembre del 1982 sanciva tutto questo.
Mi ero invaghita di qualcuno, accettandone un incantesimo breve; lui, più seriamente innamorato, di una giovane donna di Napoli, legata al teatro e alla politica, della sua terra.
Con apostrofe e ammonimenti me ne confermava, dopo il racconto anticipatomi da amici, e togliendomi il bicchiere dalla mano che stringevo, Voi – tornava a minacciarmi – voi che non potrete mutare, sapete vivere soltanto nella socialdemocrazia!
Le volte, tutte quelle in cui ci saremmo rivisti, dove lo strazio o la passione risgorgava, come mai fosse stata troncata, avrei trovato le sue parole sempre più dure, inchiodate alla terra di Napoli, una fedeltà di cui, per il mio nord, non sarei stata all’altezza.
E le prime immagini di noi, a Positano, o di noi sull’Appennino emiliano, e di noi ancora in terra di nessuno, nel centro Italia o Europa in viaggio, mi risuonavano alle spalle come una campanella all’orizzonte, “dal basso tunnel promesse / i vivi altrove.”
“So come feci, tolsi / il cielo chiaro del mattino / dal suo mattino, presi il cipresso / dal suo cielo,
c o s ì che lo conobbi / i muri cantavano le lodi.”
Ed io, d’altronde, “devo parlarti della vite / e dell’ulivo / perché non li hai più visti”
___________________________
Montenera Lama, di China.
(Biografia immaginaria)
Nacqui il tredici dicembre del millesettecentocinquantasei, nel ghetto di Colorno, vicino agli alloggiamenti reali della corte di don Ferdinando dei Borbone di Spagna, e il mio nome fu scelto dalle cugine, più ricche e potenti, di mia madre China. Fui infanta fortunata, perché nascendo nel mese di dicembre, a causa del freddo intenso che si vive nella bassa padana, fui affidata alle cure della grande segnora curandera, che faceva la balia a corte, e le prime luci e colori furono quelli della magnificenza della corte del re.
Don Ferdinando amava proteggere e circondarsi di una moltitudine di fedeli cortigiani, perché divenissero con lui la “clara llama”, come ebbe a proclamare un giorno parlando di tutto il popolo di Corte, dai ciambellani ai giardinieri ai cuochi, ai soldati alle dame di compagnia, dai precettori ai farmacisti del regno, dove altri ebrei e marrani, ormai cattolici praticanti, convivevano ricordando sempre i tempi della pacifica Spagna da dove erano venuti, Toledo e le terre della Castiglia, portando con sé, oltre quei pochi beni: vestiti, libri, strumenti d’oro e di laboratorio, stoffe, fogli di musica, i testi sacri della Cabala, e antichi strumenti per fare musica. E triste andalusa memoria negli occhi, di colline vulcaniche al sole, e di cicogne intente.
Mia madre China, potevo vederla nel sabato e, durante la settimana, nelle mattine in cui cantava alla Messa nella cappella della reggia di Colorno. Era donna di incomparabile bellezza, carnale e gioiosa nel cuore, dalle mani danzanti con noi bambini. Cantava per la regina nel coro della cappella reale o cuciva qualche costume per le recite teatrali delle festività. La sua voce era canto e la sua pelle suonava melodie speziate, il seno pieno e morbido odorava di avena, le mani erano piccole come i piedi, il naso deciso e altero, una piega improvvisa le serrava le labbra, a volte.
Mio padre non lo ricordo prima dei quattro, sei anni di vita, ma m’insegnò a camminare e a scrivere, spesso io lo chiamavo con nomi materni femminili a causa della precoce separazione dal corpo materno. Lo ricordo vicino alle prime istruzioni del precettore o ai riti, pochi e confusi dopo l’apertura del ghetto e la pubblica conversione.
Ci riunivamo, a volte, alle altre famiglie di marrani, capitati a vivere in quella contrada pacifica dove mio padre l’aveva sposata subito,assimilando gli usi religiosi e segreti della mamma in quella terra del fiume, dove la gente rideva e ballava con musiche all’aperto, un poco come noi, in Castiglia. Un giorno di questi, in occasione del Séder pasquale, China e Pietro sedevano con le sorelle, più vicini a me, raccontandoci la bellissima storia della fuga d’Egitto, sotto ai sette candelabri puntuti e, dondolandosi a lungo sulle sedie, riuscivano ad intonare certe nenie tristi e soavi da farci addormentare quasi tremanti, annientate da un vento semplice e profondo, che ci era proprio.
Dove soffiasse a poco ci serviva sapere, ma che era lì, a portata di mano, pronto a riprenderci in cammino, se un giorno avessimo ricominciato ad andarcene per il mondo. Viaggiare. Mia madre parlava e rideva ancora con noi nella sua lingua, ma alla presenza di estranei si affrettava a parlare uno stentato italiano, un po’ latino, come quello che in chiesa era cantato nelle messe domenicali.
Musica, poesia, diari di viaggio del fratelli Joseph e Pietro; storie di botanica e di erbe, antiche nenie, e libri stellari dove ogni lettera dell’alfabeto aveva pagine e pagine di fioriture ed ogni figlio battezzato della famiglia dei Lama ebbe nome dalle prime dieci lettere, come le dieci Sefirot, dell’alfabeto.
L’amicizia tra il nonno Pietro e GianBattista Bodoni, nella generazione successiva, sarebbe divenuta leggenda per noi ebrei di Parma, vanto e gloria dell’amicizia nostra con quel popolo, celebrate nell’amore della scrittura.
Ma il tempo danzava in fretta e mi ritrovai ragazzina, dalle trecce nere e gli occhi silenziosi come China, e le mani non si congiungevano più in preghiera. Conobbi l’amore e la gelosia, i torti ricevuti li rifeci, così le grandi tempeste dell’amore e piansi. Incomparabile e perduta, piansi senza rendere conto alle stelle del mio nome tradito e delle braccia chiuse.
Altre volte erano giovani sconosciuti sotto le mie finestre, a improvvisare serenate struggenti e dure, ma il tempo passava e gli editti francesi sopraggiunti alla dominazione spagnola mi portarono via dal padre e dalla dolce terra di Parma soleggiata. Tante lacrime piansi, ma il no dato a una piccola marrana rimase insondabile, non me ne interrogai più e partii.
La villa di Mediolano non parve così differente dalla piccola Parma, agli inizi, ma scintillante di promesse e sola e fiera, nella sua necessità di capitale. Quel duomo verticale e duro, quei vescovi, i primi proclami di nuovo contro l’usura e il prestito ai poveri colpirono quella parte di noi che là era salita per fare fortuna, e ci scontrammo con la durezza dei Gonzaga.
A nulla erano valse le lettere di don Ferdinando che ci aveva raccomandato come valenti uomini di corte, gli zii dottori in medicina, il nonno materno musico, con noi scappati per fare fortuna. Fummo arrestati e presi prigionieri, processati e costretti dopo pubblica abiura ad andarcene: chi a Ferrara, chi a Firenze. Parma sarebbe stata per un lungo periodo interdetta ai più di noi, e dimenticata.
Ma in fondo al cuore, quella zampa rosso bordata nera in campo azzurro dello stemma alto dei Lama che narrava “Transibo”, sarebbe stata l’unica bussola del ricordo del re Don Ferdinando di Spagna, che ci aveva reso nobili e amici del re.
Dell’infanta rimangono testimonianze di un ritratto da bambina, vestita di bianco e pizzo al battesimo, e delle canzoni da lei scritte e numerate coi titoli: “Nel viale semi spento”, “La luna che ride ancora”, tracce di una memoria da lei stessa sognata, della terra di Spagna.
___________________________________
Che queste pagine siano “prose”, o brani di romanzi, o segmenti di viaggi, di ricordi, di passioni vissute, di sperimentazioni fallite e poi lungamente e affettuosamente gestite dalla memoria, poco importa. Siamo di fronte ad un libro composito che non soffre comunque di fronte ad un possibile disegno di romanzo vissuto e di formazione, dove i due termini si sovrappongono perfettamente. Maria Pia Quintavalla giunge ai termini della propria storia con lo sparire e il riaffiorare dei ricordi, in un’atmosfera autobiografica che, se da un lato ricorda certe pagine di Anna Maria Ortese, dall’altra governa una scompigliata e irrefrenabile vena poetica, risucchiante il diario e gli amori vissuti (quelli letterari e non letterari), i viaggi e le soste, i desideri, una profonda e consapevole voluttà di vivere e di viversi, i rapporti familiari e infine una segreta pietà verso cose, luoghi e persone che il passare degli anni ha rivitalizzato fino alla fiamma dell’identificazione intera. Chiamare “prose” queste pagine è, dunque, una palese limitazione. Andrebbe bene, semmai, la definizione di prose di romanzo, là dove i due termini letterari si compendiano nel registro interno della confessione, in un alternarsi di voci (quelle lette e quelle solo ascoltate) che vanno, a un dipresso, da Fortini a Porta, da Zanzotto alla Dickinson, alla Rosselli alla Pozzi alla Valduga. Una bella confusione – dirà il curioso lettore. Sì, certamente, confusione: ma nel senso del come ci si accorge dei venti che girano intorno a noi, delle parole che mutano di timbro e di calore persuasivo e dei gesti che ti colpiscono e ti accarezzano.
Una vita intensa, quella di Maria Pia, già così ampiamente documentata sul versante poetico, persino – a tratti – invasata da una contemplazione furiosa, se è vero che “Troppo genio, mi dicevano le amiche, e io per svincolarmi e mostrare che non ero soggiogata, mi ribellavo a parole, e nei fatti, iniziando una serie di contenziosi con lui per scagionarmi dell’essere già rapita, e imbambolata dall’amore”. Ecco: il centro delle varie vicende sta in questa parola magica che accompagna l’autrice lungo tutto il corso del libro, cioè della confessione: dal ghetto di Colorno a Milano, da Parma a Milano, da Napoli ancora a Parma e alla sua provincia. Andare e tornare, quindi, che tesse un fitto velo di Penelope fatto e disfatto dentro lo stringente e intrigante struttura della poesia, dei posti e dei personaggi, Poiché questo libro è fatto di personaggi veri, anzi verissimi: il padre, la madre, i giovani amati, lasciati e ritrovati, i poeti soprattutto (uomini e donne) amici e nemici allo stesso tempo, fidenti e diffidenti, appassionati e indifferenti. Un “tutto” che precipita sul lettore occupandone ogni interesse, ora favola, ora esaltazione, ora rimpianto, ora irrazionale furore che si snoda dentro la storia degli ultimi decenni, libro di memoria che illumina il presente riconducendolo alla sua vera realtà: la “vita di una donna”.
GIUSEPPE MARCHETTI
____________________________________
Biografia
Maria Pia Quintavalla è nata a Parma, vive a Milano. Libri: Cantare semplice (1984, Tam Tam Geiger), Lettere giovani (1990, Campanotto), Il Cantare (1991, Campanotto), Le Moradas (1996, Empiria), Estranea (canzone) (2000, Piero Manni, prefazione di Andrea Zanzotto ) Corpus solum, (2002, Archivi del ‘900), Album feriale ( 2005, Archinto ), Selected poems, Gradiva N.Y. 2008, China, (2010, Effigie), I Compianti( Effigie 2013), Vitae, (2017, La Vita felice, 2017). Tra le antologie italiane: Trent’anni di novecento (a cura di A.Bertoni, 2005, Book). Numerosi i premi, finalista più volte al Viareggio. Dal 1985 cura Donne in poesia, e omonime antologie. (Presidenza Comune Milano 1988, Campanotto 1992 ), Le Silenziose ( Book City2013, 2015, 2017a Milano ) Muse, Autori, Resurrezioni (Casa della cultura Milano dal 2015, e continua). Ha curato: Bambini in rima / La poesia nella scuola dell’obbligo (Atti su Alfabeta 1987). Collabora a: Lettere, Università agli studi di Milano e di Parma con laboratori di scrittura. Tradotta in numerose lingue.



 Sono venuto qui a cercare una storia. Da architetto conoscevo i prodotti della Tecno, oggetti di un italian design che ha fatto il giro del mondo, da scrittore non immaginavo ci fosse alle spalle una storia familiare degna di essere raccontata. Una storia che ripercorre il novecento, descrivendo in maniera esemplare lo spirito imprenditoriale di questa parte di Lombardia, che ha fatto del lavoro una bussola esistenziale, una ragione vitale. A raccontarmela, questa storia, ci pensa Tommaso, che è venuto ad accogliermi sulla soglia di casa.
Sono venuto qui a cercare una storia. Da architetto conoscevo i prodotti della Tecno, oggetti di un italian design che ha fatto il giro del mondo, da scrittore non immaginavo ci fosse alle spalle una storia familiare degna di essere raccontata. Una storia che ripercorre il novecento, descrivendo in maniera esemplare lo spirito imprenditoriale di questa parte di Lombardia, che ha fatto del lavoro una bussola esistenziale, una ragione vitale. A raccontarmela, questa storia, ci pensa Tommaso, che è venuto ad accogliermi sulla soglia di casa. Tommaso mi apre la porta di casa, abbandono cappotto e ombrello e mi guardo attorno. “Questa non era la casa di Osvaldo”, mi spiega. Qui abitava Fulgenzio, il gemello omozigote. La casa è del 1944. Gli Arredamenti Borsani Varedo (ABV) viaggiavano a pieno regime, i due figli di Gaetano collaboravano attivamente col padre. Il giovane Fulgenzio aveva bisogno di una casa per la sua famiglia, a due passi dai laboratori. Osvaldo ebbe l’intelligenza di non riproporre per il fratello un oggetto radicale, come quello della Triennale, ma una casa che riuscisse ad essere raffinata e moderna, elegante e domestica. Quella che ora sto attraversando.
Tommaso mi apre la porta di casa, abbandono cappotto e ombrello e mi guardo attorno. “Questa non era la casa di Osvaldo”, mi spiega. Qui abitava Fulgenzio, il gemello omozigote. La casa è del 1944. Gli Arredamenti Borsani Varedo (ABV) viaggiavano a pieno regime, i due figli di Gaetano collaboravano attivamente col padre. Il giovane Fulgenzio aveva bisogno di una casa per la sua famiglia, a due passi dai laboratori. Osvaldo ebbe l’intelligenza di non riproporre per il fratello un oggetto radicale, come quello della Triennale, ma una casa che riuscisse ad essere raffinata e moderna, elegante e domestica. Quella che ora sto attraversando.
 “Sono circa dieci anni”, mi risponde Tommaso, “da quando la zia non c’è più”. Sento dell’affetto in queste parole. Tommaso Fantoni non è solo un architetto che mi sta facendo visitare una bella casa del secolo scorso. È anche il depositario di una memoria familiare. Non c’è angolo della casa che non sia luogo dove le migliori menti di una generazione si incontravano e dove contemporaneamente le piccole storie famigliari riprendono vita. Come nel giardino che sto attraversando, oggi sommerso dalla neve. “Qui”, mi racconta, “da bambino pedalavo in bicicletta avanti e indietro immaginandomi al giro d’Italia”.
“Sono circa dieci anni”, mi risponde Tommaso, “da quando la zia non c’è più”. Sento dell’affetto in queste parole. Tommaso Fantoni non è solo un architetto che mi sta facendo visitare una bella casa del secolo scorso. È anche il depositario di una memoria familiare. Non c’è angolo della casa che non sia luogo dove le migliori menti di una generazione si incontravano e dove contemporaneamente le piccole storie famigliari riprendono vita. Come nel giardino che sto attraversando, oggi sommerso dalla neve. “Qui”, mi racconta, “da bambino pedalavo in bicicletta avanti e indietro immaginandomi al giro d’Italia”. L’intera Varedo, che fu per decenni città-fabbrica, mi viene da dite “Tecno-Città”, cresciuta sempre più, sembra abbracciare affettuosamente questa villa suburbana ormai immersa nella enorme metropoli lombarda. E persino la neve, a ben vedere, mi appare come un dono del cielo. Prometto di tornare a visitare casa Borsani, a primavera, col sole e il verde rigoglioso degli alberi del giardino. Ma ora, sotto questa coltre imbiancata ho come la sensazione che la casa galleggi in un tempo sospeso, in letargo da dieci anni, in attesa di risvegliarsi, ospitale. Forse non più per accogliere i talenti che fecero la rivoluzione del gusto del secolo scorso, ma per aprirsi ai nuovi, giovani talenti che vogliono venire a visitarla, assieme a tutti i curiosi che desiderano imparare come ci si sentiva “a casa” quando, nel passato, si sognava il futuro.
L’intera Varedo, che fu per decenni città-fabbrica, mi viene da dite “Tecno-Città”, cresciuta sempre più, sembra abbracciare affettuosamente questa villa suburbana ormai immersa nella enorme metropoli lombarda. E persino la neve, a ben vedere, mi appare come un dono del cielo. Prometto di tornare a visitare casa Borsani, a primavera, col sole e il verde rigoglioso degli alberi del giardino. Ma ora, sotto questa coltre imbiancata ho come la sensazione che la casa galleggi in un tempo sospeso, in letargo da dieci anni, in attesa di risvegliarsi, ospitale. Forse non più per accogliere i talenti che fecero la rivoluzione del gusto del secolo scorso, ma per aprirsi ai nuovi, giovani talenti che vogliono venire a visitarla, assieme a tutti i curiosi che desiderano imparare come ci si sentiva “a casa” quando, nel passato, si sognava il futuro.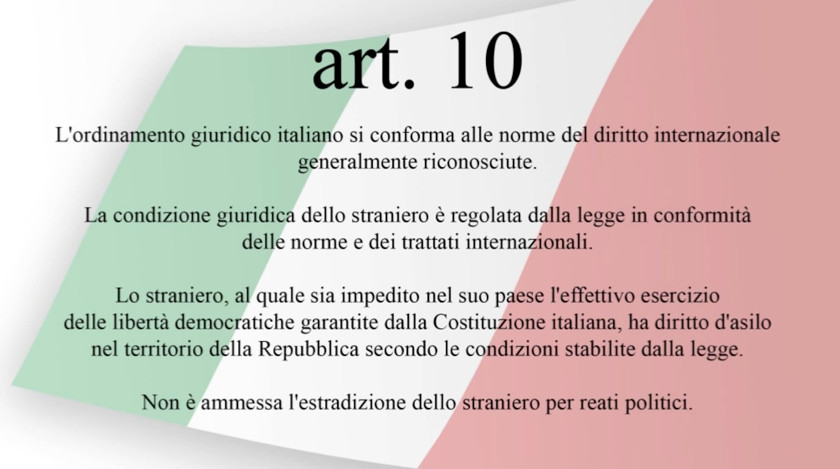



 Intervista a Bernardo Bertolucci
Intervista a Bernardo Bertolucci







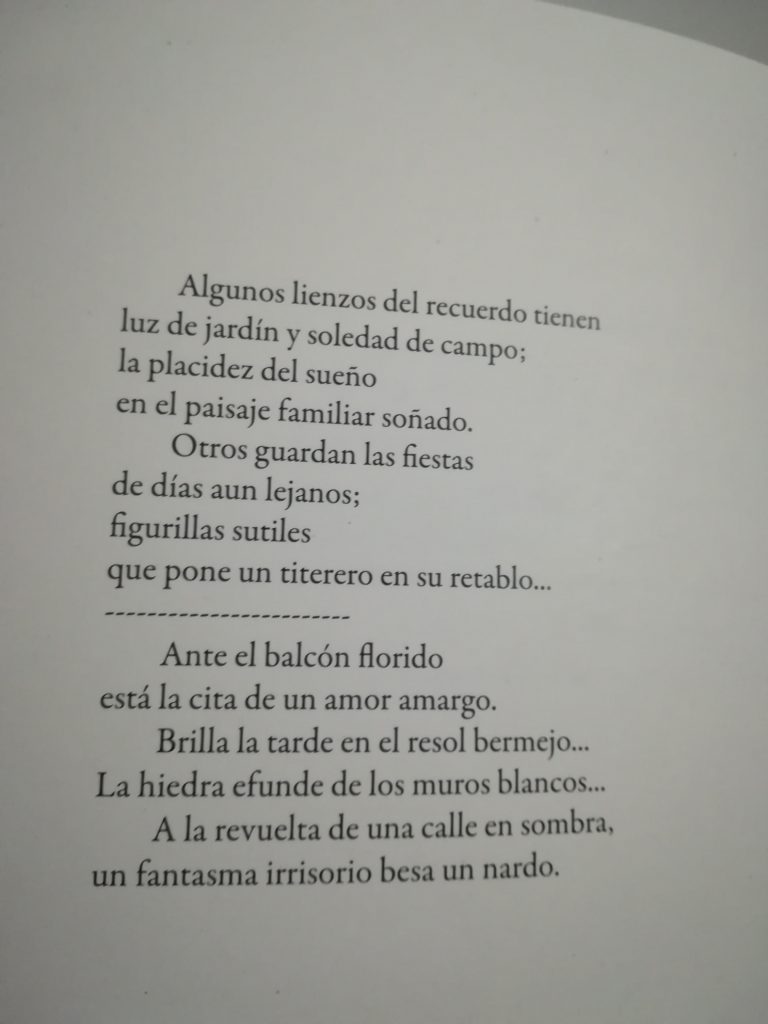
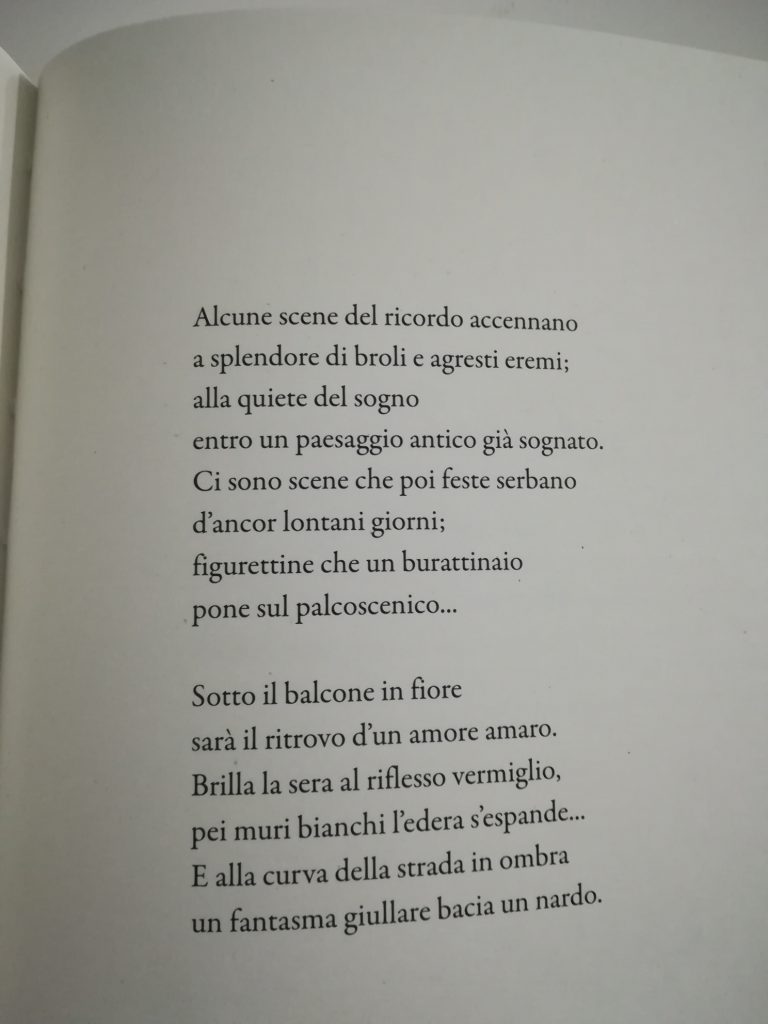




 Si definiscono lavoratori della cultura.
Si definiscono lavoratori della cultura.