di Vincenzo Frungillo
Nonostante la sua natura antologica Il luogo delle forze. Lo spazio della poesia nel tempo della dispersione segue un filone preciso della produzione poetica del nostro paese, qui infatti si prova a ragionare sulla poesia successiva agli anni zero con una precisa vocazione poematica. Questa tensione massimalista, troppo frettolosamente considerata minoritaria, è portatrice di un’esigenza specifica: lo spazio poetico non è più la sola espressione dell’io o la messa su carta di un’elaborata operazione linguistica, è anche il tentativo di dare forma alla prismatica esperienza del mondo. La sfida quindi non è assecondare la proliferazione dei segni, atteggiamento tipico della sensibilità postmoderna, ma tracciare una propria cosmogonia. Tale tendenza, detta genericamente neo-epica, non è un recupero inattuale della tradizione, pur mantenendo vivo il dialogo con gli archetipi della tradizione letterarie, essa invece prova in modo programmatico e consapevole a rimettere in gioco il senso del testo. Se la memorabilità dell’epica antica nasce all’interno dello spazio comunitario per scongiurare l’oblio causata da una forza estranea, oggi la dispersione è rappresentata dalla proliferazione indistinta e indifferenziata dei segni, ci interroghiamo sulla fine della poesia e in genere sulla fine della comunità letteraria, proprio perché ci sentiamo sopraffatti dal compiersi del destino occidentale tecnologico e ideologicamente nichilista. Il rischio riguarda la fine dello spazio della parola come depositaria di una memoria di specie, affrontarlo significa costruire opere complesse, ma rigorosamente strutturate, proprio come farebbe un architetto o un artista che lavora in relazione con l’ambiente che lo circonda. La forma testo diventa un elemento fondamentale da opporre alla disseminazione. A questo punto dovrebbe essere chiaro che se diamo per valida la definizione di neo-epica, non parliamo di poesia che evochi fatti storici trascorsi e appartenenti al passato, ma di poesia programmatica, volta al futuro, che ha però memoria della possibilità della dispersione. Ciò che dobbiamo recuperare nella parola è il rischio della perdita e quindi il problema del senso. Negli ultimi anni molti autori si sono cimentati con la composizione poematica, hanno abdicato alla scelta del frammento lirico o raccolta di versi, questa esigenza comune non può essere una mera coincidenza, di certo ci sono ragioni extraletterarie che hanno motivato questa scelta.
Il modo biologico dell’epos
In un breve scritto autobiografico Pagliarani ci ricorda che i modelli per la scrittura poematica in Italia, a partire dagli anni quaranta, sono per lo più stranieri, The Age of Anxiety di W. Auden, The Waste Land di T. Eliot e i Cantos di E. Pound; sulla base di queste nuove spinte, a riparo da equivoci formali nati durante il ventennio fascista, torna così anche nel nostro Paese la necessità di scrivere poemi. In Italia vengono pubblicati i poemetti di Pagliarani, di Giancarlo Majorino, La capitale del nord, decenni dopo, negli anni sessanta, Roberto Roversi, scrive Dopo Campoformio e Descrizioni in atto, Roberto Sanesi scrive L’improvviso di Milano, Giorgio Cesarano dà voce ai suoi paesaggi disperati e raggelati di Il sicario e l’entomologo, Ghigo vuole fare un film e i Romanzi naturali, Andrea Zanzotto realizza quello che forse è il suo libro più complesso, Il galateo in bosco, più di recente Antonio Porta pubblica Il giardiniere contro il becchino, Giuliano Mesa scrive Poesie per un romanzo d’avventura e Tiresia. La rinascita dell’esperienza poematica cerca una relazione possibile tra io e mondo, il testo diventa un raccoglitore nel quale definire i segni rilevanti di un’esperienza personale e collettiva. Il punto teorico da affrontare è la modalità di relazione con il mondo. Torna l’interrogativo sullo spazio ossia sulla abitabilità della parola. Abbiamo visto come la memorabilità, il corpo e lo spazio fossero tre pilastri dell’esperienza poematica antica, come in Elio Pagliarani fossero evocati per essere messi in crisi alla luce di nuove realtà teoriche e storiche, fino ad essere ridotti a flebile traccia; ora è possibile restare su questo passaggio seguendo le parole di Gianfranco Contini che aggiunge una significativa indicazione sulla commistione dei tre capisaldi antichi e sulla loro permanenza nell’esperienza poematica di oggi quando parla di “modo biologico”:
«Il segreto, di questo modo biologico di Dante consiste nella sua ugualmente intensa partecipazione, e addirittura nell’identificazione successiva con gli oggetti, perfettamente chiari alla coscienza.»[i]
La capacità percettiva del poeta è il mezzo che permette una poesia “locale”, ossia poesia degli spazi e delle concrezioni di realtà. Alla base di questa facoltà narrativa c’è l’equilibrio tra “lo stadio liquido e lo stadio solido della materia”[ii], non un’assoluta liquidità, cosa che porterebbe ad una spirale barocca dell’io che collassa su se stesso, né un’assoluta solidità, fonte di indistinzione dalla realtà, il rischio cronachistico del racconto. L’autore deve farsi carico, e risolvere formalmente, il contrasto tra il fluire degli eventi biologici, cognitivi, percettivi, e lo spazio condiviso, lo spazio simbolico o culturale in cui è calato. Si potrebbe aggiungere che le due deviazioni possibili si scontano nella poesia contemporanea con il biologismo, e di conseguenza con la retorica del corpo e della carne che sostituisce quella dell’io e dell’anima, o nella depressione della parola a favore del reale, il feticcio dell’oggettività o della realtà. L’equilibrio sta proprio nella relazione tra bios e mondo, tra temporalità del singolo e storia. L’intento critico di Contini è di riabilitare il poema dantesco, messo in discussione negli anni addietro dalla critica crociana. Croce aveva interpretato l’elemento descrittivo della Divina Commedia come una cornice, la struttura, o addirittura un limite della capacità lirica dell’autore fiorentino. Le descrizioni del “poeta divino” erano per Croce un momento di “pausa” dal suo magistero lirico[iii]. La grandezza di Dante sta invece, a parere di Contini, proprio nel saper unire la temporalità esistenziale, quindi l’intuizione, con lo spazio storico. I personaggi e i luoghi danteschi sono il frutto di questo equilibrio, sono il nodo in cui si innesca, si incardina il rapporto tra vita e mondo, tra vita e storia:
«La realtà su cui la versatilità e la disponibilità di Dante si precipita è storicamente sentita anche quando è eterna e ripetibile, tanto più manifesta allorché si scende verso le entità individualmente determinate.»[iv]
Stando alle indicazioni di Contini, Dante è riuscito a riscattare il singolo dalla caducità della Storia, allo stesso tempo però ha sottratto la Storia al pericolo della monumentalità. La temporalità del bios e della storia si attivano l’un l’altro nella relazione. In questo passaggio del testo di Contini si intuiscono ragioni politiche oltre che formali. Furio Jesi ci ricorda che funzione avesse durante il ventennio fascista la retorica del milite ignoto. Tra le due guerre il soldato senza nome diventa l’eroe della nuova collettività, la ricaduta politica di questo processo è evidente: le politiche totalitarie eludono il bios, la temporalità del singolo, per accomunare la collettività nella figura di un corpo anonimo, lontano nello spazio, privo di tempo, intangibile e per questo idealizzabile. Solo così la politica può essere trasformata in retorica, la tradizione in kitsch sublimato. Per questo motivo, ma non solo, tra le due guerra, i poeti italiani hanno guardato con sospetto alla grande tradizione poematica, hanno adottato misure poetiche volte all’ermetismo e, per così dire, all’economicità dei mezzi; si sentiva nei poemi della tradizione, nella narrazione in versi, l’eco della retorica mortifera dell’unità nazionale. Dopo la seconda guerra, i poemi della tradizione sono stati letti tutt’al più sotto la luce della nuova èra dei senza patria (Giorgio Caproni, Il passaggio di Enea). Scrive Jesi:
«Per la stessa ragione il cuore, il nucleo pesante, della Mostra della Rivoluzione fascista (1932-’35) era il Sacrario dei Martiri che recuperava al regime l’aura sepolcrale della retorica del Milite Ignoto, ma che nello stesso tempo per una carenza di stile e, se così si può dire, di temperatura mitologica risultava molto più un baraccone allestito con destrezza di coreografi, che il santuario o la cripta di una religione di morte». [v]
Del resto, già negli anni venti, il poeta russo Osip Mandelstam, nella sua stimolante produzione critica, sottolineava un aspetto del poema simile a quello messo in evidenza da Contini. Mandelstam parla della “chimica organica” di cui è fatto il verso di Dante, definisce Dante un “direttore chimico”. Nella Divina Commedia non esistono metafore ma condensazioni chimiche, tutto il poema è un organismo vivente che si fa narrazione, le terzine dantesche sono il camminare stesso del poeta:
«Perfino una sosta è una concentrazione di moto accumulato: la piattaforma d’una conversazione viene creata con sforzi da alpinista. Il passo –espirazione e inspirazione- è il piede del verso. Una falcata che deduce, vigila, sillogizza.»[vi]
Per Mandelstam il verso, la forma del poema deve misurare la materia e deve condensarla: il metro, la scelta formale, deve essere rigoroso perché la posta in gioco è la stessa relazione tra bios e Storia, è la forma che mantiene in potenza il rapporto tra temporalità e mondo:
«Dante non entra mai in singolar tenzone con la materia senz’aver predisposto un organo per agguantarla, senz’essersi armato di uno strumento per misurare il tempo che è trascorso goccia a goccia o si è liquefatto. In poesia, dove tutto è misura, tutto parte dalla misura, ruota intorno alla misura e grazie alla misura gli strumenti di misurazione hanno facoltà particolari, sono portatori di una speciale funzione attiva.»[vii]
L’Ulisse omerico è interpretato come il tentativo dell’uomo di afferrare il tempo in quanto storia, mentre la parte animale, il nostro limite naturale contrasta la sfera simbolica con una forza che possiamo chiamare filosoficamente alterità. La radice che richiama l’uomo al suo limite, non è più quindi divina o religiosa, non si sublima più nelle Idee, ma è naturale. Il rimando e l’equilibrio tra le due parti permette la scrittura e le dà potenza. In questo modo di può pensare di scongiurare le retoriche totalitarie del corpo idealizzato, di qualsiasi segno esse siano, anche la retorica a noi più familiare della virtualità assoluta dei soggetti sociali. È chiaro quindi che l’aspetto biologico, compresa la deteriorabilità dell’organismo vivente, è elemento consustanziale al mistero della parola. Il poetico è ricordo dell’incrocio di simbolico e naturale. Per questo motivo le pagine di Mandelstam e Contini valgono anche per lo scenario attuale:
«Nel canto di Ulisse la terra è già rotonda. È un’esaltazione del sangue umano, nel quale è contenuto il sale dell’oceano. L’inizio del viaggio è iscritto nel sistema cardiovascolare. Il sangue è planetario, polare, salino. Con ogni circonvoluzione del proprio cervello Dante disprezza la sclerosi, come Farinata disprezza l’Inferno.» [viii]
Nei personaggi del poema la storia torna ad essere con-divisa esperienza del tempo, la storia viene messa, per così dire, “sotto giudizio”. Leggiamo ancora nelle pagine di Mandelstam:
«Lo stesso metabolismo terrestre si compie nel sangue […] Il tempo per Dante è il contenuto della storia, intesa come un atto unitario e sincronico; viceversa il contenuto della storia è un con-tenere il tempo, un sostenerlo in comune da parte di compagni, co-cercatori, co-scopritori del tempo stesso.»[ix]
Dal punto di vista formale, la tendenza poematica degli anni del nuovo millennio non stabilisce un vero e proprio canone, perché la stessa forma-testo, il metro, la strofa e il ritmo, costituisce un mondo a sé stante, un mondo possibile. Anche se si parla molto di neoepica, di romanzo in versi, si cerca una definizione adatta alla tendenza, non direi antilirica (l’anelito lirico è presente anche in queste opere), ma anticonfessionale della poesia italiana più recente, sembra che la differenza la faccia il rigore con il quale l’operazione in versi riesce a creare un meccanismo complesso, chiuso in sé, ma al contempo allegorico. Qui, tutt’al più, si può solo attestare una esigenza comune che ha dato vita nell’arco di pochi anni ad una produzione diffusa di opere poematiche, di opere mondo. Si torna quindi a narrare con strutture forti e organiche, torna la necessità d’indagare la Storia, il tempo comune. Gli esempi da fare sono molteplici e ci si limita a segnalare alcuni dei più significativi della recente produzione italiana.
Ivan Schiavone, con Cassandra. Un paesaggio, ripropone il personaggio mitico-letterario, sventurata figlia di Priamo, sorella veggente di Paride ed Ettore, con una della opere più complesse e ricca di richiami del panorama poetico a noi più prossimo. Il testo, diviso in quattro parti descrive la visione della sacerdotessa destinata a profetizzare catastrofi, e a non essere creduta. Così il viaggio d’inverno (il Winterreise) della prima sezione, richiamo esplicito al libretto di Müller scritto per l’omonima opera di Schubert, è privo di una vera meta. Procediamo tra i versi a gradoni della composizione come se avanzassimo su lastre di ghiaccio franti o sul punto di spezzarsi del tutto. Basta leggere l’inizio di questa sezione per capire:
dopo che (dopo che
neanche una parola fu
se non rotta
dopo di che neanche una parola fu retta
serrata la porta che alle tue spalle
richiuso, imboccata la via
in indistinto sfuma il contorno preciso del tuo corpo e affonda
in un paesaggio d’ombre
dal mondo giunge un’eco labile
solo a tratti percepibile
come un brusio che piange
un rumore bianco[x]
La rinuncia al significante si traduce in un percorso di avvicinamento graduale ad un oikos irraggiungibile. Cassandra è la donna privata degli affetti familiari, privata della casa, costretta a girare il mediterraneo avendo visioni di catastrofi, il suo cammino non fa altro che rinnovare la misura della lontananza; questo movimento ad elastico circoscrive uno spazio in cui il topos epico e il tragico si uniscono ad una sensibilità del tutto contemporanea. Ciò che è in gioco nella composizione, più che uno sfoggio delle possibilità tecniche della poesia, tanto caro ai postmoderni, è la necessità di un disegno riconoscibile del mondo, diremmo un ethos, solo a patto però che questo termine venga colto nella pienezza del suo significato e si ricordi l’allusione del suo etimo al luogo in cui vivere. Schiavone reitera per l’intero libro le spezzature del verso tradizionale (esempio su tutti l’endecasillabo con l’accentuazione di quinta) per creare un paesaggio desolato, un paesaggio geografico, ma anche psichico, biologico e storico su cui noi tutti ci incamminiamo:
cos’è che in noi che fa noi s’è rotto?
che cos’è (le parole
che cos’è che rompe le parole?
si arrestano sulla soglia
e non entrano
perché sulla soglia?
perché non entrate e state
seduti sullo scalino?
quando passò lo sciancato
ma anche prima che lo sciancato passasse
le parole erano (anche prima che lo sciancato passasse
le parole erano rotte?
sì, le parole erano
anche prima
anche ora
e in mezzo
la soror mystica venuta con calzari fenici e con voce
(tu che ascolti sai dire se fu vera agnizione?
Viola Amarelli, in Notizie dalla Pizia, compie un’operazione poetica accostabile nel tema a quella di Schiavone, così come possiamo leggere dalla prefazione di Gianmario Lucini: “Il vero protagonista del testo poetico si rivela un ambiente sociale e umano senza tempo, quello di una civiltà che si muove molto più adagio di quanto rappresentino le scansioni storiche contraddistinte da date, avvenimenti cruciali e grandi eventi che in qualche modo formano e fermano il corso della storia per tappe e coordinate spesso arbitrarie. Questa narrazione in versi si svolge in monologhi: le indovine si presentano, raccontando il loro tempo ed esponendo il pensiero magico che attribuisce loro un ruolo, una funzione sociale, a prescindere dalle coordinate temporali e persino dalle loro stesse intenzioni. È, insomma, il mondo mitico-magico che crea le profetesse per una sua esigenza di stabilità volta a evitare la propria dissoluzione”[xi]. Scrive in uno dei prosimetri Viola Amarelli:
E anche dopo, quando tutto storicamente è finito, decaduto in siccità, niente è perso: benché nell’evidenza foucaultiana che di metamorfico e a tenuta perenne c’è solo il potere.
XXII – Finale di partita
Muta la fonte, desolato il tempio,
secco l’alloro
il dio, deo gratias, non abita più qui
chiusa la faglia rimane cicatrice
lembo d’orgoglio, demone nutrice.
Curiamo olivi, tenere le foglie
spremiamo i frutti per addolcire i gironi
alla brace rovente sotterranea
liberamente scaldiamo figli e cuori.
Più non sappiamo,
ci dicono i ricordi che nulla è perso
come mai nulla si perde, solo il potere
è trasmutato altrove dove ugualmente
nasce e, nel vivere, muore[xii].
I termini “faglia”, “cicatrice” rendono bene il confinare di mondi differenti, le stesse espressioni tornano significativamente nell’opera d’ispirazione eliotiana di Roberta Bertozzi, Gli enervati di Jumièges. Quest’ultimo è un testo esemplare per la capacità di porre domande al contemporaneo tramite una vicenda risalente all’alto medioevo. La storia è quella dei figli di Clodoveo II, colpevoli di aver cospirato contro il padre e per questo condannati ad andare alla deriva su una zattera con i tendini delle gambe bruciati. La simbologia del poema è già indicativa: il padre, il Re, che condanna i figli all’ignavia. La tradizione schiaccia, annichilisce[xiii]. Bertozzi scrive un’epica del rivolgimento[xiv], il suo dramma in versi suggerisce un ulteriore passaggio rispetto alla scomparsa dei padri e del corpo esemplare; qui i padri stabiliscono una tanatologica, vampiresca, relazione con i continuatori della specie. La forza cantata dall’epica degli anni sessanta e settanta ora ha una natura distruttiva:
Intorno non è la decadenza
fino a quando la faglia non prende a puzzare
e ci si chiede quale motivo, dove fa – tarlo.
Dietro il perimetro del labirinto,
dietro le figure-contorno stanno altri muri, altri nomi,
spesso altro e ancora
limo.
Difficile dire
quale carosello ci si pari davanti.
[…]
Heimat! Quanti ne mancano all’appello – quanti
nel repertorio dell’Istituto Luce ingialliscono trinciati
a tocchetti, a puntate, per le lame della moviola?[xv]
La decadenza non è tale fino a quando la “faglia non riprende a puzzare”. La faglia è la matrice temporale che il nostro organismo porta nella narrazione collettiva dei fatti. In questo incipit c’è un vero e proprio monito: “Quanti ne mancano all’appello?” Quanti vanno salvati dall’ingiallirsi della pellicola dell’Istituto Luce? Ci si perde gradualmente per “tocchetti”, “a puntate”: l’anestesia è l’indolore. L’interrogativo resta centrale.
Federico Italiano con I mirmidoni, poemetto d’ispirazione audiana, ambientato nella pinacoteca di Monaco di Baviera, appronta la messa in scena di una nuova arca russa (il riferimento è al film di Sokurov) in cui custodi del museo, giovani visitatori delle sale, e i guerrieri di Achille intrecciano le loro vicende.
Altrove infuriava la battaglia.
Rosenstoltz, il custode dalle cravatte cobalto,
tornò nelle sue stanze
e Maerten ordinò la pils pomeridiana.
«Hai letto l’articolo dello SPIEGEL sull’ambra?
Che roba! Due paleontologi tedeschi
Hanno beccato un geco,
tutta una testa ben conservata. Un buon pezzo,
più grande di un pugno. Resina pietrificata,
un indurimento di milioni di anni.»
«E qui torna il Baltico. Non ti dicevo che lì girano
forze strane, un magnetismo raro?»[xvi]
I calchi linguistici sono qui palesati come stratificazioni geologiche da cui emerge la voce del poeta e la scrittura è cesellamento di una realtà calcaria. Si fa ancora più chiara la poetica di Italiano nella raccolta L’impronta, titolo di per sé emblematico, che si apre con un traduzione dal Richard II di William Shakespeare:
E non possiamo dire nulla nostro
se non la morte e questo
calco d’infeconda terra che serve
da collante e da guaina alle nostre ossa.[xvii]
I codici e i miti del passato sono il calco che bisogna tradurre per sostanziare la nostra forma. Il dialogo con la lingua e la tradizione è qui presa d’atto della funzione originaria della parola, ma anche in questo libro c’è una doppia lettura, l’impronta è quella del padre, il testimone che abbandona il proprio transito terrestre per farsi voce in lontananza. Italiano ritorna sul lascito della tradizione antica e ritrae Aiace, l’eroe più solitario e severo della guerra di Troia, colui che rimane fedele ai riti d’onore, e lo raffigura sulle rive dello Scamandro mentre cerca la porta del tempo che trasbordi il passato nel futuro.
In verità, sono solo un po’ stanco,
respiro dal naso, seguendo l’onere
dei bronchi con riguardo quasi clinico.
Siedo su una panca di legno, alla destra
del fiume, dove biciclette e corpi
eliotropici striano la quiete,
mentre i volani perlustrano il verde
-topografia pensile
di una placida domenica e fragile.
Aiace è morto. Sono cinque estati
ormai che sono morto.
Come fuggono i vuoti
di bottiglia nelle mani degl’uomini
raccoglitori …
I sassi mi mancheranno – l’ottusa
resistenza della selce sul letto
dello Scamandro – e gli arrosti frugali
che precedono vittorie o disfatte.
Ma non c’è più spazio per chi arrossisce
a punture d’orgoglio: questo è il tempo
delle giustificazioni, degli alibi.
In verità, sono calmo e respiro
dal naso. Odore d’erba e di crema
solare: Aiace è morto.[xviii]
La poesia per dirla con le parola di Benjamin assume “il compito di intendere ogni vita naturale in base a quella più ampia della storia”. Così fa Alessandro Rivali, che con La riviera del sangue, titolo dantesco, e La caduta di Bisanzio cerca una soluzione messianica agli orrori della Storia, partendo dalle catastrofi antiche per arrivare a quelle a noi più vicine e per il poeta personali. In La caduta di Bisanzio fanno da soggetto poetico le città distrutte da catastrofi, Pompei, Bisanzio, Persepoli, Atlantide. Rivali attraversa queste vicende e con tono poundiano e traccia una linea verticale del tempo:
Raccontami ancora di Plinio,
l’ostinazione della scrittura,
la prua verso la scogliera.
Come avrebbe fissato i segni,
impressioni, fatti notevoli
e la fine giunta inattesa.
Ricordami la seduzione del fuoco,
il vortice dei vapori, il veleno
che serpeggiò tra le caviglie,
l’aria tramutata in siero.
Padre, adesso che non puoi,
riprendi il filo del sangue versato,
la danza macabra di Barcellona,
le lingue di fiamme dei rosoni
e la fuga dei Rivali nel ’36.[xix]
Verso Itaca[xx] di Daniele Ventre (pubblicato nel 2015), opera ambiziosa e mirabile per perizia metrico stilistica, racconta la storia di Telègono, figlio di Circe, alla ricerca del padre. La tematica del rapporto filiale è qui restituita con una prosodia che “tende a restituirci le sonorità dell’esametro “eroico” dell’epica greco-romana”, per dirla con le parole di Viola Amarelli.[xxi]Anche in questo caso l’ucronia mette insieme ambientazioni e tematiche classiche con scenari postmoderni, i videogiochi o le saghe fantasy.
Il poema per recitativi Cefalonia di Luigi Ballerini narra l’eccidio dei soldati italiani sull’isola greca successivo all’armistizio dell’8 settembre del 1943. Se si evita la monumentalità del ricordo, cosa resta? Ballerini mette in scena una commedia, nulla di quell’eccidio ha il tono alto della narrazione epica, assume piuttosto la modalità di una cronaca calcistica, come se la conta dei morti fosse il risultato di una partita tra Italia e Germania. Qui la storia, la violenza, la forza, il sangue, chiede di essere osservata, ma non si traduce mai in tragedia. Così recita una delle due voci del poemetto, l’italiano Ettore B. :
“l’acquisto del senso tragico da parte
di genti meccaniche, confinate per secoli al romanzo,
è l’opposto dell’insabbiare, azione creata per ribadire
che non è accaduto quello che non sarebbe mai dovuto
accadere”. Oggi specialmente, che l’uomo si evolve da
burocrate a faccendiere. Per la resa dei conti non resta
che aspettare la volta buona, leggere, senza battere ciglio
il bollettino di guerra dettato da un dio che si estingue,
vulgato dai più ricamati tra i capitali di una fedelissima
(inceppatissima) legione.[xxii]
Luigi Nacci, con il suo Poema disumano, compie un’operazione di metricizzazione della storia più recente, calando eventi tragici in un’atmosfera non dissimile da quella delle lasse di Ballerini. Anche qui c’è una percezione fonico sillabica degli eventi condivisi, una metabolizzazione della storia. Ciò che qui manca rispetto ad altre esperienze è l’organizzazione strutturale del poema. La cornice è la stessa cantabilità, fruibilità pubblica del testo. Diverso invece il discorso per il suo lavoro più recente in cui la fabula è il ritrovamento di un manoscritto in Sud America passato per le mani di ex-nazisti sfuggiti dall’Europa (Mengele, Priebke, Eichmann). In questo testo troviamo inni, canti e madrigali dei criminali di guerra. Autore della scoperta, della cura e della traduzione del testo è lo stesso poeta che qui compare sotto la firma Dott. Luigi Nacci. Anche questo espediente è il modo di affrontare un’interpretazione diretta con il male[xxiii]. Si potrebbero fare tanti altri esempi, come il Canto di una ragazza fascista dei miei tempi[xxiv] di Anna Lamberti Bocconi, un lungo poema confessione che dà voce ad una donna caduta nell’eversione di destra durante gli anni settanta; o La stazione di Bologna[xxv] di Matteo Fantuzzi testo che dà voce alle vittime della strage del 2 agosto del 1980 quando una bomba messa dall’eversione di destra in accordo con i servizi segreti fece saltare in area parte della stazione ferroviaria del capoluogo emiliano causando 85 morti e duecento feriti. Francesco Filia con il suo poema in frammenti La zona rossa[xxvi] racconta invece per lasse e frammenti poetici gli scontri tra manifestati e polizia per il G8 di Napoli del maggio del 2001, fatti che avrebbe anticipato quelli più clamorosi di Genova e che sarebbero poi quasi del tutto dimenticati dopo l’evento epocale dell’11 settembre. Proprio alla data simbolo della generazione a cavallo tra i due millenni è dedicato il lavoro di Federico Scaramuccia Come una lacrima[xxvii], che con grande perizia metrica ripercorre gli eventi dell’attentato di New York restituendo l’ambigua sensazione dello spettacolo della morte tanto caro a Baudrillard. La lacrima del titolo è sia la dolorosa compassione verso le vittime della tragedia che l’obiettivo della macchina da presa, così come viene chiamato nel gergo televisivo. Il metricismo ha la capacità di restituire l’ambiguità dei media, il sentimento tragico e luttuoso è restituito con l’alta precisione tecnica, è un dolore filtrato di secondo o terzo livello. In questa corrente di rilettura di fatti storici più recenti rientra il bel poema di Marilena Renda Ruggine[xxviii], un racconto a più voci sul terremoto che distrusse Gibellina nel 1968. Le voci dei testimoni, con accenti e complessità linguistica differente, formano le lasse del testo, il poemetto è una Spoon River meridionale con i toni mitici del Vittorini di Conversazione in Sicilia. Anche Novembre di Domenico Cipriano è un poema per frammenti incentrato sul terremoto che distrusse l’Irpinia nell’ottanta. Il testo ha una struttura interna meditata che asseconda una numerologia carica di senso, è lo stesso autore che ci dà i parametri per decifrarla: «ventitre poesie come la data del sisma, tutte composte da “stanze” di sette versi (poesie eptastiche) e un prologo di trentaquattro: l’ora serale che spaccò l’Italia: 7,34. Ciò accadde un novembre lontano ma sempre presente, da cui il titolo e l’introduzione di due versi (il numero corrispondente al mese di novembre)». Sullo stessa tema è lo scritto di Fabio Orecchini Per os[xxix], dedicato al terremoto dell’Aquila del 2009. Orecchini è più attento alla trama metrica e all’oralità dell’esecuzione della sua scrittura, la pagina diventa una partitura spaziale, una registrazione delle voci nascoste, che riemergono da una nuova faglia delle terra. Ma, aldilà dei più smaccati richiami alla storia, esistono altri esempi di scrittura in cui la questione centrale resta la presenza nel tempo condiviso, la presenza nello spazio. Così accade in quello che all’apparenza sembra essere un canzoniere d’amore, La divisione della gioia di Italo Testa. Il titolo del libro, oltre a citare il famoso complesso della scena new wave inglese degli anni ’80, allude al padiglione riservato allo “svago” per i soldati tedeschi durante la seconda guerra mondiale all’interno dei campi di concentramento, occupato per lo più da ragazze ebree. I due amanti protagonisti del libro vivono le scene del poema come se risorgesse da un perimetro di morte; tutta la narrazione, la messa in scena, è fondata sulla luce aurorale. Più che l’amore, il protagonista di questo testo è proprio la gioia, ossia il modo di guardare le cose, sapendo della loro fine. L’esperienza storica del campo di concentramento impone il modo dello sguardo sul presente.
o sulle poltrone in prima fila,
davanti a un sipario grigio
segui in allerta la scena vuota,
come una macchina nera in quadro
lo spazio deserto lo incornicia
In questo scenario la parola è mossa dalla vicinanza fisica all’altro e diventa un arto prensile appena utile a segnare i limiti del proprio ecosistema:
l’indifferenza naturale
appena ti ho lasciato torna,
emerge nel gelo animale
come una pelle mi contorna:
immune al mondo, freddo e ostile
striscio nel buio senza meta
con l’avambraccio irto di squame
uncino il fianco di una preda.
Lo stesso panorama disumanizzato tornerà nella raccolta i camminatori, una vera partitura modulare che riprende scenari urbani. Siamo ora all’esterno, lontani dalla camera che ha visto protagonisti i due amanti de La divisione della gioia:
camminano
rasenti ai muri
sugli autobus
si siedono tra i primi
non parlano
tenendosi le mani
si voltano
di scatto a un tratto
ti guardano
gli occhi grigi
campeggiano
poi scartano di lato
si alzano
serrando i pugni
e scendono[xxx]
Le brevi composizioni presentano soggetti denudati da qualsiasi connotazione identitaria che si muovono all’interno di un’ideale megalopoli. Il progetto poetico di Testa si chiarisce definitivamente come descrizione iperealistica del circostante, lo sguardo, la vista, è l’organo principale:
NULLA SUCCEDE PRIMA O DOPO
le sillabe sulle labbra
lambiscono le immagini
i segni nella mente
intersiano i muri
NULLA SUCCEDE PRIMA O DOPO
vuoto i vasi
e i pensieri maturano
lucido le foglie
e le foglie si staccano[xxxi]
Esiste una vera linea di scritti poematici che affrontano il problematico rapporto tra scienza e natura. Questi lavori allegorizzano la problematica relazione dell’uomo con l’ambiente. Nel poema Le api migratori Andrea Raos, attraverso la vicenda dello sciame di api assassine, parla dell’eccedenza della scienza ibridando i modelli classici sull’apicultura con un immaginario pop. Scrive Raos: «Nel 1956 alcuni membri della comunità scientifica brasiliana importarono in Amazzonia dall’Africa api di quel continente, più robuste, e le incrociarono ad api produttrici di miele, inoffensive, meno aggressive. L’obiettivo era rendere queste ultime più produttive dal punto di vista economico e industriale. Una terribile serie di mutazioni non volute produsse le cosiddette api assassine”».[xxxii] Il corpo debordante del testo è lo sguardo postremo che fatica a ritrovare un suo centro.
Non sarà certo questo disquilibrio
A trattenermi in vita-
Annuncia al contrario la mia fine
Puramente pura ed individuale:
in distinzione verso in distinzione.
Non così lo sciame.
Che pure muore, e finirà, dopo di me –
Soltanto un po’ più piano
I testi che sondano il limite del linguaggio in quanto limite della specie antropica sono soggetti di un nuovo florilegio a partire da Darwin[xxxiii] di Luigi Trucillo. L’eccezione alla catena evoluzionistica è una chiara riproposizione del senso profondo della poesia in quanto presa d’atto della legge naturale e sua simbolizzazione. Di certo la diffusa sostituzione della parola uomo con specie asseconda la sensazione di trovarsi in una fase epocale di crisi delle categorie umanistiche, in un grado zero fin troppo evocato in cui gli esseri forniti di parola si contendono lo spazio con le altre creature.
Accanto all’oceano
le specie
dimenticano in fretta
i propri ricordi.
La salsedine
stacca chele e membrane
come se fossero sogni,
unghie agitate
dal fantasma di un sauro.
Il sole batte,
ma l’onda è un mattino
o una notte allungata
da un ritmo
che mugghia i suoi inganni?
Il mio sguardo è spaccato
da strane libellule
come fossero nomi,
suoni sciamanti dall’acqua
che mi fermano il sangue:
può la scienza
essere aperta
fin dove la mente finisce
e poi aprirsi ancora
nel lampo, nella ventosa purpurea
in cui la visione si accelera
pulsando
in una scia di vapore?
Di nuovo
accade tutto così all’improvviso
da essere lento.
La sabbia spazzata dal vento
mi acceca,
mi penetra.
Stanotte ero estraneo
e oggi non potrò più diventare
un uomo
irrimediabilmente lontano.
Questo eccezionale libro di Luigi Trucillo ripercorre una sorta di biografia spirituale del famoso scienziato riuscendo a restituirci la complessità di una storia umana che cerca di darsi nella parola e con la parola una proprio ecosfera. Darwin viene pubblicato in Italia poco dopo Vom Schnee oder Descartes in Deutschland del tedesco Durs Grünbein che a sua volta scrive un poema epico sul filosofo Cartesio bloccato dalla neve nella città di Ulm. Anche qui come in Trucillo la biografia intellettuale di un filosofo serve per ragionare sugli strumenti umani e sulla possibilità dell’uomo di afferrare il mondo. Da prospettive diverse, si mette al centro di un poema la complessa relazione tra individuo e ambiente. Dopo l’importante opera di Trucillo arriva quindi il poemetto di Bernardo Pacini La drammatica evoluzione[xxxiv], che fa dei Pokemon, creazione fantastica e mitopoietica di origine giapponese, allegoria della rottura della linea consequenziale dello sviluppo creaturale. In questo stesso topos andrebbe forse letto il testo di Lorenza Mari L’ornitorinco[xxxv] che, con una chiara ispirazione filosofica tra Eco e Kant, pone la poesia sul piano delicato, ma decisivo, del linguaggio in quanto finzione. Questi esempi, anche se non hanno sempre una cornice unitaria che gli dia statuto di poema, sono di certo opere a tema, portatrici di una visione del mondo.
NOTE
[i]Contini Gianfranco, Un’interpretazione di Dante, pubblicato per la prima volta nella rivista Paragone nel 1965, ora in Un’idea di Dante, Einaudi, Torino, 1976, p. 98.
[ii]Ivi, p. 72.
[iii]Ivi, pp. 73-75.
[iv]Ivi, p. 99.
[v]Jesi Furio, Cultura di destra, 2011, Nottetempo, Roma, p. 55. Le conseguenze di questo processo Jesi le indica nel saggio Il linguaggio delle idee senza parole, in Cultura di destra, op. cit. , pp. 158-159, dove tra l’altro dice a proposito delle celebrazioni massoniche della poesia di Carducci: «Così si estenderà il più possibile il numero degli italiani che avranno come cultura il rapporto con un mucchio indifferenziato e sacrale di roba di valore, che è il passato della patria. Essi stessi diverranno sempre più culturalmente indifferenziati, massa, e un sacramento tipico di questa comunione con il valore indifferenziato sarà poi tutto il rituale culto del Milite Ignoto, significativo anche per il fatto preciso di porre implicitamente la coincidenza tra quell’anonimato e la morte.»
[vi]Mandelstam Osip, Discorso su Dante, in La quarta prosa, Editori riuniti, 1982, Roma, p. 124.
[vii]Ivi p. 126.
[viii]Ivi, pp. 139-140.
[ix]Ibid.
[x] Schiavone Ivan, Cassandra, un paesaggio, Oédipus, Salerno, 2014.
[xi]Lucini Gianmario, Prefazione a Notizie dalla Pizia, di Viola Amarelli, LietoColle libri, Milano, 2009.
[xii]Amarelli Viola, Notizie dalla Pizia, LietoColle libri, Milano, 2009. Accostabile per ispirazione all’opera dell’Amarelli è anche il poemetto di Luigia Sorrentino, Olimpia, Interlinea, 2013.
[xiii]Bertozzi Roberta, nel risvolto di copertina del suo libro, Gli enervati di Jumièges, PeQuod, Ancona, 2007, scrive: «Nel suo significato originario il termine “snervato” indicava qualcuno a cui erano stati tolti o tagliati i nervi, così da renderlo apatico, incapace di reazione. Nella disciplina della macellazione l’enervazione consiste nella recisione del midollo spinale, prassi idonea a provocare più velocemente la morte dell’animale.»
[xiv]Devo questo termine al libro di Federico Scaramuccia, Canto del rivolgimento, Oèdipus, Salerno, 2016.
[xv]Ivi, p. 33.
[xvi] Italiano Federico, I Mirmidoni, il Faggio editore, Milano, 2006, p. 13.
[xvii] Italiano Federico, L’impronta, Aragno, Milano, 2014, p. 9.
[xviii]Ivi, pp. 10-11.
[xix] Rivali Alessandro, La caduta di Bisanzio, Jaca Book, Milano, 2010, p. 19.
[xx]Ventre Daniele, Verso Itaca, d’If, Napoli, 2015.
[xxi]Amarelli Viola, http://www.carteggiletterari.it/2016/01/22/verso-itaca-daniele-ventre-2/
[xxii] Ballerini Luigi, Cefalonia, Mondadori, Milano, 2005, pp. 47-48.
[xxiii]Nacci Luigi, OdeSS, pp. 117- 166, in Poesia contemporanea. Decimo quaderno italiano, a cura di Franco Buffoni, Milano, Marcos y Marcos, 2010
[xxiv]Lamberti Bocconi Anna, Canto di una ragazza fascista dei miei tempi, Transeuropa, Roma, 2010. Una sorta di diario racconto al femminile è anche il poema di Florinda Fusco, Thérèse, Edizioni Polìmata, Roma, 2011. Qui la voce è quella di un personaggio degli anni zero e la composizione segue una scansione per cori e recitativi, vicina alla prosodia di Giuliano Mesa.
[xxv] Fantuzzi Matteo, La stazione di Bologna, Milano, Feltrinelli, formata Epub, 2017.
[xxvi] Filia Francesco, La zona rossa, Il laboratorio edizioni, Nola, 2015. De Santis Alessandro con Metro C, Manni, Lecce, 2013, usa una tecnica compositiva molto simile a quella di Filia, articola un racconto per frammenti, con vari personaggi, con una scansione temporale esibita in ore e minuti, sulla città di Roma, ambientato nella metropolitana linea c della capitale, che in verità non è mai stata realizzata.
[xxvii]Scaramuccia Federico, Coma una lacrima, d’If, Napoli, 2011.
[xxviii]Renda Marilena, Ruggine, Com Press, Milano, 2012.
[xxix]Orecchini Fabio, Per Os, Sigismundus, San Benedetto del Tronto, 2016. Di Fabio Orecchini bisogna ricordare anche il testo sul mondo operaio e le morti per amianto Dismissione, Sossella editore, Roma, 2014. Sempre sul mondo operaio è il poemetto di Sara Ventroni Nel gasometro, Le Lettere, Firenze, 2006.
[xxx]Testa Italo, I camminatori, Premio Valigie Rosse, Livorno, 2013, p. 11.
[xxxi]Testa Italo, Tutto accade ovunque, Aragno, Milano, 2016, p. 21.
[xxxii]Raos Andrea, sul retro di copertina, Le api migratori, Oèdipus edizioni, Salerno, 2007.
[xxxiii]Trucillo Luigi, Darwin, Quodlibet, Macerata, 2009.
[xxxiv]Pacini Bernardo, La drammatica evoluzione, Oedipus, Salerno, 2016.
[xxxv]Mari Lorenzo, L’ornitorinco, Prufrock, Costa di Rovigo, 2016.
Vincenzo Frungillo, Il luogo delle forze. Lo spazio della poesia nel tempo della dispersione, con tavole di Francesco Balsamo, Carteggi Letterari le Edizioni, Messina, 2017. Pagg. 141, !8 euro.



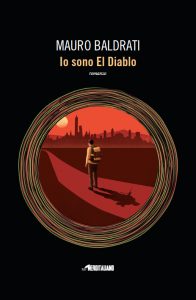


 «… devo riprendere dall’inizio? Quale inizio? Quando ho lasciato l’appartamento? È vero, se non avessi deciso di andarmene non sarei qui. Sembrava così semplice, cambiare casa, cambiare vita, semplice, vendere l’appartamento e via, d’un colpo tutto dietro le spalle. Ho deciso quest’inverno, un mattino, su due piedi. Faceva molto freddo, me lo ricordo perché avevo tirato fuori dalla canfora il pellicciotto, l’odore mi aveva dato nausea e ho pensato che mi sarei dovuta comprare un cappotto nuovo. Era un lunedì. Sono sicura. Perché era il giorno dopo, cioè il giorno prima era successa la cosa di Mathias. La data esatta? Non la sa? Una domenica d’inverno. Io, il lunedì mattina, quando mi sono guardata attorno, sono tornata indietro negli anni, quando siamo arrivate, la mamma e io, avevamo improvvisato una festicciola, sul terrazzo, noi due, in mezzo agli scatoloni, c’era un bel sole, le bibite si scaldavano e la crema delle pastine si scioglieva, ma le ho mangiate tutte, e ho bevuto l’aranciata, avevo sette anni e la mamma sembrava allegra. I gerani c’erano già, rosa e rossi, piantati in vasi di terracotta a bassorilievi, lungo due lati; le aiuole le ho fatte molti anni dopo, quando ne ho avuto bisogno. Glielo racconto poi, mi ascolti ora, è importante, quel lunedì mattina, quando ho deciso che non potevo più restare. Non pensavo al pericolo, non pensavo a niente, non volevo né nascondere né svelare, volevo solo andare via, per sempre. Facevo colazione in veranda e guardavo Mimì, dietro la vetrata, giocare con i gerani, grattare la terra. Frugava con le zampe e con il muso nelle ultime piantine, un ossicino è spuntato e un rigurgito di caffelatte mi ha dato un gusto acido in bocca: era ora di andarmene. Trentacinque anni in quell’appartamento, trentacinque anni in quel terrazzo, quindici anni da sola. Ho messo il pellicciotto che sapeva di canfora e sono scesa a comprare il giornale, però il giornalaio sotto casa era ancora chiuso per lutto, il figlio era morto la settimana prima, no, io non c’entro, un incidente stradale. Sono andata in piazza e non avevo i guanti né il cappello. Un dettaglio insignificante? No. Tutto quello che racconto ha un senso, almeno per me. Camminavo con le guance sferzate dal vento glaciale, con le mani livide sprofondate nelle tasche e sorridevo, sì, mi rallegravo del fatto che con quelle temperature avrei potuto rimandare il lavoro di giardinaggio. D’estate invece bisogna sbrigarsi, quando fa troppo caldo è dura. Estate come inverno comunque è un’operazione lunga che richiede applicazione. E una grande calma. La prima volta sporcai dappertutto, non pensavo che un corpo potesse contenere tanto sangue. E tanta carne, e viscere, budella, ossa, muscoli. Ci misi due giorni per tagliare, spezzare, triturare, bollire, gettare, sotterrare. La testa, la volli lasciare intera, tutta intera sotto un albero. Il terzo pino sulla destra, prima del ponte. Non c’è più? È passato tanto tempo! Forse era il quarto pino, forse dopo il ponte. Quella prima volta, fu una fatica, zoppa come sono, si immagini trascinare un bauletto. Il peggio è stato scavare. Dopo un’ora la cavità era ancora piccola e già avevo le mani coperte di piaghe e di vesciche, non ce la facevo più a tenere la pala, allora ficcai dentro le mani nude. Il buco a poco a poco si fece più profondo, abbastanza profondo. All’ospedale mi fecero tante domande. Piangevo, ma non per il dolore alle mani. Mio padre, mio amore, mio adorato, mio tutto, mio troppo, troppo amore, il primo uomo che ho amato, pazzamente, e non era bello, era vecchio ed era stanco. Appoggiavo la faccia sulla sua pancia rotonda, accarezzavo il pelo grigio del petto, e il mondo si esauriva in un’estasi infinita. Aveva la forza e l’ingegno di un animale selvatico, un odore aspro inebriante, le labbra tumide, le mani calde. Mi prendeva senza una parola, senza un bacio, il desiderio era il suo modo di amarmi. Forse. Avrei voluto essere piccola piccola e vivere dentro di lui. Mi mancava, sempre, crudelmente, anche quando c’era. Troppo amore, e lui aveva una moglie e due figli già grandi, e un lavoro importante, e sessant’anni, e io avevo lui, il gatto, i gerani e non ancora trent’anni. Quel lunedì mattina, mentre andavo in piazza a cercare il giornale, ho ripensato a Giovanni e ho pianto. Dovevo ucciderlo per non soffrire. Lei è una donna, mi capisce, vero? Ho pianto, ripensando al cuscino che lo soffocava nella letargia del sonnifero, poi mi sono calmata e mi è venuto in mente che dopo, quando sono riuscita a sistemare tutto, un po’ nei vasi un po’ altrove, a ripulire, a far tornare le cose e la casa nell’ordine che avevano avuto nei vent’anni passati con mamma, dopo, con le mani fasciate e la morte nel cuore, sono andata in un negozio specializzato e mi sono fatta spiegare come piantare le grandi aiuole lungo i bordi del terrazzo… »
«… devo riprendere dall’inizio? Quale inizio? Quando ho lasciato l’appartamento? È vero, se non avessi deciso di andarmene non sarei qui. Sembrava così semplice, cambiare casa, cambiare vita, semplice, vendere l’appartamento e via, d’un colpo tutto dietro le spalle. Ho deciso quest’inverno, un mattino, su due piedi. Faceva molto freddo, me lo ricordo perché avevo tirato fuori dalla canfora il pellicciotto, l’odore mi aveva dato nausea e ho pensato che mi sarei dovuta comprare un cappotto nuovo. Era un lunedì. Sono sicura. Perché era il giorno dopo, cioè il giorno prima era successa la cosa di Mathias. La data esatta? Non la sa? Una domenica d’inverno. Io, il lunedì mattina, quando mi sono guardata attorno, sono tornata indietro negli anni, quando siamo arrivate, la mamma e io, avevamo improvvisato una festicciola, sul terrazzo, noi due, in mezzo agli scatoloni, c’era un bel sole, le bibite si scaldavano e la crema delle pastine si scioglieva, ma le ho mangiate tutte, e ho bevuto l’aranciata, avevo sette anni e la mamma sembrava allegra. I gerani c’erano già, rosa e rossi, piantati in vasi di terracotta a bassorilievi, lungo due lati; le aiuole le ho fatte molti anni dopo, quando ne ho avuto bisogno. Glielo racconto poi, mi ascolti ora, è importante, quel lunedì mattina, quando ho deciso che non potevo più restare. Non pensavo al pericolo, non pensavo a niente, non volevo né nascondere né svelare, volevo solo andare via, per sempre. Facevo colazione in veranda e guardavo Mimì, dietro la vetrata, giocare con i gerani, grattare la terra. Frugava con le zampe e con il muso nelle ultime piantine, un ossicino è spuntato e un rigurgito di caffelatte mi ha dato un gusto acido in bocca: era ora di andarmene. Trentacinque anni in quell’appartamento, trentacinque anni in quel terrazzo, quindici anni da sola. Ho messo il pellicciotto che sapeva di canfora e sono scesa a comprare il giornale, però il giornalaio sotto casa era ancora chiuso per lutto, il figlio era morto la settimana prima, no, io non c’entro, un incidente stradale. Sono andata in piazza e non avevo i guanti né il cappello. Un dettaglio insignificante? No. Tutto quello che racconto ha un senso, almeno per me. Camminavo con le guance sferzate dal vento glaciale, con le mani livide sprofondate nelle tasche e sorridevo, sì, mi rallegravo del fatto che con quelle temperature avrei potuto rimandare il lavoro di giardinaggio. D’estate invece bisogna sbrigarsi, quando fa troppo caldo è dura. Estate come inverno comunque è un’operazione lunga che richiede applicazione. E una grande calma. La prima volta sporcai dappertutto, non pensavo che un corpo potesse contenere tanto sangue. E tanta carne, e viscere, budella, ossa, muscoli. Ci misi due giorni per tagliare, spezzare, triturare, bollire, gettare, sotterrare. La testa, la volli lasciare intera, tutta intera sotto un albero. Il terzo pino sulla destra, prima del ponte. Non c’è più? È passato tanto tempo! Forse era il quarto pino, forse dopo il ponte. Quella prima volta, fu una fatica, zoppa come sono, si immagini trascinare un bauletto. Il peggio è stato scavare. Dopo un’ora la cavità era ancora piccola e già avevo le mani coperte di piaghe e di vesciche, non ce la facevo più a tenere la pala, allora ficcai dentro le mani nude. Il buco a poco a poco si fece più profondo, abbastanza profondo. All’ospedale mi fecero tante domande. Piangevo, ma non per il dolore alle mani. Mio padre, mio amore, mio adorato, mio tutto, mio troppo, troppo amore, il primo uomo che ho amato, pazzamente, e non era bello, era vecchio ed era stanco. Appoggiavo la faccia sulla sua pancia rotonda, accarezzavo il pelo grigio del petto, e il mondo si esauriva in un’estasi infinita. Aveva la forza e l’ingegno di un animale selvatico, un odore aspro inebriante, le labbra tumide, le mani calde. Mi prendeva senza una parola, senza un bacio, il desiderio era il suo modo di amarmi. Forse. Avrei voluto essere piccola piccola e vivere dentro di lui. Mi mancava, sempre, crudelmente, anche quando c’era. Troppo amore, e lui aveva una moglie e due figli già grandi, e un lavoro importante, e sessant’anni, e io avevo lui, il gatto, i gerani e non ancora trent’anni. Quel lunedì mattina, mentre andavo in piazza a cercare il giornale, ho ripensato a Giovanni e ho pianto. Dovevo ucciderlo per non soffrire. Lei è una donna, mi capisce, vero? Ho pianto, ripensando al cuscino che lo soffocava nella letargia del sonnifero, poi mi sono calmata e mi è venuto in mente che dopo, quando sono riuscita a sistemare tutto, un po’ nei vasi un po’ altrove, a ripulire, a far tornare le cose e la casa nell’ordine che avevano avuto nei vent’anni passati con mamma, dopo, con le mani fasciate e la morte nel cuore, sono andata in un negozio specializzato e mi sono fatta spiegare come piantare le grandi aiuole lungo i bordi del terrazzo… »
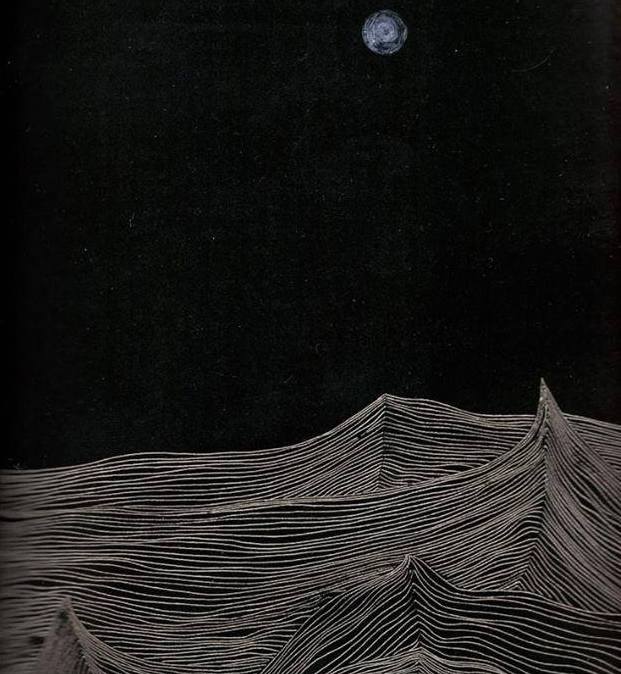
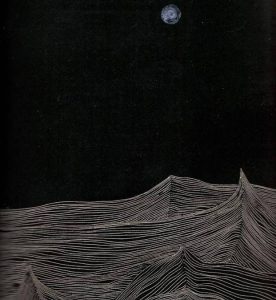




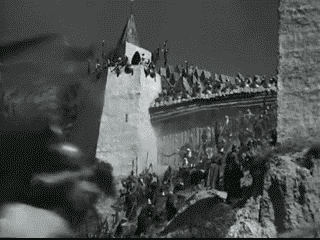













 di Nadia Agustoni
di Nadia Agustoni
 Non fosse altro che per questo motivo, il tentativo della conservazione di ciò che rimane del ponte andrebbe fatto. In realtà non è un caso che questa voce provenga da questo ambiente. Se ci si pensa, non può essere un altro ponte a rappresentare la memoria di ciò che è accaduto, come a Berlino è conservato ciò che rimane della chiesa commemorativa del Kaiser Guglielmo I a ricordo della tragedia della guerra, o la ancora più drammatica prefettura di Hiroshima, deformata e liquefatta dalla bomba atomica. Oppure, con un esempio forse ancora più parlante a noi italiani, come la sala d’aspetto di seconda classe della stazione di Bologna, mai cancellata dai cittadini dopo la strage del 2 agosto 1980, dove il muro lacerato e il pavimento incavato stanno a testimoniare quanta violenza l’uomo riserva all’altro uomo. E si vengano a vedere le commemorazioni annuali per capire quanta condivisione di quella ferita c’è ancora! Altro che i simbolici ricordi sulle nuove opere! Sul fronte opposto, purtroppo non si può che constatare una volontà di cancellare la tragedia che non si intona certo con il bisogno di ricordare le vittime.
Non fosse altro che per questo motivo, il tentativo della conservazione di ciò che rimane del ponte andrebbe fatto. In realtà non è un caso che questa voce provenga da questo ambiente. Se ci si pensa, non può essere un altro ponte a rappresentare la memoria di ciò che è accaduto, come a Berlino è conservato ciò che rimane della chiesa commemorativa del Kaiser Guglielmo I a ricordo della tragedia della guerra, o la ancora più drammatica prefettura di Hiroshima, deformata e liquefatta dalla bomba atomica. Oppure, con un esempio forse ancora più parlante a noi italiani, come la sala d’aspetto di seconda classe della stazione di Bologna, mai cancellata dai cittadini dopo la strage del 2 agosto 1980, dove il muro lacerato e il pavimento incavato stanno a testimoniare quanta violenza l’uomo riserva all’altro uomo. E si vengano a vedere le commemorazioni annuali per capire quanta condivisione di quella ferita c’è ancora! Altro che i simbolici ricordi sulle nuove opere! Sul fronte opposto, purtroppo non si può che constatare una volontà di cancellare la tragedia che non si intona certo con il bisogno di ricordare le vittime. Ora si parla di demolizione, di costruire un ponte che duri mille anni (con tutte le tristissime memorie che mi evoca questa frase) di riqualificare urbanisticamente il quartiere sottostante. Questi atti sono atti di superbia, che illudono consapevolmente facendoci credere invulnerabili alle ingiurie della natura e dell’uomo. Il ponte Morandi invece è testimone, parlerà per sempre della tragedia. La sua demolizione corrisponde alla cancellazione della memoria pubblica, e il risultato sarà per l’ennesima volta la solitudine dei familiari delle vittime e degli sfollati dalle case sotto il viadotto a patire il dolore senza una collettività che li sostenga.
Ora si parla di demolizione, di costruire un ponte che duri mille anni (con tutte le tristissime memorie che mi evoca questa frase) di riqualificare urbanisticamente il quartiere sottostante. Questi atti sono atti di superbia, che illudono consapevolmente facendoci credere invulnerabili alle ingiurie della natura e dell’uomo. Il ponte Morandi invece è testimone, parlerà per sempre della tragedia. La sua demolizione corrisponde alla cancellazione della memoria pubblica, e il risultato sarà per l’ennesima volta la solitudine dei familiari delle vittime e degli sfollati dalle case sotto il viadotto a patire il dolore senza una collettività che li sostenga.

