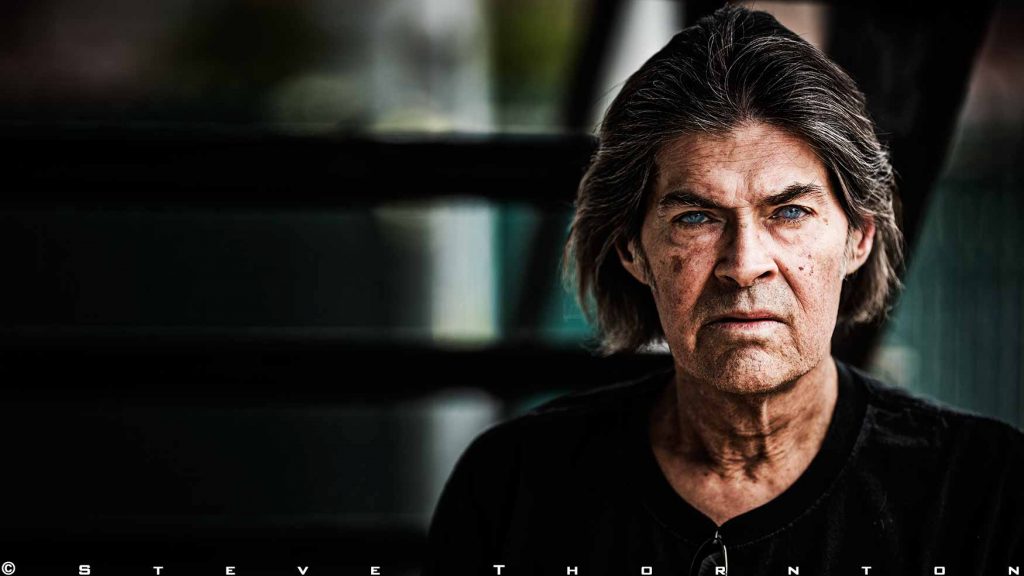di Davide Franchetto
La vide affacciarsi in cortile dalla porta della cucina. Aveva già addosso il cappotto e l’ombrello in mano, le scarpe buone ai piedi, quelle nere con un po’ di tacco che la facevano brontolare per le caviglie gonfie e rimpiangere le ciabatte e la cucina. Lui tirò un ultimo calcio al pallone che rimbalzò contro la rete di cinta e ricadde nella gigantesca pozzanghera che da poche ore s’era allargata dal centro del cortile fino ai suoi confini. Dal pollaio le anatre spingevano il becco tra le maglie delle gabbie e starnazzavano di desiderio.
“Ti prenderai un accidente!” Gli urlò.
Succedeva che la nonna lo chiamasse ad accompagnarla nelle sere in cui sua madre restava assopita sul divano e il nonno brillo davanti al televisore. Non erano molte le occasioni per le quali si prendesse un pensiero dopo che s’era fatto buio: passare la notte accanto a un malato, portare le condoglianze alla famiglia di un defunto, una messa di trigesima.
“Lavati le mani, guarda come sei sporco”. Gli disse.
S’infilò la giacca e fuori casa lei lo prese sottobraccio per condividere l’ombrello. Camminarono lungo le vie scure e gialle della luce che dai lampioni sgocciolava sull’asfalto. Più giù, alle cascine, era buio e a fare strada era la memoria, era il fosso pieno d’acqua che s’affacciava sullo sterrato, sbordava sulla ghiaia dei vialetti e gonfiava il legno dei portoni.
Dentro non c’era più posto e uno sciame si stringeva sull’uscio, contro i muri, tutt’intorno al perimetro del cortile: si scontravano le stecche degli ombrelli, si sussurravano scuse, uno, distratto, aveva scalciato un vaso di gerani lasciato a prendere pioggia: ora i petali viola spuntavano come vecchie promesse tra i cocci e le zolle. Lui e la nonna avevano conquistato una spanna di muro sul fondo, al riparo sotto uno spiovente di coppi centenari e ora lei lo teneva stretto a sé, lo cingeva al petto stringendolo contro il suo. Lui riconosceva l’odore di muffa del cappotto, affondava la faccia nella manica coprendosi fin sopra il naso. Quando erano arrivati qualcuno s’era girato a guardarli e nessuno per salutare. Una donna gli era venuta incontro, una vecchia alta e dal passo deciso con certi occhi grifagni che avevano artigliato sua nonna.
“Sei matta!” Le aveva detto. E per quanto sottovoce dopo tutti avevano bisbigliato qualcosa.
Lei non aveva risposto. Lui aveva guardato la donna e morso la manica del cappotto.
Cominciò la preghiera.
“Metti bene le mani, come ti hanno insegnato”. Lui giunse le mani all’altezza del petto e chiuse gli occhi godendosi il tepore della stretta di lei. Li riaprì subito immaginandosi che tutti lo stessero guardando, ma le rare occhiate non erano per lui, e chi le lanciava inciampava nelle orazioni per spettegolare con la vicina che annuiva e non guardava.
“Credo!” Non conosceva quella preghiera, faceva eco alle beghine che gracchiavano per prime e comandavano tutti gli altri. Lo rassicurava che anche la nonna la borbottasse, come un ricordo che si dice ma non si è sicuri di avere.
“Padre!” Si fecero più forti le voci di tutti e la sua con le altre. Scandiva bene le lodi e si guardava intorno. Sentì l’abbaiare dei cani e lo schiocco delle catene sul cemento arrivare dal lato opposto della cascina; vide sbucare in cortile un bastardino basso e grasso, un pezzato dalle zampe curve che prese ad annusare i piedi dei fedeli uno ad uno. Quando fu il suo turno disobbedì e allungò una mano verso il muso, quello l’annusò accompagnando un lento scodinzolio, lui sorrise sentendosi inumidire le dita.
“Angela”. Alzò la testa seguendo una voce poco più in alto, di fianco a sua nonna e vicina al suo orecchio. Continuando a sussurrare l’Ave Maria lei voltò lo sguardo verso la donna.
“Angela”, ripeté l’altra. Aveva un tono dolce e più che chiamare pareva stupirsi per qualcosa che le fosse apparso lì in mezzo al cortile: le ali stese sul cappotto bagnato.
“Teresa”
“Ma perché sei venuta?”
“A pregare”. Rispose Angela.
Teresa rimase al loro fianco a rimandare indietro le occhiatacce che ancora osavano. Lui appoggiò la testa al petto della nonna, continuò ad andare dietro alle preghiere, sbadigliò, seguì con lo sguardo il cane che dopo aver annusato tutti i presenti si era affacciato sulla porta di casa, era stato scacciato ed era tornato nel cortile ad annusare la terra e i ciuffi d’erba che sbocciavano dalle crepe del calcestruzzo. A torturare i vermi che la pioggia chiamava fuori.
“Amen”.
La folla si distese, si riaprirono gli ombrelli, ci furono nuovi saluti e i crocchi delle beghine e le voci ora alte degli uomini. In molti si misero in coda per le condoglianze e sua nonna e lui dietro tutti gli altri.
“Angela, vai a casa”. La supplicò Teresa.
Ma lei niente, un passo dietro il nipote e la mano sulla sua spalla. Avvicinandosi all’ingresso si cominciava a vedere il buio dentro e si sentivano i sospiri che lo attraversavano.
“Angela, andiamo a casa”.
Lui si fermò, si voltò verso la nonna.
“Torniamo a casa”. Le disse e cercò di sembrare annoiato, di non mostrare paura. Lei gli diede un’altra carezza.
“Salutiamo e poi torniamo a casa”
“Non vorrai mica”, sbottò Teresa.
“E’ grande”.
Superarono la soglia e fecero due passi in corridoio. C’erano persone che andavano e venivano da una stanza sul fondo, e qualcuno che entrava in un’altra stanza lì vicino. Si sentivano le giaculatorie sommesse di chi credeva di non aver pregato abbastanza, e gli uomini dalle donne si distinguevano dall’odore: La calce, la terra e la canfora.
Si avvicinò a loro una donna, quella di prima o un’altra con la stessa faccia. La nonna lo strinse più forte sulle spalle e lo spostò di due passi avanti, che quella si piantasse lì e non si permettesse oltre.
“Non credere eh!” Gracchiò la donna, e le sfuggì un gesto col braccio, uno schiaffo all’aria nera. L’indice indicava la stanza sul fondo. “Con tuo nipote. Senza cognizione!” E di nuovo sottovoce abbastanza da farsi sentire.
“Basta!” Saltò su Teresa.
“Non la faccio mica andare”
“Solo un momento”, disse Angela “E andiamo via”.
Lui si girò verso la nonna. La voce non era la solita ma di preghiera. Vera, non come prima. La donna imprecò, sollevò lo sguardo al soffitto o al cielo che erano ormai la stessa notte. A quel dio che aveva fatto buio.
“Vieni”. Disse Angela passando avanti.
Aspettarono che una coppia finisse l’ultima Ave Maria e consegnasse un bacio dalla punta delle dita sulla sponda della bara. Angela chinò il viso accanto a quello del nipote.
“Pensa che sta dormendo”. Gli disse all’orecchio.
Teresa entrò per prima, si fece il segno della croce, farfugliò la preghiera e come gli altri consegnò il bacio. Poi tornò sulla porta e rimase di guardia. La camera era illuminata da due grandi candele che spiccavano dai candelabri sistemati ai lati della bara, lì accanto una sedia per sostenere la notte di veglia. La luce delle fiammelle svelava la tinta porpora delle tende, sbuffava contro la vecchia credenza grande una parete. Dalle vetrine sbirciavano le statuette in gesso: una Madonna, gli angeli paffuti, un vecchio abbracciato a una damigiana, la fotografia incorniciata di una coppia d’anziani, quella di due giovani in bianco e nero.
“Non fa paura, sta dormendo”. Ripeté Angela.
Lui strusciò una caviglia contro l’altra, serrò cosce e ginocchia e s’ingobbì un poco per trattenere una scoreggia. Si fece coraggio, pensò agli amici: -Ho visto un morto. Dal vero. – Avrebbe raccontato.
Angela s’accostò alla bara, appoggiò entrambe le mani sulla sponda come per tenersi su: le caviglie gonfie, le scarpe.
“Vuoi vedere?” Gli chiese.
S’avvicinò alla nonna. A passi pesanti e attenti, sulla graniglia che i passi di tutti gli altri prima avevano reso scivolosa. Un paciocco di terra e pioggia.
Un morto vero.
Angela gli strinse la mano.
“Non fa mica paura”.
Lui si sporse oltre il bordo della cassa e guardò: era sdraiato un uomo in giacca e cravatta. Quasi calvo come tutti i vecchi, con la faccia di una cera grigiastra e le rughe stirate che lo facevano dieci anni più giovane di quanto fosse stato. Gli ricordava certi zii al Barbera conosciuti di scorcio alle cerimonie di famiglia. Uomini sottili come steli e sempre in silenzio, che ci fosse da far festa o stare abbottonati.
Non gli faceva paura.
Angela diede una carezza alla salma e si sedette sulla sedia.
“Diciamone ancora una”. Disse, e attaccò con un Ave Maria quando lui aveva già cominciato con un Padre.
Poi Angela rimase seduta a guardarsi le mani grosse, lentigginose, le unghie grigie. Teresa si scostò dalla soglia e le andò vicino.
“Andiamo Angela, dai”
“Un minuto”
“Ti guardano già male”
“Anche prima”.
Teresa rimase in piedi, in silenzio per dovere e rigida d’impazienza.
“Non ti fa nemmeno più piangere”. Disse.
“Gli somiglia”
“Chi?” Chiese Teresa.
Angela sollevò una mano verso il nipote.
“Shhht”. La riprese Teresa come prima coi pettegoli.
Lui stava ancora osservando il morto, fiero di non avere paura, quando aveva colto quel gesto con la mano: dal grembo a lui. E più d’averla vista l’aveva sentita. E Teresa che l’aveva zittita allo stesso modo di sua nonna quando lui si permetteva: col sibilo tra i denti e lo sguardo che minacciava se l’avessi fatta vergognare ancora.
“Andiamo su”, Teresa si chinò su Angela, allungò le braccia come volesse sollevarla.
“E’ abbastanza”. Disse.
Lui spiò sua nonna: aveva mezza faccia tirata da una smorfia, l’altra metà nascosta dal palmo della mano.
“L’ha fatto ancora una volta”. La sentì piangere.
Gli prese di nuovo il mal di pancia, di nuovo dovette serrare le gambe per paura di farsela addosso. A chi somigliava? A quella faccia lucida, gelida di sicuro, che per farla sembrare meno morta l’avevano fatta di cera? Angela si alzò dalla sedia, poggiò ancora la mano sul bordo della cassa ma non ci furono più preghiere e nemmeno un bacio. Guardò la salma e disse qualcosa: tre parole, non di più, che nessuno riuscì a sentire. Gli si avvicinò e lo prese per mano. Lui continuava ad osservare il vecchio: quel naso un po’ a becco, le orecchie piccole, le labbra, pallide ora, e sottili, le mani in pace sul ventre ma con le dita d’ossa storte da anni di vanga o piccone. Il vestito buono per tutte le occasioni di un paio di misure più largo. Era suo nonno o suo padre, o uno zio, un cugino dimenticato. Era tutte le generazioni di uomini ingobbiti sulla terra di Fruttuaria. Era lui. Teresa si affacciò sull’uscio e guardò in corridoio. Non c’erano altri ad aspettare. Si voltò ancora una volta verso la bara, si segnò e fece strada verso l’uscita. Angela dovette strattonarlo per portarlo via. Dalla stanza a margine del corridoio si affacciarono due cornacchie, una voce di donna da dentro sbraitò: “Sciò, sciò!”. Gli ultimi arrivati a portare le condoglianze si scostarono di un poco al loro passaggio.
In cortile i fedeli si accomiatavano, scuotevano il capo fingendo stupore per quella morte inattesa, chiedevano a dio pace per l’estinto e l’eternità che gli toccava davanti e quaggiù per gli anni, sempre pochi avrebbero giurato, che restavano loro. Si davano la buonanotte. Aveva smesso di piovere. Teresa si fermò accanto al muro sul fondo, fece per dire qualcosa, sbuffò, sollevò una mano e diede una carezza sulla guancia di Angela. Lui sentì il tocco della mano di Teresa nella mano di sua nonna che piano s’apriva e lo liberava. Fece due passi indietro e guardò verso la casa: s’era accesa una luce dietro le tende della finestra al piano di sopra, oltre la porta ancora aperta sul cortile e in fondo al corridoio lo tentavano i fuochi fatui delle candele. Si accorse di qualcosa che puntava contro la sua caviglia, abbassò gli occhi e vide il cane che lo annusava attento come se tra le pieghe dei suoi pantaloni potesse nascondersi chissà quale tesoro. Il cane sollevò il muso e scodinzolò. Come prima lui allungò la mano per sentire il naso freddo contro le nocche, poi batté i palmi sulle cosce e il cane si mise su due zampe. La coda a mulinello. Lui fece un salto all’indietro e lo chiamò di nuovo battendo le mani e il cane saltò in avanti e abbaiò.
“Shhhhtt!” Fece lui preoccupato ma lo richiamò a sé e presero a rincorrersi e a fermarsi di colpo, una carezza una grattata sotto il collo, quando qualcuno gli passava accanto. Guardò verso sua nonna che rimaneva accanto a Teresa: le parole che forse si dicevano, i gesti lenti che le accompagnavano. Sembravano due ragazze goffe e grasse cacciate dalla festa. O due streghe. Corse fino al cancello e si fermò, il cane lo seguì. Lo chiamò ancora e insieme superarono il vialetto d’ingresso e si fermarono a margine dello sterrato. Era buio da non vedersi i piedi un metro più in basso, la via un pantano, il fosso che ruggiva, minacciava di disastrare i campi. Il cane puntò il naso verso la notte, le orecchie dritte, il corpo teso in un’eccitazione tutta diversa da quella del gioco.
“Che c’è? Che hai visto?”
E il cane già s’anneriva verso la boscaglia.
“Vieni qui, torna qui!” Voleva convincerlo e non si permetteva di gridare.
“Vieni qui!”
Lo rincorse nel prato e a ogni passo si voltava verso la cascina.
“Torna qui”. Piagnucolava e si spingeva verso gli bosco e il buio dove faceva più spavento.
“Ehi quiiiii!“ E batteva le mani sulle ginocchia.
Si rannicchiò. Le mani che reggevano la testa, coprivano le orecchie.
“Vieni qui”. Pregava convinto adesso.
Sentì un abbaio, alzò il capo, scorse una sagoma, chiazze di pelo bianco, un muso, uno scodinzolio venirgli incontro.
“Qui, qui”. Quando il cane gli fu vicino gli accarezzò la testa, la schiena, si impiastrò le mani di pioggia fango e foglie. Il cane ansava, la lingua pendeva da un lato, sollevò le zampe si appoggiò alle sue ginocchia e gli leccò la faccia.
“Bravo, stai bravo”, gli disse ridendo e intanto lo stringeva a sé con entrambe le braccia.
“Non so nemmeno come ti chiami”.
Il cane smise di colpo di leccarlo, voltò il muso e puntò di nuovo verso il sottobosco. Lui lo strinse più forte.
“Che c’è? Cosa vedi? Stai qui eh. Stai qui”.
Ma intanto fissava verso lo stesso punto dove il buio avanzava avvolgendo i fusti gobbi dei castagni: i rami scheletrici sulle cime e quelli ancora vigorosi più in basso; copriva lo strepito degli insetti e il gorgogliare sazio della terra. Guardò verso la cascina: due sagome, di donne certo, erano ferme sul vialetto. Poi guardò di nuovo verso il buio e gli sembrò più vicino.
“Andiamo”. Disse.


 di Mariasole Ariot
di Mariasole Ariot  [Dal sito
[Dal sito

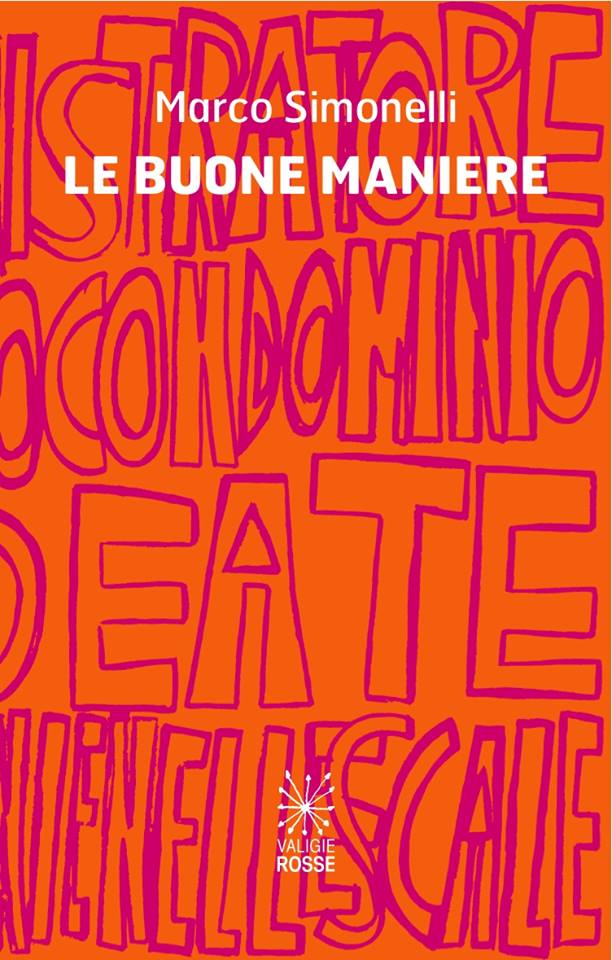




 Nota
Nota 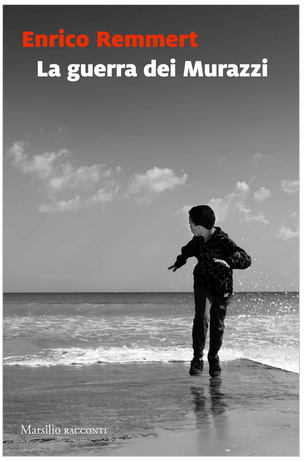 Questo si chiede Manu, barista di uno dei luoghi in cui si sta rifacendo la storia delle notti torinesi, protagonista del primo racconto, ma anche di quell’ incredibile epoca dei murazzi a Torino. Quello che non riusciamo a capire è se la ragazza questa domanda la stia facendo all’io narrante, al proprio creatore e dunque come ascoltatrice o a sé stessa. Certo è che la descrizione nelle prime pagine dello scontro tra hooligans e una banda di quartiere magrebina, superiore per numero ma non addestrata, ti coinvolge nella minuziosa descrizione del campo di battaglia- quei famosi controviali di Torino che nessun italiano al mondo potrà mai capire. E ti immedesimi a a tal punto in quella prospettiva, le due ragazze assistono da un balcone agli eventi, che la visuale da cui tutto si genera si sovrappone all’occhio del lettore come se si fosse dentro a una pagina dell’arte della guerra o di certe riproduzioni della battaglia di Waterloo che si possono vedere al Musée de l’Armée a Parigi. Non aveva forse scritto. Sun Tzu che “Fondamentale in tutte le guerre è lo stratagemma”? Senza voler qui rivelare i dettagli di ogni singola storia dove la trama è un semplice incidente di percorso nello svelamento del senso che il lettore compirà davvero solo alla lettura, quello che colpisce è la leggerezza con cui i giochi si fanno attraverso l’elemento tattico e dunque razionale, in tutte e quattro le storie. Se c’è una traccia che potrebbe servire nella comprensione dell’estetica di Remmert questa va sicuramente trovata tra le lezioni americane di Italo Calvino e in particolare la prima, dedicata alla leggerezza. Come non mettere in relazione infatti questa prima immagine degli hooligans, rapidi, impercettibili, con una delle ultime, l’annegamento nel Po davanti ai Murazzi di Abdellah? Come non scorgervi infatti l’opposizione tra leggerezza dei gesti e delle fughe nel primo, e pesantezza di un corpo che annega in mezzo a una festa in grado di annientare ogni residuo di razionalità, di umanità e permettere ai tanti testimoni di assistere alla morte di un uomo senza coglierne la gravità, il peso, appunto.
Questo si chiede Manu, barista di uno dei luoghi in cui si sta rifacendo la storia delle notti torinesi, protagonista del primo racconto, ma anche di quell’ incredibile epoca dei murazzi a Torino. Quello che non riusciamo a capire è se la ragazza questa domanda la stia facendo all’io narrante, al proprio creatore e dunque come ascoltatrice o a sé stessa. Certo è che la descrizione nelle prime pagine dello scontro tra hooligans e una banda di quartiere magrebina, superiore per numero ma non addestrata, ti coinvolge nella minuziosa descrizione del campo di battaglia- quei famosi controviali di Torino che nessun italiano al mondo potrà mai capire. E ti immedesimi a a tal punto in quella prospettiva, le due ragazze assistono da un balcone agli eventi, che la visuale da cui tutto si genera si sovrappone all’occhio del lettore come se si fosse dentro a una pagina dell’arte della guerra o di certe riproduzioni della battaglia di Waterloo che si possono vedere al Musée de l’Armée a Parigi. Non aveva forse scritto. Sun Tzu che “Fondamentale in tutte le guerre è lo stratagemma”? Senza voler qui rivelare i dettagli di ogni singola storia dove la trama è un semplice incidente di percorso nello svelamento del senso che il lettore compirà davvero solo alla lettura, quello che colpisce è la leggerezza con cui i giochi si fanno attraverso l’elemento tattico e dunque razionale, in tutte e quattro le storie. Se c’è una traccia che potrebbe servire nella comprensione dell’estetica di Remmert questa va sicuramente trovata tra le lezioni americane di Italo Calvino e in particolare la prima, dedicata alla leggerezza. Come non mettere in relazione infatti questa prima immagine degli hooligans, rapidi, impercettibili, con una delle ultime, l’annegamento nel Po davanti ai Murazzi di Abdellah? Come non scorgervi infatti l’opposizione tra leggerezza dei gesti e delle fughe nel primo, e pesantezza di un corpo che annega in mezzo a una festa in grado di annientare ogni residuo di razionalità, di umanità e permettere ai tanti testimoni di assistere alla morte di un uomo senza coglierne la gravità, il peso, appunto.


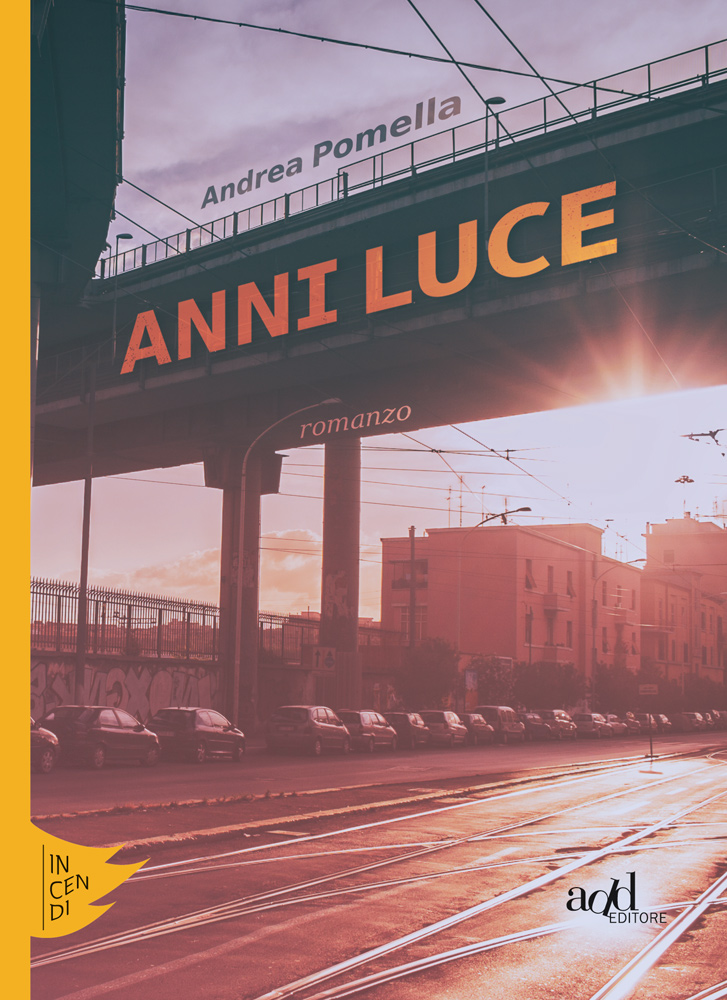
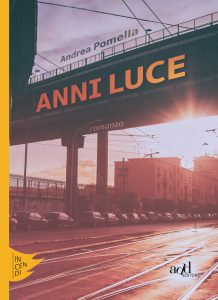 di Francesca Fiorletta
di Francesca Fiorletta