di Giacomo Sartori
facce affacciate (alle facciate)
facce affaccendate (alle faccende)
facce sfaccendate
di Giacomo Sartori
facce affacciate (alle facciate)
facce affaccendate (alle faccende)
facce sfaccendate
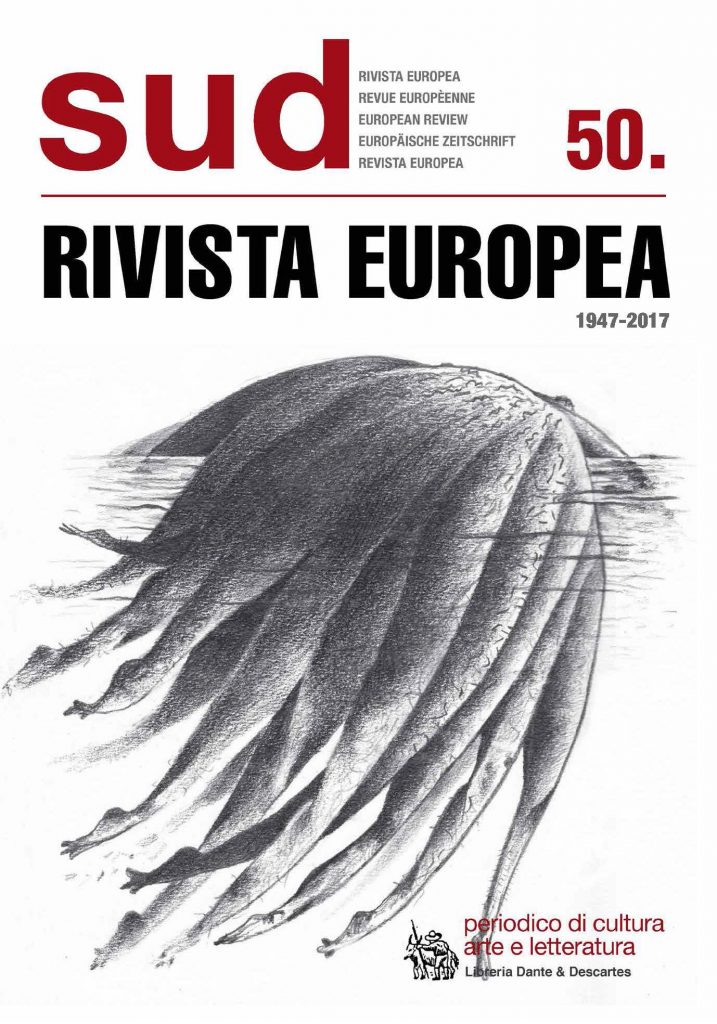
Ksamil-Albania
di Paolo Mastroianni
E il padrone, come al solito senza parlare, ha intascato il danaro e con un cenno del capo mi ha passato la busta coi pesci che un turista aveva appena comprato. Quattro spigole. Ho iniziato a pulirle. L’uomo si è fatto vicino: barba d’argento, occhi castani spensierati e guizzanti in un volto abbronzato e rugoso. Sicuramente italiano.
Abbassato lo sguardo, ho affondato il coltello nel primo pesce, l’ho aperto, l’ho ripulito con un giro veloce lasciando cadere le interiora nell’acqua, poi mi sono abbassato, ho allungato il braccio aldilà della chiazza rossastra e marrone di sangue e interiora intorno ai miei piedi, l’ho sciacquato con acqua di mare pulita e mi sono rialzato incrociando gli occhi attenti dello straniero: forse non aveva mai visto nessuno pulire del pesce nel mare. Ne ho approfittato e gli ho chiesto:
– Per quale motivo gli Inglesi non vogliono stare in Europa?
Sorpreso, è rimasto un poco in silenzio. Tanto per prendere tempo, ha fatto anche lui una domanda:
-Com’è che parli italiano adesso che avete televisione e canali e programmi?
-Perché voglio andare in Italia, perché anche se molti Albanesi da un pezzo dicono che ci sono paesi migliori, l’Italia è sempre l’Europa, ed è per questo che non capisco gli inglesi.
L’uomo ha chiuso e riaperto gli occhi. Poi ha iniziato a parlare, con lentezza, scandendo ogni parola:
-E’ che evidentemente gli inglesi pensano che stare in Europa sia peggio per loro, per la loro economia, per il fatto che le persone dagli altri paesi d’Europa possono andare liberamente da loro…
Ho risposto:
-Resteranno isolati, come noi che non sopportiamo nessuno e nemmeno noi stessi, la Grecia che ci ha rubato la storia, il Kosovo che pure sono albanesi ma sono e saranno diversi…
L’uomo mi guardava pensoso. Mi sono fermato. Lui ha detto:
-Non si sta bene in Italia, non c’è niente di buono davanti, c’è disoccupazione, soprattutto tra i giovani…
-Per noi c’è lavoro! – gli ho detto.
Mi ha guardato perplesso. Ho capito che pensava alludessi agli albanesi che fanno imbrogli e rapine e portano droga e gestiscono prostituzione. Così ho ripreso a parlare:
-Non ce ne sono più di italiani che fanno i muratori e trasportano mattoni e cemento, che raccolgono frutta nelle campagne d’estate, o che portano al pascolo greggi per giorni e per notti e fanno formaggio di capra e di pecora, o che lavano cessi…
Lui mi ha interrotto:
-Ed ha senso venire in Italia per fare questi lavori? Non è meglio restare?

L’ho fissato. Ero sul punto d’iniziare a parlare, di dirgli “Lo sai quanto prendo e solo d’estate? Lo sai che mia madre non ha medico e medicine e oramai si trascina come una vecchia? Lo sai che qui non c’è lavoro in inverno, e che in inverno c’è solo freddo e disperazione? Lo sai che qui devi conoscere per ogni piccola cosa, e mia madre non conosce nessuno e mai nessuno ha voluto conoscere?” E lui allora mi avrebbe risposto: “E pensi che avresti medico e medicine con i lavori che hai nominato? Pensi che avresti una casa, o che potresti sposarti e fare dei figli?”. E io gli avrei ribattuto: “Sarei in Italia, in Europa, dove tutto è più semplice e comodo e presto o tardi mi passerebbe davanti una buona occasione. Magari qualcuno mi farebbe portare una partita di droga, mia mamma non verrebbe a saperlo, forse lo immaginerebbe a distanza di mesi o di anni vendendomi fuori dalla miseria per sempre, e allora ne sarebbe felice dentro di sé… E seppure nessuna occasione mi passasse davanti, seppure dovessi patire la fame, sarebbe in un posto migliore, con le ragazze e i ragazzi che hanno gusto e vestiti e spensieratezza negli occhi. Almeno godrei nel vederli, a immaginarmi cresciuto come uno di loro”.
Tutto questo ero sul punto di dirgli, ma il tempo non sarebbe bastato. Così, in modo da fargli capire, ho velocemente abbracciato con uno sguardo accigliato il coltello, le spigole che ancora non avevo pulito, il grembiule marrone e rosso di sangue e interiora, la baracca con le conche e il padrone, che adesso mi stava guardando poiché c’era un altro cliente cui pulire tre pesci, albanese stavolta, con l’aria di chi va di fretta.
Fingendo di non averlo notato, ho riabbassato la testa per raschiare le squame dell’ultima spigola dell’italiano, ripulirgli la pancia, sciacquarla, avvolgerla dentro la carta, allungare il braccio e passare la busta, con un movimento deciso che ha indotto l’albanese ad avvicinarsi e allungarmi i suoi pesci, l’italiano finalmente a capire che non c’era più tempo e allora a farmi un sorriso dolce e un po’ divertito, come a dirmi che stavo sbagliando, che qualcuno mi aveva messo in testa stronzate, quindi – in un istante veloce, simile a quello in cui avevo abbracciato il coltello, il grembiule marrone e rosso di sangue, la baracca e le conche e il padrone – a guardare il tramonto, il mare pulito, la costa rocciosa, le colline verdi alle spalle, ed a dirmi un’ultima cosa prima d’incamminarsi e sparire per sempre dalla mia vista:
-E’ una terra bellissima, e si vive con poco.
A mezza bocca, senza sorriso, gli ho detto:
-Ma non è l’Europa.
 [Questo testo fa parte di un dossier curato dal Cartello (Forlani, Sartori, Schillaci e il sottoscritto) uscito nella rivista francese “La Revue Littéraire” e ora nel numero 68 di “Nuova Prosa” col titolo Esercizi di sopravvivenza dello scrittore italiano.]
[Questo testo fa parte di un dossier curato dal Cartello (Forlani, Sartori, Schillaci e il sottoscritto) uscito nella rivista francese “La Revue Littéraire” e ora nel numero 68 di “Nuova Prosa” col titolo Esercizi di sopravvivenza dello scrittore italiano.]
di Andrea Inglese
C’era la rivoluzione permanente. È un concetto di cui ho sentito parlare molto tempo fa, e qualcuno me l’ha pure spiegato.
di Orsola Puecher
Chi sono e dove si trovavano i bambini con i vestitini sporchi e stracciati come il monello di Charlot, i monelli come con arguta dolcezza qui nelle Marche si chiamano comunemente i bambini? 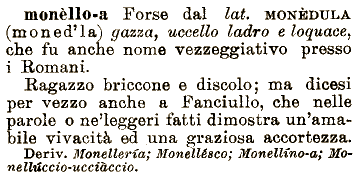 E i soldati e ufficiali della Wehrmacht sorridenti che li prendono per mano, le donne in posa, i neonati in carrozzina, le suorine ammassate a sbirciare da un balcone, poi con gli ombrelli neri? Nelle riprese sfocate del Dr. Tomuschat, ufficiale medico della Wehrmacht, ⇨giunte dopo molte traversie fino a noi nel terzo millennio dal secolo delle guerre, in un ordinato antico paesaggio rinascimentale di vigneti e fondi agricoli si riconosce la cinquecentesca Villa Selvatico Sartori di Battaglia Terme, Rovigo, sui Colli Euganei, con la sua lunga scalinata a terrazze, la quadrata sagoma massiccia, il belvedere tutto intorno, la cupola turrita. Edificata in cima al colle di Sant’Elena, detto fin dall’alto Medioevo “colle della Stufa” (o stupa) per la presenza di una famosa grotta sudorifera, la Grotta Radioattiva, per curare malattie e dolori articolari con il calore e le acque termali che sgorgavano dal sottosuolo, fu frequentata nel tempo da famosi personaggi: da Francesco Petrarca, al duca Francesco III di Modena, il filosofo Michel de Montaigne, lo scrittore francese Stendhal e il poeta tedesco Heinrich Heine. E li possiamo ancora immaginare, sudati e accaldati, seduti fra le rocce vulcaniche, avvolti in bianchi panni drappeggati come senatori romani, o dannati di un un qualche antro acherontico dantesco.
E i soldati e ufficiali della Wehrmacht sorridenti che li prendono per mano, le donne in posa, i neonati in carrozzina, le suorine ammassate a sbirciare da un balcone, poi con gli ombrelli neri? Nelle riprese sfocate del Dr. Tomuschat, ufficiale medico della Wehrmacht, ⇨giunte dopo molte traversie fino a noi nel terzo millennio dal secolo delle guerre, in un ordinato antico paesaggio rinascimentale di vigneti e fondi agricoli si riconosce la cinquecentesca Villa Selvatico Sartori di Battaglia Terme, Rovigo, sui Colli Euganei, con la sua lunga scalinata a terrazze, la quadrata sagoma massiccia, il belvedere tutto intorno, la cupola turrita. Edificata in cima al colle di Sant’Elena, detto fin dall’alto Medioevo “colle della Stufa” (o stupa) per la presenza di una famosa grotta sudorifera, la Grotta Radioattiva, per curare malattie e dolori articolari con il calore e le acque termali che sgorgavano dal sottosuolo, fu frequentata nel tempo da famosi personaggi: da Francesco Petrarca, al duca Francesco III di Modena, il filosofo Michel de Montaigne, lo scrittore francese Stendhal e il poeta tedesco Heinrich Heine. E li possiamo ancora immaginare, sudati e accaldati, seduti fra le rocce vulcaniche, avvolti in bianchi panni drappeggati come senatori romani, o dannati di un un qualche antro acherontico dantesco.
Nel filmato appare anche un grande edificio “moderno”, in stile ventennio, che è lo Stabilimento Termale INPFS, Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale: un suo padiglione era stato adibito in quegli anni a ospitare i molti orfani di guerra della zona. Cosa che giustificherebbe la presenza dei “monelli”.
Lo stabilimento idro-termale, costruito ai piedi del colle per preservare la littoria salute dei lavoratori, venne inaugurato in pompa magna nel 1936, alla presenza di autorità regie e fasciste, Piccole Italiane e Balilla e folla festante.
Nel ’43-’44 l’Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale fu requisito dal comando Tedesco per ospitare il Feld-Lazarett 95, ospedale da campo della 5a Gebirgs-division della Wehrmacht, una divisione di montagna paragonabile agli alpini. La 5a Gebirgs-Division dopo le vittoriose operazioni militari nell’isola di Creta nel ’41, che si conclusero però con grandissime perdite di uomini, dopo l’impiego nel settore sud-ovest di Leningrado, dove fronteggiò l’Armata Rossa fino al novembre 1943, contribuendo tra l’altro all’accerchiamento del cosiddetto “fronte Volchov” ma subendo anche là grandi perdite, venne trasferita in Italia settentrionale per un periodo di riposo. Dal gennaio 1944 entrò in azione sulla linea Gustav, scontrandosi anche nella battaglia di Montecassino. A settembre era sulle Alpi Marittime, e il 2 maggio 1945 si arrese alla 5ª armata statunitense nei pressi di Torino.

Nel filmato del Dr. Tomuschat compaiono ufficiali, soldati, in divisa, in maniche di camicia, in esercitazioni militari che paiono scampagnate domenicali, mentre brandiscono fiaschi di vino e bottiglie di prosecco, con bambini per mano e tutti sempre sorridenti e benevoli. Anche il saluto nazista con il braccio alzato è veloce, appena accennato, simile a un normale gesto di commiato. La gente qui è in posa di fronte agli shot di cinematografia amatoriale, con cinepresa portatile Agfa Movex e pellicola Agfa 8 mm del Dr. Tomuschat e non esposta, almeno per una volta, agli shot letali delle armi da fuoco di diverso calibro dell’esercito tedesco, ormai sconfitto e per questo ancora più incattivito, in quella precipitosa ritirata attraverso il Veneto, via di fuga diretta verso la Germania, detta comunemente marcia della morte per il numero di vittime di stragi, una lunga scia di atti di pura rappresaglia e crudeltà perpetrati contro una popolazione civile inerme e provata da anni di guerra.  Il filmato ricevuto e fatto sviluppare da ⇨ Home Movies di Bologna e diffuso sui principali siti dei quotidiani per vedere se per caso qualcuno, ancora dopo tutti questi anni passati, vi si riconoscesse, è ora oggetto di analisi da parte di storici e studiosi. In vari articoli che ne parlano si cerca di identificare, un po’ forzatamente, e forse inutilmente, al suo interno, fra la quotidianità pacifica della situazione tracce del Male Assoluto, che ha percorso l’Europa nella prima metà del secolo scorso. La quotidianità, l’esistenza di una quotidianità, fatta di gesti normali, insignificanti è quasi impensabile in periodi di guerra, eppure la vita andava avanti comunque, nonostante tutto, per tutti, vittime e oppressori. Ad essere oggettivi, cosa molto difficile in casi come questi, non ci si può sbilanciare nè sul versante della celebrazione degli alcuni, rari, nazisti buoni, oppure di quella certa vulgata in cui si distingue Wehrmacht buona e SS cattive, cosa che farebbe solo il gioco di un certo strisciante e mai morto negazionismo, ma neppure è possibile virare le immagini riprese di indizi di terrore imminente, come un po’ fa intendere il pur bel accompagnamento musicale di sottofondo. Il terrore è interiorizzato dentro noi che guardiamo il passato con il futuro alla spalle, nel nostro occhio che non riesce ad essere innocente di fronte alla storia e alla sue bufere. Come l’Angelus Novus di Klee-Benjamin:
Il filmato ricevuto e fatto sviluppare da ⇨ Home Movies di Bologna e diffuso sui principali siti dei quotidiani per vedere se per caso qualcuno, ancora dopo tutti questi anni passati, vi si riconoscesse, è ora oggetto di analisi da parte di storici e studiosi. In vari articoli che ne parlano si cerca di identificare, un po’ forzatamente, e forse inutilmente, al suo interno, fra la quotidianità pacifica della situazione tracce del Male Assoluto, che ha percorso l’Europa nella prima metà del secolo scorso. La quotidianità, l’esistenza di una quotidianità, fatta di gesti normali, insignificanti è quasi impensabile in periodi di guerra, eppure la vita andava avanti comunque, nonostante tutto, per tutti, vittime e oppressori. Ad essere oggettivi, cosa molto difficile in casi come questi, non ci si può sbilanciare nè sul versante della celebrazione degli alcuni, rari, nazisti buoni, oppure di quella certa vulgata in cui si distingue Wehrmacht buona e SS cattive, cosa che farebbe solo il gioco di un certo strisciante e mai morto negazionismo, ma neppure è possibile virare le immagini riprese di indizi di terrore imminente, come un po’ fa intendere il pur bel accompagnamento musicale di sottofondo. Il terrore è interiorizzato dentro noi che guardiamo il passato con il futuro alla spalle, nel nostro occhio che non riesce ad essere innocente di fronte alla storia e alla sue bufere. Come l’Angelus Novus di Klee-Benjamin:
IX.
C’è un quadro di Klee che si chiama Angelus Novus. Vi è rappresentato un angelo che sembra in procinto di allontanarsi da qualcosa su cui ha fisso lo sguardo. I suoi occhi sono spalancati, la bocca è aperta, e le ali sono dispiegate. L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Là dove davanti a noi appare una catena di avvenimenti, egli vede un’unica catastrofe, che ammassa incessantemente macerie su macerie e le scaraventa ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e riconnettere i frantumi. Ma dal paradiso soffia una bufera, che si è impigliata nelle sue ali, ed è cosi forte che l’angelo non può più chiuderle. Questa bufera lo spinge inarrestabilmente nel futuro, a cui egli volge le spalle, mentre cresce verso il cielo il cumulo delle macerie davanti a lui. Ciò che noi chiamiamo il progresso, è questa bufera.
Il nostro occhio, il nostro ricordo è sempre nell’attimo di pericolo e forse è giusto che sia così, perché il ricordare, la memoria, non sia un mero esercizio di nostalgia, di conformismo, ma la scintilla di speranza per i cui morti, le vittime, non muoiano due volte nell’oblio e nel ritorno della stessa violenza, sempre pronta a rinascere, a ritornare a vincere, e che mai non ha smesso di vincere.
VI.
Articolare storicamente il passato non significa conoscerlo «proprio come è stato davvero». Vuole dire impossessarsi di un ricordo così come balena in un attimo di pericolo. Per il materialismo storico l’importante è trattenere un’immagine del passato nel modo in cui s’impone imprevista nell’attimo del pericolo, che minaccia tanto l’esistenza stessa della tradizione quanto i suoi destinatari. Per entrambi il pericolo è uno solo: prestarsi ad essere strumento della classe dominante. In ogni epoca bisogna tentare di strappare nuovamente la trasmissione del passato al conformismo che è sul punto di soggiogarla. Il messia infatti viene non solo come il redentore, ma anche come colui che sconfigge l’Anticristo. Il dono di riattizzare nel passato la scintilla della speranza è presente solo in quello storico che è compenetrato dall’idea che neppure i morti saranno al sicuro dal nemico, se vince. E questo nemico non ha smesso di vincere.
Un dottore nazista con dei bambini con faciloneria evoca subito un qualche Mengele, eventuali terribili esperimenti su di essi, le donne le vedi come possibili deportate, rasate, nude, messe al muro, stuprate, i bambini ostaggi di rappresaglie, episodi realmente e iteratamente avvenuti, ma forse questo Dr. Tomuschat, era solo un medico militare che curava i feriti di guerra nazisti nel Feld-Lazarett 95 situato nello stabilimento termale. La cinepresa è amatoriale e quindi pare improbaibile che proprio in quel drammatico 1944 di ritirata, il film fosse girato per propaganda, ma bensì forse era solo per uso personale, per ricordo. Per raccontare a casa di un bel ricordo, da viaggio in Italia, che lavasse la coscienza dalla stragi di quel periodo, in quasi ognuno dei piccoli paesi vicini dei Colli Euganei. Il comando della Wehrmacht della zona, posto nel Collegio Vescovile della vicinissima Este, era in mano a un certo Willy Lembcke, protagonista di atti indegni. Qualcuno dei soldati sorridenti in pausa terrore del filmato vi aveva partecipato, vi parteciperà?
Nel suo romanzo La vita eterna [1972] ⇨ Ferdinando Camon, scrittore un po’ dimenticato ma che molto ha dedicato alla Storia del Veneto martoriato dai nazifascisti, descrive la crudeltà di Lembcke.
Sul far della sera arrivò nel paese una moltitudine di ragazzini tedeschi sui sedici anni, con cappotti più lunghi di loro che spazzavano la terra e le facce spaventate e perciò spaventevoli, e disponendosi metà a destra della strada e metà a sinistra, in totale silenzio come per una cerimonia sacra, cominciarono la loro processione. Dietro di loro venivano i tedeschi anziani che sopraggiungevano continuamente in camion e lasciavano i camion al crocevia incolonnandosi a piedi per la processione che andava a benedire le Sette Albare. In mezzo alla processione come una reliquia santa portata a spalle sul baldacchino veniva la faccia di pugnale del colonnello Lembcke sulla gip silenziosa che pareva procedesse a motore spento, e ai quattro lati della gip c’erano quattro ufficiali tedeschi che con la coda dell’occhio tenevano continuamente sbirciato il colonnello. Come arrivarono in zona, il colonnello ad ogni casa che incontrava pareva che si svegliasse da un sogno, perché illuminandosi di una luce sporca trasformava il pugnale in una faccia e con lo sguardo annoiato e sofferente toccava qualcuno dei quattro ufficiali, a destra o a sinistra del suo tronetto a seconda che la casa fosse a destra o a sinistra, e l’ufficiale così toccato si trasformava in bestia e schizzava via come un cane rabbioso e mordeva le file della processione che in un grande urlìo si scompigliava di qua e di là tutt’attorno alla casa come vesponi inveleniti, e poi saltavano dentro la casa per le finestre e per le porte, e per scoprire se c’era gente piantavano la baionetta sui letti trapassando i materassi e sugli armadi sforacchiando le porte e sulle madie e attraverso le tende dei sottoscala, sempre di corsa per le camere e saltando i gradini e nella fretta più volte scontrandosi tra loro con fragore di elmetti e ruotare delle occhiaie bianche senza pupilla, poi saltavano fuori per le finestre e mentre quattro si disponevano agli angoli della casa gli altri tornavano di corsa a riprendere il loro posto nella processione.
Sono casi questi in cui la colpevolezza collettiva di un intero popolo, cozza con l’innocenza individuale, effettiva magari in qualche caso, o pretesa, sempre. A tutti i processi di criminali nazisti, la scusa più usata per giustificare ogni tipo e grado di crudeltà e autoassolversi individualmente, non è sempre quella di aver ubbidito a ordini superiori?
Dando uno sguardo alla mappa dell’⇨ Atlante delle Stragi Nazifasciste in Italia, colpisce questa nuvola cosi densa di segni rossi delle etichette luogo di Google Maps, tale da non lasciare quasi intravedere l’orografia del territorio, e ingrandendo con lo zoom, ecco che si evidenzia come quasi ogni piccolo paese ne fu colpito in misura maggiore o minore.
Nel libro Soldaten, Garzanti [2012], lo storico Sonke Neitzel e lo psicologo sociale Harald Welzer analizzano i comportamenti brutali e la psiche dei soldati nazisti studiando i verbali degli archivi inglesi e americani, che trascrivono le intercettazioni delle conversazioni tra i soldati tedeschi rinchiusi nei campi di prigionia di Trent Park e Wilton Park, nel Regno Unito, e di Fort Hunt, in Virginia, Stati Uniti, e da cui emerge che quella violenza così incomprensibile era una violenza talmente profonda e ideologicamete radicata da essere davvero normale.
In Italia, in ogni luogo dove arrivavamo, il tenente ci diceva sempre “cominciate ad ammazzarne un po’ “. Io parlavo italiano, avevo compiti speciali.
[Dice un caporalmaggiore della Wehrmacht e un suo compagno di prigionia.]
Il tenente ci diceva, ammazzatene venti, così avremo un po’ di pace, alla minima loro sciocchezza via altri cinquanta. Ra-ta-ta-ta con le mitragliatrici, lui urlava, “crepate, maiali”, odiava gli italiani con rabbia.
I sorrisi dei militari della Wehrmacht non ci ingannano nemmeno per quei pochi minuti del filmato, ma forse queste immagini ci dicono molto di più dell’Italia del ’44-’45, di ville antiche e storiche, luoghi sacri o profani requisiti dai tedeschi e che spesso furono teatro di saccheggi, di torture, e di violenze di ogni tipo. E questi monelli ci raccontano la condizione di un paese ridotto a una miseria profonda da anni di guerra. Si fanno riprendere con maggiore o minore ritrosia, gli viene detto di certo Sorridi… sorridi…, si avvicinano agli uomini in divisa, ai loro mezzi con la confidenza e la curiosità che solo i bambini possono avere. Si fanno prendere per mano. Ma i visi già quasi adulti, già provati da mille privazioni, da una vita dura, anche oltre la guerra, che forse abbiamo troppo presto rimosso, con un cagnolino al guinzaglio, una canna da pesca in mano, i piedi nudi, le gambine un po’ rachitiche e sporche, i fiocchi nei capelli, nonostante, e le treccine ben strette intorno alla testa da mani sapienti, guardano diritto in camera, ci guardano e noi con commozione li guardiamo. Come ci guardano, e anche noi li possiamo guardare negli occhi, i soldati, a volte un po’ pingui, lo sguardo da padri di famiglia, spesso con un certo imbarazzo. La sagoma del Dr. Tomuschat curvo nel riprendere si sovrappone sotto forma di ombra per ben due volte. Ci siamo tutti sulla scena in questa pausa sospesa fra le violenze. Ed è forse per questo che l’emozione di questi quasi sette minuti che paiono apparire come per miracolo dalle code della pellicola con i loro disturbi di linee e di erosioni, non ci abbandona facilmente.

testo e foto di Dario Coletti
Più di altri il territorio del Sulcis Iglesiente può essere visto come punto di incontro tra più
di Mariasole Ariot
Da stasera, a Trento, comincia CinemaZERO. Tra le più importanti realtà cinematografiche, il festival si propone di far incontrare autori e opere all’insegna di una ricerca nazionale e internazionale – e al cui interno troviamo anche un concorso destinato a cortometraggi autoprodotti.
Per quanti avessero letto qui la recensione di Alberto Brodesco a The Good Intentions di Beatrice Segolini, il film verrà proiettato sabato 2 dicembre alle ore 18,15.

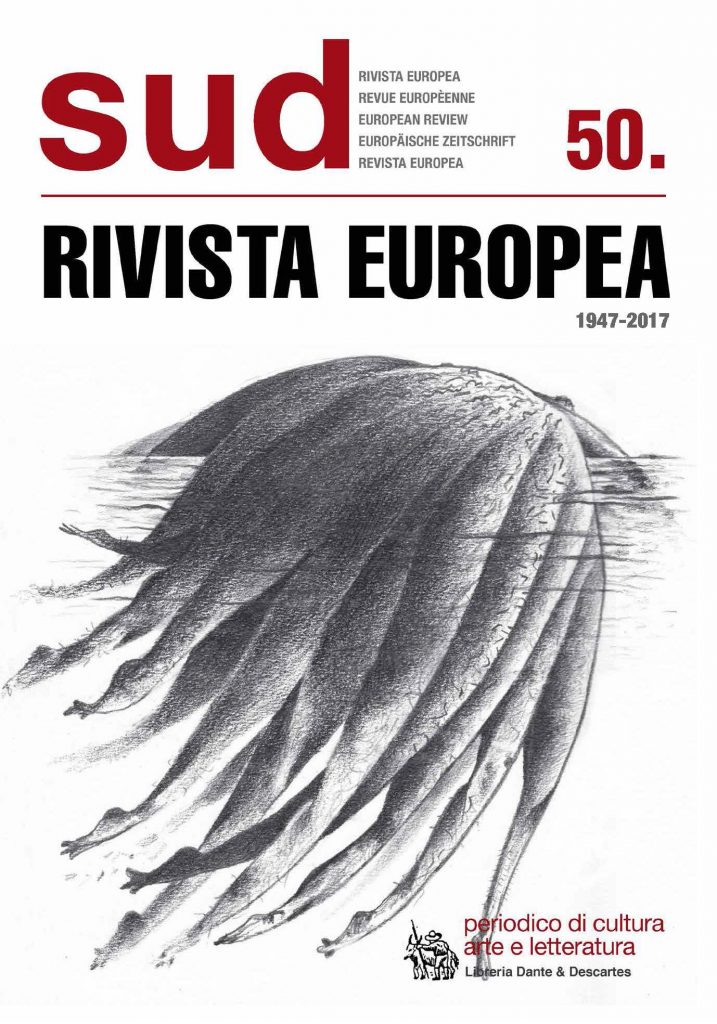
Tales from an european journey: Steven Brown e l’Europa dei Tuxedomoon
di Mirco Salvadori
traduzione a cura di Andrea Aguzzi
da Sud n°50
Sembrerà strano chiedere ad un americano nato in Illinois e residente in Messico cosa rappresentava il vecchio continente per chi, negli anni a cavallo tra i ’70 e gli ’80 lo vedeva da oltre oceano. Eppure è una domanda che giunge quasi spontanea, se pensata dopo aver conosciuto Steven Brown, la musica e il lungo percorso dei Tuxedomoon, una formazione che incarna la purezza dell’avanguardia cresciuta in un’Europa vissuta come terra ritrovata, forse mai del tutto abbandonata.
Mirco, prima di rispondere alle tue domande vorrei solo condividere alcuni pensieri sul tema più ampio riguardante il vecchio continente. Ho sempre creduto nel ruolo fondamentale degli artisti, lo stesso rivestito dai re, gli eserciti e le chiese nella creazione della futura Europa. Tra il ‘700 e l’800 del primo millennio, nel vostro continente sono vissuti Goethe e Byron e Shelley e Keats e Wagner, per citarne alcuni. Questi uomini attraversavano l’Europa, le Alpi, i fiumi e le valli spesso a piedi, prima ancora che tale luogo esistesse ufficialmente. Si potrebbe dire che già covava un ideale nelle menti dei grandi pensatori e artisti. Inconsciamente stavano tessendo un futuro basato sull’ identità europea. Già a quel tempo le frontiere per loro non esistevano: i trovatori, i protagonisti della commedia dell’arte e le piccole compagnie teatrali si muovevano costantemente, senza dimenticare gli innumerevoli pittori espatriati. In un certo senso i Tuxedomoon, con umiltà, hanno seguito il loro esempio come europei della seconda e terza generazione sradicata dall’Europa.
Per molti di noi, estimatori della prima ora, ascoltare brani come In A Manner Of Speaking o The Cage, Les Six, A Piano Solo, Egypt, Time To Loose, Soma, ecc. – tracce che ho scelto d’impeto, a memoria – rappresentava una sorta di salto indietro nel tempo, quell’ascolto ci portava a respirare l’atmosfera satura di frenesia artistica imperante dentro gli indefiniti confini di una mitteleuropa sempre vista come ricettacolo di passioni. La vostra musica ci immergeva nel fumo dei caffè letterari parigini e nella frenesia dei circoli lettarari del primo ‘900. Voi eravate coscienti del potenziale immaginativo scatenato dalle vostre composizioni, era quella la via idealmente percorsa dai Tuxedo o il vostro fine era altro.

Tu fai riferimento alla natura paradossale di un’intervista ad un americano che parla di Europa. Dire che un gruppo di musicisti e artisti provenienti da San Francisco è riuscito a trasportarvi nella Parigi fin de siècle e nel glorioso passato mitteleuropeo può suonare assurdo. Poi però penso ai Rolling Stones, gli inglesi che hanno introdotto milioni di persone, negli Stati Uniti e in tutto il mondo alla musica afroamericana del ventesimo secolo. Oppure i Beatles che si sono evoluti da “I wonna hold your hand” alle tecniche in studio di Stockhausen. Per molti di noi il primo contatto avuto con Stockhausen e la tape-music è arrivato attraverso interviste con i Fab Four. Ecco, forse abbiamo bisogno di condotti o di filtri per elaborare i nostri sogni e i nostri desideri nascosti. Altri esempi potrebbero essere Philip Glass, Steve Reich e Terry Riley, che trasformarono il mondo attraverso il proprio suono usando stili impensabili come per esempio la musica minimalista orientale di Bali e non solo.
A volte il termine “straniero” “étranger” “outsider” ci fornisce solo il giusto contatto per apprezzare qualcosa che non potremmo altrimenti percepire. Un esempio di questa torsione o cambiamento di percezione provocato dallo “straniero”, anche se negativo, è il cosiddetto “Malinchismo”, qui in Messico.
Malinchismo si riferisce all’idea comunemente diffusa in questa terra, che qualsiasi cosa straniera sia migliore o preferibile a qualsiasi cosa nazionale, sia essa formata da uomini o oggetti.
Il nome deriva da “la Malinche” la donna indigena che è diventata amante di Hernan Cortez. La donna mayana che ha preferito l’europeo alla propria gente.
Certamente siamo stati immersi nella musica europea per lungo tempo prima di arrivare in Europa. Ricordo di aver usato Schoenberg per una colonna sonora di un film super 8 realizzato al liceo e ancora, al San Francisco City College ho conosciuto Blaine (Reininger), assieme andavamo a vedere le mostre sui futuristi e amavamo ascoltare i Kraftwerk, Bowie e Eno, per dire.
Che aria si respirava nella San Francisco fine anni ’70.
San Francisco, a metà degli anni settanta, era ancora immersa nel crepuscolo dorato degli anni Sessanta. Ho vissuto in un comune del distretto di Haight; gay, uomini, donne e cani tutti vegetariani e tutti talentuosi artisti a tempo pieno.
Ci siamo formati come tutti, in quei tempi, all’interno di questa comune dove ho avuto la ventura di diventare un membro del gruppo chiamato Angels of Light. Figli e figlie di Duchamp o Breton che hanno lavorato a rendere la vita quotidiana un’opera d’arte, anche grazie alle loro produzioni teatrali. Nessuno di noi andava al negozio all’angolo senza indossare qualche costume o altre stravaganze. Dal lato politico gli Angels erano sostenitori della cultura “free” di San Francisco. Credevamo che tutta l’arte doveva essere libera. Gli Angels non facevano mai pagare un biglietto e per farne parte non potevi avere un lavoro normale (un’influenza del situazionismo?) o essere coinvolto in qualsiasi cosa che comportasse un pagamento. E così quando ho iniziato a suonare con i Tuxedomoon in bar o in locali dove si facevano pagare ho dovuto lasciare il gruppo. Erano tempi inebrianti.
Il Punk ha aperto i portali, ha rotto la musica commerciale che ci ha tenuto in scacco per anni. E anche se in un primo momento fu difficile, fu grazie a questa ribellione culturale che la creatura Tuxedomoon poté crescere.

Che ne pensavate del movimento di protesta europeo di fine anni ’60, aveva lasciato traccia nella San Francisco psichedelica di quegli anni?
Il movimento studentesco e quello dei lavoratori del ’68 si era diffuso oviamente in tutto il mondo. Per quanto riguarda il suo impatto su San Francisco negli anni ’70 però, la mia sensazione è che la Bay Area si fosse già reinventata tutto senza l’aiuto di Parigi… le comuni, le cooperative, gli hippies i movimenti neri e quelli delle donne e poi i gay, tutto era già accaduto negli anni ’60! C’era uno zeitgeist vero. Ecco il perchè del nome “Holy Sixties”. A Berkeley si, loro erano più in linea con quello che stava accadendo in Europa in quel momento.
Quale è stato il vostro primo contatto con la cultura europea contemporanea e cosa vi ha spinto ad attraversare l’oceano.
Il mio primo contatto è avvenuto attraverso la musica e il cinema: Kraftwerk, Bowie, Eno, Fellini, Pasolini, Fassbinder. I loro messaggi parlavano di un altro spazio e del tempo, qualcosa di diverso e nuovo. Qualcosa di più serio e interessante degli USA. Winston (Tong) e Bruce (Geduldig) erano già stati in Europa come duo, l’agente di Winston a Parigi è diventato l’agente europeo di Tuxedomoon e via, ci siamo diretti verso l’Europa che per noi era come un altro pianeta. Quando abbiamo deciso che era ora di lasciare San Francisco pensavamo di avere 3 opzioni: Los Angeles, New York o l’Europa. Abbiamo scelto quest’ultima in parte incoraggiati da Winston; in un modo incredibilmente ingenuo, quasi infantile, siamo saliti sopra un aereo e abbiamo iniziato a muoverci senza piani prestabiliti, siamo andati… e siamo rimasti.
Come si immaginava Steven Brown questo continente, la sua cultura e come lo ha realmente trovato una volta sbarcato dentro i suoi confini nei primi anni ’80.
Il primo anno trascorso a Londra e poi a Rotterdam fu quanto di più lontano dalla scena californiana ci si potesse immaginare: freddo e grigio… persone e paesaggi. Penso che in qualche modo la mia natura malinconica ne fosse felice. Ma alcuni di noi si lamentavano molto, desiderando il calore della California.
Ricordo che durante il nostro primo giro in Olanda eravamo in un furgone e cercavamo il posto in cui avremmo dovuto suonare (un centro giovanile sponsorizzato dal governo, sconosciuto negli Stati Uniti). Abbiamo chiesto informazioni ad una ragazza in bicicletta che ci ha detto di seguirla. Le siamo stati dietro per qualche chilometro, abbiamo seguito quella ragazza su una bici per qualche chilometro e siamo arrivati alla nostra destinazione grazie al suo aiuto. Questa prima percezione degli Olandesi e dell’Olanda è stata confermata nel corso degli anni. Naturalmente ci sono molte altre storie in altri paesi … ma un’altra volta? Un altro posto? Forse…
Che mi dici della nostra penisola, quella che mi sembra sia come una vostra seconda casa.
Mia madre era italiana. Il suo cognome era Fuga. L’architetto del XVIII secolo Ferdinando Fuga è un parente lontano. L’Italia è diventata una seconda casa, sì. Ogni volta che visito il vostro Paese non vorrei più andarmene. Qui si ncontrano nuovi amici, si impara la lingua e si conoscono sempre nuovi luoghi. La bellezza fisica dei paesaggi, la storia, l’arte… inebrianti.
Due sono le domande che volevo porti da tempo, questa occasione mi permette di farlo. Quale secondo te, tra tutti i lavori dei Tuxedomoon, é quello pensato e ideato con modalità contenuti ed intenti cari al vecchio continente.
La risposta ovvia a questa domanda è il poco conosciuto “Les Six” dal cd Joeboy in Messico.
La seconda ed anche ultima domanda della nostra chiaccherata: Luigi Tenco.
Un’estate dovevo fare la cover del disco di un cantautore italiano degli anni sessanta. Ho chiesto per i suggerimenti. Penso sia stata Velia Papa ex agente italiano dei Tuxedomoon e direttore del Festival di Teatro Polveriggi che mi ha fatto conoscere questo cantante. Alla fine dovevo scegliere tra Gino Paoli e lui. Mi piacevano entrambi ma ho scelto Tenco perché è il cattivo ragazzo dei due. Mi piaceva la tensione e la tematica delle sue canzoni… e naturalmente “suicide is sexy”.

Come in tutte le intervista canoniche il finale è destinato al tempo a venire, tuo e dei Tuxedo. Ce lo sveli?
Cinema Domingo Orchestra è un progetto che ha le sue radici nella Bruxelles dei primi anni novanta con il vecchio amico Alain Martel, una collaborazione continuata qui in Messico negli ultimi 15 anni. Siamo un gruppo di 4-6 musicisti che compongono e realizzano le colonne sonore per film muti poco conosciuti. Quello che è iniziato come intrattenimento fai da te con gli amici, è diventato un progetto professionale che ora coinvolge festival e teatri in tutto il paese. L’anno scorso siamo stati commissionati per la seconda volta dall’Istituto Goethe del Messico per mettere in musica gemme silenziose recentemente restaurate e poi suonare per le loro prime nazionali. Il 2 novembre di quest’anno, per il Giorno dei Morti, ci esibiremo con il film italiano Rapsodia Satanica di Nino Oxilia del 1917 che vedeva la diva Lyda Borelli come protagonista. Sorprendente simbolismo di mixaggio cinematografico e immagini preraffaelite con la storia di Faust in versione femminile, decorazioni art nouveau e sezioni dipinte a mano.
Ensamble Kafka è un quintetto inaugurato nel 2010 dopo aver messo in musica il film documentario El Informe Toledo del regista Albino Alvarez. È stato nominato per un premio accademico messicano. Julio Garcia è il fedele compositore e il mio partner in Kafka. Suona l’oud, la jarana, la chitarra. Gli altri strumenti sono Tuba, Trombone, Tromba e io con il sax e il clarinetto. La nostra è musica contemporanea messicana. Mentre giochiamo con i brani messicani tradizionali, il nostro obiettivo è quello di creare una nuova musica tradizionale. Abbiamo appena finito il nostro secondo cd. Lo pubblicheremo presto
Nel 2014 Blaine (Reininger) è venuto a Oaxaca per un mese e abbiamo composto e registrato Monte Alban. Pubblicato su Independent Recordings nel 2015, la musica è per pianoforte, violino, organo e sax.
L’estate scorsa, mentre eravamo a Bruxelles a fare le prove per il tour imminente, Peter Principle improvvisamente ci ha lasciato. Peter (Pierre) era la roccia dei Tuxedomoon. Ha creato il terreno su cui poter resistere, lui era il fulcro. Uno dei tre sul palco, quello che sosteneva tutto il lavoro.
Purtroppo ci ha abbandonati, rimaniamo Blaine, Luc (Van Lieshout) e io, continuiamo a lavorare insieme, come da quarant’anni a questa parte.
L’ultimo disco dei Tuxedomoon e l’ultimo registrato con Peter è Blue Velvet Revisited insieme al gruppo Cult With No Name. È una colonna sonora per un bellissimo documentario fatto oltre 30 anni or sono da Peter Brantz durante la realizzazione di Blue Velvet di David Lynch.
Senza nessun suono sincronizzato e con una bellissima fotografia questo film evoca la magia di Lynch in modo veramente originale.
Joeboy continua a viaggiare, Joeboy continua a suonare.
intervista pubblicata su Sud n°50
Questa poesia nasce da un racconto molto personale sull’eccidio di Santomoro, avvenuto il 22 giugno 1944. I fatti sono riportati in varie pubblicazioni locali, ultima in ordine di tempo: C’era una volta un torrente che scorreva lungo un piccolo paese, nato su una strada che portava alla Badia… a cura di Laura Bassareo per il Centro Sociale di Santomoro, stampato in proprio nel 2017. Serrantona è la località dove si trova il cippo dedicato alle vittime. Un altro cippo, dedicato a tutti i caduti del paese nelle due guerre, si trova sotto la chiesa di Santomoro. “Non vi è nulla di nuovo sotto il sole” (Ecclesiaste, 1:9). La mia scelta di pubblicare qui questa poesia ha un valore di testimonianza, certo, ma è anche un atto di gratitudine, per tutto quanto questo piccolo paese in cui sono tornata a vivere mi continua a insegnare, anche in tempi cupi, come quelli che viviamo (ndf).

di Francesca Matteoni
Tra una donna di ottant’anni e una bambina
che ancora non va a scuola
passa una vita oppure un corpo
che diviene e si infittisce
ma anche l’altro che stranisce
nella fossa privata della storia
o nel cipresso chiuso
della Serrantona.
Non vi è nulla di nuovo sotto il sole
in un posto minuscolo si scuce
la rete del cielo, si scompare
si ripongono i resti sotto un fiore.
Vennero all’inizio dell’estate
ne presero cinque
per il soldato che si ferì da solo
e non lo voleva confessare.
Io non so come sia morire
per il calcio del fucile
la bocca sulla terra e scava
respira tutto
com’è forte ridere, esserci, tremare
non strappare più l’erba per gioco –
il prato a testa in giù dove si è liberi
per poco, sprofondati
tra gli animali minimi del suolo.
Uno era anche il tuo babbo e mi hai detto
che non sai più che viso avesse
una voce che viene e non si vede chi parla
una bambina che corre e non urla
sotto il cancello del cimitero.
Ci stanno cinque scale coi pioli
Ci stanno cinque morti senza chiodi
legati dai paesani con stupore
per non farli cadere sul selciato
legati con pietà o con dolore
legati con il sangue alle colline
come si lega il male alle memorie.
Non resistono giorni abbastanza
per tradire il passato
io non so come sia dopo aver ascoltato
perché poi bisogna crescere, andare
dimenticare
eppure sta questa nostra amicizia
tra il torrente gentile della Bure
e l’umano non trascorso
come un tempo presente, tutto intero.
Dove nasce un paese, dove finisce
dove vanno le cose che sappiamo
dove t’incontro, dove si accampa il vero?
Dove sono coloro che amiamo?
E io dov’ero?
Perché mente chi dice che non c’ero.
Si ricompone in sogno la bambina
quello che è fratturato si fa saldo
sentire che ogni giorno ricomincia
l’impresa disumana di tenere
le briglie troppo corte dell’amore
e più le tiro più ci fanno stretti
ci allacciano dispersi in un racconto
dove ora abbasso gli occhi per capire
costringo questo soffio di futuro –
dove eravamo tutti, ma tu eri una soltanto
anch’io provavo a vivere lì accanto.
di Viola Amarelli
(è uscito per i tipi di Sartoria Utopia “Il cadavere felice” di Viola Amarelli, di cui riportiamo alcuni estratti)
da narrazioni
– di cosa parlano?
– al dunque, niente
sorda sirena
I.
da qualche parte, in qualche tempo, qualcuno
II.
il conto, infinitesimale, del
macellaio
III.
ammutola per scanto, stanchezza
delle labbra, fatica delle sillabe
IV.
da qualche parte qualcuna scuote le anche
lì vuoto chaos
la nascita del mondo
V.
aironi, fenicotteri, libellule
ma le poiane pure hanno il loro ruolo
scarnificano, pulendo all’ossoessenza
quello che resta, quel che m’interessa.
VI.
dite qualcosa, io vi dirò altro
VII.
e molti, molti addii, alle prossime volte
da cronache
I.
aveva pensato di avere
una vita diversa, una vita migliore
fuori di gabbia, lui e i canarini
II.
cerca un buco, una tana
per barricarsi, darsi al formaggio
ma senza veleno per topi
III.
dalle stelle alle stalle
e nessuno che porti la biada
***
l’imbecillità dilagante
niuna nova
lo starsene da soli
la risposta
il silenzio lungo il bordo
il frattale, della costa
il colore sbiadito delle ossa
da dèmoni
vi vedo dietro il vetro,
non vi tocco, un lucido delirio
l’urlo muto, pesci:
chi è il morto
morto morto morto
fare il morto sull’acqua
vivo
passa il sale
sale le scale avvolge il suono
emette e squaglia
gioia
per poco
siate siate gioiosi
l’intento tenace
non s’ulcera più
lo sbrego, diruto
l’io spiritato,
arso, scomparso
il truciolo sbriciola
novo, un tarlo suicida per fame
la vittima in progress
(il prezzo, alto/basso)
Spett.li
Come già
Nel rimarcare
Non si ha modo
Riscontro
Saluti saluti saluti
Molto vi piango
per gli affollati dèmoni che siamo
amplifica: miriadi di voci
***
uno sciame di mediocrità
ronzanti sulla polpa – quel che resta –
sull’osso, ma
il cadavere – dicono – felice
da φαντασματα
VI.
la canna di bambù piegata
tel quel, identica
la curva e la postura,
l’indistinto fruscio della palude.
da cerchi
potresti scrivere una poesia semplice?
certo, una parola sola
affetto
e un dono: mangiare insieme pane e pomodoro
salto, lieve, di festa come la tua vita
nel balenio di coda, corsa che
danza
***
me ne
vado (a vanto) del
te ne avvantaggi, varco, antro,
quando, in due, troppi
il cappio e il ceppo
dei vari modi del saggio
costeggiando, morte dell’amoroso
vento
ostaggio
l’agio, il solitario
***
“ho perso, ho perso, ho perso”
ma non ricorda più cosa
da vincere ci fosse”
—————–
Venerdì 1 dicembre alle ore 18,30 il libro verrà presentato a Milano, all’Officina Coviello, via A. Tadino, 20 con la partecipazione di Viola Amarelli ed Enrico De Lea
 Domenica 1 luglio 2012.
Domenica 1 luglio 2012.
Siamo nell’ex convento dei Cappuccini di Mesagne. È il secondo e ultimo giorno della Terza festa di Nazione Indiana.
La cittadina che ci ospita porta ancora il lutto per Melissa Bassi, la studentessa uccisa il 19 maggio da una bomba fatta esplodere vicino all’ingresso della scuola a Brindisi, ferendo altre sei compagne scese dallo stesso autobus. A causa della presenza della SCO e al fatto che il bersaglio è un istituto dedicato a Francesca Morvillo Falcone, sulle prime si è pensato alla pista mafiosa. Invece quella strage è un atto di terrorismo individuale.
«Beninteso, “individuale” non è automaticamente sinonimo di “folle”. Potrebbe segnare invece l’irrompere di forme di terrorismo nichilistico-individuale nel nostro paese, un tipo di terrorismo nord-americano o nord-europeo. Si pensi ad esempio a Breivik, l’autore della strage di Utoya, o alla vicenda narrata nel bellissimo libro dello scrittore svedese Gellert Tamas, “L’uomo laser” (Iperborea): si racconta la biografia di un “uomo della porta accanto” che inizia a sparare con un fucile munito di mirino laser contro gli immigrati, colpendo una quindicina di vittime individuate a caso.» Alessandro Leogrande lo scrive a pochi giorni dall’attentato sul Corriere del Mezzogiorno.
Alessandro accetta dunque di passare un pomeriggio con noi “indiani” a Mesagne per ragionare insieme delle molte cose di cui si è occupato: le trasformazioni della Puglia, del Sud e dell’Italia, le mafie, l’inadeguatezza mediatica, la fame di un complesso realismo che impronta il lavoro di molti Narratori degli Anni Zero, inclusi nell’antologia curata da Andrea Cortellessa.
Nella sala c’è l’attenzione di un piccolo convegno, visto che non siamo in tanti. Colpa anche di una grave svista nel far cadere la “Festa di Nazione Indiana” proprio su quel fine settimana. C’è la finale degli Europei con l’Italia che, dopo aver sconfitto la favoritissima Germania, deve giocare contro la Spagna.
Alessandro Leogrande ama il calcio. Lo conosce benissimo, si muove con agio straordinario negli annali di campionati lontani nel tempo e nello spazio. Nel 2010 ha curato un’antologia per “Minimum Fax” intitolata Ogni maledetta domenica.
La domenica sera del 1° luglio 2012 la Nazionale perde 4 a O nello stadio olimpico di Kiev.
Noi a Mesagne siamo tutti nel cortile dell’ex-convento, con gli occhi fissi sul muro che ci serve da sfuocato, improvvisato maxi-schermo. Ci siamo organizzati con pizza e birra come un qualsiasi gruppo di amici o di parenti. È bello ricordarlo così, che s’infervora per un tiro sbagliato, ancora in mezzo a noi, Alessandro Leogrande.
⇨ Alessandro Leogrande su Nazione Indiana

di Biagio Cepollaro
VII
al ruotare del pianeta l’aria
anche questa volta acquista
in dolcezza: anche quest ‘anno
ci sorprende come un dono
si disse che guardato dalla fine
solo l’amore è cosa che val la pena
di realizzare e con ciò non s’intendeva
una situazione ma il modo globale
di fare mondo -dentro standoci- e
in ogni cosa da fare -facendola
ma quando tutto questo sta
nel palmo di una mano
ogni cosa mostra suo nome
e sopra tutto oltre la mano
c’è il nulla dell’esser già
passati altrove o in niente
è così difficile tollerare questa vista
contare con le dita di cosa è fatta
poi la propria vita
e
nome
per nome
avere coscienza
di questo passare: è la malinconia
che si accompagna all’intensità
del desiderio che quando è sano
ha sempre inizio e fine
noi –diceva saggia- andiamo
in giro da sempre a chiedere
l’essere da qualcuno
dall’inizio
dal primo sguardo
a fuoco
di neonato oltre il primo
riconoscimento
a fiuto
e la completezza che cerchiamo
nel darci da fare o nello stare
fermi lasciando avvicinare
è cosa che sfugge in breve:
ogni giorno daccapo cerchiamo
il ciclo al suo ritorno quell’attimo
solo che poggia a terra il piede
e sembra senza peso per potere
andare
*
e insomma ora che fare? la scomparsa
dei racconti del mondo in una dittatura
mondiale ci lascia l’uso
solo di una parola
lunga come dura la nostra vita: sarebbe
altrimenti restata sullo sfondo ma ora
è l’unica da svolgere così come di un giorno
si racconta dall’alba
alla notte il farsi
e il disfarsi
di inezie
–come il Tao
che chiedeva come può la durata
di farfalla saperne di stagioni
così noi con la storia –
(nel Paese
occupato non collaborare con nemico
è ricerca di un’altra lingua pur sempre
parlando nella propria pur sempre
restando comuni –anche se di comunità
privi)
siamo in attesa di quel che accade
e forse per questo
stiamo accadendo: ci difendiamo
poco e senza riassumerci
in un motto
avanziamo: le cose
possono anche all’improvviso
avere un nome
nuovo
oppure tranquille
persistere in una loro
faticosa
scorrevolezza
di qui il disagio quando si sta
in mezzo a gente
che fa progetti
che fa e non si capisce
per cosa e perché
come uno che manca
per troppa presenza
come uno che non sa
vuota la natura di quella
presenza
*
diciamo che siamo stanchi
dei teatrini altrui
e nostri
che piuttosto ce ne stiamo
buoni e zitti
da qualche parte
come chi abituato
a lottare
in un campo
un bel giorno scopre
che il campo
non c’è più
-che questo è accaduto:
la poesia nel Paese
occupato
come in genere la rosa
dei simboli in cui
dice di sé
la vita
non c’è più: ancora
si scrive e si pensa
ancora si fa arte
ma da un’altra parte
(una volta si rifugiavano
sulle montagne
preparando imboscate
ora si sparisce nei monitor
e il bosco è salvaschermo )
NOTA
Da Lavoro da fare (2002-2005), Dot.com Press, Milano,2017.
L’immagine, Ibrido digitale n.3, 2008 di Biagio Cepollaro, funge da copertina del libro.
Qui viene pubblicata la parte VII del poemetto che consta di otto parti e un prologo. Lavoro da fare uscì come e-book nel 2006 con la postfazione di Florinda Fusco. L’edizione cartacea del 2017 comprende, oltre all’originaria postfazione, anche i contributi critici di Giuliano Mesa e di Andrea Inglese. Il saggio di quest’ultimo , diviso in due parti, è rintracciabile qui e qui. Reazioni, interventi e video relativi al poemetto sono raccolti qui e qui.
di Enzo Campi
In linea di massima e per quel che mi riguarda, basterebbe dire che quest’opera è costituita da una serie di poesie erotiche o, se preferite, aggiungere un’etichetta di genere: «omoerotiche», e il discorso sarebbe già chiuso. Non ci sarebbe bisogno di aggiungere altro. Non tanto per lo specifico dell’opera di cui qui si vagheggia, ma per il «genere» che, nella maggior parte dei casi, rasenta i territori del risibile e del grottesco. Non è facile destreggiarsi dignitosamente in quest’ambito. Scrivere una «buona» poesia erotica è un po’ come scrivere una «buona» poesia comica. È difficile, tremendamente difficile. Per questo il prodotto che ne viene fuori è spesso scadente, o comunque dozzinale e scontato. Credo che chiunque pratichi questo genere debba chiedersi come sia possibile evitare questa incombenza. Ma vista l’eccedente presenza-a-sé che pervade l’opera, credo che non sia stata questa una delle preoccupazioni dell’autrice, quella cioè di trovare una risoluzione a questa eventualità. Comunque, partendo anche da questi presupposti, si potrebbe aggiungere un plusvalore all’impostazione formale e grafica con cui l’opera si presenta a noi. Perché si tratta, a tutti gli effetti, di una scelta. Le dichiarazioni dell’autrice in tal senso non lasciano adito a dubbi. Si tratta di una raccolta di poesie concepite in un arco temporale piuttosto ampio, compreso tar il 1986 e il 2015, e la cui forma originaria era quella di una versificazione piana e distesa, ovvero lineare. Il corpus testuale originario di queste poesie non prevedeva l’uso di diversi formati, caratteri, dimensioni, l’avvicendarsi, quasi furioso, di corsivi, tondi, grassetti, il ricorso ad apici, pedici, parole barrate, delocalizzazioni spaziali e quant’altro concorre alla forma definitiva che è stata poi fissata sulle pagine. Solo dopo aver deciso di farne un libro le liriche originarie hanno subito una trasformazione, per così dire, sperimentale, avvicinandosi a quello che è stato, da molti, definito come una sorta di manierismo futurista. Ma, al di là di una certa predisposizione intenzionale dell’autrice e di una vicinanza alla fenomenologia visiva futurista, non credo che l’etichetta sia calzante, non completamente almeno. Dico questo almeno per due ragioni. La prima consiste nel fatto che le parole in libertà futuriste non avevano un’impronta lirica e queste poesie, checché se ne dica, sono essenzialmente liriche. La seconda è che il ricorso ad espedienti grafici comunque conserva un andamento ordinato, lineare, decisamente consequenziale, e quindi non entra in un regime di stretta parentela con i vortici tipografici delle parole in libertà futuriste. Certo, se andiamo a soffermarci sulle minime differenze strutturali di costruzione grafico-spaziale possiamo anche trovare testi contenenti passaggi più affini alla strutturazione futurista (p. 57, 58, 62, 104, 133, 138, ecc.). Ma le eccezioni più evidenti sono più che altro di tipo calligrammatico, un po’ alla Apollinaire tanto per capirci, come ad esempio nella poesia denominata “Lacrime” (p.35). E anche altrove, il dispositivo para-calligrammatico si rende funzionale spezzettando una singola parola nelle lettere che la compongono e imprimendola sulla pagina in verticale dall’alto verso il basso, in un processo sinonimico tra concetto e risoluzione grafica, come ad evidenziare, per esempio, una caduta (“colante”, p.141; “pioggia”, p.123; “lacrimare”, p.99, e via dicendo). Del futurismo, classicamente inteso, resta comunque un’eco idealizzata, persiste cioè una vicinanza elettiva, forse rivolta a spiazzare il lettore attraverso una messa in scena egotica/dispotica (di cui vedremo meglio più avanti).
Detto questo si abbisogna di una ripartenza.
“Dove fu così, devo venire”.
La citazione è di Freud, citazione che vado a ri-definire in: “Dove fu così, devo (av)venire”. Mi sembra evidente che la «venuta» cui si accenna abbia almeno una doppia valenza, e che l’avvenimento o, se preferite, l’avvento possa istradarsi lungo diversi e contorti sentieri. Si dice che i sentieri debbano essere battuti, ovvero: praticati. Ma qui c’è la volontà preminente di battersi e di praticarsi nel tentativo di conferire logica formale e ordine concettuale alla venuta e all’avvenimento (“e quando ti sento cercarmi / le mani nella brezza immobile vaganti nel vago di un soffio / la guazza immota di sperma colato / rapprende in saliva alchemica / i nostri frementi e pulsanti torrenti di linfa e parole” [p.59]). E ciò avviene propriamente «a posteriori» , si potrebbe dire col senno di poi. Quindi il nostro “dove fu così” va identificato in quel tempo che è già stato vissuto ma che continua a caratterizzare sia il presente che l’a venire. Tutto ciò che, in arte e in letteratura, rinvia ad un a venire è comunque sintomatico di una progettualità. Ed è così che le singole lettere o le singole parole sono divise in blocchi concettuali dove il significato risiede a monte e il significante invece si configura, a valle, anche a livello prevalentemente visivo.
Perché ho citato Freud?
In quest’opera non si dà un punto d’arrivo, non un solo punto d’arrivo almeno. Sarebbe buona norma quindi concentrarsi sul punto di partenza. Il mio personale punto di partenza consiste in un lapsus che si potrebbe definire freudiano. Quando a Maggio del 2016 presentai quest’opera, in uno degli eventi del Festival Bologna in Lettere, citai testualmente «eteromaculae» invece che «erotomaculae». Comprenderete che, in un’opera dove viene celebrato e idealizzato l’amore saffico, pronunciare la parola “etero” rappresenti una sorta di contraddizione in termini. Ma, al di là dell’aneddotica, non credo che Freud possa assumere il ruolo di referente dell’opera. Forse, con una leggera forzatura, si potrebbe tirare in ballo Lacan, ma solo nei termini del «godimento» del soggetto scrivente verso l’oggetto attraverso il quale si estende o, se preferite (tanto per restare in ottica lacaniana), si estroietta. Il soggetto scrivente è naturalmente l’autrice (con tutte le accezioni di presenza/assenza/essenza che qualcuno potrebbe conferirle) e l’oggetto estroiettato è l’opera che induce l’autrice al godimento. Qui si tratta di «gettare» qualcosa. La gettata di Caporossi, con buona pace di Heidegger prima e Derrida poi, non rappresenta necessariamente un atto liberatorio ma un tentativo d’edificazione. Non tanto l’edificazione di una struttura (che comunque c’è) quanto l’edificazione di una consapevolezza comportamentale, per quanto non ci sia psicoanalisi che possa tenere le redini di una poesia erotica o omoerotica, così come non ci sono un inconscio o un subconscio da far riaffiorare, non necessariamente almeno. Il nostro “dove fu così” è già «venuto» e si è già consolidato.
Come districarsi allora in questa res extensa che erotomaculae mette al lavoro?
O meglio quali sono gli aspetti da evidenziare senza cadere nel tranello freudiano del “dove fu così”?
Si abbisognerebbe, forse, di un’altra «venuta», della venuta dell’altro che guarda da fuori. Un occhio esterno che dovrebbe indagare per poter argomentare, o quantomeno congetturare. E qui c’è da stare attenti a non trasformare l’atto dell’occhio esterno in una pratica voyeuristica, cosa che potrebbe intrigare un Bataille o un Klossowki ma che non sarebbe funzionale alla creazione di un «mezzo differenziale» che sveli, che porti all’aperto, che es-tenda le valenze significanti dell’Eros qui praticato e idealizzato come modus vivendi (“fibrilla il mio impavido peritoneo / sento che danza nell’etere in fiamme / il nostro sacro amor greco di sole” [p.56]).
Di quest’opera, o meglio del suo senso complessivo e della sua particolare ed eccedente «messa in forma grafica» conosciamo i pensieri e le opinioni profuse dall’autrice nel corso delle presentazioni pubbliche e nelle dichiarazioni programmatiche fino ad arrivare a qualche recensione e interviste presenti in rete. Sarebbe quindi pressoché inutile ri-proporre gli aspetti-chiave della strutturazione dell’opera, dalla rivendicazione di una matrice futurista (su cui comunque ho già puntualizzato) ai riferimenti più o meno espliciti a certi canoni della poesia greca antica, dell’elegia latina e del dolce stil novo, dalla presenza fantasmatica di Saffo alle chiare dissertazioni filosofiche su un’esserci che, per quanto sembri consolidato, è sempre da ricercare, e via dicendo.
Per evitare quindi di risultare prolissi e ripetitivi ci toccherà concentrarci su qualcosa di altro e provare ad entrare nelle pieghe di questo diktat sovrastrutturato.
Ci troviamo di fronte ad una serie di esperienze vissute da donna a donna, e consumate quindi con una serie di donne. Il regime è essenzialmente al plurale. Se ognuna di queste donne dovesse essere considerata come una musa ispiratrice: (“come fai a non capire che sei un essere divino / che la materia che ti compone è il punto zero del cielo” [p.101]), ci troveremo al cospetto di una serie di muse. Nell’impossibilità di citare tutti i passaggi significativi che pervadono l’opera, solo un’altra occorrenza che mi sembra, in tal senso, esemplare: “tu aggiungi forma all’informe / come il calco di un riflesso diamantato che rivela accecando […] tu aggiungi parole ai pensieri / modelli le onde proteiformi delle maree cerebrali […] tu aggiungi vita alla vita / tu aggiungi amore all’amore” (p.65).
Con buona pace di Foucault, quella della musa al singolare sarebbe una “linea di soggettivazione” (così come evidenziava Deleuze: “un processo, una produzione di soggettività” [Gilles Deleuze, Che cos’è un dispositivo?, Trad. Antonella Moscati, Cronopio, Napoli, 2007, p.17]) perché è fruibile solo dal soggetto scrivente, o quantomeno è destinata a rifluire verso il mittente. E anche la musa di turno vivrebbe la stessa situazione idealizzata in quanto «filtro» per un avvento corporeo e «tramite» per la messa in scena del sé scrivente.
La musa, al singolare, produce Eros solo nell’univocità e nella presunta immanenza di una specifica e limitata temporalità che ad essa è riferita e che con essa è vissuta. Ma non si tratta di una vera e propria produzione, perché l’Eros può darsi solo in un regime di serialità.
L’Eros, in quanto concetto universale (sebbene proiettato verso una continua ri-definizione e, come vedremo più avanti, verso il costante spostamento del suo centro), non può riferirsi ad una particolarità specifica. Se così fosse sarebbe errato chiamarlo Eros perché si ridurrebbe ad un semplice rapporto tra un uno e un altro. L’Eros è, in sé e fuori di sé, plurale.
In una diversa accezione o, se preferite, in una diversa terminologia, un’occorrenza esemplare sarebbe quella di conferire all’Eros una plusvalenza artistica. Come fa giustamente notare Nancy, la musa al singolare non potrebbe esistere perché rappresenterebbe l’arte stessa e non il mondo plurale delle arti (Cfr. Jean-Luc Nancy, Le Muse, Trad. Chiara Tartarini, Diabasis, Reggio Emilia, 2006).
Ci si potrebbe avvicinare così ad una definizione di Eros come arte, o meglio: come un insieme di arti (vista la molteplicità intrinseca della sua essenza). E sembra proprio che l’autrice sia orientata in tal senso, che cerchi cioè di conferire a quest’opera in particolare e all’Eros in generale una plusvalenza artistica: “poesia è il vomito di un istante / l’alleggerirsi scabro di succhi gastroenterici / un dito immerso nell’egolatria / della Musa di turno, / nei suoi affreschi vaginali” (p.8).
Scrivendo “della Musa di turno” è proprio l’autrice a predisporsi in un regime al plurale. Sottintende cioè la presenza/essenza di più muse, e quindi di una serialità. Se si considera che si tratta del testo introduttivo (e quindi di una dichiarazione programmatica) e che il titolo recita: “La funzione postmoderna dell’arte”, il circolo sarebbe già chiuso e determinato. Inoltre, se fossi costretto a puntualizzare, nella poesia denominata “Le figlie di Mnemosine” (pp.28-29), che è, forse, il momento dove l’autrice trova il più alto e intenso valore lirico di tutta l’opera, e che rappresenta un vero e proprio inno, oserei dire giubilante, all’Eros, l’autrice dicevo, attraverso il filtro e il tramite delle figlie di Mnemosine, ovvero delle «nove muse», certifica inoppugnabilmente la pluralità della pratica che contraddistingue l’opera.
Ma l’arte non si nutre di sola liricità o di quelle che l’autrice definisce “prospettive emozionali”. Bisogna fare i conti anche e soprattutto con la carne (non a caso l’autrice, in una intervista presente in rete, dichiara: “Erotomaculae è un libro ancor prima che scritto, pensato in carne e sangue. La sostanza materica che trasuda dalle sue pagine è composta dagli umori irriverenti del corpo e del sesso. È l’istinto omoerotico allo stato condensato, raggrumato, rappreso”), ovvero con la prospettiva materica e con il movimento dei corpi; nel nostro caso specifico anche con il movimento conferito alla scrittura, ai corpi della scrittura.
Difatti talvolta Caporossi sovverte, categoricamente, la lezione di Adorno sulla “discrezione” (“il movimento dei momenti posti in posizione discreta l’uno rispetto all’altro, nel quale l’arte consiste” [T. W. Adorno, Teoria estetica, cura E. De Angelis, Einaudi, Torino, 1975, p.259.]). In molti dei passaggi dell’opera non viene contemplata nessuna tipologia di “discrezione”. La descrizione, drammatizzata, dei corpi al lavoro è, spesso, decisamente sfacciata, quindi esposta ed esibita: “una lucida follia dell’intelletto sopperisce / alla mancanza delle mie unghie morsicate / ti penetra nel culo ti passa tra gli orecchi / ti distrugge la fica come un batocchio tritacarne / il tuo clito in calore mi squarta la pelle dell’anima (p.14)”. I corpi, nel porsi l’uno accanto all’altro, eccedono qualsiasi tipo di discrezione. L’accostamento, per usare le parole dell’autrice, deve accadere e cadere su una linea di pensiero, carne, sperma, amnio, sangue. Devi dirsi e agirsi. Difatti c’è una sacralità, per certi versi, quasi teatrale, o comunque teatralizzata.
Non a caso il riferimento alla caverna platonica è volutamente ambiguo e polivalente. C’è la caverna, casa-di-sé o dell’esserci, ma anche il «filtro» dove il regista Platone con l’escamotage visivo-concettuale delle ombre muove, da sapiente burattinaio, la propria macchina desiderante (il teatrino della vita) usando come «tramite» l’inconsapevolezza dei suoi personali burattini. A questa prima caverna si oppone la “caverna pubica” (p.24) caporossiana, che riprende da Platone solo l’idea che all’interno debba esserci, per così dire, una certa «animazione», che qualcosa (che sia solo un’idealizzazione, una sensazione o la reale tattilità di un corpo poco importa) produca un movimento volto a caratterizzare e ri-definire, per così dire, la messa a nudo dei corpi nel tempio della vita. E l’antiplatonismo, cui talvolta fa riferimento l’autrice in sede critico-esplicativa, è direttamente riferibile, per quel che mi riguarda, anche al fatto di essere lei stessa regista consapevole della propria caverna. Per la norma, non scritta, che due diversi registi non possano avere un punto di vista e una risoluzione comune, Caporossi deve definirsi antiplatonica, perché le sue ombre animate non sono quelle di Platone (passaggi come questi: “Aiutami se puoi / perché Platone ha aperto gli occhi stamattina e dal soffitto / traspariva l’idea di una caverna senza luce” [p.80]; “languo disamorata nella mia maschera virile / canto epicedi tantrici al funerale di Platone”[p.138], possono ritornare utili in tal senso).
Ma, d’altro canto, è conscia del fatto che si può «(av)venire» partendo dal “dove fu così”. In buona sostanza si tratta di assimilare e dimenticare, per poi poterne scrivere e drammatizzare. Per questo la «gettata» caporossiana potrebbe consistere essenzialmente nell’edificazione di una casa-caverna-struttura dove «agitare» e mettere in movimento il lavoro di tutta una vita in senso globale e non una semplice giustapposizione di attimi intensi vissuti e consumati tra un uno e un altro. Come se l’urgenza fosse quella di un vissuto da rivendicare, da un lato attraverso la trasmissione di dati sensibili, e dall’altro lato attraverso la drammatizzazione di un cortocircuito tra corpo e arte, ma anche tra il corpo proprio dell’arte e l’arte del corpo.
Il fatto che l’Eros sia anche una pratica artistica per molti potrebbe essere una cosa abbastanza scontata, ma solitamente (sconfessando la sua pluralità di base) si dà e si consuma nel privato. Renderlo pubblico, cioè estenderlo verso un fuori generalizzato conferisce, al di là dei risultati, un’intenzione artistica.
Ed è anche per questo che si abbisogna di un «tramite» e di un «filtro».
Nel corso di questa disamina abbiamo già incontrato qualche filtro e qualche tramite (l’accostamento oppositivo/riconciliativo tra classicismo e sperimentazione; l’estroiezione di un’anteriorità intesa come flusso e godimento; la produzione di soggettività differita nell’altro, le muse da usare e in cui usarsi, ecc.) e altri ne incontreremo che, seppur diversi tra loro, ci condurranno comunque verso una sola parola: «corpo».
Siamo alla presenza di un linguaggio performativo e insieme informativo, che compie realmente delle azioni e che ci informa su quello che accade (“e il mondo delle api si sveglia, e quello degli amanti va a dormire / ma vibra ancora nelle nostre viscere violente e scarnificate / dal rito d’una lussuriosa dignità l’evacuazione / il latte cagliato e rappreso del nostro istinto animale / di un supremo godimento interinale / conseguito / soddisfatto / e poi sfinito” [p.60]).
Partendo da questi presupposti si potrebbe anche ricercare un «codice», una sorta di scansione ricorrente attraverso i cui termini ri-considerare i singoli elementi in una vera e propria griglia concettuale. Ci toccherebbe quindi stabilire delle frequenze lungo le quali sia possibile trasmettere dati sensibili. Consideriamo queste frequenze come «linee di frattura» e insieme di rinsaldamento. Le terminologie più ricorrenti vanno ad identificarsi in una sorta di tavola dei comandamenti: rosso, silenzio, sangue, amnio, sperma, linfa, latte, fuoco, fonte, fiato, clitoride, spruzzo, umore, lacrime, labbra, ecc.
Ora, se consideriamo ognuno di questi termini come una parola d’ordine, come quelle che Nancy definiva “medaglie verbali”, noteremo che nel decorso del flusso testuale alcuni contesti sono costruiti in uno schema circolare e concentrico, il cui scopo potrebbe essere quello di rifluire proprio verso quella determinata parola d’ordine, verso quella determinata “medaglia verbale”. E questo avviene non solo in un singolo testo ma anche a distanza, come se fosse necessario dislocarsi da corpo a corpo, da testo a testo, rincorrendo i marchi distintivi del proprio status.
Un corpo che agisce e subisce, che dispensa e riceve, che incarna ed escarna sia il soggetto che l’oggetto, un corpo che si fa tramite e filtro sia delle azioni compiute che di quelle mancate, un corpo idealizzato e verificato sia nel cominciamento che nella fine (“là dove affondano le mie labbra / come agnelle spaurite dal coltello del Vate / come due pagine dello stesso libro / che si chiudono per sempre // sulla parola fine” [p.13]).
Nel nostro caso specifico, per estensione del concetto (e tenendo conto che anche le “linee di soggettività” possiedono comunque punti di fuga), la musa al singolare potrebbe essere considerata un Eros idealizzato come pratica salvifica incarnata in sé, e le muse al plurale rappresenterebbero invece l’escarnazione dell’Eros verso altri sé.
Ma risulterebbe comunque semplificativo e riduttivo.
Sarebbe difatti utile affermare che l’incarnazione potrebbe consistere anche nell’atto di toccare l’altro al solo scopo di toccarsi. E già questo sarebbe un primo aspetto sacrificale. Si sacrifica l’altro per sacrificare se stesso proprio nel ritorno-a-sé, anche a costo di fallire nell’intenzione primaria (“E quando abbiamo finito / mi sento ancora più sola. / Consapevole / di non esserti penetrata sotto la pelle. // In tutta l’estensione del tuo corpo, // in tutta la profondità del tuo pensiero. / Avendo fallito / a un solo passo / dal permutare identità. // Avendo perso l’occasione / dell’abbaglio metamorfico / che avrebbe fuso il nostro plasma / in un unico risultato” [pp. 40-41]).
Certo, stiamo parlando di eccedenze, ma per l’autrice sembrerebbe che l’aspetto dell’eccedenza (riconducibile, per certi versi, a quello che altrove è stato definito, di volta in volta, “neo massimalismo” o “realtà aumentata”) sia determinante a definire il suo status.
Per Bataille l’erotismo, in quanto sacrificio, è anche vita mescolata alla morte (“Scoppierei a piangere, / ti abbraccerei fino a farti morire / mentre soffoco di lacrime / sangue animale raggrumato // umore cristallino di ogni vano desiderio” [p.37]). Qui invece – nonostante la citazione, che è comunque idealizzata in una coloritura metaforica – si sostiene, sottotraccia, che l’erotismo sia invece «vita che eccede la vita».
Valga come esempio la poesia “Nel Segno” (p.20) che riporto per intero, la cui chiusa, sempre espressa attraverso metafora, non rappresenta altro che un inno alla “morte che muore”, ovvero alla vita che vive: “nel segno che incide la carne dei polsi / nel prisma iridato che incarna i tuoi occhi // nel battito esangue del fiato che muore / squassando un delirio che affoga parole // io sento il mio istinto assetato di gioco / io vedo il mio fiato forgiato nel fuoco // un significato pretende ben poco / ed altro da sé non ha di che dire // la tua sacra fame mi nutre nel cuore / strappandomi a morsi pietosi il dolore // mi salvi ogni giorno di grazia e calore / io ora contemplo la morte che muore”.
O almeno questo è quello che l’autrice trasmette attraverso quella che si potrebbe definire una gettata di carne (“le tue grandi labbra traboccano bocche di mille baccanti”; “seno bianco di latte fluido di calcio”; “la guazza immota di sperma colato”, [rispettivamente p. 16-25-59]), una sorta di rivelazione illimitata della carne, proprio perché differenziata da corpo a corpo, da musa a musa.
Abbiamo quindi messo a fuoco due diversi aspetti di questo sacrum facere. Naturalmente, una vita che eccede la vita è già, in sé, un atto sacrale e sacrificale, vuoi solo perché ritualizzato. In ogni rito c’è, per così dire, una componente divina (l’allusione all’acqua santa [p. 52] o la presenza ricorrente di un Cristo-Dio [p. 84, 87, 90, 93, 101, ecc.] lavorano in tal senso, per quanto l’uso sia comunque metaforizzato), o meglio una idealizzazione «con» il divino (“io / croce di Cristo fatta carbone da camino / cerco le stimmate sulle mie mani rattrappite” [p.80]).
Nell’usare l’altro per un ritorno-a-sé ci si pone come su di un piedistallo. Ma non è oro tutto quello che luccica. Difatti l’identificazione con il divino (si consideri anche l’accezione più estrema di tale pratica che consisterebbe nella divinizzazione del proprio ego) porta anche ad una perdita-di-sé. E può accadere che in questa perdita prenda consistenza la rivalsa dell’altro, cioè che avvenga un’inversione di ruoli, o che comunque prenda vita e forma un regime di «consegna» dall’uno all’altro e viceversa (“ed io / io / io, solo un giovane Tiresia non ancora accecato dal Sole / ti invoco, amica dei giorni e delle notti // tu mi possiedi, // tu mi hai completamente avvinta” [p.70]).
La pluralità che inneggiamo ad emblema di questa disamina contempla, anche e soprattutto, un regime di riconciliazione, o comunque di compresenza dei contrari. La sacralità dell’atto con cui ci si consegna alla perdita-di-sé nell’altro o all’acquisizione della perdita dell’altro in sé, rappresenta a tutti gli effetti un sacrificio o, se volete, una sorta di divinizzazione (del resto tra l’eccedenza e la trascendenza il passo è breve). Bisognerebbe forse insistere sul «divenire divino», perché tale pratica, se sublimata e quindi vissuta e consumata in un regime d’«intensità», porta alla definizione di uno status d’intoccabilità (lo vedremo meglio più avanti). Potrebbe sembrare un paradosso: una pratica basata, anche e soprattutto, sul «toccare» porta all’intoccabilità. Ma è ciò che può realmente accadere: la sublimazione rende l’artefice intoccabile, e quindi divino. Ci si pone su un piedistallo idealizzato dal quale sia possibile spiccare il salto non verso l’indivisibilità tra morte e vita ma verso la divisibilità del mondo della vita che eccede se stessa creando una dimensione altra in cui è l’Eros a dettare le norme comportamentali.
Che morte e vita rappresentino la totalità dell’essere è cosa indubbia, ma l’erotismo si consuma nella vita proprio vivendola. Ed è proprio questo, per certi versi, il vero aspetto sacrale e sacrificale, quasi religioso, dell’Eros.
Facendo il verso a Bataille, e con le dovute precauzioni, si potrebbe parlare dell’erotismo come “esperienza interiore” dall’aspetto religioso, ma che prescinde da qualsiasi religione precostituita per rivolgersi solo al sacrum facere, ovvero al rituale in cui rivelare i misteri dell’Eros.
L’aspetto sacrale, in quest’opera, si dà attraverso più dispositivi di disvelamento. Per amor di brevità ne enunciamo solo alcuni: la continuità (che è anche ripetibilità, sebbene di volta in volta differenziata), la risonanza (propria del «contatto»), la ridondanza (relativa all’apparato formale), il pervertimento.
Se il pervertimento (si tenga presente l’accezione di tale termine che Barthes conferiva a Bataille) rappresenta anche un rovesciamento o un ribaltamento, la perversione (l’allitterazione ci rinvia automaticamente ad una famiglia etimologica comune), che in esso è inscritta (vi invito a considerare anche accezioni quali per il verso, per il verso giusto, per una [diversa] versione) può permetterci di addentrarci nei meandri di una messa-in-scena o, se preferite, di una certa ob-scenità di fondo.
Secondo la lezione di Carmelo Bene l’osceno è il fuori scena, ciò che si conduce verso la totale estromissione dall’azione. Ma l’ob-scenità di Caporossi non sembra ricercare una vera e propria estromissione, anzi sembra così presente a se stessa che il condursi verso la scena-di-sé potrebbe portarci a ri-definire il concetto di Eros.
“Ob” nella lingua latina è una preposizione e significa “tendere a”, condursi verso”, “porsi di fronte”, in buona sostanza ricercare un «con» o definirsi in un «con». Se mi concedete una forzatura, nella lingua tedesca “ob” è una congiunzione. Significa “se”. Il “se” fa scendere in campo un’ipotesi (che comunque presuppone un antefatto, un qualcosa che viene prima e che potrebbe condizionare l’a venire) ma è la sua natura di congiunzione a rientrare, di diritto, nel nostro specifico.
Questo è uno dei conflitti irrisolvibili che più avanti ci condurranno verso l’intoccabile: da un lato un’eccessiva e ostentata presenza-a-sé (“… e l’impegno di portarmi sempre / questo calvario addosso / questa fellatio esausta delle mie pagine bianche / alla punta fallocentrica polipale / -venature d’inchiostro a filo d’aria- / del mio cosmico, sfottuto, bastardissimo E / G / O” [p.23]) e dall’altro lato la predisposizione ad una congiunzione con un altro (“leccami le ferite / prima che me le bagni il cielo / e poi, / crudemente riposa / il flusso sanguigno / perché io poi ne beva ancora e ancora” [p.26]).
A questo punto, e in tal senso, la scena dell’Eros caporossiano potrebbe anche istradarsi verso la condivisione di un fuori scena come eccedenza della presenza-a-sé «filtrata» da un altro, dalla congiunzione con un altro.
Ma, al di là di eventuali presupposizioni con-giuntive con il «filtro», con l’altro, comunque ciò che resta è la scena. La scena è ciò che viene prima del porsi fuori scena, è l’ipotesi che potrebbe condizionare il risultato finale. Una scena condivisa, ma vissuta nella divisione – e mi si scusi l’iperbole – con il «con». Per puntualizzare un’accezione di questo concetto a pag. 87 possiamo leggere “io temo // la mia conoscenza a te, a voi // la mia conoscenza a me stessa/o / fugge come la lepre sull’orlo del baratro / fugge come presenze benigne nel calderone delle streghe // lègami ti prego ad una immagine di me // fammi restare immobile in un giudizio, in un pensiero”.
Come a dire che non si può sottovalutare l’ipotesi che la congiunzione e la condivisione usino il «filtro» dell’altro per un ritorno – di volta in volta differenziato – alla presenza-di-sé. E questo non è un paradosso, ma ciò che essenzialmente cade e si fissa su queste pagine, anche attraverso il «tramite» di una messa-in-forma, decisamente eccedente, che esalta e consolida la congiunzione di una divisione ri-definita nella pluralità degli espedienti grafici, nel «divenire molteplice» dell’ego scrivente e nell’avvicendamento delle muse.
Ora, depositiamo il ritorno-a-sé nelle pieghe del sottotesto e proviamo ad allargare il raggio d’azione.
Entrambe le categorie, toccarsi e toccare, si offrono come trampolini di lancio verso innumerevoli estensioni. Limitiamoci a considerarle come «tramite» e «filtro» verso l’intoccabile. Non pensate al solito paradosso linguistico da cui attingere linfa vitale o all’aporia del gesto che si ritrae proprio mentre si dà. Non si tratta di questo, non solo di questo almeno (perché comunque in un regime di pluralità anche aspetti cosiddetti secondari conducono alla definizione di un concetto). Colui che dà, che tocca, il toccante, è a sua volta toccato (anche indirettamente se volete) da colui che riceve il tocco. È la natura stessa del contatto tra due corpi ad esprimere e consolidare questo assioma. Così facendo, il gesto originario del toccante perde il suo valore di assolutezza proprio perché è toccato mentre tocca. Ed è in questo preciso momento che si verifica l’intoccabilità. Nel momento in cui si verifica il contatto il nostro toccare si accresce di un significante aggiuntivo e relativo (si legga anche relazionabile) che vanifica il primo significante, quello assoluto. In tal senso, il toccante non tocca il toccato e il toccato non riceve il tocco del toccante. Eppure entrambi si toccano nel contatto. Il contatto sarebbe quindi l’intoccabilità che si verifica solo rinunciando ad una estensione univoca e assoluta da un uno a un altro, solo traslando verso un’estensione biunivoca e relativa tra l’uno e l’altro.
Cosa significa tutto ciò?
Che l’Eros ha bisogno, sia nella sua incarnazione che nella sua escarnazione, di un regime di «complicità», di una sorta di comunione d’intenti, di una forte predisposizione a toccare l’intoccabile, o meglio ad appropriarsi dell’intoccabile dell’altro.
Se ciò avviene si dà Eros.
Così abbiamo già visto, questo aspetto – mettendo a morte il valore assoluto – rappresenta a tutti gli effetti un sacrificio. Osando e forzando, si potrebbe dire che l’intoccabile rappresenti la sacralizzazione dell’Eros attraverso la sublimazione di un contatto sovradeterminato.
Ma oltre al reciproco toccarsi bisognerebbe considerare anche il reciproco sentirsi. Ed è qui che la musa del corpo, della carne, delle viscere lascia il posto alla musa dell’anima, del pensiero. La corporeità cede il passo alla cerebralità.
Per chiudere questa triade ci tocca anche accennare al reciproco vedersi e considerare l’occhio come quell’organo che può toccare, idealmente, il profondo.
Toccarsi, sentirsi, vedersi sono le tre componenti essenziali, direi fenomenologiche e genetiche, dell’Eros. Componenti intersoggettive e plurali, linee intercomunicanti, piani sovrapposti e interagenti. Potrebbero addirittura essere considerate come un unico insieme. Una sequenza come questa “Eros le guarda avvolte di peccato / concludere le braccia e stringersi le mani / sentendo dentro a sé nell’atto di fuggire / il divino urlo di gioia che invoca il suo nome (p.28; i corsivi sono miei)” è esemplare, in quanto la «reciprocità» viene formalizzata proprio nella nostra triade: vedersi, toccarsi, sentirsi; senza tener conto del fatto che l’”atto di fuggire” possa rientrare nel concetto dell’intoccabilità.
Ma, naturalmente, in ogni insieme che si rispetti non bisogna sottovalutare i sotto-insiemi che esso comprende. Al di là della componente del ritorno-a-sé che abbiamo messo a riposo nelle pieghe, ma che rimane comunque sempre attiva sottotraccia, i sotto-insiemi mettono al lavoro l’intoccabilità, l’inascoltabilità e l’inguardabilità, ovvero le fenomenologie che alimentano l’insieme primario rendendolo suscettibile di deviazioni dalla strada maestra e facendo in modo che esso non possa mai definirsi in una assolutezza.
In una diversa terminologia queste fenomenologie, questi sotto-insiemi potrebbero essere definiti distanze. Si tratterebbe quindi di attingere qualcosa dall’altro nella distanza che intercorre tra un corpo e l’altro (“L’unica cosa che voglio / ora / è esitare sulla danza delle tue labbra” [p.41; il corsivo è mio]). Che sia la possibilità di toccarsi o l’intoccabilità, che sia la dedizione verso l’altro o il ritorno-a-sé poco importa. Ciò che conta è per l’appunto la distanza.
Ecco: la distanza è toccabile.
La carne (che non è il corpo, non solo almeno, e questo è proprio l’autrice ad affermarlo) pratica questa distanza, si pratica in questa distanza che è il luogo della «chiamata» all’altro.
Giunti a questo punto, ci toccherebbe aggiungere una quarta categoria ai nostri «imperativi relativi»: il reciproco chiamarsi lungo una linea elettrica, fibrillante che precede il contatto. Qualora fosse necessario puntualizzare con un’altra occorrenza, l’esitazione che sottintende il desiderio e che formalizza la distanza viene ribadita poco più avanti (p.63): “segretamente godere / esitare sulla porta e guardarti ridere”. Ed è attraverso questa linea che vengono trasmessi i dati sensibili dell’Eros. Si può toccare l’Eros prima di incontrarsi con l’intoccabilità dell’altro. Questa linea può essere, al contempo, sia fisica che cerebrale, sia carnale che elettiva. Non ci sono limiti alle possibili combinazioni dei due aspetti (al di là della presenza, come già evidenziato, dei sotto-insiemi) e anzi è proprio nel proiettarsi verso il limite e nel situarsi al limite che si dà Eros.
Non dimentichiamo la correlazione eros-morte enunciata da Bataille che può essere non condivisibile ma che comunque, in sede teorica, è determinante in quanto punto di non ritorno (per quanto Bataille considerasse la morte come “segno di vita” e come “apertura sull’illimitato”). Ma eros=morte significa, sempre e comunque, la morte dell’Eros. Questo concetto individua così il limite dell’Eros. Ma il limite al singolare, in quanto unicità e assolutezza, non rientra nelle nostre linee di pensiero. Bisogna lavorare sui limiti al plurale e considerare i diversi aspetti della reciprocità come l’entrata in campo di una sorta di «concorso di colpa» (beninteso: provate a conferire un’accezione positiva a questa enunciazione, magari trasformandola in «concorso di merito») ove possa avvenire una riconciliazione tra i contrari, tra il tramite e il filtro, tra il toccarsi e l’intoccabilità e soprattutto tra il ritorno-a-sé del toccante e quello del toccato.
Questo concorso di colpa viaggia ancora una volta all’interno di una distanza, quella intercorrente tra l’incarnazione e l’escarnazione che in apertura abbiamo provato a definire, ma che andrebbe di volta in volta ri-definita, vuoi solo per il continuo avvicendarsi delle muse e per il peso che le «distinzioni» formali conferiscono all’opera.
Difatti c’è una organizzazione della forma che risponde a canoni precisi. Questa organizzazione diventa espressiva di un senso a priori, o meglio di una scelta di campo orientata verso quella che si potrebbe definire «distinzione». I vari elementi formali si distinguono gli uni dagli altri nelle varianti tipografiche attraverso le quali si estendono, ma anche nella ri-definizione contestuale delle cosiddette “medaglie verbali”.
Tra un’estensione orizzontale della scrittura e dei segni che la trasfigurano e l’erezione verticale di un significante, talvolta esibito nella sua nudità e crudità, talaltra solo accennato o celato nel sottotesto o nelle pieghe (si potrebbe dire anche nelle fibre nervose della struttura testuale, così giusto per rinsaldare una certa corporeità da cui risulta comunque difficile distaccarsi), in questa doppia linearità, dicevo, si situa e si sistematizza un regime d’enunciazioni sorprendentemente omogenee.
Per quanto eccedenti nella forma che si slancia e si distende, esse sono finalizzate ad una funzionalità quasi rassicurante, ad una progressione che incide sì, ma senza ferire. Non ci sono evidenti lacerazioni o crepe insanabili. Anzi, sembra quasi che l’autrice operi per suture e accorpamenti più che per tagli e disgiunzioni.
All’organizzazione della forma si aggiunge quindi un’organizzazione del testo attraverso ordini semantici e stratificazioni concettuali, anche facendo ricorso a semplici enunciazioni informative (quelle più evidenti risiedono nei titoli attribuiti alle diverse sezioni che compongono l’opera, ma ci si potrebbe sfinire nell’elencare tutti gli indicatori intertestuali che operano in tal senso), il tutto sistematizzato in quella che è la tematica centrale, in quell’Eros che però è sempre (dis)impegnato a spostare il suo centro.
In poche parole la centralità dell’opera risiede in un «centro in fuga».
Al di là degli evidenti registri d’immanenza, se in quest’opera vengono messi al lavoro anche registri di trascendenza, ebbene: essi sono da ricercarsi proprio in questo «centro in fuga», ovvero: nella ricerca – continua e vitale – di un centro da conquistare e in cui situarsi per mescolare le proprie linee di soggettività con quelle dell’altro, anche a rischio di creare delle linee di frattura tra il toccante e il toccato, anche a rischio di generare unità traumatiche nell’enunciazione linguistica di tali fratture. Beninteso, le unità traumatiche non devono essere considerate come un aspetto negativo, in quanto frutto di una scelta ben precisa.
Credo che si possano rilevare almeno due categorie di unità traumatiche. La prima è relativa all’uso di termini inusuali in poesia, quali ad esempio: autoconcupirsi, polipale, ambiforme, biancobracciute, terramaricolo, compossibile, rimbrotto, sinoptiche, criptomelodia, e via dicendo. Checché se ne dica questi sono, a tutti gli effetti, termini cacofonici e anti-lirici. La seconda categoria invece è riferibile allo spostamento dell’Eros verso un’accezione porno-grafica, e ciò è dovuto proprio alla strutturazione grafica e formale.
Se il porno è l’eccedenza dell’Eros in quanto atto esteso, esibito e ripetuto, la grafia attraverso la quale questo Eros si mette al lavoro eccedendo la sua natura, estendendosi verso un fuori, esibendosi come scena-di-sé e ripetendosi, è a tutti gli effetti «porno-grafia».
Si dilata e si contrae. Si fonde, si auto-cancella, si gonfia e si sgonfia. È insieme estesa e invaginata, si protende verso l’alto e poi sprofonda, talvolta sembra quasi imitare i movimenti del coito.
È porno-grafica in quanto esposta alla visione-di-sé.
È visibilmente impegnata ad articolarsi e disarticolarsi, come se fosse alla ricerca della giusta posizione in cui fissare la propria estroiezione. Posizione sulla pagina e posizione corporea. Ma, lo sappiamo, ogni posizione è, in sé e fuori di sé, una deposizione, in quanto trasferimento da un corpo all’altro, in quanto passaggio dalla pratica erotica intima alla visione pubblica della pratica intima.
Checché se ne dica, un atto erotico esibito in pubblico (esposto e deposto in pubblico) è comunque pornografico, una poesia erotica esibita in pubblico (anche solo e semplicemente fissata sulla pagina) è allo stesso modo pornografica.
Se la posizione è un «filtro», la deposizione è il «tramite», attraverso il quale il gesto si estromette da sé per divenire altro-da-sé, per esibirsi nell’eccedenza. In tale ottica l’Eros si trasferisce nel porno attraverso una grafia visibilmente eccedente. Sebbene semplificando e riducendo, cercherò di puntualizzare. La messa in grafia, la porno-grafia di quest’opera ri-organizza il dettato poetico in una sovrastruttura che trascende la struttura originaria. La prima struttura è quella che tende e si conduce all’eros. La seconda struttura trascende l’eros divenendo porno-grafica. Compie l’atto, esibisce l’atto e si esibisce nell’atto. Caporossi crea quindi un piano di correlazione tra i corpi umani e i corpi della scrittura mettendo in campo diverse linee di forza e tentando di operare in quella che abbiamo definito riconciliazione dei contrari.
Come avviene ciò?
Attraverso la creazione di quadri viventi.
Quest’opera, da un certo punto di vista, è costituita proprio da una successione di quadri in esposizione. Si tratta di una vera e propria mostra, classicamente intesa, con tanto di vernissage (“baciando l’epidermide dei miei pensieri sacri / dispersi in nubi amorfe / nel deserto del tuo grembo / restiamo qui, penombre nebulari / impiccate un tempo al giogo del dolore / che ora lecca le ferite dell’interiorità / cercando avidamente, nei sogni silenziosi, / le muta ambiguità di grida sconosciute” [p.11]) e finissage (“sei il giglio che colsi nel fiume che scorre incessante nel greto / sei il senso del mio lancinante non-senso in etereo vagare / sei il sogno che venne una notte e all’alba non volle svanire / sei l’estasi enfatica e santa di un brivido che ancora mi scuote” [p.143]). Senza dimenticare l’evento performativo che si posiziona e si depone nel mezzo, che scandisce le ripetizioni e le differenze spazio-temporali e psico-fisiche del farsi scena come avvento-di-sé.
Questo aspetto del ritorno-a-sé trova anche altre connotazioni specifiche, magari un po’ forzate, ma di cui bisognerebbe comunque tener conto nella possibile impossibilità di incorniciare la raffigurazione dell’Eros, ovvero di conferirgli dei margini all’interno dei quali contenerlo e definirlo. La forma più alta, o più estrema, del ritorno-a-sé consisterebbe nel praticare l’Eros con se stessi. Fare sesso con se stessi, ovvero: masturbarsi.
Al di là del fatto che una delle poesie dell’opera reca come titolo proprio “Masturbazione” (p.19), è questa una fenomenologia in cui il toccante e il toccato, escludendo l’altro, coincidono nello stesso corpo o, se volete, nel pensiero e nell’idea di un corpo che basta a se stesso (non a caso la masturbazione viene definita dall’autrice con il termine “autoconcupirsi”).
Sulla falsariga di questa presunta autosufficienza si potrebbe aggiungere un’altra connotazione, quella dell’androginia (si vedano i chiari riferimenti alle pp. 24 e 90). Secondo i principi dell’orfismo, Eros nasce doppio (Eros-Phanès), metà uomo, metà donna. In sede teorica, in quanto due riunito in uno, non avrebbe bisogno di un altro per realizzare la propria scena erotica e per consumarsi nella propria scena erotica.
Ci sono però altri due aspetti sacrificali di cui bisognerebbe tener conto, e che vertono sulla «mancanza», una mancanza che è propria di entrambe le connotazioni. La mancanza non è tanto quella dell’altro ma il rovesciamento (ricordate il pervertimento di cui si accennava in apertura?) dell’unico vero elemento che permette all’Eros di esistere, ovvero: il «centro in fuga».
Nell’essere un corpo che si basta-da-sé, il centro rinuncia alla fuga e rientra in sé. Continua comunque a moltiplicarsi ma lo fa attraverso un’introiezione e non attraverso un’estroiezione. In tal senso sia la masturbazione che l’androginia corrispondono ad una «invaginazione» della scena erotica.
Ma è anche vero che – estendendo il concetto, e solo per puntualizzare la compresenza o l’accostamento dei contrari – l’uno del ritorno-a-sé funge da trampolino di lancio per la connotazione dell’ennesima pluralità. Se l’idealizzazione dell’androginia trasla sui piani della congiunzione con l’altro, la pratica del trasferimento della sfera erotica non avviene più da donna a donna, ma da una androginia ad una donna (almeno per il momento). Non a caso, se l’autrice afferma: “leccami baciami ama l’uomo che c’è in me” (p.26), vuol dire che non ci sono più solo due corpi a calcare la scena dell’Eros, perché almeno uno dei due corpi è due riunito in uno. Ancora una volta, quindi, siamo alla presenza di un regime al plurale.
Secondo le lezione spinoziane, l’incontro (ocursus) tra due aspetti, due corpi, due cose, due entità produce comunque una terza identità risultante dalla fusione delle prime due. Sempre in sede teorica, l’incontro tra un uno e un altro potrebbe produrre l’Eros e questo, come abbiamo già visto, può avvenire anche attraverso l’appropriazione dell’intoccabilità dell’altro o attraverso la pratica in cui ci si consegna all’altro.
Cioè i due corpi distribuiscono il proprio peso erotico per generare e mantenere una sorta di equilibrio. In tal senso l’Eros potrebbe essere identificato anche come un equilibrio condiviso tra le parti. Ma nel caso di un’androginia comune ad entrambe le parti in causa (che sia idealizzata e/o latente poco importa) come potremo orientarci?
I due corpi anatomici, in questa eventualità, sarebbero formati da quattro essenze, e risulterebbe comunque difficile determinarne peso ed equilibrio. Quando l’autrice, invitando l’altro ad amare l’uomo che è in lei, quando cioè si pone e si offre attraverso la sua componente maschile, non è sicura che l’altro (che è comunque una donna) accetti l’invito con la sua componente femminile. Potrebbe invece darsi anch’essa nella sua componente maschile. Allora l’ocursus non sarebbe più consumato da «donna a donna» ma da «uomo a uomo».
Sempre ricorrendo a Spinoza, in tal caso l’affettività diverrebbe affezione, e la presenza si nutrirebbe dell’essenza, o meglio di una delle essenze dell’altro. E mi sembra piuttosto evidente che il significato (o uno dei significati) della parola “ambiforme”, che l’autrice declina più volte nell’opera, viaggi proprio a cavallo di questa linea di ambiguità e molteplicità.
Ne converrete, la nostra situazione al plurale diventa sempre più complessa e intricata, vuoi solo perché gli atti, performativi e informativi, si moltiplicano a vista d’occhio, accrescendo le accezioni del loro porsi in scena.
La sfida di ogni performance (esposizione, esibizione) è quella di mettere in movimento i dati. In tale ottica, al di là dei gusti soggettivi, l’opera si direbbe riuscita, soprattutto nella veicolazione di un significato globale. Ma la catena dei significanti (quelli sotto-traccia e quelli sovrastrutturati), quelli che precedono i significati, resta comunque volutamente «aperta».
La porno-grafia della sua messa in scena aiuta non poco a confondere e sovradeterminare quello che Derrida avrebbe definito “il tessuto della traccia”.
È questo è un bene. Conferisce all’opera un valore aggiunto e le consente di non esaurirsi dopo la lettura.
Attraverso l’uso del segno, attraverso l’abuso di una traccia, di un’impronta, di un marchio, le poesie – un tempo lineari – vengono ri-configurate e quindi ri-materializzate. È inutile negarlo, siamo alla presenza di un corpo ri-modellato. Il corpo nuovo viene qui presentato, ostentato, installato, messo in piazza, gettato in un «aperto» a cui è possibile accedere con relativa semplicità.
Ecco, la soluzione formale consente un accesso agevolato alla sfera erotica, al contesto saffico, all’idealizzazione di una continuità comportamentale, all’apologia di una contiguità tra il tramite e il filtro, tra le muse come corpi da toccare e le muse come anime con cui condividere non il gesto fine a se stesso ma l’idea stessa dell’eros come eccedenza dei singoli atti (“leccami la sostanza, la forma tu già la possiedi” [p.14]).
Per questo bisogna sovradeterminare la scena, ovvero: porsi fuori scena, ovvero ancora: creare una linea di intercomunicazione tra il fare-scena-di-sé e l’idealizzazione di un modus vivendi in cui l’eros corporeo e cerebrale non può fare a meno della porno-grafia della scrittura che si concede il lusso di traslarlo verso un fuori-di-sé.
E se anche ciò avvenisse vanificando l’ordine oggettivo che dovrebbe ricevere il messaggio e ritornando all’ordine soggettivo che invia il messaggio, sarebbe comunque irrilevante, perché ciò che qui conta è quel fantomatico, plurisignificante «centro in fuga» che non può esimersi di riaprire le danze ad ogni virata di rotta.
In tale ottica non sarebbe una forzatura declinare l’espressione io+tu=io.
La confusione dell’io e del tu, del soggetto agente/scrivente e dell’oggetto che funge da filtro e tramite è prevalentemente indirizzata verso una realizzazione egotica, e quindi dispotica. L’io ordina e dispone, sceglie sempre la carta più alta per illudersi di poter vincere la partita.
Ma la vera partita che qui si gioca non è quella tra l’io e il tu, bensì quella tra l’io e l’eros. Una partita dove l’io è comunque destinato a soccombere. Il toccante non potrà mai essere “discreto” in senso adorniano, anzi sarà costretto a divenire, in un certo senso, isterico. Ed è proprio per questo che il tessuto delle tracce formali (la porno-grafia enunciativa) è riconducibile a quella che Deleuze e Guattari chiamavano “isteria dei segni”: “[…] il segno salta da un cerchio all’altro spostando continuamente il centro e al tempo stesso non cessa di riferirsi ad esso (la metafora o isteria dei segni) […]” (Gilles Deleuze, Felix Guattari, Mille piani, vol.1, p.169, Treccani, Roma, 1987).
Riferendoci a quanto già detto, il centro a cui le enunciazioni ritornano è prevalentemente (ma non esclusivamente) il toccante e non il toccato. Le muse si avvicendano, si sostituiscono. Solo l’eros sopravvive al massacro e perpetua l’estasi sacrificale attraverso linee di fuga, il cui compito non è propriamente quello di correre a perdifiato verso un nuovo punto d’arrivo, ma quello di una ri-proposizione differenziata dell’identico. E l’identico qui non è l’io che basta a se stesso ma l’io deterritorializzato nell’eros. Un eros che, per definizione, non può bastarsi né bastare.
E in tutto ciò dov’è finito il toccato?
Qual è la sua funzione specifica?
È possibile che tutte le reciprocità del toccarsi, sentirsi, vedersi siano solo delle favole?
Come districarsi in tutta questa carne al fuoco?
Non ci sono soluzioni assolute da prendere come assioma. Non ci sono soluzioni relative alla portata di tutti. Del resto ciò che conta non è il praticante ma ciò che si pratica.
L’unico che continua a lavorare è lui: l’Eros.
© Enzo Campi (Reggio Emilia – Novembre 2016)
 di Gianni Biondillo
di Gianni Biondillo
Iaia Caputo, Era mia madre, Feltrinelli, 166 pagine
I rapporti fra Alice e sua madre non sono dei migliori. La prima è una ballerina che vive un’esistenza precaria a Parigi, la seconda è una grecista napoletana, docente universitaria ora in pensione. La madre ha nel suo passato una vita di lotte politiche, di emancipazione sociale e di genere, la figlia sente la rabbia di appartenere alla prima generazione che vivrà in condizioni peggiori di quella che l’ha preceduta.
C’è rabbia, c’è tensione, c’è incomprensione. Ma sono madre e figlia. Questo legame resta indissolubile. E verrà compreso appieno da Alice quando, all’inizio del romanzo, vedrà accasciarsi a terra la madre colta da un malore che la ridurrà al coma. Alice è perduta. Decide di riportare a Napoli la madre per le cure, aspettando l’inevitabile fine. E così, giorno dopo giorno, tornando sui luoghi della sua infanzia, scoprirà quanto poco credeva di sapere di quella donna.
Era mia madre è un romanzo che cerca l’impossibile compito di far dialogare due generazioni in apparenza vicine ma nei fatti attraversate da una frattura epocale insanabile. Tutto il futuro che la generazione precedente ha voluto conquistare è il presente scippato a quella che le è succeduta. Ma durante il coma di sua madre Alice scoprirà che quella donna forte, volitiva, tetragona, aveva altrettante fragilità e debolezze, così simili alle sue. Ché se non si può cercare un dialogo fra generazioni lo si può trovare fra legami che sono più profondi.
La scrittura di Iaia Caputo in questo senso è fatta di movimenti tellurici a basso impatto. Mai colpi di scena rocamboleschi, ma un continuo, incessante bradisismo sentimentale. Questo comporta un controllo della frase ferreo, ineccepibile. Fra nonne, madri e figlie a tutto tondo, le figure maschili appaiono come inconsistenti, egotiche, puerili. Incapaci di sondare l’abisso che c’è in ognuno di noi.
(pubblicato precedentemente su Cooperazione n° 30 del 26 luglio 2016)
di Mariasole Ariot
[Eric Satie – Gnossienne no.1]
Quando il tempo si ferma, si contrae lo spazio in un grumo denso e solido modificato solo dal suono delle campane. Non è un giorno di festa, non è domenica, non è il ricordo dei morti: è solo, semplicemente, un arresto cardiaco che traccia una linea netta sulla fronte.
Siamo saliti sulla montagna più alta per osservare il lago da vicino: gelido, plastificato, una concavità che si trasforma in escrescenza muta come gli animali che ci fanno il giro attorno, e sopra, e beccano la pelle mordicchiandola appena appena.
Ho sognato un agnellino, si chiamava Anacleto, l’ho trovato nel bosco alle tre del mattino. Poi, mi sono svegliata.
Seduti attorno al grande territorio generato dal lago, non avevamo lanterne né fiammiferi per accendere un fuoco. Abbiamo così deciso per congelarci insieme, riparandoci dal vento del nord, con le teste bucate dagli eventi. A volte siamo contenitori, a volte siamo contenuti – e non ce ne accorgiamo. Io sono il tuo contenitore, sono la tasca delle tue frasi accese, tu sei ciò che contengo, un brivido molle, un’assenza in forma di presenza. Tutto quello che non ci diciamo, lo trasformiamo nel linguaggio dei segni: una mano rotea davanti alle fosse degli occhi, un dito indica il petto, poi la sinistra e la destra scoppiano dilatando il mondo.
Significa dire: tutto ciò che abbiamo coricato dentro, sta per esplodere.
Abbiamo portato con noi dei vecchi manichini, ci serviranno come totem per gli animali delle alture, se riuscissimo a confondere la pelle con il silicone, forse potremmo salvarci, fare della finta una direzione d’intento, disorientare i disorientati. Eppure, ti chiedo: non siamo noi, i primi esserini a essere senza bussola?
Il tempo continua a fermarsi, sono passati tre mesi e ancora sembra estate.
La verità è che non ci siamo mai detti nulla.
Nel secondo sogno è arrivato un uomo arancione, ha cercato di rubare Anacleto, l’ha venduto come fosse un porcospino e ha minacciato di non farmi passare al di là del dirupo.Se è possibile svegliarsi da un sogno, non è possibile svegliarsi dalla veglia.
Così ci siamo divisi. Tu hai portato le bende per fasciarti i piedi, io quelle per oscurare gli occhi. Vedere è uno strazio, un senso troppo acuto che cade da fuori nella gola, e poi scivola all’interno della cassa toracica, brivida gli organi, li mescola uno a uno, scalciano, si spostano, si aggrappano alla carne viva. E’ l’inferno del corpo, quello che ti raccontavo quando restavamo seduti sulla muraglia.
Hai ancora freddo? Le tue gambe possono muoversi?
Se dire non è scrivere, se scrivere non è ancora dire, cosa resta di questo tempo, di questo spazio rallentato in cui le informazioni passano piano tra nervo e nervo, nella camera del cervello? Il filo che avevano cucito alla nascita, come un cordone, collegava la nuca alla mano, permetteva il fluire dell’inchiostro sulla riga, appena fuori dall’unghia.
Ora il polso è gonfio, il liquido che cova all’interno è bloccato: non esce più niente.
Nel terzo sogno il gatto mi ha indicato la zona dei morti . Le due sagome giganti come statue ridevano sul piedistallo. Sant’Antonio da Padova, e uno sconosciuto. Il Santo si è chinato, mi ha detto: abbiamo poco tempo (i morti durano poco) – e ci siamo avvicinati alla cripta.
“Vedi la donna dipinta?” “Sì, la vedo”
“Anamorfosi. Da questo punto puoi vederle i seni, dall’alto il viso, da sotto non vedi niente”
“Come posso vederla intera?” “L’intero non esiste”
“Perché ci sono questi segni blu?” “Un corpo violato. Sono i graffi del re: anno 1215”:
E’ tornato sul piedistallo, ha riso, mi sono accerchiata di dolore. Il gatto traghettatore ha riattraversato la strada, l’ho seguito.
La voce dei morti non è mai abbastanza.
Ora non ci sono più mani: non c’è più il tu che fa di noi un noi. La montagna ci sorveglia – tu nella tua recrudescenza, io nella mia postazione immobile.
Sono costretta a rifugiarmi nella caverna, a mettere pezzi di carne sui bulbi: vedere, ora, significherebbe accecarsi.
Può un bambino fermare il tempo fino a quando il tempo non dà più segni di vita? Può il mondo non avere più mondo? Può lo spazio contrarsi in una coda di verme?
I bambini sanno nascondersi dal temporale. Noi ci limitiamo a dire: piove.
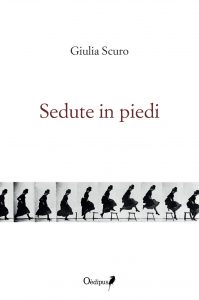
di Giulia Scuro
.
Ventottesima ora di lavoro
Dottoressa, come le ho già più volte
detto, pur con le molte
divagazioni del caso
io sono preoccupata per il mio naso.
Ho paura che la sua sporgenza
sia uno sfoggio di esistenza
e che al vederlo chi è di fronte
pensi a lui come ad un ponte
nella mia direzione,
fatto di binari olfattivi,
alla portata dei suoi incisivi.
Dottoressa, è un delirio
o solo fervida immaginazione?
Mi rassicuri, mi comprenda,
alle prese con l’ammenda
mi sprofondo nelle suole.
 di Mario De Santis
di Mario De Santis
“Ho scritto un testo che non tende a nulla. Vuole solo esserci, come tutti”. Ci accoglie alla fine della prima poesia, questo verso che dice già nettamente qual è uno dei cardini del nuovo libro di Guido Mazzoni. Anche il titolo, La pura superficie, circoscrive un’idea del mondo che i testi, senza aspirare a conoscerlo, tuttavia inquadrano. Usare questo termine preso dalla fotografia o dal cinema serve per dire come lo sguardo del poeta si sposti assieme alle cose che accadono, facendosi cosa esso stesso, e diventi straniante fino ad osservare “la propria vita che esiste e scivola, ogni giorno, sulla pura superficie”.
di Antonio Sparzani

come certo ricordate da quanto detto qui, Wolfgang Pauli, il luminare della fisica del secolo scorso, era in ottimi rapporti, oltre che con Carl Gustav Jung, con la sua più stretta collaboratrice, Marie-Louise von Franz. In occasione del trentasettesimo compleanno di lei, il 4 gennaio 1952, le invia, come testimonianza di affetto e di vicinanza, un breve dialogo da lui scritto dieci anni prima, quando si trovava a Princeton, negli USA, per sfuggire ai molti pericoli della guerra che devastava l’Europa. Questo dialogo è stato letto, al Calumet Voltaire del 28 ottobre scorso a Fano, dal sottoscritto, nella veste di Immanuel e dall’indiana Orsola Puecher nella veste di Afrodite. Il testo è il seguente:
La lotta dei generi — Una commedia filosofica
Afrodite e Kant
Afrodite: vorrei anzitutto scusarmi di ricorrere all’aiuto delle parole per comunicare emozioni. Sarebbe certo più gradevole se io impiegassi a tale scopo soltanto carezze; ma ciò, a parte un piccolo numero di casi, non sarebbe gradevole per me. Per questo adopero parole per rendere accessibili le mie emozioni ai pensatori, i quali hanno emozioni così indifferenziate e fanciullesche che, senza carezze e senza parole, non sono in grado di indovinare le mie. . Indubbiamente le parole non sono che razionalizzazioni delle emozioni. Ci fu pur chi, in modo infantile e incosciente, disse “in principio era il verbo” e anche “cogito ergo sum”, mentre all’inizio vi erano naturalmente le emozioni, altrimenti mai sarebbero state trovate le parole e “amo, ergo sum”, e soprattutto mai sarebbero nati i pensatori.
Immanuel: ma v’è pur tuttavia l’ampio campo della scienza, con i suoi metodi classificatori, con gli esperimenti e la logica!
Afrodite: questa è l’eccezione che conferma la mia regola. I metodi scientifici possono essere usati solo nel ristretto dominio in cui non esistono le emozioni umane. La logica è sempre la stessa, sia che a Lei un certo oggetto piaccia o non piaccia, sia che io parli di una piccola mosca o dell’intero cosmo. I metodi scientifici possono anche essere razionalizzazioni di immaginazioni intuitive, ma questo a me non interessa. Quel che invece mi interessa è la loro indipendenza dal valore degli oggetti. In questo piccolo dominio – che mi diletta assai come passatempo, per prendermi un po’ di ferie dalle mie emozioni, cioè dalla vita vera – ci sono espressioni così straordinarie come vero e falso. A parte questa piccola eccezione, che Lei ha appena definito come un ampio campo, non esiste alcuna verità oggettiva.
Immanuel: Satana, Anticristo, non indurmi in tentazione! Non c’è dunque alcun criterio oggettivo per il bene e il male? I dieci comandamenti non sono una verità oggettiva? Non vi è alcuno scritto per il sistema della morale?
Afrodite: Vi sono certo scritti di questo tipo, ma si tratta di razionalizzazioni di emozioni. Ad esempio sta scritto “tu non ucciderai”. Questa è appunto una razionalizzazione dell’esperienza emotiva elementare della “cattiva coscienza” che gli uomini si sono costruiti dopo aver ucciso altri uomini. Queste parole, così scritte, sono necessarie per pensatori baby con emozioni deboli o per uomini malati che sarebbe bene rinchiudere in ospedali piuttosto che in prigione, ma certo non per adulti con sane, chiare e profonde emozioni.
Immanuel: Lei dunque mi spinge in un dominio di completo soggettivismo in materia di fede e di morale. Secondo quanto Lei afferma non avrebbe assolutamente alcun senso la domanda “Perché il signor X non crede in un Dio personale?” oppure “perché la signorina Y è così nazionalista?” Così come nell’ambito dell’amore tra persone non ha alcun senso chiedere “perché la signorina X non ama il signor Y?” Tutto quello che Lei ha dire su questo è che certe parole suscitano certe emozioni in alcuni uomini, mentre ne suscitano altre, o nessuna, in uomini diversi. Se le emozioni di qualcuno non sono sensibili al quinto comandamento “tu non ucciderai”, non ci si può fare proprio niente. La grande idea diventa ora “soltanto” una razionalizzazione che non raggiunge più il suo scopo di riprodurre e guidare le emozioni. “Il signor X non è più guidato dal quinto comandamento, egli ucciderà”. “Nella nazione A le canzoni nazionali richiamano, in grandi raduni di folla, emozioni tali da spingere la nazione ad intraprendere una guerra contro la nazione B.” “Il signor X non può soffrire la comunità e si rifiuta di partecipare alla guerra”. Sono sicuramente tutte realtà emotive semplici e loro razionalizzazioni, proprio come “la signorina X si innamora del signor Y”. Soltanto i pensatori baby si chiedono perché.
Comincio a disperarmi: ciò non avrebbe dunque nulla a che fare con una verità oggettiva, perché riguarda solo sentimenti; devo prendere tutte queste reazioni emotive come semplici dati di fatto. Ci sono soltanto amore, odio ed emozioni, indipendenti e libere, ci possono essere ragioni che li motivano, ma non hanno alcun interesse. Non c’è alcuna responsabilità morale, non c’è nessuno spirito santo!
Tutto questo non mi soddisfa, sento proprio di dissociarmene!
Afrodite: Povero pazzo, non ho mai detto che le emozioni siano libere e indipendenti, anche se nego che esse siano direttamente influenzate dalle idee. I filosofi sensisti dicevano “nihil est in intellectu, quod non antea fuerit in sensu”. Mentre io dico “nihil est in intellectu, quod non antea fuerit in corde”. Le emozioni non sono mai isolate, così come Lei le ha descritte. C’è un legame segreto tra tutte le emozioni del mondo, anche se non viene percepito. Per questo le emozioni sono influenzate da altre emozioni e hanno una vita propria. Esse sviluppano una loro tendenza interna a crescere e a propagarsi, come le piante. Perciò devo far di tutto per unificare, e rafforzare, emozioni diverse, e devo impiegare qualsiasi mezzo per raggiungere questo scopo. La musica, la poesia, lo spirito – e persino Lei. Ammetto che La sto usando, tuttavia non creda di essere altro che uno strumento per tale fine. Lo chiami pure “crescita della coscienza” se vuole, ma non si dimentichi che la coscienza non consiste soltanto di parole, idee e pensieri. Ogni emozione che sia abbastanza chiara, intensa e profonda, di per sé fa crescere la coscienza, senza parole.
Immanuel: Sono ben lieto di vedere che anche una donna usa la logica, e che Lei mi usa. Ma ho ancora molte difficoltà a proposito del soggettivismo morale e le sue terribili conseguenze come la guerra, la fame e la povertà. Abbiamo bisogno di un sistema morale valido in generale, come i dieci comandamenti.
Afrodite: dapprima sono stata rinchiusa nella famiglia e nelle chiese, poi nei libri di filosofia e infine si è cercato di comperarmi per la mia utilità. Ho bisogno del male, della guerra e delle catastrofi per essere liberata. Finché rimango rinchiusa tutto andrà avanti sempre così e le Sue razionalizzazioni saranno inutili.
Immanuel: soltanto in assenza dello spirito Lei non sarà mai liberata ed avrà sempre bisogno di me, così come io avrò bisogno di Lei. Lei stessa è soltanto uno strumento per raggiungere scopi lontani e sconosciuti. Perciò sempre ci saranno amore, matrimoni e bambini. Questi sempre chiederanno “perché?” e “che cosa venne prima, il pensiero o l’emozione?”, il che mi ricorda l’antica scherzosa domanda “viene prima l’uovo o la gallina?”. Quello che davvero venne prima fu qualcosa che era tanto pensiero quanto emozione, e anche intuizione e sentimento, qualcosa da cui origina la radice della vita e dove nascita e morte sono un tutt’uno. Se abbiamo una sufficiente intensità e ci spingiamo a questa profondità, ciascuno a suo modo, Lei vedrà che io sono un’immagine dentro di Lei, così come io vidi che Lei è un’immagine dentro di me. È questo lo scopo del vero matrimonio e ne è anche la causa prima, perché a tale livello di profondità scopo e causa prima sono la stessa cosa. E l’intera morale è racchiusa nella coscienza che ciascuno è un’immagine all’interno di chiunque altro. È vero che questa immagine è soltanto una razionalizzazione della vita, ma è anche vero che la vita è soltanto la realizzazione di un’immagine.
Afrodite e Immanuel: E così per sempre nei secoli!
di Biagio Cepollaro
La critica come “esperienza di lettura”.
[Nel 2006 scrissi alcune note nell’intento di mettere a fuoco ciò che per me era l’atto della critica come atto di lettura. Sono apparse poi sulla rivista Atelier, Numero 46, giugno 2007. Tale scritto ha dato il titolo ai Quaderni di critica letteraria che curai con Andrea Inglese tra il 2007 e il 2010 e che si possono leggere qui.
Ripropongo qui, come materiali, gli undici punti che inviai come stimolo iniziale agli invitati alla serata dedicata al tema della critica di Tu se sai dire dillo 2014. B.C.]
1.
Cosa vuol dire, leggendo della poesia, fare poi della critica? Cosa vuol dire oggi, in un tempo in cui il testo come entità semiologica, tende ad avere diverso statuto, incalzato dall’oralità secondaria (Walter Ong) della telematica e dall’utilizzo di altri media, diversi dal libro, con relative implicazioni?
Paradossalmente l’esteriorizzazione a cui sembra richiamare il mutamento del paesaggio tecnologico, invita, può invitare, ad una concentrazione maggiore sull’atto di lettura (a monitor, su foglio appena uscito dalla stampante, su pagina densa di libro)…
2.
Le dimensioni a cui un testo poetico allude, il crocevia di informazioni in cui consiste, anche quando si irrigidisce in una pretesa autoreferenziale, anche quando esibisce la sua letterarietà come un luogo atemporale e impermeabile, sono troppo presenti perché sia possibile ignorarle.
Certo, vi sono testi che indicano questa molteplicità di attraversamenti, altri testi che addirittura mimano il caotico sovrapporsi di informazioni, ma il punto è sempre, per chi legge, riuscire ad individuare il punto di vista, la posizione, il contributo di intelligenza che non è calco ma fattura originale dell’autore. Perché dall’altra parte del testo c’è un autore: qualcuno che ha ridotto la molteplicità ad una serie di scelte discrete: ha scelto per noi un lessico, una sintassi, una ritmica. Oppure si può dire che da queste cose è stato scelto. Se si dice in questo secondo modo, la ragione sta nel fatto che si sottolinea la parte non consapevole dell’agire artistico. Dunque alla fine il paradosso di un agire non consapevole capace di questi attraversamenti molteplici …
E allora da dove origina uno stile piuttosto che un altro? Una selezione lessicale, sintattica, ritmica, piuttosto che un’altra? Il critico dovrebbe, tra l’altro, forse mostrare proprio la necessità di questa riduzione (la configurazione formale): in questa sottrazione di possibilità, tra l’altro, sta il segreto dell’efficacia di quella allusione alla molteplicità di dimensioni …
3.
Le convenzioni letterarie, e in genere, le strutture che permangono nel tempo, riconoscibili socialmente come arte, le fondamenta antropologiche della poesia, sopravvivono attraverso i secoli e le tecnologie, mutando continuamente, non solo nell’utilizzo dei materiali ma anche nelle funzioni.
E così da un certo punto di vista l’oralità primaria delle epoche prima dell’invenzione della scrittura e della stampa, e l’oralità secondaria indotta dalle nuove tecnologie, non spostano nulla di fondamentale per quel che concerne il ‘fenomeno di lunga durata’ che è l’arte o la poesia, in questo caso. Eppure le convenzioni di volta in volta devono essere animate per poter vivere; il rito continuamente deve rinnovarsi come esperienza di qualcuno, anzi come esperienza di più di uno …
Ed è da questo lato, dal lato di chi rinnova il rito, dal lato delle sue concrete circostanze storiche peculiari, che la nostra attenzione si sposta, quando si formula la domanda intorno al leggere, cioè all’uso concreto della poesia.
La critica è innanzitutto un atto di lettura che attualizza, in senso letterale, una ritualità dell’immaginazione e del pensiero. Ma i modi dell’immaginazione e del pensiero sono sempre legati a contesti peculiari: forse è proprio questo lo specifico di una critica che riemerge come bisogno, bisogno di tratteggiare delle peculiarità .
Chi fa la poesia sente oscuramente che i modi della critica, cioè i modi della lettura, devono rinnovarsi nel rinnovarsi dei contesti … Ogni atto di lettura ripercorre le scelte, le prospettive complessive a partire dalle quali le selezioni (lessicali, sintattiche, ritmiche, metriche etc.) si sono realizzate. Questi punti di vista si ancorano alla radice doppia del dentro e del fuori, della molteplicità degli attraversamenti e delle scelte compiute: tutto ciò va ripercorso accettandone le sollecitazioni, amplificando questo o quell’aspetto dell’insieme.
Rispondere a tali sollecitazioni (di immaginazione e pensiero) significa leggere, ricostruire il punto di vista, significa interpretare: aggiungere una chiave al mazzo delle esperienze possibili.
4.
L’atto di lettura del critico, nella sua imprevedibilità di esperienza, resta comunque un gesto disciplinato. Innanzitutto diventano assai problematiche le classificazioni che veicolano, in modo più o meno implicito, delle ipostatizzazioni e delle ontologizzazioni del testo. Le classificazioni nascono soprattutto dall’esigenza economica di produrre dei segni che abbiano funzione distintiva, ma l’atto di lettura come ‘esperienza di qualcuno, anzi come esperienza di più di uno’, come si diceva nella Nota 3, segue non una logica dell’economia ma una logica della moltiplicazione e dell’amplificazione semantica per risonanza.
Non si tratta, leggendo, di ridurre i molti all’uno ma al contrario di moltiplicare la prodigiosa sintesi in cui consiste il testo, nella molteplicità degli esiti possibili: la ritualità dell’immaginazione e del pensiero è, tra l’altro, proprio questo rispondere del lettore, questo ripercorrere, a partire dalla configurazione formale del testo, le scelte e gli esiti possibili di quelle scelte. Leggere è insomma un lasciar risuonare una chiave provando ad aprire altre porte, già comprese nel testo, ma ancora silenti. In questo senso il testo importa soprattutto per quel che non dice, non perché non l’avrebbe mai detto, ma perché ciò che ha detto attendeva il lettore per poter esser ascoltato, per risuonare. Ecco perché in una poesia, precisa nella sua configurazione formale, ogni elemento è semantizzato.
5.
In un certo senso la critica negativa non ha motivo di esserci. L’atto di lettura è promessa di esperienza e l’esperienza che si ritiene non valida, non significativa, è un’esperienza interrotta, morta al suo nascere, come un passo che non segue l’altro. Il critico non ha motivi per censurare, semplicemente smette di leggere. Censurare comporta un passaggio dal piano dell’esperienza della lettura a quello delle razionalizzanti ipostasi del gusto. Questo è il nodo che permette all’ideologia di sostituirsi all’atto di lettura finendo per adulterare l’intero processo.
L’atto ‘positivo’ del critico, come lasciar risuonare una chiave provando ad aprire altre porte, non abbisogna di sostegni esterni, ideologici, gli strumenti di cui fa uso sono subordinati all’esperienza che va facendo, così come scarponi, corde, e altro necessitano a chi va per monti.
Alla fine della lettura ci sarà ancora il testo e la sua moltiplicazione, la risposta, l’attualizzazione di possibili sensi, mentre nel caso della critica negativa, della censura, il testo non c’è più e vi sono soltanto ribaditi i punti di partenza del critico, le sue convinzioni più o meno sclerotiche, i suoi fantasmi identitari.
L’ascolto di chi legge è già un rispondere se leggere è appunto riattivazione di una ritualità dell’immaginazione e del pensiero.
L’atto di lettura, insomma, o avviene o non avviene. L’esperienza o avviene o non avviene. Ma se non avviene non vi sarà nulla da dire, così come degli innumerevoli eventi di una giornata nessuno fa cenno perché ritenuti non pertinenti.
Il punto non è stabilire, leggendo, dei valori, e delle relazioni tra valori, ma leggere, appunto. La materia del testo in qualche caso non ci abbandona dopo la lettura, noi continuiamo a parlare la nostra lingua ma, in modo appena percettibile, questa , dopo l’esperienza della lettura, risuona diversa.
Quando si dice banalmente che la lettura arricchisce non ci si riferisce a dei contenuti ma all’ampiezza dei toni e delle tonalità di cui siamo capaci . L’esperienza della lettura, come ogni altra esperienza, in misura diversa, coinvolge simultaneamente i livelli mentali, emotivi e fisici: il lettore dovrebbe in questo caso, dopo la lettura, ritrovare in sé un’ampiezza di spettro del pensare, del sentire e dell’immaginare, accresciuta e approfondita.
6.
Il nuovo non è costitutivo del testo ma dell’esperienza che del testo si fa.
Si possono leggere molte volte gli stessi libri perché ogni volta quei libri sono nuovi nell’interazione con il lettore. Il nuovo non è categoria ontologica ma relativa all’esperienza di qualcuno … D’altra parte l’esperienza perché sia tale è sempre nuova.
L’ideologia moderna dell’avanguardia trova uno dei suoi fondamenti nell’ontologizzazione del nuovo così come l’ideologia postmoderna lo trova nella sua negazione. Anche qui alla concretezza delle relazioni, dagli esiti sempre imprevedibili, si è sostituita l’astratta identità di un’ ipostasi.
Quindi il nuovo non sembra ridursi ad un oggetto ma sembra piuttosto essere una relazione di volta in volta imprevedibile.
Tale aggettivo non andrebbe mai sostantivato, reso sostanza: vuol dire cose diverse di volta in volta in contesti diversi. Per un lettore non dovrebbe porsi tale questione: la lettura non cerca il nuovo perché essa stessa in quanto esperienza di qualcuno, se davvero è tale, se davvero riesce a riattivare una ritualità dell’immaginazione e del pensiero, è sempre nuova.
7.
Il detto ‘si fa ciò che si è’, riferito all’arte, può anche voler dire che leggere è sempre un leggere tra le righe. L’extratestuale coincide con ciò che traspare tra le righe, non come qualcosa di estraneo al testo ma come qualcosa che sembra averlo generato; alla fine della lettura sarà il suo senso, anzi, un suo senso. La scelta lessicale, la voce che cova nelle relazioni fonosimboliche, l’intero impianto retorico sono la materia del senso e dei sensi da ricostruire, da ripercorrere.
Le porte che la lettura dovrà aprire sono le porte che alludono all’esperienza dell’autore che la prodigiosa sintesi del testo racchiude, socchiuse.
Più accosto è il movimento della lettura ai passi che il testo compie, più si avvicina il momento in cui si profila il senso, cioè l’esperienza di uno tende a diventare l’esperienza di un altro.
Ricostruire il punto di vista significa interpretare: non abbiamo mai di fronte ciò che un autore è ma sempre ciò che un autore ha fatto. Eppure ciò che ha fatto lo possiamo interpretare leggendo tra le righe ciò che lui è. Credevamo di esserci appiattiti sulle parole del testo, sul testo come insieme di parole, e ci ritroviamo, invece, con un possibile distillato di umana esperienza.
8.
Una poesia, alla lettura, innanzitutto consiste in un insieme di parole collocate e collegate in modo tale da essere riconosciute come poesia, appunto. Il Poetico costituisce l’orizzonte d’attesa della poesia anche se spesso quando la Poesia viene riconosciuta, il Poetico è costretto a riconfigurarsi.
La tautologia che lega Poesia e Poetico non è statica ma continuamente si trasforma al suo interno. Ciò che ieri, in molti casi, aveva funzione politico-religiosa, oggi ha funzione estetica.
Ma si potrebbe anche notare come molta della produzione estetica attuale (non certamente poetica per questione di mancata diffusione, ma massmediale) ha funzione politica e mitologica. Su questa ultima condizione si è spesso in passato concentrata la critica della cultura, essa stessa, come si è detto, ipostatizzante.
La presunta separatezza della sfera estetica da quella morale, psicologica, religiosa, economica e politica, alimenta uno di quei pregiudizi che hanno caricato la stessa sfera dell’arte di tutto il peso di queste mutilazioni. L’egotismo dell’artista potrebbe essere considerato anche come una conseguenza di questo sovraccarico, quasi a compensazione e a risarcimento della frattura.
La ricerca del nuovo del moderno si è così concentrata, per lo più, sulle parole e sul modo di collocarle e collegarle, più che sul nuovo come una relazione di volta in volta imprevedibile, come una qualità dell’esperienza non mutilata, non relegata alla sfera estetica, salvo il rovesciamento puro e semplice delle poetiche nelle ideologie.
Le avanguardie storiche, tra l’altro, hanno preparato il terreno per ciò che sarebbe diventata l’estetizzazione della vita e della politica: la vita, o meglio, le rappresentazioni della vita, come opera d’arte. L’universo massmediale ha potenziato tecnologicamente in modo esponenziale la forza e la pervasività di queste rappresentazioni, riducendo e standardizzando ma anche offrendo, in qualche caso, stimoli alla ricerca artistica, dal momento che spesso un nuovo medium retroagisce su quello precedente.
Una lettura che legga tra le righe tende a ricomporre ciò che è stato diviso: la logica della moltiplicazione e dell’amplificazione semantica per risonanza aprirà le porte che il Poetico costituito, nella separatezza della sfera dell’arte, tende a lasciar chiuse.
Leggere tra le righe potrebbe voler dire allora ricondurre il testo alla sua potenzialità morale, psicologica, politica…
9.
Se bisogna essere qualcosa per fare qualcosa, ciò vale anche per il lettore. Un lettore potrà aprire solo le porte del testo di cui in qualche modo, anche solo per un presentimento, aveva la chiave. Conoscere qui è più che mai riconoscere. E la gratitudine del lettore, ad esperienza compiuta, è propriamente riconoscenza.
La chiave in questione non è soprattutto nozione stilistico-retorica. Tale modo di intendere i prerequisiti del lettore sono da ascrivere a quella concezione romantico-avanguardista-postmoderna della separatezza sostanziale dell’arte. La chiave in questione appartiene piuttosto a quel percorso inverso che dalla separatezza porta alla reintegrazione: il leggere tra le righe. Reintegrazione non è altro che ricostruzione di una prospettiva, aggiungere una chiave al mazzo delle esperienze possibili, ricondurre il testo alla sua potenzialità morale, psicologica, politica …, appunto.
Il cosiddetto godimento estetico può essere considerato come un effetto collaterale di questa reintegrazione che è, insieme, cognitiva, emotiva e, in una certa misura, fisica.
Le fondamenta antropologiche della poesia, ciò che della poesia e dell’arte fa fenomeni di ‘lunga durata’, si ritrovano proprio in questo carattere di reintegrazione simbolica. La lettura che si limita all’ analisi stilistico-retorica spesso finisce con ipostatizzare le convenzioni letterarie, rendendo il testo simile ad un feticcio, mentre, come si è detto nella Nota 3, ‘le convenzioni di volta in volta devono essere animate per poter vivere; il rito continuamente deve rinnovarsi come esperienza di qualcuno, anzi come esperienza di più di uno …’
10.
Ricondurre il testo alla sua potenzialità morale, psicologica, politica, tenderebbe a radicare l’atto della lettura nelle fondamenta antropologiche della poesia, riconoscendole pienamente.
Il testo si presta alla lettura come una voce che parla ai molti anche se in pochi o pochissimi ascoltano. Ciò vuol dire che il significato sociale della poesia è costitutivo, non contingente. Ed è puramente una questione quantitativa la cerchia dei lettori potenziali o reali, dal momento che sul piano della qualità, e quindi anche della qualità dell’umana esperienza, i lettori per un testo sono sempre e, sin dall’inizio, una possibilità indefinita nello spazio e nel tempo.
A fronte della reintegrazione simbolica dei piani molteplici dell’esperienza umana, massima promessa che l’arte condivide con ogni ritualità dell’immaginazione e del pensiero, le persistenze egotiche di matrice romantica, relative alla confusione tra individualismo proprietario borghese ed epopea dell’Io, possono anche passare in secondo piano. Così come le lamentazioni sempre pronte a richiedere risarcimenti in termini di fama, se non di danaro, sembrano fraintendere il carattere sociale costitutivo della poesia e dell’arte. Perdendo il senso e il gusto della festa, resta, in non pochi casi, solo l’accumulo dell’amarezza: ciò è davvero un peccato.
11.
Dunque sembra che potremmo scegliere di confrontare, tra le tante, due strade che qui con chiarezza si scorgono: una è quella dell’ estetizzazione della lettura (insistenza sulla separatezza del testo con rischio di asfissia autoreferenziale o sulla classificazione che fa, dei termini distintivi, delle categorie interpretative non sempre rispettose della pecularietà dei testi), l’altra, quella della reintegrazione, che si è chiamata lettura come attualizzazione della ritualità dell’immaginazione e del pensiero che punti alla potenzialità morale, psicologica, politica del testo attraverso la moltiplicazione e l’amplificazione semantica per risonanza.
Nel primo caso l’analisi, più o meno compiutamente testuale, in definitiva ci dirà: ‘il testo si tiene in piedi così e così’, A=A, la classificazione ci dirà:‘questo testo rientra nella categoria, inventata ad hoc, di testi che hanno le medesime caratteristiche’ e se introduce anche relazioni di valore ci dirà: ‘questo testo è migliore di quest’altro’, A>B, oppure A<B, in caso contrario.
Nel secondo caso, quello della reintegrazione, la lettura, nella sua imprevedibilità di esperienza, nella consapevolezza della molteplice possibilità degli esiti, presuppone che ‘il testo dica qualcosa e lo dica in questo modo’.
Il qualcosa che il testo dice, nell’atto della lettura, è proprio una potenzialità del suo senso, alla cui attuazione concorrono tutti i suoi elementi formali, insieme e grazie, a ciò che il lettore fa leggendo tra le righe: aprire le porte del testo di cui in qualche modo, anche solo per un presentimento, aveva la chiave.
di Federico Di Vita
 Avete presente Lady Midnight di Leonard Coen? La canzone parte con l’ossessiva richiesta di un innamorato (Whatever you give me, I seem to need so much more) cui risponde la sfida della donna (Just win me or lose me / It is this that the darkness is for), per concludersi col perfetto ribaltamento delle parti quando, nell’ultima strofa, è la signora a implorare l’amante (You’ve won me, you’ve won me, my lord), chiudendo un cerchio di desiderio febbrile, in quella che è una sintesi mirabile di uno dei grandi classici della letteratura: la furia d’amore, la fuga, l’inseguimento, il ritorno disperato – del resto a teorizzare che tanta parte delle nostre lettere sia giocata su questo schema è stato Denis de Rougemont ne L’Amore e l’occidente – e basti pensare alla figura di Elena di Troia per capire quanta ragione avesse… in ogni caso, pare che l’antico pozzo non abbia alcuna intenzione di prosciugarsi, e il gorgo dell’amore, usurato ma divorante, continua a far scaturire varianti. L’ultima in cui mi è capitato di imbattermi è la storia raccontata in Voi due senza di me di Emiliano Gucci (Feltrinelli, 222 pp, 16 euro), la cui vicenda è tutta tesa a colmare le distanze createsi in venti anni di lontananza – e di pensiero costante, rimorso, nostalgia – tra Marta e Michele, un tempo coppia invincibile il cui rapporto si è spezzato in seguito a un evento drammatico.
Avete presente Lady Midnight di Leonard Coen? La canzone parte con l’ossessiva richiesta di un innamorato (Whatever you give me, I seem to need so much more) cui risponde la sfida della donna (Just win me or lose me / It is this that the darkness is for), per concludersi col perfetto ribaltamento delle parti quando, nell’ultima strofa, è la signora a implorare l’amante (You’ve won me, you’ve won me, my lord), chiudendo un cerchio di desiderio febbrile, in quella che è una sintesi mirabile di uno dei grandi classici della letteratura: la furia d’amore, la fuga, l’inseguimento, il ritorno disperato – del resto a teorizzare che tanta parte delle nostre lettere sia giocata su questo schema è stato Denis de Rougemont ne L’Amore e l’occidente – e basti pensare alla figura di Elena di Troia per capire quanta ragione avesse… in ogni caso, pare che l’antico pozzo non abbia alcuna intenzione di prosciugarsi, e il gorgo dell’amore, usurato ma divorante, continua a far scaturire varianti. L’ultima in cui mi è capitato di imbattermi è la storia raccontata in Voi due senza di me di Emiliano Gucci (Feltrinelli, 222 pp, 16 euro), la cui vicenda è tutta tesa a colmare le distanze createsi in venti anni di lontananza – e di pensiero costante, rimorso, nostalgia – tra Marta e Michele, un tempo coppia invincibile il cui rapporto si è spezzato in seguito a un evento drammatico.
Si capisce subito, sin dal titolo, che a raccontare la storia è il figlio dei due, mai chiamato per nome, morto giovanissimo a causa di una disattenzione (o forse qualcosa di peggio) di Marta, mentre Michele si era allontanato dopo un momento di tensione. La morte del fanciullo, così come fecero le sue urla disperate di poppante, sembrano segnare più profondamente la donna, che regge meno lo stress emotivo esplorando spazi di disperazione sconosciuti, l’insonnia le incrina una diga profonda. Michele appare sin dall’inizio più ossessionato invece da lei, da Marta, e dalla purezza del loro irripetibile amore, che anche a distanza di tempo non ha mai smesso di apparire come una Stella polare a cui tendere, alla quale tornare con l’idea (impossibile?) di farla rivivere. La brama cieca di ritorno di Michele fa venire in mente quella della Lupa di Giovanni Verga, alimentata (come a tratti il protagonista del romanzo di Gucci) da una brama erotica cieca e totalizzante.
In Voi due senza di me la brace del sentimento brucia sotto le ceneri dei due vecchi amanti, certi amori non si schiodano dalla mente di chi li ha vissuti, di più, dalla tattile memoria del corpo, dagli automatismi animaleschi. Ma è ripetibile l’amore dei vent’anni? Michele vuole credere di sì e per questo torna – a dieci anni di distanza – a cercare Marta, non aveva mai smesso di seguirla, di informarsi su di lei, con derive a tratti da stalker, da maniaco. Ma anche Marta non l’aveva mai dimenticato, e come accade in Lady Midnight anche questo romanzo è costruito attorno a un ribaltamento, articolato nelle due giornate – a distanza di dieci anni l’una dall’altra – nella prima delle quali a cercare l’altro è Michele, mentre nella seconda è Marta a tornare. La specularità anche qui è perfetta: nella prima occasione era Marta a essersi costruita una nuova vita, nella seconda è Michele, che a quel punto ha addirittura un altro figlio.
Se parlo di alcuni dettagli della trama lo faccio perché il romanzo di Gucci non vive di questi elementi (gli incidenti della vita dei due protagonisti sono comuni, e tolto il tragico innesco, anzi compreso pure quello, perfino banali – come è giusto che sia: sono in scena sentimenti assoluti in una danza di archetipi millenaria), a tenerlo su sono la delicatezza dello scavo psicologico, la finezza linguistica (esempio: il titolo dei capitoli è costituito dall’attacco della prima frase, in un modo che rimanda alla Vita Nuova di Dante), e le impennate liriche – che si dispiegano in una prosa di cui l’autore non perde mai il controllo –, tra queste vale la pena ricordare almeno le pagine laceranti eppure lievi in cui Michele tenta di riconquistare Marta. Colpisce l’equilibrio che Gucci riesce a mantenere tra la violenza di alcune scene (una rissa tra cani, il ricordo degli ultimi istanti del figlio, il suicidio di un vecchio amico) e la costante felicità del linguaggio, che in un libro giocato tutto sulla dinamica sentimentale non scade mai nel melenso.
Gucci ambienta il romanzo a Firenze (tra le boutique del centro e i paesini dell’hinterland), uno sfondo che gioca un ruolo marginale, a volte si ha la sensazione che l’autore vorrebbe caricarlo di significati maggiori ma che poi si trattenga di fronte alla consapevolezza che uno scenario così già visto non possa in fondo ambire, in una storia come questa, che ad un ruolo da fondale di cartapesta. Per sottolineare l’eccezionalità degli incontri allora l’autore ricorre a un altro sistema, è l’aria stessa a colorarsi in modo eccezionale: nella prima occasione di un azzurro soprannaturale, “come ormai non si vede più”, e nella seconda del bianco di un’abbondante nevicata. Queste figure atmosferiche sono di tutto il romanzo forse l’elemento che mi ha convinto meno: la straordinarietà degli incontri e la potenza degli spettri chiamati in causa era tale da non necessitare di null’altro che della sua viscerale potenza (questa evocata magistralmente lungo tutta la tessitura) per continuare, ancora una volta, a far vibrare nel cuore del lettore corde antiche e tremendamente sensibili.

di Marina Massenz
Appena toccammo terra, uscendo da una valigia aperta alla dogana, capimmo di essere nel Nuovo Mondo. Dal nostro primo punto d’osservazione, una rientranza del bordo del marciapiede, vedevamo infatti marciare una serrata flottiglia di scarpe da ginnastica. Tutti si muovevano sportivamente.
Con la nostra struttura, fatta solo di scheletro, un asse centrale e diverse ramificazioni trasversali, non ci sarebbe stato facile passare all’operazione “metamorfosi”, così insita nella nostra natura e che sempre ci aveva aiutato in simili situazioni. Camuffarci da scarpe da ginnastica sarebbe stato impossibile anche per noi. Ci suggerì la soluzione la panoramica locale vista dal marciapiede che adottammo come secondo punto di osservazione. La passeggiata mostrava maggior varietà e a suggerirci la soluzione adatta ci apparvero dei sandali. Neri, come noi, con un listello centrale e vari trasversali, erano la forma già in voga in questo Nuovo Mondo che più si avvicinava alle nostre possibilità. Non ci restava quindi che creare quella materia bianco-rosata che univa un listello all’altro e al resto dell’essere in movimento. Attivammo le nostre particolari risorse, senza troppa difficoltà, diventando la forma compiuta adeguata a questo nuovo ambiente e ci mettemmo in moto allegramente lungo il marciapiede, mischiandoci alla flottiglia multicolore. Dai battelli che solcavano il fiume Hudson giungeva ad intermittenza il suono delle sirene, come proveniente dallo sfiatatoio di un immenso polmone rauco.