di Davide Gatto

Uno scrittore e saggista poliedrico e inafferrabile Georges Bataille (1897-1962), un non specialista che si è concesso la libertà di rincorrere il suo pensiero attraverso i tradizionali confini accademici tra le discipline riuscendo nel contempo a stimolare con la sua eccentricità la riflessione di specialisti quali Sartre, Blanchot[1], Derrida, Arendt[2], Baudrillard[3] e altri, tanti che citarli tutti renderebbe assai lungo l’elenco.
Un pensatore inoltre caparbio e ossessivo – anche spericolato se si considera la leggerezza con cui in questo libro trascorre da un capo all’altro della storia, dell’economia, dell’etnologia -, un pensatore capace, una volta intravista una grande idea, di inseguirla per tutta la vita e in tutte le sue opere come un vero predatore, o come un vero artista o un vero filosofo: in fondo è lo stesso.
È la stessa scelta editoriale originale di questo testo (1967, Editions de Minuit, Paris) a dimostrarlo: La parte maledetta, pubblicato la prima volta nel 1949, è uno svolgimento coerente dell’idea centrale contenuta ne La nozione di dépense, saggio apparso su «La Critique sociale» nel gennaio del 1933 e più volte ripreso e rielaborato.
L’idea chiave, a partire dalla quale Bataille attua un capovolgimento totale della legge fondamentale dell’economia politica, è che l’attività principale dell’uomo, quella che meglio lo determina e che determina in definitiva una data società e l’intera storia, non è la produzione e la conservazione di beni in vista di un profitto futuro, dell’utile, ma il dispendio improduttivo delle risorse, la consumazione senza tornaconto, lo spreco, il lusso: la dépense, conservando l’ampiezza semantica che il termine francese ha nel saggio di Bataille[4].
In principio è l’energia (ovvero: L’energia universale e la necessità del dispendio)
Lo sguardo di Bataille sull’economia è innanzitutto vasto, una vastità che chiama in causa il movimento incessante e infinito dell’energia materiale dell’universo e che viene deliberatamente opposta come un rimprovero alla ristrettezza di vedute dell’economia classica. Mentre quest’ultima infatti, “particolare”, delimita un campo misurabile dell’agire umano in cui risorse (apparentemente) limitate devono essere accumulate e lavorate per soddisfare necessità potenzialmente illimitate di un individuo o di un gruppo sociale, Bataille non manca di far notare che dalla prospettiva dell’inesauribile energia che dal cosmo il sole irradia sulla terra la “questione primaria dell’economia” – e non solo – è data dal movimento “dell’energia eccedente, tradotto nell’effervescenza della vita.”[5]
Infatti – argomenta Bataille – se noi guardiamo al mondo naturale, osserviamo che l’energia che alimenta il rafforzamento e l’estensione di una specie vegetale o animale è sempre sovrabbondante, tanto che darebbe luogo a una crescita infinita se non incontrasse qualche limite.[6] Limite, peraltro, che è intrinseco alla vita sulla terra, e quindi anche ad ogni attività umana: “La limitazione immediata per ogni individuo, per ogni gruppo, è data dagli altri individui, dagli altri gruppi.”[7]
Invece che concentrarsi sulla crescita dunque – come fanno gli economisti classici e l’intera logica del capitalismo e del liberismo borghese che noi tutti abbiamo introiettato -, Bataille rivolge la sua attenzione alla sorte dell’energia che, una volta incontrato un ostacolo, una volta che non può più convertirsi in crescita, diventa necessariamente esuberante, eccedente, “sempre al limite dell’esplosione”.[8]
Non appena l’indagine dell’economia politica, che marxianamente investe come sovrastruttura l’intero campo della storia e delle altre attività umane, venga estesa ai meccanismi di dilapidazione del sovrappiù, di dépense appunto – ragiona Bataille – il primo fenomeno che si presenta allo sguardo è che senza questo dispendio inutile dell’eccedente il ribollire dell’energia giunta al limite della sua conversione in crescita può esplodere in esiti disastrosi.[9]
Si tratta quindi per Bataille non solo di comprendere i modi della dépense nel ragionamento economico (e di conseguenza politico, sociale, culturale), ma di apprezzare i valori che essa indubbiamente e naturalmente possiede al di là dello schermo utilitaristico dominante che la fa apparire ai nostri occhi come – appunto – “parte maledetta”.
La parte maledetta, tra economia e antropologia
Basta d’altronde scorrere l’elenco di attività umane che Bataille rubrica come “spese cosiddette improduttive” per riconoscerle istintivamente come maledette, oggetto cioè di riprovazione, di angoscia, quando non addirittura di scongiuro: “il lusso, i lutti, le guerre, i culti, le costruzioni di monumenti suntuari, i giochi, gli spettacoli, le arti, l’attività sessuale perversa (cioè deviata dalla finalità genitale) (…).”[10]
Questa angoscia, paradossale visto che secondo Bataille “l’uomo è, tra tutti gli esseri viventi, il più adatto a consumare intensamente, lussuosamente l’eccedente di energia che la pressione della vita offre”[11], dipende dal “punto di vista particolare” con cui si guarda a una “situazione generale”: “A partire dal punto di vista particolare, i problemi sono in primo luogo posti dall’insufficienza delle risorse. Se si parte dal punto di vista generale, sono invece posti in primo luogo dal loro eccesso.”[12]
Mentre dunque l’individuo teme la guerra per la miseria che gli può arrecare, fino alla miseria massima data dall’annullamento di sé con la morte, o riprova il lusso e la lussuria per la dispersione di energie e di risorse che essi comportano, secondo le leggi generali dell’economia guerra, morte, lusso e lussuria sono meccanismi indispensabili di dilapidazione dell’eccedente, così da garantire una stabilità complessiva: “(…) se si considera la vita nel suo complesso, non c’è in realtà crescita, ma conservazione del volume in generale”, così che “la crescita viene ridotta a una compensazione delle distruzioni operate.”[13]
Il punto è cruciale, dato che l’uomo non può arrestare il movimento sempre eccedente dell’energia che circola sul globo, ma può acquisirne consapevolezza e decidere di volta in volta come usare il sovrappiù: “La nostra ignoranza (…) ci conduce a subire ciò che potremmo, se sapessimo, operare a nostro modo.”[14] Si comprendono bene le implicazioni, sempre attuali, di questa riflessione, che perviene senza possibilità di equivoco all’ipotesi, scandalosa solo per la morale borghese e capitalistica, di cessioni di ricchezza senza contropartita (non prestiti…) laddove questa dovesse diventare eccessiva e pronta a innescare esplosioni incontrollabili.
Ma l’indagine sulla percezione paradossale che noi abbiamo della cosiddetta “parte maledetta” possiede anche un risvolto più profondo, più filosofico.
Non si dà paradosso senza istanze in conflitto tra loro, senza una doppia modalità – qui propriamente antropologica – con cui nel caso specifico l’uomo pensa se stesso e il mondo che lo circonda. Un modo, a noi più familiare, ricade sotto la logica dell’utile, per cui ogni elemento della realtà –compresi gli altri uomini – è ridotto a un oggetto di cui servirsi, propriamente a una cosa. Di fatto – spiega con chiarezza Bataille – un mondo degradato a una congerie di cose che non hanno altra ragion d’essere che quella di servire ai bisogni di uno specifico uomo costringe anche quest’uomo nel rango delle cose, lo rende a sua volta servo delle cose di cui si serve: lo schiavo serve al padrone per incrementare i suoi profitti, il padrone serve allo schiavo per sopravvivere.[15] Questo “ordine delle cose” – come lo chiama Bataille – è stato originariamente introdotto dal lavoro, caratterizzato dalla preoccupazione per il futuro e dalla “posizione separata di ogni cosa, ridotta all’uso che essa ha.”[16]
D’altra parte però “A questo decadimento l’uomo di tutti i tempi si sforzò di sfuggire. (…) l’uomo è fin dall’inizio alla ricerca di una intimità perduta.”[17] Inutile a dirsi, questa intimità è connessa al movimento indistinto e incessante dell’universo, libera l’uomo da qualsiasi rapporto servile con la realtà intorno a lui e gli consente quindi di assecondare il suo desiderio presente senza fare alcun conto del tempo a venire: di essere profondamente autentico, libero e sovrano. Il rapporto di questa parte profonda e sfuggente della coscienza dell’uomo con la dépense, cioè con il dispendio inutile, è evidente: “La distruzione è il miglior mezzo per negare un rapporto utilitario tra l’uomo, l’animale o la pianta.”[18]
La partita che si gioca in questo libro – e nell’intero pensiero di Bataille[19] – è dunque doppia, come doppia è la natura dell’uomo: se pure reintegrare la categoria della consumazione infruttuosa nella riflessione politico-economica mira a rendere il mondo più equo, più stabile e più sicuro, il vero obiettivo di Bataille è avvicinare alla piena coscienza di sé e del suo bifrontismo l’uomo, per un verso teso a istituire rapporti servili con le cose in vista di una (impossibile) crescita illimitata, per l’altro a disprezzare la (inevitabile) reificazione di sé e del mondo per ritrovare l’intimità perduta, quella che lo stesso Bataille chiama “sovranità”.

Una panoramica etnologica e storica secondo il criterio rovesciato della dépense
Fissata una nuova legge generale dell’economia, per cui la forma di una società dipende dall’uso che essa fa dell’eccedente che sempre produce – può destinare questo surplus alla crescita, sia essa demografica, militare o degli impianti a loro volta produttivi, oppure destinarlo alle forme suntuarie della religione o del lusso personale, o ancora puramente consumarlo, distruggerlo –[20], e senza mai trascurare la fondamentale contraddizione antropologica cui poco sopra si accennava, Bataille traccia una rivoluzionaria – ancorché frammentaria e più che altro didascalica – storia dell’economia secondo la logica del dispendio inutile.
I primi a essere considerati sono gli antichi aztechi del Messico, che espressero una società di puro consumo del tutto antitetica alla nostra: persino le guerre non erano finalizzate ad altro che all’acquisto di ricchezze e prigionieri da sacrificare immediatamente e continuamente “affinché il sole potesse mangiare.”[21] Il consumo qui è interpretato come desiderio primario di sottrarsi all’ordine e alla servitù delle cose per riavvicinarsi alla sfera indifferenziata e intima del sacro in cui vittima e carnefice si sentono una cosa sola e l’energia eccedente si scarica in una festa collettiva.
Più interessante e centrale è poi l’indagine su un istituto sociale che gli aztechi condividono con popolazioni indiane di rilievo etnografico del Nord-ovest americano: il “potlàc”.[22] In questo caso personaggi di rango distruggevano pubblicamente enormi quantità dei loro beni, schiavi e prigionieri compresi, solo apparentemente senza contropartita: di fatto il disprezzo delle cose che così manifestavano – e che li avvicinava alla sfera del sacro, li sottraeva all’ordine servile delle cose – era finalizzato all’umiliazione di un avversario, che si sentiva a sua volta obbligato a rispondere con una distruzione ancora più grande. Bataille osserva qui pienamente dispiegata la contraddizione – inevitabile – per cui l’accesso alla sfera della intimità che solo la dilapidazione di energia consente non può che passare attraverso il campo delle cose: non si tratta più di dispendio inutile, ma finalizzato al mantenimento o all’acquisizione di una reputazione sociale, appunto di un rango.[23]
Passa quindi Bataille a considerare l’espansione militare dell’Islam dopo l’Ègira di Maometto, il profeta che secondo la prospettiva economica del dispendio avrebbe convertito la stabilità dilapidatrice delle tribù arabe dedite al lusso – per esempio – delle dispute filosofiche e poetiche in energia concentrata di conquista: una vera e propria società di impresa militare, tanto che Maometto vi figura come un direttore di fabbrica, severo fustigatore di ogni spreco, di ogni energia sottratta all’impresa. Una volta raggiunti però i limiti della crescita di conquista, le società islamiche – conformemente al tipico bifrontismo dell’uomo – sarebbero tornate alla stabilità e al dispendio culturale, come testimonia bene il recupero dell’antica passione per la poesia che dalla Spagna musulmana si sarebbe irradiata, attraverso la colta Castiglia di Alfonso X il Savio, alle più note (per noi) scuole di Provenza, di Sicilia e di Toscana.[24]
Alla ricerca di opposizioni estreme e quindi argomentativamente più convincenti, Bataille si sofferma anche sul lamaismo tibetano, una “società disarmata” che avrebbe scelto di destinare il suo pur misero eccedente ai monaci, che avrebbero assolto al compito di drenare con il loro parassitismo energie minacciose per la pace interna, dato che una eventuale espansione del Tibet era impedita, oltre che dalla conformazione del suo territorio, da paesi militarmente ed economicamente più forti (Cina e India inglese).
La rassegna si sposta quindi sulla nascita della società industriale, con un’analisi contrastiva che dal Medioevo cristiano giunge – fase dopo fase – fino all’odierna realtà borghese. Il Medioevo – puntualizza Bataille – è profondamente connotato in senso religioso in quanto destina gran parte dei suoi beni eccedenti (generalmente eccedenti) al lusso del clero e dei suoi riti. Lutero però coglie in questa attitudine che apparirebbe di puro dispendio, e quindi di liberazione dell’uomo dall’ordine delle cose, una contraddizione insanabile: la dilapidazione della Chiesa medievale ha comunque per fine un utile, la salvezza, e quindi ripristina di fatto il valore servile delle cose da cui proclama di voler affrancare l’uomo.
La soluzione di Lutero è però secondo Bataille ancora più fallimentare secondo la prospettiva della ricerca dell’intimità perduta, perché il padre della Riforma attua “una decisiva separazione di Dio e di tutto quanto non fosse la profonda vita interiore della fede, da tutto quanto possiamo fare e realmente effettuare”: la sua dottrina “è la negazione compiuta di un sistema di consumo intenso delle risorse”[25], di quella dépense che secondo il filosofo francese è l’unica via per sfiorare la nostra interiorità sovrana, non servile.
Sarà invece Calvino a rivalutare il mondo delle cose, della realtà trasformata produttivamente e utilitaristicamente in cosa, salvaguardando nel contempo la sfera del sacro – che è come dire dell’uomo emancipato dalla servitù alle cose -, visto che invita sì a impegnare tutte le energie a produrre e non a consumare, ma destina in partenza il frutto del lavoro a glorificare Dio, non ad avvantaggiare il produttore/detentore della ricchezza. Il capitalismo, che giustamente secondo Bataille Max Weber nel suo famoso saggio aveva legato all’etica protestante[26] – non farà altro che svincolare in modo netto il mondo della produzione dalla sfera del sacro, escludendo così completamente l’esigenza profonda dell’uomo di ritrovare la sua intimità, lo stato di un rapporto non servile con la realtà.
Dell’economia, ovvero della coscienza di sé
Dietro lo schermo dell’economia generale, degli usi molteplici e complessi che nell’accezione di Bataille le diverse società fanno dell’energia sempre eccedente, la posta in gioco è più alta: si tratta della necessità che l’uomo prenda atto del suo irrisolvibile bifrontismo, della maledizione che lo anima da una parte a farsi cosa tra le cose producendo e accumulando quante più ricchezze possibile, dall’altra a sottrarsi all’ordine delle cose per riappropriarsi della sua originaria, libera e sovrana interiorità, a prezzo però di dilapidazioni che possono essere disastrose se non governate da chi ha acquisito – appunto – la necessaria coscienza di sé.
È alla luce di questo obiettivo fondamentale della sua “esposizione”, la “coscienza di sé”[27], che Bataille esprime i suoi giudizi. Sferzante sulla borghesia capitalistica, schiava delle cose eppure confusamente alla ricerca di una interiorità che la sua stessa matrice protestante agita nei meandri del suo subconscio, lo studioso francese si esprime invece con favore verso il calvinismo per la lucidità con cui ha compreso che solo attraverso le cose l’uomo può avvicinarsi allo stato di sovranità “sacra” cui ambisce, così come verso la Riforma che, staccando risolutamente la dimensione religiosa da quella necessariamente utilitaristica dell’agire umano e relegando l’uomo in quest’ultima, ha da una parte lasciato una traccia di nostalgia consapevole della sfera più intima dell’esistenza, dall’altra ha forse influenzato con il suo lucido rigore lo stesso marxismo. Questo infatti mira secondo Bataille in un primo momento a sanare lo squilibrio di un mondo materiale in cui molti sono ridotti a cose (proletari) e pochi hanno il privilegio di rincorrere la loro interiorità sovrana (i padroni, ammesso che intendano inseguire questo obiettivo), per rinviare a una seconda e decisiva fase (nell’interpretazione di Bataille) il momento “in cui l’uomo avrebbe infine la libertà di ritornare alla propria verità intima, di disporre a suo piacimento dell’essere che sarà, che oggi non è perché è servile.”[28]
Non c’è allora da stupirsi se nell’ultima sezione del libro Bataille, sfoderando un ottimismo che a lui stesso dovette apparire azzardato[29], dopo aver di fatto giustificato il sanguinario totalitarismo staliniano – senza il quale l’Unione Sovietica non avrebbe potuto impiegare nella crescita del suo apparato industriale le ingenti risorse umane di cui disponeva e non avrebbe di conseguenza potuto arginare l’espansione dei paesi confinanti, in particolare della Germania nazista -, saluta il Piano Marshall come una operazione – consapevole o meno che fosse – di dispendio inutile, di dilapidazione delle eccedenze, l’unica capace di disinnescare l’esplosione di turbolenze tanto interne quanto esterne ancora peggiori delle due guerre mondiali recentemente concluse.
In definitiva quindi la storia dell’economia generale sembra raccontare un progresso graduale verso una sempre maggiore coscienza di sé dell’uomo, un progresso a cui contribuisce anche la civiltà borghese e capitalistica, apparentemente la più estranea al pensiero di una emancipazione dell’uomo dal dominio delle cose, anzi completamente e confusamente serva delle cose.
Una sempre maggiore coscienza di sé, si diceva, ma non la piena coscienza di sé, perché se l’uomo intimamente non è una cosa, e la stessa conoscenza non può applicarsi che a contenuti che siano “qualche cosa, non il nulla della pura dépense”[30], noi restiamo a noi stessi inafferrabili, o appena intuibili come gli strani fantasmi delle visioni dei mistici, della schiera dei quali l’autore dichiara di sentirsi perlopiù parte, anche se sui generis, in quest’opera.[31]
***
Note
[1] Vd. in particolare Maurice Blanchot, La conversazione infinita, Giulio Einaudi editore, Torino, 2015, pp. 247-262: a Bataille, recentemente scomparso (la prima edizione francese è del 1969), è dedicata la più parte di un capitolo che reca significativamente il titolo dell’intera sezione centrale del libro (“L’esperienza-limite”).
[2] Si veda per esempio la reazione critica della Arendt (Le origini del totalitarismo, Torino, Einaudi, 2004, p 604) a un intervento di Bataille sugli orrori dello stalinismo: cito di seconda mano dal saggio di F. Recchia Luciani compreso nel volume collettaneo Pop Shoah? Immaginari del genocidio ebraico, Il Melangolo, 2016, reperibile in rete al seguente indirizzo: http://www.leparoleelecose.it/?p=21834.
[3] Il riferimento a Bataille e a La parte maledetta è esplicito in alcuni passi de Il delitto perfetto, Raffaello Cortina editore, 1996; per esempio alle pagg. 62-64, per le quali rinvio al mio saggio su questo libro di Baudrillard recentemente pubblicato da Jamila Mascat su Nazione Indiana, in particolare alla nota 11 e al testo corrispondente (http://www.nazioneindiana.com/2017/02/12/jeanbaudrillarddelittoperfetto/)
[4] Cfr. Georges Bataille, La parte maledetta preceduto da La nozione di dépense, Bollati Boringhieri, Torino, 2015, pag 41, nota 1 (NdT): “In questo primo saggio (…) viene mantenuto il termine francese dépense, per sottolineare, in qualche modo, la ricchezza (l’incertezza) d’implicazioni, di significati che questo termine mantiene lungo tutto il saggio. Più avanti tradurremo con dispendio, la parola, in italiano, che più si avvicina allo spazio concettuale occupato dalla nozione di dépense nel testo di Bataille.”
[5] Georges Bataille, La parte maledetta preceduto da La nozione di dépense, Bollati Boringhieri, Torino, 2015, pag 64
[6] Ivi, pag. 81: “Il caso più leggibile è quello di un viale che viene aperto e mantenuto sgombro da un giardiniere. Una volta abbandonato, la pressione della vita intorno lo ricopre di erbe e di cespugli dove pullula la vita animale.”
[7] Ivi, pag. 86
[8] Ivi, pag. 81
[9] È quanto Bataille esemplifica efficacemente alla pag. 87: “(…) dopo un secolo di popolamento e di pace industriale, raggiunto il limite provvisorio dello sviluppo, due guerre mondiali hanno ordinato le più grandi orge di ricchezza – e di esseri umani – che la storia abbia mai registrato.” Va da sé che per lo studioso anche le distruzioni e le stragi belliche rientrano a pieno titolo nella categoria del dispendio necessario, qualora l’uomo non provveda altrimenti.
[10] Georges Bataille, op. cit., pag. 44. Termini che sembrano a prima vista possedere una qualità positiva rispetto ai lutti e alle guerre, come giochi e spettacoli, trovano spiegazione nel fatto che lo studioso guarda ad essi “nelle condizioni primitive”. Quanto al lusso e alle arti, è nota – per il primo termine – la contestazione di ipocrisia che lo stesso Bataille rivolge alla borghesia, che condanna il lusso mentre non fa altro che inseguirlo, così come non sfugge a nessuno che fu proprio l’utilitarismo capitalistico a puntare il dito contro l’improduttività dell’artista e a suscitare la reazione, per primi, dei romantici.
[11] Ivi, pag. 87
[12] Ivi, pag. 89. I corsivi sono dell’Autore.
[13] Ivi, pag. 83, passim. Più avanti (pag. 89), Bataille chiarisce con un esempio concreto di scala planetaria: la miseria dell’India, che non può tradurre in crescita l’energia della sua esplosione demografica per l’insufficienza del suo apparato industriale, potrebbe essere risolta con “un transfert di ricchezza americana senza contropartita” di cui anche gli americani beneficerebbero, dato che le loro eccedenze generano naturalmente instabilità e sono foriere di dilapidazioni forzate e spesso disastrose. È sulla scorta di questo ragionamento che Bataille saluterà più avanti con estremo favore il Piano Marshall (cfr. pag. 201 ss., fino alla fine del volume; cfr. anche l’ultima pagina del presente saggio).
[14] Ivi, pag. 75. I corsivi sono dell’Autore: così anche nelle citazioni d’Autore successive.
[15] Ivi, pagg. 104-105: “(…): nessuno può render cosa l’altro se stesso che è lo schiavo senza allontanarsi nello stesso tempo da ciò ch’egli medesimo è intimamente, senza porre a se stesso i limiti della cosa.”
[16] Ivi, pag. 105, passim
[17] Ivi, pagg. 105-106
[18] Ivi, pag. 104. Quando Baudrillard (Il delitto perfetto, pp. 44-45) associa la scomparsa dell’uomo reale dietro gli schermi degli artefatti tecnologici agli antichi sacrifici umani come prova del nostro desiderio di eludere “la gravità dell’esistenza” mostra chiaramente di aver sviluppato questo tema di Bataille.
[19] Cfr. M. Blanchot, op. cit., indica ne L’esperienza interiore il centro di gravità della speculazione di Bataille. L’esperienza interiore, o sovranità, o coscienza di sé – come viene definita in questo libro – si pone sul crinale tra l’essere e il nulla; è impropriamente detta “esperienza”, dato che non può essere agita perché solo il mondo delle cose è il mondo dell’azione: è “Esperienza della non-esperienza” (p. 256). Ecco perché Bataille si ascrive tra i mistici: un mistico senza religione, il mistico in bilico tra la realtà, il mondo delle res, e l’oltre, il Nulla. Cfr anche l’introduzione di Franco Rella a La parte maledetta, cit., in particolare le pagg. 19-20 e 23-24.
[20] Ivi, pag. 147
[21] Bataille (op. cit., pag. 98) si avvale qui del resoconto etnografico del francescano spagnolo Bernardino de Sahagun, Historia de los Mexicanos por sus pinturas, cap. 6. È lo stesso Bataille a affermare (p. 96) che “Nei loro pensieri il consumo occupava un posto non minore di quello che la produzione occupa nei nostri.”
[22] A questo proposito il filosofo francese dichiara a chiare lettere che i suoi studi confluiti nel presente libro partono dalla “lettura dell’ Essai sur le don” del noto etnologo Marcel Mauss: cfr. p. 115, in particolare la nota 9.
[23] Bataille, op. cit., pag. 115, nota 9: “(…) il fatto è che una dilapidazione di energia è sempre il contrario di una cosa, ma che non entra in considerazione se non una volta immessa nell’ordine delle cose, cambiata in cosa.”
[24] Cfr Marìa Rosa Menocal, Principi, poeti e visir, Il Saggiatore, Milano, 2009, soprattutto pagg. 61-63 e 119-121.
[25] Bataille, op. cit., pag. 161, passim
[26] È lo stesso Bataille a riferirne puntigliosamente in nota (p. 155, nota 1)
[27] Bataille, op. cit., pag. 91: “Certamente l’esposizione di una economia generale implica l’intervento negli affari pubblici. Ma innanzitutto e più profondamente, ciò a cui mira è la coscienza, ciò che prepara è fin dall’inizio la coscienza di sé che l’uomo realizzerebbe finalmente nella visione lucida di una concatenazione delle sue forme storiche.”
[28] Bataille, op. cit., pag 173
[29] Ivi, pag. 220, nota 13: “È, si dirà, ciò che soltanto un pazzo può vedere nei Piani Marshall e Truman.”
[30] Ivi, pag. 220
[31] Ivi, pag. 220, nota 13


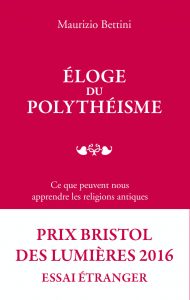 Intervista a Maurizio Bettini
Intervista a Maurizio Bettini
 Come per il campionato di calcio, no?
Come per il campionato di calcio, no?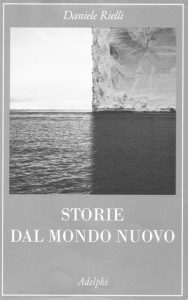

 Sei qui, al mio fianco, nell’auto fa caldo, fuori un vento solido simula le onde, borbotta.
Sei qui, al mio fianco, nell’auto fa caldo, fuori un vento solido simula le onde, borbotta. 









