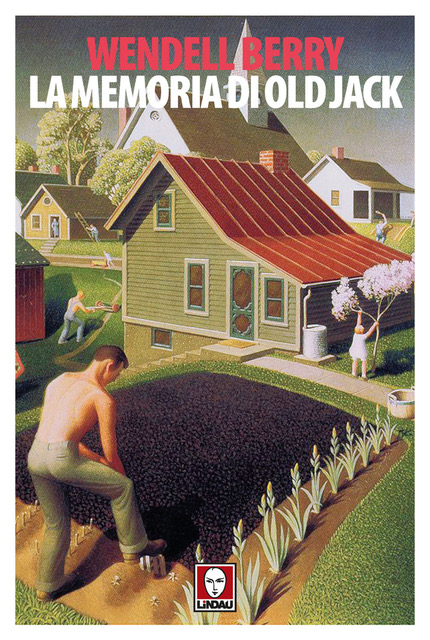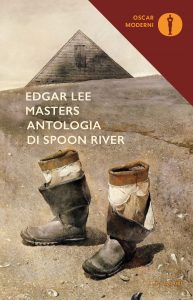Srewot niwt
di
Anna Maria Carpi
Cara Fatima, la dolcezza di questo paesaggio m’incanta. Case, alberi, vigne, frutteti, colori teneri, segni di pace. E poi amo viaggiare in treno, oziare col tempo davanti, e al tramonto rientrare in una pianura lasciandomi alle spalle il mare, e questa pianura arriva lontano, mi pare, fino alle Alpi, quelle alture che la orlano, lontano, a nord, sono, credo, già loro. Allah è grande.
Siamo in pochi, gente d’affari, come me, che ogni tanto telefona, sottovoce, per poi tornare alle sue carte, ai giornali. I giornali, eh? Titoli che bucano la pagina.
Alla stazione distribuivano gratis un giornaletto, e l’ho preso, anche quello: con l’uomo in giubba di carta gialla che lo distribuiva, ci siamo guardati un attimo negli occhi. Un orientale, forse indiano, pelle bruna, occhi neri come me, un remoto parente. Tra poco, forse, invece di affidargli questi lavoretti, li arresteranno, per motivi di sicurezza. Fratello, stavo per dirgli, tieni duro, che la riscossa arriverà. Invece gli ho gettato uno sguardo dall’alto: ogni paria non spera che verso l’alto, e non bisogna defraudarlo di questa speranza.
Anche questo foglio porta una piantina di Manhattan, coi colossi andati in briciole. Me li ricordo benissimo, per tutte le volte che ci sono passato, ma le piantine mi attraggono di per sé, come ogni carta geografica. Ci potrei star sopra delle ore, la terra in piccolo mi allarga gli occhi, il cuore, la misericordia e la ferocia.
Sintomatico che le due strade sul lato sud e ovest si chiamino Liberty Street e Church Street. Vogliono avere tutto costoro, libertà e religione, e questi giorni, dice la CNN, d’un colpo, dopo decenni di vuoto, le chiese hanno traboccato di devoti. Bella la foto in prima pagina – “Il day after” coi resti delle due torri: carcasse di balene preistoriche. Uno come me deve cavarsela con più lingue, e quel po’ d’italiano che capisco credo di doverlo al latino, a un mio caro amico che lo studiava, al college, in Inghilterra.
Giusto annunciare a caldo che il prezzo dei biglietti aerei aumenterà – per via dei maggiori controlli da eseguire d’ora in poi su ogni volo. Così si chiude la bocca ai clienti che, si capisce, vogliono volare sicuri, e la gente non registra che le astute compagnie non hanno perso un colpo, già si sono rifatte sfoltendo il personale. Anche i licenziati proveranno un’ineffabile sicurezza. Ma “Decisiva nel futuro sarà la fiducia dei consumatori”. Che continuino a consumare e a indebitarsi, crescete e moltiplicatevi. Lacrime negli occhi, il festival di Toronto e le sfilate di moda a Milano e a Parigi sono confermati, perché, dicono, sospenderli farebbe solo il gioco del nemico. In che senso? Chi lo sa. Lo sport: c’è chi sospende le gare e chi no, dipende dai conti. E gli artisti?
Questi sono gli eroi dell’Occidente. E in fondo pagina pubblicità di film: su sei film quattro hanno il titolo in inglese. Servi dell’America! Questi venduti che non sanno che le parole sono le cose, la propria anima, la sua salvezza eterna.
Notiziole marginali in coda: la barriera corallina sta morendo soffocata dai veleni e dai rifiuti – i loro sacrosanti rifiuti – e i boschi nel Portogallo bruciano. Semplice, dico io: metti a morte gli incendiari. Ma loro non ci pensano, sono teneri, confusi. Mi dispiace per il Portogallo: ci sono stato, una volta, quand’era ancora povero e selvaggio e a Lisbona e a Oporto, davanti all’oceano, si poteva ancora sognare di quando il Nuovo Mondo non era ancora stato scoperto.
 To’, nella tasca sotto il tavolino c’è una rivistina delle ferrovie italiane: in tutto uguale a quelle delle compagnie aeree che te la fanno trovare nella tasca della poltrona. Odio, lo sai, la carta patinata e l’aggressione dei colori: non mi lasciano pensare. C’è un servizio che fa ridere ancor prima di leggerlo: “Carne reale: i signori della bistecca, del pollo e del maiale”. E il servizio sulla moda del prossimo inverno? Un po’ di mogli di sceicchi verranno di nuovo a fare shopping nelle capitali europee. A rigore, andrebbero frustate. Se chiudo gli occhi e penso a te, alla tua eleganza nativa, a com’è bello stare a guardare, mia Fatima, mia Dudu, mentre rapida, leggera, ti vesti e svesti sempre degli stessi panni. Ma, tu lo sai, ai particolari della realtà, anche ai più miserabili, io non dico mai di no, mi ci caccio dentro, potrei farne indigestione, come della pasta di mandorle. E qui c’è fotografato un uomo-donna, copricapo da guerriero del Sol Levante, seni nudi sotto una giacca di patchwork coi polsi di volpe, bisaccia da nomade, ombelico di fuori e pantaloni da cowboy con smaccate frange, rosso e verde, che arrivano appena sopra il pube. Vedi, non gli basta più essere uomo o donna come natura li ha fatti, vogliono la libertà di essere l’uno e l’altro, androgini, a capriccio…Sindrome da figli unici. E io che sono figlio della decima moglie di mio padre e diciassettesimo dei suoi cinquanta figli…
To’, nella tasca sotto il tavolino c’è una rivistina delle ferrovie italiane: in tutto uguale a quelle delle compagnie aeree che te la fanno trovare nella tasca della poltrona. Odio, lo sai, la carta patinata e l’aggressione dei colori: non mi lasciano pensare. C’è un servizio che fa ridere ancor prima di leggerlo: “Carne reale: i signori della bistecca, del pollo e del maiale”. E il servizio sulla moda del prossimo inverno? Un po’ di mogli di sceicchi verranno di nuovo a fare shopping nelle capitali europee. A rigore, andrebbero frustate. Se chiudo gli occhi e penso a te, alla tua eleganza nativa, a com’è bello stare a guardare, mia Fatima, mia Dudu, mentre rapida, leggera, ti vesti e svesti sempre degli stessi panni. Ma, tu lo sai, ai particolari della realtà, anche ai più miserabili, io non dico mai di no, mi ci caccio dentro, potrei farne indigestione, come della pasta di mandorle. E qui c’è fotografato un uomo-donna, copricapo da guerriero del Sol Levante, seni nudi sotto una giacca di patchwork coi polsi di volpe, bisaccia da nomade, ombelico di fuori e pantaloni da cowboy con smaccate frange, rosso e verde, che arrivano appena sopra il pube. Vedi, non gli basta più essere uomo o donna come natura li ha fatti, vogliono la libertà di essere l’uno e l’altro, androgini, a capriccio…Sindrome da figli unici. E io che sono figlio della decima moglie di mio padre e diciassettesimo dei suoi cinquanta figli…
Uno speaker annuncia che stiamo arrivando nella stazione di…Verona, sì Verona, e invita la gentile clientela giunta a destinazione a non dimenticare i propri oggetti e bagagli a mano. Mi colpiscono sempre questi riguardi. E’ civiltà? No, sono solo le piccole incontinenze emotive di una società di bronzo, di pelo sullo stomaco e di corse agli ostacoli.
La città è su un fiume, su entrambe le rive: tutta abbastanza bassa, qualche timido grattacielo, qua e là una torre, un campanile. Antico, suppongo. Bello, nel sole del tramonto, quello laggiù, rossastro, che termina in un cono. Il bello si creava quando si usavano i materiali e le maestranze locali – pensa anche all’Alhambra, o al miracolo di Sana nello Yemen. Quando hanno incominciato a far venire i materiali da lontano, è finita; ma ormai sono secoli. Noi stessi negli ultimi anni abbiamo edificato porcherie internazionali.
Un gran bel fiume. Acqua, acqua, acqua, quanta ne hanno.
CNN ieri sera, stanotte, stamattina, a Venezia, in casa di…, casa principesca, tu sai chi intendo. Ma dopotutto preferisco ancora leggere – in pace, guardando fuori, questa dolce campagna coi suoi angoli segreti.
I giornali sono fantasiosi. Questo – si vede che ha mezzi – ha chiamato a raccolta gli scrittori. Anche stranieri. Odio gli scrittori. Perché questo racconta che si trovava per lavoro a New York, dove ha una casa, a Brooklyn, e che il vento soffiava verso Brooklyn e per il polverone sua moglie non poteva tenere aperti gli occhi…E questo Ashley, americano pare, che descrive i suoi presentimenti, sabato 9, a cena al ristorante dentro una delle due torri – da ubriaco fradicio, scommetto. E José Saramago? Ha come le mestruazioni. Quest’altro assicura – fatti suoi, al lettore cosa gliene importa? – di non aver mai amato tanto New York come davanti a quei dinosauri svuotati…Poi ci sono un francese, che si limita a un’alzata di spalle e a dire che trova l’Islam la più stupida di tutte le religioni, e un altro che esordisce con “io, come autore di gialli”. Assennato sarebbe, a volte, Tahar Ben Jelloun – se solo parlasse meno e non insegnasse alla sua bambina grossolanità del genere di “A loro non piace la musica, la pittura, la scultura, l’arte: è per questo che diventano terroristi”. Certo, è stato un errore marchiano, da bestie quali i talebani sono, far saltare quei Buddha.
E to’ chi si vede: la Sonntag. Io l’ho conosciuta, a Manhattan: una donna grande e grossa con una ciocca bianca sulla fronte, non è il mio genere di femmina – troppa testa. E’ una scrittrice famosa, però è onesta. Dice che si vergogna della puerilità dei suoi connazionali in questo frangente, che cerchino solo rassicurazione, “è tutto ok, sai? e tu non hai fatto niente e sei grande e forte”. Non sanno gestirsi il dolore, dice. Un intervento rispettabile, consono alla missione dello scrittore, che è d’indagare la verità. Ma gli scrittori occidentali è un pezzo che se ne…scusa, stavo per usare una parola da soldataccio che avrebbe offeso i tuoi orecchi. Brava quest’ebrea. Io lo so che questi ebrei, figli di Abramo come noi, avrebbero un’ottima stoffa se non fossero traviati; al meglio sono quando vanno raminghi, allora sono davvero illuminati, la patria, come a tutti, gli dà alla testa. Dov’è, scrive la donna, il “vile attacco alla civiltà, all’umanità, al mondo libero”? Quelli che quel martedì hanno provocato l’ecatombe non erano dei vili, vile è semmai chi attacca dall’alto, e in ogni caso il disastro è una “conseguenza di nostre specifiche azioni”.
Vedi, Fatima, tu che, come in genere le donne, sei ancora più estrema di me: di giusti ce n’è anche da questa parte. Un giusto è anche quest’altro, italiano – c’è scritto che vive da trent’anni in Medio Oriente. Ricordatevi, occidentali, dice, della guerra dell’oppio in Cina, e delle “navi nere” dell’ammiraglio Perry allo stupro di Yokohama. E Hiroshima e Nagasaki e il napalm sui villaggi vietnamiti? E il mezzo milione di morti di stenti, perlopiù bambini, per l’embargo in Irak? E Bophal in India, 1984, quando lo scoppio di quella fabbrica chimica ha ucciso poco meno di 20.000 indiani, e la multinazionale non si è nemmeno giustificata? E chi li ha pianti?
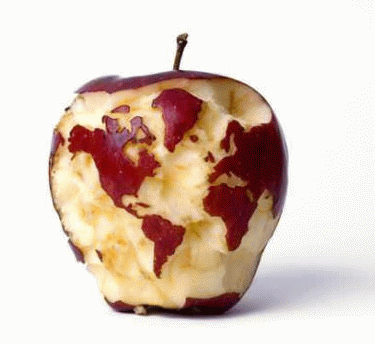 Bravo italiano. L’Islam, dice, si presta bene, per la sua semplicità e il suo carattere di militanza, a essere “la fede dei dannati della Terra, di quelle masse di poveri che oggi affollano, disperate e discriminate, il Terzo Mondo occidentalizzato”. Vero. Salvo che…io dubito della fede, anche della nostra musulmana…In questo mondo la fede è sempre stata solo in un modo di dire, che figura più o meno in tutte le lingue, ed è un passivo “Dio me la mandi buona”.
Bravo italiano. L’Islam, dice, si presta bene, per la sua semplicità e il suo carattere di militanza, a essere “la fede dei dannati della Terra, di quelle masse di poveri che oggi affollano, disperate e discriminate, il Terzo Mondo occidentalizzato”. Vero. Salvo che…io dubito della fede, anche della nostra musulmana…In questo mondo la fede è sempre stata solo in un modo di dire, che figura più o meno in tutte le lingue, ed è un passivo “Dio me la mandi buona”.
Quelli che mi fanno più pena o ira, Fatima, sono però i russi, che ancora si ritrovano a domandarsi: siamo europei o siamo asiatici? I pasticcioni. Sono contento per quelle migliaia che sono stati acchiappati ed evirati sulle montagne afghane. Una bella partita fra uomini. Mi torna sempre in mente un mucchio di testicoli che marciva al sole, tra le mosche, finché, tra le risate degli uomini, sono arrivati gli sciacalli. Anche questi hanno diritto a qualcosa. Io lo sapevo mentre si costruivano i bunker per la CIA e i suoi talebančiki, che i russi sarebbero stati fatti a pezzi, come un secolo fa gli inglesi; l’Afghanistan è difeso dagli angeli, in particolare dall’arcangelo Gabriele, l’Afghanistan è Roncisvalle, dove mille anni or sono cadde il paladino Orlando e dei franchi si sperse l’eco di là dei Pirenei.
I russi. Presero il comunismo in Europa e continuarono a fare gli asiatici per altri settant’anni, e adesso che sono in rovina si aggrappano all’Occidente e strillano che loro sono europei e che hanno sempre amato l’America e offrono basi in Asia centrale. Dove siete, o miei umili ortodossi spazzati via dall’uragano comunista, o miei piccoli impiegati atei, un tantino ladri e molto buoni a nulla, col distintivo di Lenin all’occhiello, spazzati via dall’uragano capitalista?! Che poesia, che tempo che fu. E ora, essere lì spaesati, a metà strada… e per giunta avere in bocca – ti risparmio una parola più efficace – il dente marcio della Cecenia. Ma se t’infili nelle case moscovite…Sai che io con le inchieste, fasulle come sono, qualche volta mi diverto, come un gatto col topo, e la TV gli ha lanciato un test, “la vostra reazione alla tragedia americana”, con tre possibili risposte: uno sono scioccato, due mi spiace per le vittime ma non per gli USA, tre non so. Le risposte danno: 1100 scioccati, 815 dispiaciuti ma non per gli USA, 130 senza opinione.
Più di 2000 risposte sono un risultato significativo, L’articolista annota: un sollievo che la maggioranza abbia compassione, ma troppi sono, purtroppo, quelli che nutrono sentimenti di vendetta. Ma quel poliziotto-seminarista di Putin va molto più in là: quanto è accaduto, dichiara, è più grave dell’olocausto. Ma andiamo, ma su! Allora il nome Putin ti sta proprio bene: non mi dire che viene da put’, la via – quale via? Viene da pùtaniza, stato confusionale. E niente vsjo budet chorošò, cioè è tutto ok, questo lascialo dire agli americani: da te è l’inverso, è tutto ko. Putja, la natura ti ha fatto in economia. Succede, e avrà pure un senso: osso frontale sottile, tempie strette, una testolina che sembra lisciata con la lingua. Un burocrate esangue. Tu, Fatima, lo degneresti di uno sguardo? E, mia bella, degneresti di uno sguardo un Bush? Con quell’aria drammatica dell’inane profondo? Il figlio di papà, il ragazzo del rancho, di colpo si è trovato sbalzato in prima fila. Su, su, gli sussurrano i supporter alle spalle. A volte minacciano di dargliele: hai voluto la bicicletta? pedala. E adesso si trova peggio che mai: deve pur fare qualcosa di adeguato. Inutile che serri le labbra: e che cosa, che cosa? domandano gli occhietti errabondi. Catapultato a primo attore, è nel panico. Ma d’altra parte non gli par vero. Quest’evento ha salvato lui dall’inanità e i supporter dalla recessione. Si sono dati una manata sulla fronte: George, la guerra rianima l’economia! Devo fare Churchill, o Roosvelt? chiede lui, e gonfia il petto. Per intanto s’infila una popolare giacca a vento e corre in mezzo ai soccorritori: “Violenza senza precedenti, risponderemo uniti all’aggressione” e si appella all’art.5 del trattato NATO sul mutuo soccorso. Poi comincia a dare ordini, uno al giorno. Cina e India si fregano le mani: spazzare via quei quattro musulmani che danno fastidio entro i nostri confini, pensa la Cina, pigliarmi il Kashmir, pensa l’India. Ma in Europa tutti a lustrare la targa NATO.
 Quel bolso di Schröder, anche lui fra i lustratori – tutto purché non affiori il ricordo di chi è stato a scatenare l’ultima guerra mondiale. Ve’ come siamo buoni, dicono ogni momento i tedeschi, nell’ultimo mezzo secolo siamo stati a testa bassa su nient’altro che su industria e commerci, e urbi et orbi lui manda un bellissimo testo intitolato “La cultura contro l’odio”. Poi dimentica il titolo – lapsus freudiano – e dal principio alla fine parla d’altro, sfacciatamente, ossia dell’unico oggetto del suo desiderio, il profitto. Ma almeno una volta, signore, una, pro forma, rimettiamocela la parola cultura! Niente da fare: little Schröder va dritto alla meta. Lei scriva intima al suo ghost writer: l’odio non potrà prevalere sulle forze della crescita economica né a New York né in Germania né in Cina, la crescita mondiale sarà coronata da successo. Ai consumatori che oggi chiedono “che cosa dobbiamo fare?” rispondiamo: niente pessimismo e paura, avanti con gli investimenti e coi consumi.
Quel bolso di Schröder, anche lui fra i lustratori – tutto purché non affiori il ricordo di chi è stato a scatenare l’ultima guerra mondiale. Ve’ come siamo buoni, dicono ogni momento i tedeschi, nell’ultimo mezzo secolo siamo stati a testa bassa su nient’altro che su industria e commerci, e urbi et orbi lui manda un bellissimo testo intitolato “La cultura contro l’odio”. Poi dimentica il titolo – lapsus freudiano – e dal principio alla fine parla d’altro, sfacciatamente, ossia dell’unico oggetto del suo desiderio, il profitto. Ma almeno una volta, signore, una, pro forma, rimettiamocela la parola cultura! Niente da fare: little Schröder va dritto alla meta. Lei scriva intima al suo ghost writer: l’odio non potrà prevalere sulle forze della crescita economica né a New York né in Germania né in Cina, la crescita mondiale sarà coronata da successo. Ai consumatori che oggi chiedono “che cosa dobbiamo fare?” rispondiamo: niente pessimismo e paura, avanti con gli investimenti e coi consumi.
La marionetta tedesca calzata sul pugno dei suoi burattinai. Non ha che la zucca e le manine, e sotto niente. Ti faccio una carezza sulla zucca! Perché anch’io sono un burattinaio, no? Ma del teatrino concorrente, ovvero…ogni tanto i teatrini si litigano, ma il teatro, il teatro del petrolio è sempre uno. Questa è la tragedia del mondo. Ma cos’altro potrebbe fare little Gerhard? Così è la democrazia, manine e zucca, star lassù e parlare sempre al modo giusto, altrimenti è la fine, e in basso, dove regnano le emozioni, non li rieleggono, e più in là, dove regna la ragione, gli danno il benservito. Che ne dici, Fatima? Venirgli in aiuto? Forse si potrebbe soccorrerlo col rompergli in due il grattacielo della Deutsche Bank a Francoforte. Non sarebbe male. Dati i loro trascorsi, i tedeschi non farebbero il putiferio degli americani; guaiolerebbero, con la coda fra le gambe. Fra tutti questi pallidi bambinoni non circoncisi sono i più buoni, i più aperti, il più tutto.
E’ così che si ritrovano in casa un certo stock di “belle addormentate” – tu sai cos’intendo: studiano con lo stipendio del babbo arabo, come facevo io in Inghilterra, stanno nelle loro università, prendono buoni voti e si tengono pronti agli ordini. Ma non è un caso: la Germania è di per sé fatta per le lunghe latenze. Hanno un’anima lenta loro, lenta e radicale.
A sentire di crescita, consumi, investimenti a me, filosoficamente parlando, viene la nausea della vita. Anche a te, vero? Solo in certe occasioni mi monta invece un ghigno satanico, un rigurgito di ghiaccio – e in questo, lo so, non puoi seguirmi, le donne non conoscono questo genere d’odio, nemmeno quando ti pugnalano alle spalle. Ma se così volete, mi dico, se oggi sono queste le coordinate della lotta, accetto. Il sapore di muffa della sconfitta non è per me, e poi: l’aldilà si guadagna ai punti nell’aldiquà.
Ma c’è un altro particolare che non finisce d’irritarmi. E’ l’uso improprio delle parole. Già “olocausto” mi dà un maledetto fastidio, e guardacaso l’hanno diffuso gli americani. E ora, Fatima, guarda: perché quel calcolatore da tasca del sindaco Giuliani di New York sarebbe un “eroe”? Al pari dei pompieri che si sono buttati tra le fiamme? Cosa devono pensare i pompieri? E perché i sei, cinque, tremila sventurati di quel giorno – starà ad Allah giudicarli – te li chiamano, con un colpo di mano, “caduti” e “martiri”? Dispiace, s’intende, erano carne viva anche quelli, ma cosa devono pensare i caduti autentici, nella guerra del Golfo e nelle giungle del Vietnam? Si rivolteranno nella tomba. Quanto ai “martiri”, prendi qualsiasi vocabolario – e più moderati dei vocabolari non c’è nessuno, sono il senso comune, lo spirito del tempo: “martire”, dicono, è colui che muore testimoniando per un’idea. Bene: ma in Occidente gli ultimi esemplari si sono avvistati all’Est, ai tempi della cortina di ferro. Andrebbero reintrodotti, come si fa col coala o il panda gigante. Il fatto è che “martiri” è una parola superlativa, l’etichetta massima; più in su c’è solo “santi”, ma quest’articolo lo tratta solo la Chiesa cattolica.
Non è tutto come leggendario? Nel deserto del Nevada, favoleggia il popolo del Midwest, la NASA custodisce delle navi spaziali di ultraterrestri. Questo mondo vive sempre più di leggende. O sublime scimmione King Kong che, una biondina in pugno come un mazzo di chiavi, si affacciava sopra Manhattan. Geniale, profetico quel film del 1933. Lo scimmione o, come nel film di Woody Allen, la mamma che sgrida il figlio dal cielo di New York. Geniale anche questo. Ricordi? L’abbiamo visto assieme a Parigi. Mamma o scimmione: qui c’è tutta l’anima loro. Come vedi, io l’arte l’apprezzo.
Ma a noi, invece di apparire grandiosamente lassù, tocca farci piccini e filiformi e introdurci nei vasi capillari del sistema. Sull’autostrada Washington-Baltimora c’è la NSA, il Grande Orecchio che raccoglie ogni fremito e sospiro di quanto sulla terra striscia e vola: i dati di Echelon, la rete mondiale delle intercettazioni. Te lo devo aver già raccontato che fino a un anno fa quelli della NSA si divertivano a fare ascoltare ai visitatori i nastri di Bin Laden che dall’Afghanistan parlava con la sua mamma in Arabia Saudita, e ridevano a più non posso: lo scemo usa un telefono satellitare! Poi da un giorno all’altro lo scemo e la mamma non ci sono più: silenzio, scomparsi. Al pari dell’andirivieni nei campi d’addestramento afghani: i satelliti che ti leggono una targa d’auto e scorgono una sigaretta accesa da 300 chilometri d’altezza di colpo segnalano solo polvere, montagne, sciacalli. In men che non si dica, due ore dopo i dirottamenti, non c’è più nessuno. O to’.
 Tu lo sai, perché anche tu ti ci diverti – e come sei graziosa quando dentro i tuoi lini immacolati, solo i piedini fuori, sporta in avanti, a ginocchia divaricate, clicchi qua e là alla ricerca di qualcosa di stravagante – tu lo sai, i motori di ricerca internet, come tante persone, non capiscono i contesti, gli dai una parola e vanno a sbattere Dio sa dove. Sai quante informazioni radunano i computer della NSA? Fino a due milioni all’ora. Pensa alle sviste, e ai costi: da sghignazzare. Ma loro confidano nei biscotti, i cookies. Restano attaccati al tuo computer quando visiti un sito. Tu attiri l’uomo in qualche sito che glieli appiccica, dopodiché ovunque vada è pedinato. Ma l’uomo pensa – e cosa fa? Tiene pulito il suo aggeggio personale e per navigare e mandare i suoi mail va fischiettando da qualche internet-cafè o biblioteca pubblica. Qualcuno negli USA adesso grida: bisogna tornare all’intelligenza naturale, ai vecchi 007, a James Bond, alle spie umane, pagare per pagare meglio pagare queste. Però si alza qualche mano: non infiltrerete un bel niente, non lo sapete che “là”, fra quei primitivi, non è come qua, che non si lasciano corrompere, che nelle loro cerchie si entra unicamente per legami di sangue o di nozze? Giusto – o quasi…Tutto in questo mondo è quasi, perché così impermeabili ai dollari non sono nemmeno quei primitivi, io ne so qualcosa. Anche i miei piccoli talebani si sono così abituati a quei rettangoli grigioverdi con la faccina di Washington che non possono più farne a meno e – l’Onnipotente li perdoni – coltivano l’oppio, con la scusa che nessuno è obbligato a drogarsi. Verissimo, se questo pensiero non fosse un po’ occidental-individualistico. E quel mastino del caro presidente pakistano? E’ ridotto a un hotdog: sopra ha i biglietti grigioverde che svolazzano, sotto i servizi segreti e il popolo che avversa gli USA, lui è come la farcitura, e non lo invidio.
Tu lo sai, perché anche tu ti ci diverti – e come sei graziosa quando dentro i tuoi lini immacolati, solo i piedini fuori, sporta in avanti, a ginocchia divaricate, clicchi qua e là alla ricerca di qualcosa di stravagante – tu lo sai, i motori di ricerca internet, come tante persone, non capiscono i contesti, gli dai una parola e vanno a sbattere Dio sa dove. Sai quante informazioni radunano i computer della NSA? Fino a due milioni all’ora. Pensa alle sviste, e ai costi: da sghignazzare. Ma loro confidano nei biscotti, i cookies. Restano attaccati al tuo computer quando visiti un sito. Tu attiri l’uomo in qualche sito che glieli appiccica, dopodiché ovunque vada è pedinato. Ma l’uomo pensa – e cosa fa? Tiene pulito il suo aggeggio personale e per navigare e mandare i suoi mail va fischiettando da qualche internet-cafè o biblioteca pubblica. Qualcuno negli USA adesso grida: bisogna tornare all’intelligenza naturale, ai vecchi 007, a James Bond, alle spie umane, pagare per pagare meglio pagare queste. Però si alza qualche mano: non infiltrerete un bel niente, non lo sapete che “là”, fra quei primitivi, non è come qua, che non si lasciano corrompere, che nelle loro cerchie si entra unicamente per legami di sangue o di nozze? Giusto – o quasi…Tutto in questo mondo è quasi, perché così impermeabili ai dollari non sono nemmeno quei primitivi, io ne so qualcosa. Anche i miei piccoli talebani si sono così abituati a quei rettangoli grigioverdi con la faccina di Washington che non possono più farne a meno e – l’Onnipotente li perdoni – coltivano l’oppio, con la scusa che nessuno è obbligato a drogarsi. Verissimo, se questo pensiero non fosse un po’ occidental-individualistico. E quel mastino del caro presidente pakistano? E’ ridotto a un hotdog: sopra ha i biglietti grigioverde che svolazzano, sotto i servizi segreti e il popolo che avversa gli USA, lui è come la farcitura, e non lo invidio.
Strano, dice il mondo, che gli USA non si siano accorti di niente. Ma è perché loro niente legami di sangue e nozze, loro prendono tutti, purché siano efficienti. Giusto, no? Però così si trovano pieni di traditori e non se ne accorgono. Proprio perché sono in mezzo a loro. Ah, dolce Fatima, se vuoi nascondere al meglio un oggetto che l’avversario non deve ritrovare, mettiglielo sotto il naso. E come quella storia della donna che diventa l’amante del miglior amico del marito – bada, se mai tu mi facessi questo, ti ucciderei nel più barbaro dei modi. Così un bel giorno il marito piomba non annunciato in casa dell’amico, nella stanza dove lui sta giusto a letto con la donna. Con una presenza di spirito degna di un terrorista, l’amico copre la testa di lei e ne scopre il corpo nudo, come per dire vedi, eh, non sono solo, e il marito…non vi riconosce la propria moglie, si scusa e se ne va. Io, con la mia passione per i particolari, ti riconoscerei anche su Marte, ma per i comuni mortali la cosa è assolutamente plausibile. Se non pensano che una cosa sia lì, la cosa non c’è. Ma a Baltimora succede ancora di peggio: ignorano ciò che in fondo sanno. Tu credi che non subodorassero l’attacco alle torri? Sono troppo crudele, Fatima? Ma con chi mente con se stesso non si può non esserlo. Perché questo è il più grande peccato che esista, è il peccato contro lo spirito.
Mentono, e giocano. Hai presente il Protocollo di Kyoto sulla questione del clima? Ho letto che gli ultimi quindici giorni di Kyoto furono un grandguignol. Liti furibonde nei corridoi, tumultuose sessioni notturne seguite da sbornie. 30 delegati finirono disidratati all’ospedale. Nella sessione finale che durò tutta la notte i delegati USA montavano sulla sedia cercando di farsi dare la parola dal presidente, altri già ronfavano con la testa sul banco. Il giorno dopo, aggiunte alcune formulazioni deliberatamente imprecise, il presidente diede il via alla votazione. Svegliati dal sonno, alcuni delegati in seguito ammisero di non sapere per cosa avevano votato. E dopo Kyoto in quattro anni non è successo più niente, ovvero sì: in Guatemala si sono piantati 52 milioni di alberi, si calcola che possano assorbire il carbonio emesso da un nuovo impianto a carbone nel Connecticut. Tu riderai: io ho pietà di quegli alberi.
Giocano. E hai notato, nei loro notiziari, la parola “missing”? Dispersi, cinque, seimilamila dispersi? Cavalcano la comprensibile speranza dei parenti, giacchè ognuno vorrebbe che il suo caro non fosse morto, potesse tornare. Però è grottesco: o eroi, caduti, martiri, o dispersi. “Morti”, semplicemente morti come tutti – mai. In Occidente la morte è all’indice, ovvero bisogna grattarla via, scioglierla come una macchia, coi migliori detersivi. Si chiama “elaborazione del lutto” – altra espressione che mi fa rizzare tutti i peli del corpo, anche i più intimi. A Manhattan da una settimana ci sono, ho letto, i “vetrinisti del lutto”, perché “l’elaborazione del lutto”, dicono, è un “processo di shift dei consumi”. Però pare che dal lunedì nero nei ristoranti si mangi di meno. Che quelle coorti di balordi che s’affogano di carne, pizza, gelato, pommes frites col ketchup abbiano aperto un occhio? Non so. Appena sentita la parola “guerra”, pare si siano affollati nei supermercati a fare incetta di scatolette e di surgelati. Poi il loro George ha cambiato “guerra” in “guerra infinita”, che è dopotutto meno pauroso, poi in un sublime “libertà duratura”: allora si sono calmati. Libertà duratura è ciò che già abbiamo, si sono detti, allora non c’è da agitarsi, e la crapula ha visto una nuova impennata. Ah, di sobri non restano che le femmine nevrotiche che digiunano per essere più interamente se stesse e gli intellettuali passati al vegetariano perché vuol dire salute e lunga vita, e la loro vita è assolutamente necessaria al mondo. E sul 10% di dimostranti pacifisti e straccioni del no global non farei molto affidamento.
A parte il cibo: cinema pieni, leggo, e vendite straordinarie di libri di fiabe. Eccellente. Quando la gente è ben nutrita vuole solo le fiabe o l’orrore. La verità no. E in quattro giorni hanno sfornato sul mercato tonnellate di t-shirt con la scritta “I Y N Y.” e tonnellate di poster con King Kong. Vendono anche i frammenti delle macerie in bustine di plastica. La verità è che non sentono più niente e vanno in tondo, alla cieca, come i pipistrelli all’imbrunire, di conseguenza non hanno più memoria, di conseguenza si attaccano ai souvenir, ai ricordini.. Ma ancora più commovente, su questo serissimo quotidiano nazionale che ho davanti, è un decalogo per gli adulti – adulti, ovvero facenti funzione di tali – su come gestire i “bambini del day after”. Questa me lo sono ritagliata e te la porto. A parte il decimo, “Farli addormentare con la luce accesa”, c’è un “Invitarli a tenere un diario” e un “Farli parlare di sé”. Hanno la follia del proprio sé.
 Se a queste masse piene di confusione si potesse praticare la carota, come si fa col suolo per stabilire cosa ci sia sotto, credo che da loro nel sottosuolo troveremmo: giacimenti di piacere. Tu sei sempre paradossale, mi dirai. Ma, togli i parenti delle vittime, a tutti gli altri è stata offerta o no? una grande emozione. Meccanizzati, informatizzati, cibati, usati e gettati, in orbita ventiquatt’ore su ventiquattro…tu puoi immaginare cos’è il piacere di poter piangere, schiumare, andar ciarlando nei bar, far petizioni in internet, scrivere sui muri o invocare “ammazzate tutti gli arabi” o minacciare il vicino arabo di Brooklyn di devastargli il negozio?
Se a queste masse piene di confusione si potesse praticare la carota, come si fa col suolo per stabilire cosa ci sia sotto, credo che da loro nel sottosuolo troveremmo: giacimenti di piacere. Tu sei sempre paradossale, mi dirai. Ma, togli i parenti delle vittime, a tutti gli altri è stata offerta o no? una grande emozione. Meccanizzati, informatizzati, cibati, usati e gettati, in orbita ventiquatt’ore su ventiquattro…tu puoi immaginare cos’è il piacere di poter piangere, schiumare, andar ciarlando nei bar, far petizioni in internet, scrivere sui muri o invocare “ammazzate tutti gli arabi” o minacciare il vicino arabo di Brooklyn di devastargli il negozio?
Corea, Vietnam non ce l’hanno fatta a diventare leggendari, la guerra del Golfo è stata una caricatura, Černobyl rumore umanitario e poi nulla, i 50.000 morti di Groznyj in Cecenia acqua che va: così dagli Urali al Pacifico, yankees e no, da cinquant’anni erano costretti, per avere qualcosa di grandioso, a friggere e rifriggere il nazismo e l’olocausto. E adesso, to’, hanno materia fresca! Ma intanto la storia vola a 300.000 chilometri al secondo e solleva le sabbie del nulla e annulla le orme, e tutto è ormai solo delirio. Come quello per la morte della principessa di Galles, ti ricordi? Allah abbia pietà di lei. Il mondo la piange, esequie in Westminster, una puttana da postribolo che nella cattedrale intona “Like a chandle in the wind”…poi…poi si passa ad altro. Passare ad altro, oh, questa è la segreta passione dell’occidentale.
Il mite sole di settembre è calato. L’ultimo oro si va spegnendo laggiù sopra chilometri di sobri alberi scuri e le colline si sono come sciolte dentro la terra. Milano, la grande città, non è lontana. Sono atteso, tu sai da chi. Ci sarà una ricca cena, immagino, un vero spreco per uno come me che vivrebbe di cipolle, riso e tè. Non così sarebbe per certi miei ricconi arabi, quei plebei, che sprecano come gli occidentali.
Ora ti confesso una debolezza – tu sai che le piccole cose concrete m’incantano: ho incaricato Ahmed a New York di comprarmi un altro orologio da polso, uno di quelli appena usciti, con King Kong e la donnina bionda sul quadrante. Pare che gli adolescenti USA e UN l’orologio da polso non lo vogliano più. S’impuntano contro il tempo, la necessità di far qualcosa, la responsabilità. Per me, sin da bambino, gli orologi da polso sono sempre stati una passione, ma è pressoché l’unico vizio che mi permetto. Nei piaceri, lo sai, sono un entusiasta che si modera, uno spartano che fa festa solo una volta tanto. Con la pasta di mandorle. La moderazione è l’unica cosa che renda calda la vita. Io non sono un talebano. E il mio dilemma è se restare con loro o allontanarmi, in che modo non so ancora. Sono diviso. Kabul l’hai vista, è un ossario abbandonato…case in rovina, come denti marci e cariati, donne dietro finestre sbarrate e quando escono, in quelle grottesche burke, sembrano tante tende scalzate dal suolo. Perché se la sono presa tanto con le donne, le loro sagge donne, cosa gliene viene? Ma è sempre così: le stupide dittature oscurantiste più che di comandare hanno l’ossessione di vietare. Sono un pugno di contadini e di cosiddetti studenti, e si sa che nella storia queste categorie hanno poi la peggio. Eppure c’è in atto una struggente ingiustizia: tutti li hanno usati, e adesso si coalizzano per schiacciarli. Se penso a questo, mi dico: non è sensato, ma non importa, ma io devo restare con loro.
Stazionari, negli USA, gli acquisti di bandiere, saliti del 70 % gli acquisti di armi ma alle stelle, fra le Kodak usa e getta, come poster e come asciugapiatti le cartine dell’Afghanistan e il volto di quello che si sostiene sia il mandante del vile attentato, con sotto “Wanted dead or alive” – ah vecchio West degli sceriffi! Variante: lui a tutta figura che sembra un santo, un Mosè, uno sciamano: sorridente, in bianco, tunica e turbante, salvo il mitra che gli pende dalla sinistra, come il violino a un suonatore che si applaude dopo l’esecuzione. Costo 20 dollari, mi dicono – cosa che un afghano ci vivrebbe tre mesi. Ha fatto bene, pensavo, il mullah Omar a sfuggire o quasi ai fotografi, così le leggende intorno a lui si rafforzano e aumentano l’amore. Già si narra, fra i brividi, che, colpito a un occhio da una scheggia di bomba russa, si sia strappato da sé l’occhio e l’abbia gettato via. Un gesto da antico giapponese, o da antico romano, ma giuro che nessuno sa più chi fosse Orazio Coclite ossia “occhio solo”, o Muzio Scevola, e meno che mai sanno che il loro Cristo ha detto “se un occhio ti è di scandalo, gettalo via da te, perché è meglio che perisca una parte piuttosto che l’uomo intero”.
Mister “Wanted dead or alive” invece si è visto in foto, video, TV, che parla, l’indice alzato come un maestro di scuola, ma la leggenda ugualmente lo circonfonde, perché non è solo un guerriero o un mullah, ma anche un onnipotente uomo d’affari – prossimo incarico: ampliare le moschee di Mecca e Medina – e si chiedono: chi è, com’è? e soprattutto: perché invece di organizzare atrocità non si gode in pace i suoi miliardi? Godere! Devono sempre ridurre tutto al loro piccolo formato! Al tempo stesso…non osano dirlo, ma sentono che lui è…come dire? lo spirito della terra, polimorfo e sempre uguale a se stesso, a sé e a tutti, che è come la natura e l’infinito che loro hanno perduto. E poiché con gli umani oltre ai soldi c’è sempre di mezzo l’amore – loro quest’uomo lo amano, sotto sotto, s’intende, nel loro segreto. Le donne mormorano fra sé “finalmente un uomo!”, altri provano per lui un amore ingenuo e delicato, come i russi per il loro mitico brigante Stenka Razin che rubava ai ricchi per dare ai poveri. E tutti, quando la storia lo spazzerà via, si sentiranno orfani per qualche ora.
 C’è un cristiano, un russo di un secolo e mezzo fa, che ha avuto due visioni che dell’essere umano dicono tutto, e altro non occorre: le ha chiamate l’Uomo del sottosuolo e il Grande Inquisitore. Fra i loro scrittori io questo lo rispetto e venero, come anche l’altro, coevo, che da vegliardo non ne poteva più di tutti gli ipocriti volti noti, compreso il proprio, ed è andato a morire in una stazioncina sperduta, in mezzo agli ignoti. Poi a cercare la verità ci sono stati un ebreo di Praga morto di tubercolosi e un ebreo galiziano crepato d’alcool a Parigi e da ultimo forse – maledizione, sempre loro! – un paio di ebrei tedeschi.
C’è un cristiano, un russo di un secolo e mezzo fa, che ha avuto due visioni che dell’essere umano dicono tutto, e altro non occorre: le ha chiamate l’Uomo del sottosuolo e il Grande Inquisitore. Fra i loro scrittori io questo lo rispetto e venero, come anche l’altro, coevo, che da vegliardo non ne poteva più di tutti gli ipocriti volti noti, compreso il proprio, ed è andato a morire in una stazioncina sperduta, in mezzo agli ignoti. Poi a cercare la verità ci sono stati un ebreo di Praga morto di tubercolosi e un ebreo galiziano crepato d’alcool a Parigi e da ultimo forse – maledizione, sempre loro! – un paio di ebrei tedeschi.
Mia dolce Fatima, non guardare mai dritto davanti a te, ad altezza d’uomo, è solo uno sconforto, guarda in basso, ai tuoi piedi, agli insetti del deserto, o in alto, ad Allah. Se proprio vuoi, resta a metà, ai bambini.
I kamikaze? E perché mi dovrebbero piacere? Se ne dai una definizione pulita, da dizionario, “tipi che si suicidano per ammazzare gli altri”, sono solo stupidi, riprovevoli e possono dare un’emozione solo a chi trova romantici i delinquenti. Ma è quando poi vedo la paura di soffrire e di morire di questi altri, di tutto il cosiddetto primo mondo, che allora mi dico: be’, se proprio devo scegliere, preferisco quelli.
I media hanno spiegato alla gente, per sua tranquillità, che il movente dei feroci giovanotti è la puerile convinzione di essere attesi nell’aldilà da 72 vergini a testa e da una sedia alla destra di Allah. Non che la situazione sia mal pensata – risponde a due brame base, sesso e onori – però a crederci c’è solo qualche analfabeta di piccolo cabotaggio, che nessuno gliel’ha chiesto e lui si lancia in proprio, con una bomba alla cintura. Ma i professionisti delle Due torri te li vedi?!
Al solito al di qua e al di là dell’Atlantico non afferrano il nocciolo della questione. Forse perché non gli torna comodo. Tutti, in Occidente, dai direttori di banca ai taxisti, si riempiono la bocca del fastidioso “ho una vita sola” – i cristiani, in teoria, non dovrebbero, ma lasciamoli perdere. Io una volta, non so più a chi, ho obbiettato: se davvero ne abbiamo una sola, puah, per me perde ogni interesse, e buttarla non è più niente. Hanno riso. Hanno pensato che fosse una battuta. Ma poiché, ho continuato, di vite ne abbiamo invece anche un’altra, questa qui, se occorre, posso anche buttarla senza paura. Logico, no? Allora hanno scosso la testa e un ometto attempato, credo un ministro, mi ha borbottato il vecchio luogo comune: Dio è un’invenzione degli uomini.
Oppure vengono e ti dicono: la vita è sacra. Io dico: ma il sacro non l’avevate abolito? E poi: la vita di chi? Di chi si tratta come un gioiello, consuma per dieci, si lustra da mane a sera ed è pronto a farsi sostituire i pezzi, anche cuore e cervello, pur di continuare a esserci? Francamente, io qui di sacro non vedo più nulla. Ma il punto non è che non vogliono morire: è che non sanno nemmeno più soffrire. Come sai, sono anch’io un affarista e un assassino, però a sofferenza e morte dico: venite, vi ho messe nel conto.
Non so se verrà la guerra. Ma sì, verrà. Gli USA non aspettavano che una buona occasione per rimetter piede in Afghanistan, poi metterlo poi anche in Irak e in Iran. Ma dov’è lo stato da attaccare? Quei pezzenti degli stati non sono più responsabili di nulla, caos e debiti, funzionante e in attivo è solo il privato; anche il terrore è in mano al privato. Ma anche se verrà la guerra, tu, mia Fatima, mia cerbiatta, mia bella tagika, in Tagikistan sarai al sicuro: anche il cuore ex sovietico dell’Asia salterà in aria, giusto quello, per via del suo grasso sottosuolo, ma c’è tempo. E la causa sarà sporca – come un mare inquinato – ma sulla causa galleggeremo tutti, come resti di un naufragio, kamikaze e damerini, obesi e anoressici, donne, vecchi e bambini. E poi mi dicano che l’umanità non ha bisogno di Dio.
Per ora, ossia questa settimana, e sia grazie ad Allah onnipotente, gli USA vogliono prima provare a spedire sulle piste afghane del saudita, degli esperti, mezzi militari mezzi spie, e li stanno addestrando alla dura vita di grotta, di caverna – alla vita dei talebani, capisci? Per addestrarli li hanno piazzati parte in Virginia, in certi umidi sotterranei ribattezzati “Bin Laden Lane”, parte in un puzzolente garage di New York. Bush ne è rimasto impressionato, non immaginava proprio: l’America, ha comunicato per TV, deve sapere che ci sono uomini e donne che da giorni, per la sicurezza di tutti, dormono sul pavimento, mangiano pizza fredda e telefonano ai figli la sera per scusarsi se non possono tornare a casa.
Non li odi tu? Io le Twin towers le chiamo Srewot niwt. Perché, mi domandano, e io rido: no, non è arabo né ebraico, è solo il loro nome alla rovescia, le torri rovesciate.
Da ultimo mi sono riguardato alcune foto che ho di Osama Bin Laden. Ti piaccio sempre, cerbiatta? Il cranio robusto, la fronte dritta come nell’ariete, il viso che sotto la barba si affina, le labbra rosee che ti hanno tanto baciata? A trent’anni, quando venivo in Afghanistan alla caccia col falcone – è una vecchia tradizione dei principi sauditi – ero uno splendore, ero il desiderio di tutte le donne. Adesso non caccio più animali, sono cacciatore o persuasore di uomini, li ammaestro, li minaccio…col dito alzato. Eppure detesto di predicare, e persino di parlare in pubblico, e si dovrebbe già capire da come tengo il microfono, in punta di dita.
Tu dici che per via dei sopraccigli che al centro vanno leggermente in su io ho un’espressione dolcemente malinconica, a volte persino smarrita, e che dei miei occhi il destro, un po’ più grande, guarda o come dentro di me o come in lontananza – lo chiami l’occhio geografico, e che il sinistro, più stretto, più freddo, guarda nel tempo che fu – e lo chiami l’occhio storico. Adoro le donne che sanno esprimersi come te, per immagini, l’immagine è donna, e quando abbracciandomi mi dici queste e altre cose, anche come mi trovi affascinante quando scendo dalla limousine e balzo a cavallo e via come il vento verso le gole, mi sento così deliziosamente descritto e individuato che potrei rinunciare a tutto il resto. Ma tu ridi e mi colpisci sulla guancia: ah, Osama, rinunciare alla vita sì, però finché sei vivo non rinuncerai al tuo sogno di fondare uno stato islamico, che controlla gas, petroli, anime. Gli stati, dici, non sono più attuali? Ma il tuo tenebroso cuore, Osama, è proteso alla conquista della terra. Touché, mia uri, mia fata, colpito nel segno, confesso. Come ha bisogno di voi lo stupido fallo maschile, che se non agisce gli pare di non esserci.
Sai che un grafologo inglese intervistato dal “Times”, studiata la mia firma su non so che documento, ha stabilito che, tronfia nel complesso, contiene però un “bozzolo”, ossia, nel loro gergo di grafologi, un bisogno di protezione? Inoltre tira al basso – s’intende a sinistra, che per l’arabo è la coda. Lo sceicco del terrore, conclude il professore, è ambizioso e creativo, ma è un infelice cronico. Ma scusi, Sir: lei non ha preso che la definizione dell’homo sapiens dal vocabolario.
Però è vero, mia Fatima, io a volte potrei piangere per come sono infelice, e a volte lo faccio, il viso nascosto nella manica, nel braccio piegato. Sai che piacere sono le caverne afghane!
Nemmeno del mullah Omar mi fido. Ha sposato una mia figlia adolescente, la più cara, ma qui da un giorno all’altro non si sa più chi è il più forte e chi ha dietro di sé, e se e chi tradirà chi, anche la truppa comincerà a passare al nemico – non si può pretendere che tutti siano eroi. Possono uccidermi. Non mi meraviglierei. O mandarmi sotto processo, qui o negli USA. A un processo negli USA avrei l’immensa gioia di rivelare al mondo cose che da sé taglierebbero in due alcune altre torri. Ecco perché, a patto che non parlassi mai più, mi offrono un asilo segreto, da loro, o in Florida o nel Nevada. Ho fatto un sogno grottesco l’altra notte: che mi affidavano l’incarico di ricostruire le Twin. Tu credi che sia proprio escluso? Niente è mai escluso. E per quanto tempo l’Islam resterà Islam? Ah, tutto sta diventando Occidente.
Morire è meglio. Un cavallo nero, già bardato, ti guarda, nitrisce, batte con lo zoccolo, e tu gli salti in groppa, e via…di là, nell’altra vita, della quale sono molto curioso. Oh non credere che non mi dorrebbe di perdere te e mia madre, e tante cose, anche questa morbida serata italiana, e certi piatti di riso, e i miei orologi. Il bello della vita, di questa, sono le piccole cose, l’altra non le avrà. Oh, niente, niente potrà competere con la dolcezza di questa.
Resterei, se morissi, nel tuo cuoricino? Chissà. Nel mondo già non resterà di me nulla. Mi succederà come alla principessa di Galles.
Eppure le opere valgono pure, più degli uomini che le compiono. Perché? Questo è un mistero che mi affascina.



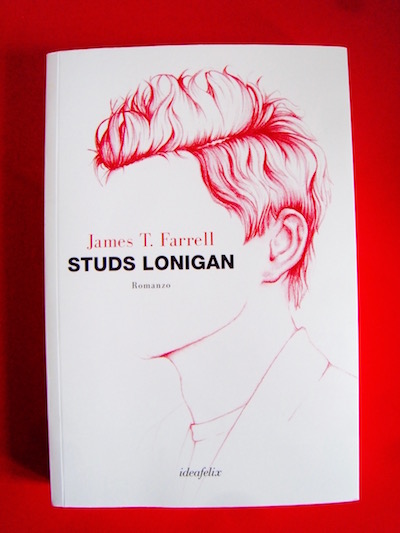
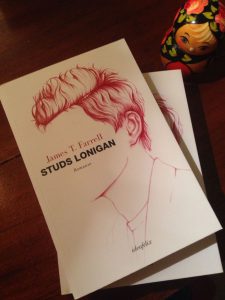 Sembra che i libri debbano darsi da fare. Non possono più accontentarsi di essere libri. Così, per restare nel mondo, i libri mutano. Alcuni perdono il potere della carta, e acquistano qualità digitali. Altri prendono la strada della socializzazione in Rete; capita in questi casi che il libro, che già di suo dovrebbe contenere tutte le storie possibili, divenga parte di una storia, o di uno storytelling intarsiato di status, post, video e immagini del quale il volume è solo l’innesco e poi appena un frammento. Altre mutazioni, le più frequenti, esulcerano nel protagonismo (virtuale, di network sociale) degli autori, che a volte aiuta il libro, a volte lo danneggia, a volte incoraggia i lettori ma può anche distrarli.
Sembra che i libri debbano darsi da fare. Non possono più accontentarsi di essere libri. Così, per restare nel mondo, i libri mutano. Alcuni perdono il potere della carta, e acquistano qualità digitali. Altri prendono la strada della socializzazione in Rete; capita in questi casi che il libro, che già di suo dovrebbe contenere tutte le storie possibili, divenga parte di una storia, o di uno storytelling intarsiato di status, post, video e immagini del quale il volume è solo l’innesco e poi appena un frammento. Altre mutazioni, le più frequenti, esulcerano nel protagonismo (virtuale, di network sociale) degli autori, che a volte aiuta il libro, a volte lo danneggia, a volte incoraggia i lettori ma può anche distrarli.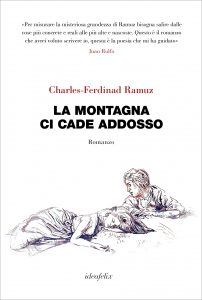
 (La biblioteca del viandante è una nuova collana diretta da
(La biblioteca del viandante è una nuova collana diretta da 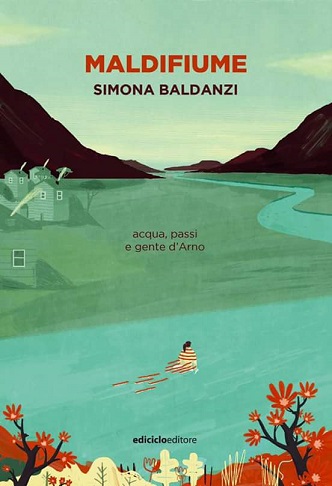








 To’, nella tasca sotto il tavolino c’è una rivistina delle ferrovie italiane: in tutto uguale a quelle delle compagnie aeree che te la fanno trovare nella tasca della poltrona. Odio, lo sai, la carta patinata e l’aggressione dei colori: non mi lasciano pensare. C’è un servizio che fa ridere ancor prima di leggerlo: “Carne reale: i signori della bistecca, del pollo e del maiale”. E il servizio sulla moda del prossimo inverno? Un po’ di mogli di sceicchi verranno di nuovo a fare shopping nelle capitali europee. A rigore, andrebbero frustate. Se chiudo gli occhi e penso a te, alla tua eleganza nativa, a com’è bello stare a guardare, mia Fatima, mia Dudu, mentre rapida, leggera, ti vesti e svesti sempre degli stessi panni. Ma, tu lo sai, ai particolari della realtà, anche ai più miserabili, io non dico mai di no, mi ci caccio dentro, potrei farne indigestione, come della pasta di mandorle. E qui c’è fotografato un uomo-donna, copricapo da guerriero del Sol Levante, seni nudi sotto una giacca di patchwork coi polsi di volpe, bisaccia da nomade, ombelico di fuori e pantaloni da cowboy con smaccate frange, rosso e verde, che arrivano appena sopra il pube. Vedi, non gli basta più essere uomo o donna come natura li ha fatti, vogliono la libertà di essere l’uno e l’altro, androgini, a capriccio…Sindrome da figli unici. E io che sono figlio della decima moglie di mio padre e diciassettesimo dei suoi cinquanta figli…
To’, nella tasca sotto il tavolino c’è una rivistina delle ferrovie italiane: in tutto uguale a quelle delle compagnie aeree che te la fanno trovare nella tasca della poltrona. Odio, lo sai, la carta patinata e l’aggressione dei colori: non mi lasciano pensare. C’è un servizio che fa ridere ancor prima di leggerlo: “Carne reale: i signori della bistecca, del pollo e del maiale”. E il servizio sulla moda del prossimo inverno? Un po’ di mogli di sceicchi verranno di nuovo a fare shopping nelle capitali europee. A rigore, andrebbero frustate. Se chiudo gli occhi e penso a te, alla tua eleganza nativa, a com’è bello stare a guardare, mia Fatima, mia Dudu, mentre rapida, leggera, ti vesti e svesti sempre degli stessi panni. Ma, tu lo sai, ai particolari della realtà, anche ai più miserabili, io non dico mai di no, mi ci caccio dentro, potrei farne indigestione, come della pasta di mandorle. E qui c’è fotografato un uomo-donna, copricapo da guerriero del Sol Levante, seni nudi sotto una giacca di patchwork coi polsi di volpe, bisaccia da nomade, ombelico di fuori e pantaloni da cowboy con smaccate frange, rosso e verde, che arrivano appena sopra il pube. Vedi, non gli basta più essere uomo o donna come natura li ha fatti, vogliono la libertà di essere l’uno e l’altro, androgini, a capriccio…Sindrome da figli unici. E io che sono figlio della decima moglie di mio padre e diciassettesimo dei suoi cinquanta figli…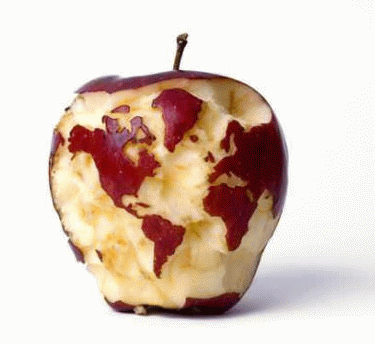 Bravo italiano. L’Islam, dice, si presta bene, per la sua semplicità e il suo carattere di militanza, a essere “la fede dei dannati della Terra, di quelle masse di poveri che oggi affollano, disperate e discriminate, il Terzo Mondo occidentalizzato”. Vero. Salvo che…io dubito della fede, anche della nostra musulmana…In questo mondo la fede è sempre stata solo in un modo di dire, che figura più o meno in tutte le lingue, ed è un passivo “Dio me la mandi buona”.
Bravo italiano. L’Islam, dice, si presta bene, per la sua semplicità e il suo carattere di militanza, a essere “la fede dei dannati della Terra, di quelle masse di poveri che oggi affollano, disperate e discriminate, il Terzo Mondo occidentalizzato”. Vero. Salvo che…io dubito della fede, anche della nostra musulmana…In questo mondo la fede è sempre stata solo in un modo di dire, che figura più o meno in tutte le lingue, ed è un passivo “Dio me la mandi buona”. Quel bolso di Schröder, anche lui fra i lustratori – tutto purché non affiori il ricordo di chi è stato a scatenare l’ultima guerra mondiale. Ve’ come siamo buoni, dicono ogni momento i tedeschi, nell’ultimo mezzo secolo siamo stati a testa bassa su nient’altro che su industria e commerci, e urbi et orbi lui manda un bellissimo testo intitolato “La cultura contro l’odio”. Poi dimentica il titolo – lapsus freudiano – e dal principio alla fine parla d’altro, sfacciatamente, ossia dell’unico oggetto del suo desiderio, il profitto. Ma almeno una volta, signore, una, pro forma, rimettiamocela la parola cultura! Niente da fare: little Schröder va dritto alla meta. Lei scriva intima al suo ghost writer: l’odio non potrà prevalere sulle forze della crescita economica né a New York né in Germania né in Cina, la crescita mondiale sarà coronata da successo. Ai consumatori che oggi chiedono “che cosa dobbiamo fare?” rispondiamo: niente pessimismo e paura, avanti con gli investimenti e coi consumi.
Quel bolso di Schröder, anche lui fra i lustratori – tutto purché non affiori il ricordo di chi è stato a scatenare l’ultima guerra mondiale. Ve’ come siamo buoni, dicono ogni momento i tedeschi, nell’ultimo mezzo secolo siamo stati a testa bassa su nient’altro che su industria e commerci, e urbi et orbi lui manda un bellissimo testo intitolato “La cultura contro l’odio”. Poi dimentica il titolo – lapsus freudiano – e dal principio alla fine parla d’altro, sfacciatamente, ossia dell’unico oggetto del suo desiderio, il profitto. Ma almeno una volta, signore, una, pro forma, rimettiamocela la parola cultura! Niente da fare: little Schröder va dritto alla meta. Lei scriva intima al suo ghost writer: l’odio non potrà prevalere sulle forze della crescita economica né a New York né in Germania né in Cina, la crescita mondiale sarà coronata da successo. Ai consumatori che oggi chiedono “che cosa dobbiamo fare?” rispondiamo: niente pessimismo e paura, avanti con gli investimenti e coi consumi. Tu lo sai, perché anche tu ti ci diverti – e come sei graziosa quando dentro i tuoi lini immacolati, solo i piedini fuori, sporta in avanti, a ginocchia divaricate, clicchi qua e là alla ricerca di qualcosa di stravagante – tu lo sai, i motori di ricerca internet, come tante persone, non capiscono i contesti, gli dai una parola e vanno a sbattere Dio sa dove. Sai quante informazioni radunano i computer della NSA? Fino a due milioni all’ora. Pensa alle sviste, e ai costi: da sghignazzare. Ma loro confidano nei biscotti, i cookies. Restano attaccati al tuo computer quando visiti un sito. Tu attiri l’uomo in qualche sito che glieli appiccica, dopodiché ovunque vada è pedinato. Ma l’uomo pensa – e cosa fa? Tiene pulito il suo aggeggio personale e per navigare e mandare i suoi mail va fischiettando da qualche internet-cafè o biblioteca pubblica. Qualcuno negli USA adesso grida: bisogna tornare all’intelligenza naturale, ai vecchi 007, a James Bond, alle spie umane, pagare per pagare meglio pagare queste. Però si alza qualche mano: non infiltrerete un bel niente, non lo sapete che “là”, fra quei primitivi, non è come qua, che non si lasciano corrompere, che nelle loro cerchie si entra unicamente per legami di sangue o di nozze? Giusto – o quasi…Tutto in questo mondo è quasi, perché così impermeabili ai dollari non sono nemmeno quei primitivi, io ne so qualcosa. Anche i miei piccoli talebani si sono così abituati a quei rettangoli grigioverdi con la faccina di Washington che non possono più farne a meno e – l’Onnipotente li perdoni – coltivano l’oppio, con la scusa che nessuno è obbligato a drogarsi. Verissimo, se questo pensiero non fosse un po’ occidental-individualistico. E quel mastino del caro presidente pakistano? E’ ridotto a un hotdog: sopra ha i biglietti grigioverde che svolazzano, sotto i servizi segreti e il popolo che avversa gli USA, lui è come la farcitura, e non lo invidio.
Tu lo sai, perché anche tu ti ci diverti – e come sei graziosa quando dentro i tuoi lini immacolati, solo i piedini fuori, sporta in avanti, a ginocchia divaricate, clicchi qua e là alla ricerca di qualcosa di stravagante – tu lo sai, i motori di ricerca internet, come tante persone, non capiscono i contesti, gli dai una parola e vanno a sbattere Dio sa dove. Sai quante informazioni radunano i computer della NSA? Fino a due milioni all’ora. Pensa alle sviste, e ai costi: da sghignazzare. Ma loro confidano nei biscotti, i cookies. Restano attaccati al tuo computer quando visiti un sito. Tu attiri l’uomo in qualche sito che glieli appiccica, dopodiché ovunque vada è pedinato. Ma l’uomo pensa – e cosa fa? Tiene pulito il suo aggeggio personale e per navigare e mandare i suoi mail va fischiettando da qualche internet-cafè o biblioteca pubblica. Qualcuno negli USA adesso grida: bisogna tornare all’intelligenza naturale, ai vecchi 007, a James Bond, alle spie umane, pagare per pagare meglio pagare queste. Però si alza qualche mano: non infiltrerete un bel niente, non lo sapete che “là”, fra quei primitivi, non è come qua, che non si lasciano corrompere, che nelle loro cerchie si entra unicamente per legami di sangue o di nozze? Giusto – o quasi…Tutto in questo mondo è quasi, perché così impermeabili ai dollari non sono nemmeno quei primitivi, io ne so qualcosa. Anche i miei piccoli talebani si sono così abituati a quei rettangoli grigioverdi con la faccina di Washington che non possono più farne a meno e – l’Onnipotente li perdoni – coltivano l’oppio, con la scusa che nessuno è obbligato a drogarsi. Verissimo, se questo pensiero non fosse un po’ occidental-individualistico. E quel mastino del caro presidente pakistano? E’ ridotto a un hotdog: sopra ha i biglietti grigioverde che svolazzano, sotto i servizi segreti e il popolo che avversa gli USA, lui è come la farcitura, e non lo invidio. Se a queste masse piene di confusione si potesse praticare la carota, come si fa col suolo per stabilire cosa ci sia sotto, credo che da loro nel sottosuolo troveremmo: giacimenti di piacere. Tu sei sempre paradossale, mi dirai. Ma, togli i parenti delle vittime, a tutti gli altri è stata offerta o no? una grande emozione. Meccanizzati, informatizzati, cibati, usati e gettati, in orbita ventiquatt’ore su ventiquattro…tu puoi immaginare cos’è il piacere di poter piangere, schiumare, andar ciarlando nei bar, far petizioni in internet, scrivere sui muri o invocare “ammazzate tutti gli arabi” o minacciare il vicino arabo di Brooklyn di devastargli il negozio?
Se a queste masse piene di confusione si potesse praticare la carota, come si fa col suolo per stabilire cosa ci sia sotto, credo che da loro nel sottosuolo troveremmo: giacimenti di piacere. Tu sei sempre paradossale, mi dirai. Ma, togli i parenti delle vittime, a tutti gli altri è stata offerta o no? una grande emozione. Meccanizzati, informatizzati, cibati, usati e gettati, in orbita ventiquatt’ore su ventiquattro…tu puoi immaginare cos’è il piacere di poter piangere, schiumare, andar ciarlando nei bar, far petizioni in internet, scrivere sui muri o invocare “ammazzate tutti gli arabi” o minacciare il vicino arabo di Brooklyn di devastargli il negozio? C’è un cristiano, un russo di un secolo e mezzo fa, che ha avuto due visioni che dell’essere umano dicono tutto, e altro non occorre: le ha chiamate l’Uomo del sottosuolo e il Grande Inquisitore. Fra i loro scrittori io questo lo rispetto e venero, come anche l’altro, coevo, che da vegliardo non ne poteva più di tutti gli ipocriti volti noti, compreso il proprio, ed è andato a morire in una stazioncina sperduta, in mezzo agli ignoti. Poi a cercare la verità ci sono stati un ebreo di Praga morto di tubercolosi e un ebreo galiziano crepato d’alcool a Parigi e da ultimo forse – maledizione, sempre loro! – un paio di ebrei tedeschi.
C’è un cristiano, un russo di un secolo e mezzo fa, che ha avuto due visioni che dell’essere umano dicono tutto, e altro non occorre: le ha chiamate l’Uomo del sottosuolo e il Grande Inquisitore. Fra i loro scrittori io questo lo rispetto e venero, come anche l’altro, coevo, che da vegliardo non ne poteva più di tutti gli ipocriti volti noti, compreso il proprio, ed è andato a morire in una stazioncina sperduta, in mezzo agli ignoti. Poi a cercare la verità ci sono stati un ebreo di Praga morto di tubercolosi e un ebreo galiziano crepato d’alcool a Parigi e da ultimo forse – maledizione, sempre loro! – un paio di ebrei tedeschi.


 di Francesca Fiorletta
di Francesca Fiorletta