di Michele Cocchi
Questo racconto è apparso sul numero III/IV della rivista cartacea e online dell’associazione Palomar.
C’è un piccolo dosso, e poi lo stradello di terra battuta curva leggermente a sinistra, lasciandosi definitivamente alle spalle l’ampio recinto del lupo.
Mio figlio mi stringe un po’ più forte la mano e io ricambio la stretta. Se ne sta in silenzio e io a quel silenzio mi accordo. Dev’essere l’effetto che nell’uomo provoca la vista del lupo. Un rispetto innato e primitivo. Mentre lo guardava trottare avanti e indietro tra i balzi erbosi, mio figlio ha detto: – È come un cane.
– Sì, è come un cane. Te l’ho detto che non faceva paura. Sono parenti stretti.
– Che significa parente?
– Che fanno parte della stessa famiglia. Come tuo zio Michele, e tua zia Sara.
– È più bello di un cane.
Ho sorriso. – Sì, è vero. È più bello di un cane. – Ho pensato di dirgli che il lupo ha qualcosa di più selvaggio, ma ho preferito non insistere.
Adesso cammina silenzioso e io so bene che sta rimuginando su questa cosa del lupo, per cui preferisco rispettare i suoi pensieri e non parlare, nonostante siamo a ridosso del recinto dell’orso, e io l’orso già lo veda, lento e goffo, camminare tra gli arbusti. Mio figlio no, non può vederlo, è troppo basso, e il muricciolo sulla sinistra che delimita la vasca dei pinguini gli copre la visuale.
Non mi sono mai documentato, ma immagino che l’orso provenga da qualche zoo siberiano, o da una villa di privati che lo tenevano incatenato nel parco per mostrarlo agli amici; per via di quel suo strano comportamento ritualistico. L’orso, infatti, compie sempre lo stesso percorso, un centinaio di metri attorno alberi e rocce. Non posso constatarlo, ma sono quasi sicuro che poggi le zampe esattamente sulle sue stesse impronte impresse sul terreno. Vederlo muoversi così è angosciante, come angosciano certi bambini che vedo nella mia stanza di terapia, quando ossessivamente ripetono lo stesso gioco ora dopo ora, seduta dopo seduta. È a questo punto che ho l’immagine di un orfanotrofio. Una di quelle Case dei bambini dove i piccoli senza famiglia dell’est europeo trascorrono i primi anni della loro vita. Ho pensato che fosse stato l’orso a guidarmi verso quest’immagine. Poi la mia attenzione si è spostata su un ragazzino con un impermeabile blu che se ne stava affacciato alla balaustra a guardare l’animale. Un tredicenne circa, di cui vedevo il profilo affilato. Il mio cervello lo aveva registrato prima che io ne fossi consapevole. Quanto prima? Prima che pensassi all’orfanotrofio? O anche prima che riflettessi sul passato traumatico dell’orso? Non importa. Il ragazzino era Gabriel e il mio cervello lo sapeva molto prima di quanto non lo sapessi io.
Isso mio figlio sulle spalle e gli dico: – Lo Vedi?
– Dove?
– Laggiù. Quello che cammina intorno alle rocce. Guarda quant’è grande.
– Eccolo!
– L’hai visto?
– Sì. È grande!
– Certo che è grande.
– Andiamo più vicini.
– Ora andiamo. Aspettiamo ancora un poco. Da qua lo vediamo meglio.
Gabriel è cresciuto. Si è fatto alto e sottile. Eppure c’è qualcosa nella sua figura che richiama il suo modo di essere spavaldo e graffiante. Incurante del rischio. Forse un certo modo di sporgersi dalla balaustra. O di tenere la testa diritta e il mento sporgente. Non so, non so dire. Lo fisso ancora un poco, da una distanza tale che non possa riconoscermi. Poi invento una scusa a mio figlio, gli dico che dobbiamo tornare indietro per un pezzetto di strada e che dall’orso torneremo più tardi. Lui protesta, ma lo convinco con la promessa che la tigre non lo deluderà.
A casa, il giorno dopo, cerco il quaderno con gli appunti delle sedute. Gabriel era un abile narratore e i giochi erano chiari e diretti. Trame articolate ma ben orchestrate che io seguivo, inscenando i ruoli che lui mi attribuiva. Frequentemente, però, mi scoprivo a pensare: Come devo sentirmi, Gabriel? Guidami, per favore. Cosa devo provare? Sono un personaggio triste? Arrabbiato? Confuso? Tu non me lo dici, e io non riesco a capirlo.
Ora lo so: il problema era proprio questo. Più di tutto il resto. Più del fatto che fosse stato adottato. O che fosse un potente provocatore. O che si mostrasse arrogante coi suoi genitori adottivi. Gabriel non sapeva cosa avrebbe dovuto provare in una certa situazione. Forse perché, a lungo, era vissuto nella condizione di non avere adulti con cui condividere le emozioni. O forse, le emozioni, aveva dovuto ricacciarle in profondità, nelle caverne buie che lui costruiva nei suoi giochi di fantasia.
Nella steppa siberiana c’è un piccolo villaggio. Cespugli, pochi alberi solitari. La terra dura e fredda e case di legno squadrate dove vivono poche famiglie. In una di queste un uomo ha cresciuto due orsi fratelli. Li tiene nel giardino della casa, si prende cura di loro. Non si conosce la loro età, ma sicuramente sono ancora cuccioli. Ogni mattina l’uomo va a lavoro. Prende il suo furgoncino e guida fino a un grande cantiere dove è impiegato come carpentiere. Lavora fino a sera, poi torna a casa dalla moglie e dai due orsi.
Una mattina, improvvisamente, qualcosa cambia. L’uomo, diretto al cantiere, lascia la casa come se fosse intenzionato a non farvi più ritorno. Appare freddo e distante, disinteressato ai due cuccioli e alla donna. I due orsi devono cogliere il cambiamento, perché corrono dietro al furgoncino, lo vorrebbero raggiungere per bloccarlo e non farlo andar via. Ma l’uomo guida indifferente lungo la strada senza accorgersi di loro. Oppure fa finta di non vederli. – L’uomo, – spiega Gabriel, – pensa che gli orsi siano diventati appiccicosi, si è stancato di loro. – Quello dei due che corre più veloce riesce a raggiungere il furgoncino e affiancarlo, così che l’uomo possa vederlo dal finestrino. Il furgoncino improvvisamente sterza e lo colpisce a una zampa, gliela calpesta con la ruota. L’orso è ferito e deve fermarsi, non può proseguire. Rassegnato, guarda il furgoncino allontanarsi e perdersi all’orizzonte. Il fratello si ferma per soccorrerlo, lo aiuta a trascinarsi fino a casa.
– Hanno paura? Sono arrabbiati? – Domando. Gabriel non sa rispondermi.
Io mi sentirei sconvolto, ma io non sono quei due orsi. Non posso dire come mi sentirei io. – E l’uomo? Come si sente?
– Non lo so. Decidi tu.
Lui non mi aiuta e io, nonostante mi sforzi, non provo alcunché. Non sento le emozioni dell’uomo, né quelle della moglie, né quelle dei due orsi. Il terreno emotivo è come quello dove sorge il villaggio: brullo e indurito dal freddo.
Nelle settimane successive gli orsi attendono invano il ritorno dell’uomo. Le notti si susseguono ai giorni con regolarità. Il sole siberiano non arriva mai a scaldarli davvero, è soltanto un cerchio pallido velato di nubi. Loro non soffrono il freddo, hanno pellicce folte che scaldano. Non escono mai dal giardino, lo sguardo puntato nella direzione della strada, nella speranza di vedere il furgoncino ritornare. Eppure gli orsi non appaiono particolarmente ansiosi, o addolorati, o furiosi. Questa è la loro storia e loro la affrontano, come se non esistesse un’alternativa.
La mia stanza di terapia di allora era molto ampia. Addossata a una parete, una sabbiera dove Gabriel costruiva il villaggio con le casette di legno. L’uomo – un pupazzetto di legno e corda – sedeva nel furgoncino e si allontanava, percorreva un lungo tratto di pavimento, saliva sopra il tappeto, scompariva sotto la poltrona, nascosto alla vista dei due cuccioli.
Molte volte ho chiesto a Gabriel cosa provassero gli orsi, cosa pensassero.
– Gli orsi non pensano niente.
– Niente.
– Niente.
– E cosa provano?
– Niente.
– Né pensano, né provano emozioni, – dico.
– Esatto.
– Probabilmente è meglio così. Se lo facessero, per loro sarebbe molto doloroso.
Gabriel indossa questo mantello che lo tiene caldo e sufficientemente distante dagli altri. Allungare una mano verso di lui è penetrare nello strato di pelle, grasso e peli della pelliccia dell’orso. Non lo si raggiunge mai per davvero. Cosa c’è sotto il mantello? È rimasto qualcosa del cucciolo? C’è mai stato un cucciolo Gabriel?
Le giornate siberiane hanno avuto temperature molto rigide. Quella dentro il gioco, e quella che io sentivo correre tra di noi. Un freddo che non si può mitigare. Nemmeno per mezzo della voce che cerco di far uscire avvolgente. L’entusiasmo che metto nella seduta. – La mia zampa. La mia zampa è ferita, – dico con dolore. – Il mio padrone l’ha colpita. Come ha fatto a non accorgersi di me? Eppure ero lì, proprio lì vicino al furgoncino. Doveva vedermi. Forse non ha voluto. Sono un orso appiccicoso. Un piccolo orso appiccicoso e inutile.
Un giorno, l’uomo torna a casa e uccide i cuccioli. Gli spara. – Era stanco di loro, – spiega Gabriel. È un’esecuzione rapida e pulita. Nella notte, mentre loro festeggiano il suo ritorno, lui punta il fucile e spara.
Gabriel non mangia carne. Nemmeno un pezzetto. Non ne sopporta la consistenza. Strano incontrare un orso che non mangia carne, ho pensato. Ha sette anni. Gli occhi grigi come certe pietre di fiume. Le labbra piegate in un sorriso amaro. I capelli biondi arruffati. Piccolo di corporatura, i muscoli sempre in tensione, pronti a fargli spiccare un balzo in avanti. A casa trascorre gran parte del suo tempo giocando nei campi. Si arrampica sugli alberi. Costruisce strumenti per la caccia in pietra e legno. Trappole. Scava buche profonde, cerca nascondigli naturali, anfratti e crepe nelle rocce sufficientemente larghi da contenerlo. Colleziona reperti naturali: sassi, ossi, pigne, animali morti, ogni tipo di seme che riesce a raccogliere.
In realtà, nelle nostre storie, gli orsi la carne la mangiano, carne di pesce che cacciano nel lago ghiacciato vicino casa. Incidono il ghiaccio con le loro forti unghie e con un colpo della zampa fanno saltare fuori i pesci. Non sono morti. Le ferite riportate non erano mortali. Se la cavano con un po’ di riposo e qualche impacco a base di erbe medicinali. Il maggiore si prende cura del minore. Quando finalmente possono sciogliere le bendature, rimane soltanto un circolo di pelle privo di pelo. Una cicatrice che ricorderà loro dove l’uomo ha colpito.
Insieme lasciano la casa e intraprendono un viaggio, diretti al grande mare. Giunti al porto, osservano le piccole imbarcazioni lasciare la terra ghiacciata e dirigersi a sud, verso terre più miti. Un pomeriggio, mentre guardano le persone salire sulle barche, i due orsi intravedono il loro padrone. L’uomo, in procinto di partire, si sporge dall’alto parapetto di una nave che trasporta uomini e merci. Gli orsi corrono verso di lui, ma non fanno in tempo a raggiungere la scaletta fuoribordo. La nave sta salpando e loro decidono di gettarsi nell’acqua gelida. Nuotano controcorrente, mentre l’acqua fredda punge loro il naso e gli occhi, e le onde prodotte dal movimento della nave li respinge e minaccia di farli affogare. Eppure loro non desistono, nuotano disperatamente, chiamano, gridano, vogliono raggiungere l’uomo.
Mentre scrivo questo racconto, sento l’angoscia assalirmi. La paura e il dolore. Ma allora non sentivo niente. Gli appunti sono chiari: nella seduta non provo alcun sentimento. Come se non potessi permettermi di provare emozioni. Come non potessero permetterselo i due orsi. Pena: un dolore troppo grande. Inconcepibile.
– Sei sicuro Gabriel?
– Sicuro di cosa?
– Sicuro che lottino con tutte le loro forze e rischino la vita per un padrone che ha sparato loro contro?
– Tu che dici?
– Non lo so. Io non sono sicuro che lo farei. Non sono sicuro che potrei ancora fidarmi.
– Loro lo fanno.
– Forse hanno paura.
– Forse.
– Io l’avrei.
– Loro invece stanno bene.
Ha ragione lui. Sto usando la testa, non il cuore. Adesso è troppo presto per usare la testa. Questi pensieri devo tenerli per me. Lui ha bisogno che gli orsi lottino per raggiungere l’uomo. E io devo ascoltare questo bisogno.
Uno dei due fratelli riesce nell’intento. Raggiunge la nave, lo issano a bordo. L’altro deve arrendersi.
Gabriel cresce e sta meglio. È meno provocatore. Smette di farsi la pipì addosso la notte. Comincia a interessarsi agli altri bambini. La carne, però, ancora non la mangia.
All’orso rimasto in Siberia crescono lunghe zanne affilate. Le zanne sono ottime per difendersi dai predatori, utili per uccidere, ma ingombranti se si ha necessità di incidere la carne per mangiarla. Sono uno strumento di difesa molto efficiente, ma allo stesso tempo rischiano di farlo deperire e morire di fame. L’orso sonnecchia tutto il giorno, si lima le zanne con una pietra speciale per tenerle sempre appuntite, esce di sera con la luce soffusa del tramonto, respinge gli attacchi dei lupi famelici scesi dalle montagne in cerca di cibo.
– L’orso non caccia?
– Non caccia. Tanto non saprebbe come mangiare la carne.
– Allora come fa a nutrirsi?
– Senza carne.
– Ci riesce?
– Ci riesce.
– Certo che è inusuale trovare un orso vegetariano.
– Lo sai. Ha le zanne troppo lunghe.
– Sì, lo so. Secondo te perché?
– Perché cosa?
– Perché gli sono cresciute queste zanne?
– Ne aveva bisogno.
– Per difendersi?
– Per difendersi.
L’orso raccoglie carcasse di animali morti. Le trascina dentro la caverna, un ampio spazio circolare con una volta a botte. Le scuoia. Le spolpa con le unghie. Spezza le ossa e le trita. Versa il trito nell’acqua e beve la mistura. Le sue zanne diventano sempre più lunghe e robuste. Questo orso teme la sua stessa natura, penso. Uccide solo se è davvero indispensabile alla sopravvivenza.
Nella foresta fredda del nord un orso ha la tana dentro un grosso tronco cavo. Vive con il suo cucciolo di pochi mesi. Caccia le prede con forza e agilità, le azzanna al collo, le uccide e le squarta. Mangia la carne, e altra carne la porta nella tana per il piccolo. Il piccolo deve crescere, ha bisogno di molto cibo, così l’orso deve allontanarsi per trovare nuove prede. Ha paura. Teme che un altro orso possa entrare nel suo territorio, fiutare l’odore del cucciolo, ucciderlo o portarlo via. Così si muove circospetto, annusa con attenzione ogni pietra, albero o cespuglio, compie movimenti concentrici attorno alla tana, allontanandosi progressivamente, torna costantemente a controllare che il cucciolo stia bene.
– Chi è questo orso?
– In che senso?
– È l’orso che ha raggiunto la nave?
– Quella è un’altra storia.
– E l’orso che può arrivare chi è?
– Un orso.
– Vive lontano?
– Non troppo lontano.
– Potrebbe essere l’orso dalla zanne affilate?
– Sì. Potrebbe essere lui.
– Secondo te è davvero pericoloso?
– Potrebbe venire. Lo sai, uccide le prede senza mangiarle.
– Perché lo fa?
– Cosa.
– Perché uccide?
– Non lo so.
– Potrebbe essere per paura?
– Forse sì. Potrebbe essere.
– Oppure?
– Oppure è cattivo.
C’è un fratello lontano, penso. Un fratello molto impaurito. A lui è andata peggio: non ha cuccioli, ha fame, il cibo scarseggia. Potrebbe tornare incattivito. Potrebbe tornare accecato dall’invidia e uccidere suo fratello. Ucciderne il cucciolo. Non comunico a Gabriel questi pensieri. Perché non so da dove provengano. Se provengono da lui, allora provengono da luoghi molto remoti di lui.
Alla fine il timore si materializza. Un orso scende dai monti del sud, si avvicina al territorio di Gabriel e trova rifugio in una grotta, non troppo distante dal tronco cavo. Non è l’orso dalle lunghe zanne affilate, oppure, sei è lui, ha perduto le zanne. Come l’altro, ha un cucciolo da proteggere.
Devo procedere gattoni sul pavimento. Costruire una grotta di cuscini e coperte. Scegliere un peluche da portarmi sempre dietro. Il nuovo orso sono io.
Usciamo fuori dalle nostre tane, portiamo i nostri cuccioli con noi. Stringiamo delicatamente tra i denti la loro collottola e loro si abbandonano. Zampe e testa molli che dondolano assecondando i nostri movimenti. Mi avvicino alla tana di Gabriel e vi entro. Lui entra nella mia. Occupo il suo territorio. Lui il mio. Ci scambiamo: Io sono lui, lui è me. Siamo simili eppure diversi. Finché un giorno io esco a caccia e lascio il cucciolo nella tana pregandolo di non uscire. Gabriel fa la stessa cosa. Due immagini speculari. Due fratelli. I cuccioli sono curiosi, intraprendenti, escono disattendendo le raccomandazioni. Si allontanano troppo. Io catturo il suo, lui cattura il mio. Va bene così: a lui il suo cucciolo non manca, a me non manca il mio. Iniziamo a scambiarceli, tanto uno vale l’altro, non c’è differenza.
I due orsi portano ai cuccioli la carne che strappano dagli ossi delle prede. Spolpano le carcasse. I cuccioli crescono e i due orsi decidono di unire i loro territori. Vanno alla ricerca di un’unica grande tana tra le rocce. Sono maschi? Sono femmine? Gabriel non lo sa. Penso ai due fratelli orsi divisi dal mare che si sono ritrovati. I loro cuccioli diventano fratelli a loro volta. La storia si ripete ciclicamente.
Arriva un mattino in cui la foresta è immersa in uno strano silenzio. Irreale. Gli uccelli non cantano. Le scimmie non gridano. Gli orsi cuccioli sono fuori dalla tana, si sono avventurati ben oltre il loro territorio. All’orizzonte vedono animali che non avevano mai visto. Esseri che camminano con due zampe e utilizzano le due zampe libere per trasportare bastoni e altri oggetti. Sanno dell’esistenza degli uomini, i due orsi adulti ne hanno parlato spesso.
Si avvicinano e gli uomini puntano loro contro i bastoni, gridano qualcosa in una lingua incomprensibile e si abbassano. I bastoni non assomigliano affatto a dei bastoni. Sentono un suono e un dolore cupo. Provano a scappare ma dopo pochi metri le zampe posteriori cedono sotto il peso di una invincibile stanchezza. Si accasciano sulle foglie. Quando si risvegliano sono dentro una gabbia. Una grande gabbia con sbarre di metallo.
Il sole acceca loro gli occhi. Hanno fame e sete. Nella gabbia gli uomini hanno lasciato loro acqua e cibo. Io mi aspetto che i due cuccioli si avvicinino, si tocchino, trovino conforto un con l’altro. Ma non accade, è un bisogno mio, non un bisogno di Gabriel. Gabriel non ha paura, almeno apparentemente. Davanti a noi, fuori dalla gabbia, pali di legno ben piantati nel terreno delimitano il territorio del lupo. – Dove siamo? – Gli chiediamo.
– Non l’avete capito?
– No, non l’abbiamo capito.
– Gli uomini vi hanno catturato. Siete in uno zoo.
– Possiamo scappare?
– Perché dovreste?
– Non vogliamo stare in uno zoo. Vogliamo essere liberi,– dice Gabriel.
– Qua stiamo bene, – dice il lupo. – A noi animali non manca niente. Abbiamo cibo, acqua, un recinto spazioso.
– Ma siamo in prigione.
– Dipende da te, – dice il lupo. – Puoi pensare di essere in prigione, oppure in un posto tranquillo in cui vivere.
Passano i giorni. Gli uomini ci nutrono e noi li guardiamo sospettosi.
– Secondo te che succede, Gabriel?
– In che senso?
– I due orsi hanno paura?
– Non hanno paura.
Finalmente ci trasferiscono. Gli uomini si fidano abbastanza di noi per portarci dentro un recinto. Credono di averci addomesticato. Credono che non fuggiremo. I pali di legno sono alti, ma non abbastanza da non permetterci di fuggire, se lo volessimo. Lo vogliamo? Non lo so. Gabriel non me lo dice. Probabilmente non lo sa nemmeno lui.
– Difficile decidere, – dico.
– Decidere cosa?
– Se restare o andare.
– È semplice invece
– Tu che hai deciso?
– Non te lo dico. Dillo prima tu.
È una trappola. Non posso scegliere io per lui. Non sarebbe giusto. Dico che non lo so, sono combattuto. Da una parte vorrei andarmene, tornare in libertà, nella foresta. Dall’altra qua si sta bene. Gli uomini con noi sono buoni. Ci danno cosa buone da mangiare. Ci hanno costruito una tana robusta dove riposare. Si prendono cura dei nostri bisogni. E poi abbiamo fatto amicizia: il lupo, la tigre, la zebra. Sarebbe doloroso perderli.
Non è soddisfatto, lo sento. Finalmente sento qualcosa: la sua insoddisfazione. Allora lo dico: – Lo so. Le mie risposte sono insoddisfacenti. Sono un fratello orso che non sa scegliere la strada. Il problema è che non so se posso fidarmi.
– In che senso?
– Fidarmi degli uomini. Ti ricordi i due orsi in Siberia? L’uomo, il loro padrone, tentava di ucciderli.
– Ma poi sono guariti.
– È vero. Ma gli orsi hanno dovuto separarsi. Uno è diventato buono, l’altro cattivo. L’hai detto tu stesso.
Gabriel decide di fuggire via. Nella stanza di terapia c’è una bella luce. La giornata è solare e calda. Tra poco ci saranno le vacanze estive. Lui ha sentito un richiamo. Non ha resistito. Gabriel mi guarda, sull’estremo limite del tappeto che delimita il nostro recinto. – Tu che fai? – Mi domanda.
– Cosa vuoi che faccia?
– Devi decidere tu.
Provo a uscire dal personaggio: – Secondo te, Gabriel, cosa dovrebbe fare l’orso?
– Te l’ha detto: devi decidere tu.
Decido di seguirlo. Ma è una scelta che faccio razionalmente, non emotivamente. – Altrimenti finisce come l’altra volta. – Dico
Gabriel annuisce. – Esattamente.
– Uno era andato e uno rimasto. Ma non era stata la scelta migliore.
Girovaghiamo per due giorni in cerca di cibo. Siamo stanchi e deboli. Le iene ci attaccano. Dobbiamo difenderci. Lo facciamo insieme, siamo uniti nella lotta. Io penso allo zoo, là stavo bene, mi mancano i miei amici ma non dico niente. Finalmente me lo domanda: – Cosa pensi?
– In che senso?
– Abbiamo fatto bene?
– Comincio a pensare che questa libertà sia molto faticosa. Nello zoo non eravamo liberi, ma ci sentivamo contenti.
Così decidiamo di tornare. Gli uomini e gli altri animali festeggiano il nostro ritorno. Finalmente i due fratelli sono davvero uniti. O almeno così sento io. Due orsi uniti. Ma anche qualità opposte che possono integrarsi: la ferocia e la bontà. L’intraprendenza e la mitezza. Il senso di indipendenza e quello di dipendenza. Il carnivoro e l’erbivoro.
Ho visto i genitori adottivi di Gabriel. Il padre ha spesso gli occhi lucidi. Lei spaventati. Chiedo come vadano le cose a casa, poi racconto i progressi che vedo. I movimenti emotivi di Gabriel. Gli racconto che il tema del fratello per lui è importante. È un fratello immaginario? È un’altra parte di sé? Difficile a dirsi. Entrambi spalancano gli occhi, si agitano sulla poltrona. Il padre sospira due volte rumorosamente.
– È un tema spinoso? – Domando. – Ho la sensazione di avervi messo in agitazione.
– Crede che sua sorella c’entri qualcosa, dottore?
Per un attimo non capisco. Strizzo un po’ gli occhi come faccio solitamente quando qualcosa non mi è chiaro. – Sorella, – dico a bassa voce.
– Si ricorda? Gabriel ha una sorella. Una sorella maggiore che è rimasta in Polonia.
Non me lo ricordavo. Eppure lo sapevo. Loro me lo avevano raccontato. Appena usciti dalla stanza, sono corso a recuperare il quaderno degli appunti. Sfoglio le prime pagine, quelle che ho scritto durante gli incontri coi genitori. Sorella. L’avevo scritto, e a margine del foglio avevo anche fatto tre piccoli freghi verticali per segnalare che era un’informazione importante. Eppure lo avevo dimenticato. Com’è possibile che abbia dimenticato un dato di realtà così rilevante?
Gabriel non sa di avere una sorella. Il padre e la madre hanno deciso di non raccontarglielo. Non per adesso, almeno. Di lei, all’epoca dell’adozione, non si avevano tracce. Era stata portata in un’altra Casa, per bambini più grandi, e poi probabilmente adottata. Anche se loro avessero voluto, non sarebbe stato possibile portarla con loro. Avrebbero voluto? Mi domando. Forse non è una domanda importante. La domanda importante è: Gabriel sa di avere una sorella? La ricorda?
Certamente sì, se non la ricorda a un livello consapevole, la ricorda sicuramente a un livello inconsapevole. La ricorda il suo corpo: da qualche parte l’esperienza di una bambina che ti accarezza o ti colpisce; da qualche parte la sua voce, i suoi pianti e le sue risate; da qualche parte il tuo sentimento di ammirazione e la tua gelosia. Eppure io l’ho dimenticata. Come Gabriel. Qualcosa mi ha indotto a dimenticarla. Qualcosa di mio o qualcosa di suo?
Con mio figlio sono tornato molte volte allo zoo. Superato il recinto del lupo, ho sempre una certa fretta di raggiungere quello dell’orso. Gettare un’occhiata in lontananza nella speranza di vedere il ragazzino con l’impermeabile blu. Adesso non avrei timore di andargli incontro e salutarlo. Adesso che ho dato un ordine alla sua storia e ai miei pensieri. Ma Gabriel non l’ho più visto, chissà se il suo manto di orso, nel tempo, si è fatto più spesso o più sottile.

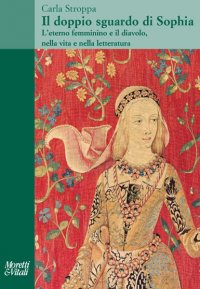




 Manifestazione, Place de la Nation, Parigi, 9 aprile.
Manifestazione, Place de la Nation, Parigi, 9 aprile. Manifestazione, Place de la Nation, Parigi, 9 aprile.
Manifestazione, Place de la Nation, Parigi, 9 aprile. Manifestazione dei ferrovieri à Montparnasse, Parigi, 10 maggio.
Manifestazione dei ferrovieri à Montparnasse, Parigi, 10 maggio. Sciopero generale contro la Loi travail, corteo da Place Denfert-Rochereau a Place de la Nation, 28 aprile.
Sciopero generale contro la Loi travail, corteo da Place Denfert-Rochereau a Place de la Nation, 28 aprile. Sciopero generale contro la Loi travail, corteo da Place Denfert-Rochereau a Place de la Nation, 28 aprile.
Sciopero generale contro la Loi travail, corteo da Place Denfert-Rochereau a Place de la Nation, 28 aprile. Sciopero generale contro la Loi travail, corteo da Place Denfert-Rochereau a Place de la Nation, 28 aprile.
Sciopero generale contro la Loi travail, corteo da Place Denfert-Rochereau a Place de la Nation, 28 aprile. Manifestazione contro la Loi Travail, Place de la Nation, 26 maggio 2016.
Manifestazione contro la Loi Travail, Place de la Nation, 26 maggio 2016. Manifestation contro la Loi Travail, Esplanade des Invalides, 14 giugno 2016.
Manifestation contro la Loi Travail, Esplanade des Invalides, 14 giugno 2016. Manifestazione contro la Loi Travail, verso l’Esplanade des Invalides, 14 maggio.
Manifestazione contro la Loi Travail, verso l’Esplanade des Invalides, 14 maggio. Manifestazione contro la Loi Travail, Place de la Nation, 26 maggio 2016.
Manifestazione contro la Loi Travail, Place de la Nation, 26 maggio 2016. Manifestazione contro la Loi Travail, Esplanade des Invalides, 14 maggio.
Manifestazione contro la Loi Travail, Esplanade des Invalides, 14 maggio. Manifestazione contro la Loi Travail, Place de la Nation, 26 maggio 2016.
Manifestazione contro la Loi Travail, Place de la Nation, 26 maggio 2016. Manifestazione contro la Loi Travail, verso l’Esplanade des Invalides, 14 maggio.
Manifestazione contro la Loi Travail, verso l’Esplanade des Invalides, 14 maggio. Manifestazione contro la Loi Travail, Place de la Nation, 26 maggio 2016.
Manifestazione contro la Loi Travail, Place de la Nation, 26 maggio 2016.



 Ci veniva spesso, e per Tito fu costruita a Bugojno la villa “Gorica”. Si diceva che i bosniaci catturassero l’orso in anticipo, e lo tenessero per il presidente. Giravano barzellette su vari politici bosniaci che tenevano personalmente con le proprie mani l’orso finché Tito, ormai vecchio, non lo uccideva.
Ci veniva spesso, e per Tito fu costruita a Bugojno la villa “Gorica”. Si diceva che i bosniaci catturassero l’orso in anticipo, e lo tenessero per il presidente. Giravano barzellette su vari politici bosniaci che tenevano personalmente con le proprie mani l’orso finché Tito, ormai vecchio, non lo uccideva.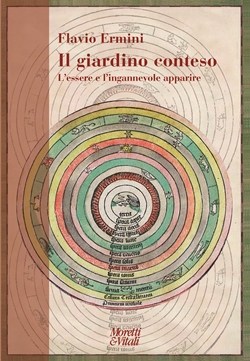
 di Francesco Borrasso
di Francesco Borrasso

 La mia educazione sentimentale è passata attraverso libri assai differenti tra loro.
La mia educazione sentimentale è passata attraverso libri assai differenti tra loro.
 Piuttosto che andare a Istanbul, avrei preferito ascoltare “The Beatles” a Londra, passare insieme alle dive cinematografiche per via Veneto a Roma, passeggiare in minigonna per gli Champs Elysées a Parigi. L’Occidente piuttosto che l’Oriente era la meta preferita dei giovani di allora.
Piuttosto che andare a Istanbul, avrei preferito ascoltare “The Beatles” a Londra, passare insieme alle dive cinematografiche per via Veneto a Roma, passeggiare in minigonna per gli Champs Elysées a Parigi. L’Occidente piuttosto che l’Oriente era la meta preferita dei giovani di allora.