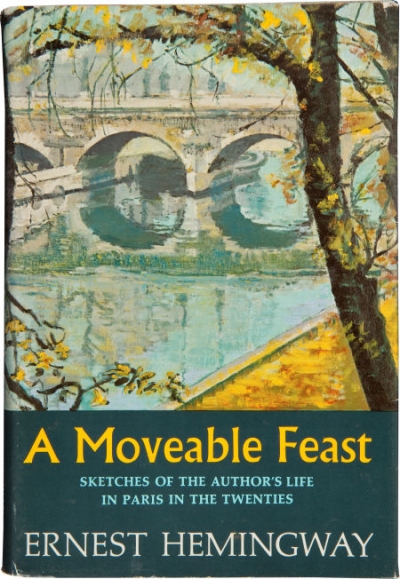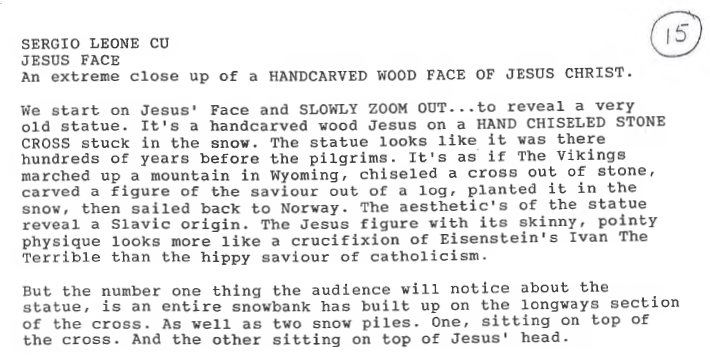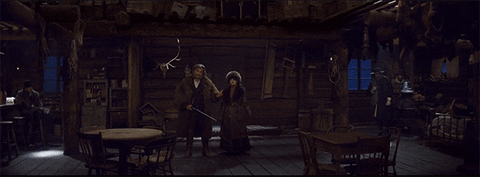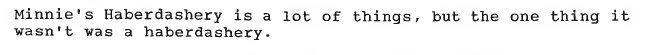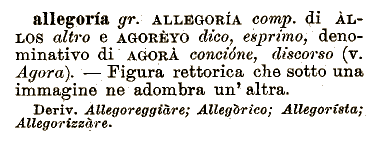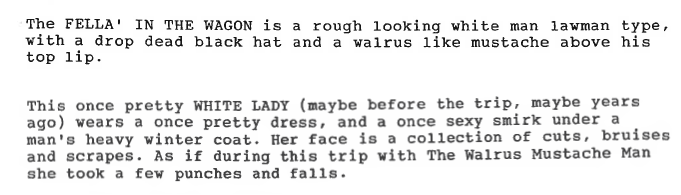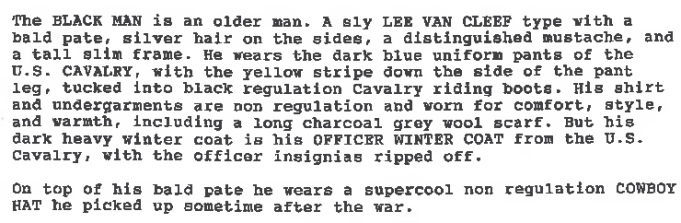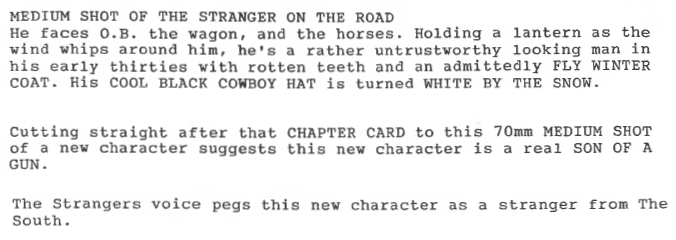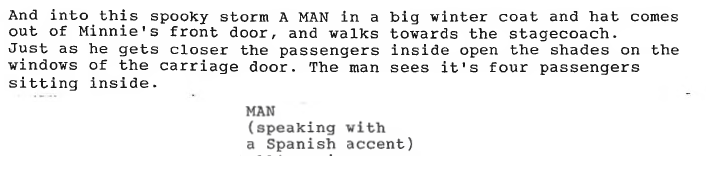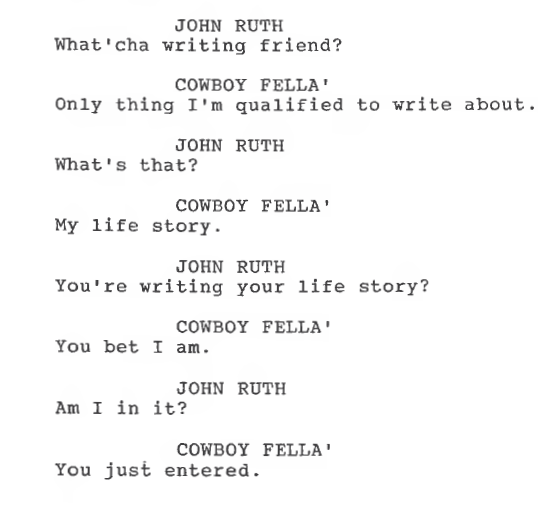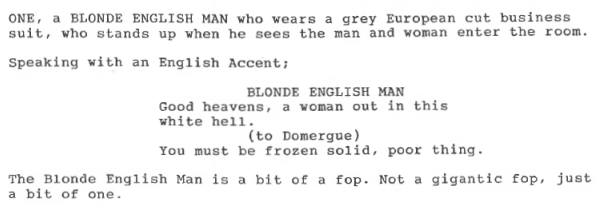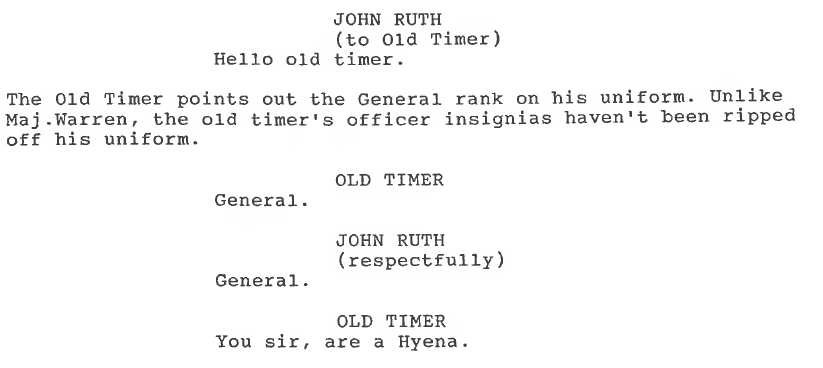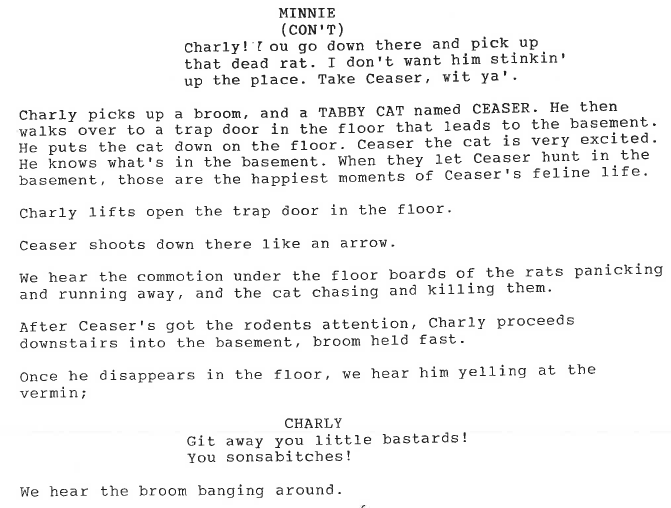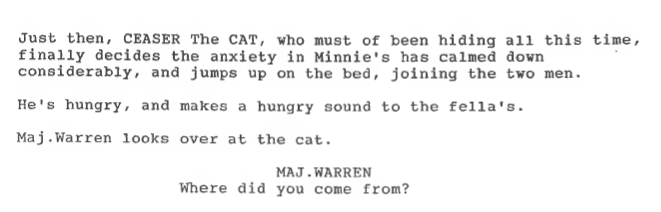Ecco, con un po’ di ritardo, il terzo e ultimo atto della rubrica « Braccia rubate (al cinema) », corredato da una breve bio-filmografia dell’autore e da un link a un film che evoca il testo (o viceversa).
Le ultime braccia rubate sono quelle di Ivan Polidoro, con la sua storia che edifica poco, ma bene.
Una storia poco edificante
Il giorno in cui la signora Santi morì c’erano tutti e tre i suoi figli. Non li vedevo da tempo, per motivi di lavoro erano andati via da Napoli e si erano stabiliti altrove. Avevano messo su famiglia e da quel che ricordo facevano ritorno saltuariamente. Aldo, il maggiore dei tre, fu il primo ad andarsene. Fece un po’ di pratica presso un’azienda del Varesotto, poi si mise in proprio. Materiali di gomma e simili. Profili, trafilati, lastre calandrate, guarnizioni per termoformatrici, raschiatoi, soffietti, membrane, ventose. E con ogni tipo di mescola. Dai siliconi al poliuretano alla gomma naturale. La sua aspirazione erano però i tubi industriali, tubi raccordati e rigidi, me ne parlò in occasione del compleanno del padre, era l’autunno di cinque anni fa. I giardini del parco erano cosparsi di foglie, ne rastrellai abbastanza da farne quattro pile della grandezza di un sacco. Lui non fece che parlare di questi tubi e di quanto il mercato in quel settore fosse in espansione. L’animo dell’imprenditore o ce l’hai o non ce l’hai, e lui ne aveva da vendere. La Santi Gomme ha alle sue dipendenze una dozzina di persone, non poche di questi tempi. Aldo è sposato e ha due figli, un maschio e una femmina. Li ho visti un Natale di tre anni fa, belli e biondi come la madre, Margaret. Margaret credo sia austriaca o belga, comunque mezza e mezza, di padre italiano e mamma straniera. O viceversa. Margaret è una bella donna, elegante, sempre gentile, un fisico asciutto e longilineo da gran signora. Riservata al punto che di lei si sa poco o nulla, e hai voglia a chiedere. Quelle rare volte che è venuta l’ho sempre salutata con discrezione, quasi ne avessi timore. Non mi sono mai arrischiato a un baciamano perché non so se sia il caso, mi sono sempre tenuto alle mie disposizioni: cordiale e rassicurante. Come mi ha insegnato mio padre.
Il portiere questo fa, questo deve fare. Tutti i santi giorni, che ci sia pioggia o neve, che faccia freddo o caldo infernale, lui deve essere quello a cui affidi la casa prima di recarti al lavoro. E quando fai ritorno vuoi sapere se è tutto a posto, o se è scoppiato un tubo dell’acqua. E allora basta un cenno o un sorriso per chiudere la giornata. Perciò è giusto che sia cordiale e rassicurante. Anche se la sua vita va a rotoli o gli è morta la madre.
Matteo, il secondo, è sempre stato il più fannullone, sfaticato per natura. Non faceva altro che starsene seduto sulla panchina con quei suoi fumetti. Ne leggeva in quantità disarmanti, ciancicando i suoi chewing-gum alla fragola o che so io. E lo pregavo di non buttarli a terra o appiccicarli alla panchina, sennò sarebbe stato un bel casino, a togliere quella roba ci metti una vita e imprechi tutti i santi possibili. Perché mai li hanno inventati i chewing-gum? A Ilaria per un po’ gliel’ho vietati, tassativamente vietati.
– Fanno male ai denti, fanno venire le carie – le dicevo.
Mia moglie sorrideva, lasciava che queste schermaglie rimanessero tali. Credo che sotto sotto lei qualche chewing-gum glielo concedesse. D’altronde tra donne c’è quell’intesa che non potrai mai capire, inutile che ci sbatti il grugno, per loro sarai sempre e solo un uomo. Uno stupido uomo, testardo e cocciuto. Le ho voluto bene a Maria, un gran bene. E ce ne siamo voluti fino alla fine, fino al giorno in cui ha esalato l’ultimo respiro. Gran donna, mi ha insegnato un mucchio di cose, per esempio come rammendare un calzino, ora non si fa più, ma un tempo si faceva eccome, a mandare avanti la casa, a fare i conti, robe del genere, non buttava via niente quella donna. Ma soprattutto mi ha insegnato a vivere. A passarci sopra. Ero uno che non mandava giù tante cose, permaloso, sospettoso, credevo che il mondo intero ce l’avesse con me. Insomma, ogni accidente che mi capitava doveva avere una causa, e di solito era qualcuno che voleva il mio male. Non era difficile per me stanarlo, ce n’erano di persone a cui non andavo a genio, forse il mio aspetto, il mio carattere riservato, non so, fatto sta che le cose stavano così. La colpa di quello che mi succedeva era sempre di qualcuno e quel qualcuno, una volta individuato, per me diventava croce nera. Meglio evitarlo.
Dicevo, Matteo, il secondo dei Santi, era il più sfaticato. I suoi fecero di tutto per fargli prendere il diploma e seppure con qualche difficoltà alla fine ci riuscì. Non ebbe un voto degno di quella famiglia, ma era pur sempre un diploma! Il padre era professore di Storia medievale alla Federico II, aveva pubblicato diversi libri e per un certo periodo di tempo fu un valido esponente della Democrazia cristiana, insomma era uno che contava a Napoli. Sapere che il figlio si era diplomato per il rotto della cuffia non lo fece certamente sorridere. Di continuare gli studi Matteo non ne volle sapere, perciò si mise ben presto a lavorare. Con le conoscenze che aveva, al signor Santi non fu difficile trovargli una giusta collocazione. Entrò così al Banco di Napoli, e da semplice impiegato divenne in pochi anni direttore di filiale. Ora credo sia un pezzo grosso di una banca del nord. Anche lui ha due figli, un maschio e una femmina che studiano a Londra, e sua moglie, oltre che andare al cinema, al teatro e alle sfilate di moda, non fa che organizzare cene e aperitivi. A differenza di Margaret, Betta è una che fa parlare e molto di sé. – Organizzo eventi culturali cool – la sentii dire una volta. Quarant’anni portati come una ragazzina e un corpo burroso che non puoi non guardare. Immagino che fare sesso con lei sia una gran bella soddisfazione. Da quel che so hanno una splendida villa a Bergamo, una a Saint-Tropez e persino un appartamentino a Miami. Insomma, avrebbero di che essere felici. È che non esiste una regola per questo genere di cose.
Quel giorno Matteo mi sembrò particolarmente giù di corda. Mentre tutti sfilavano per fare le condoglianze all’ultimo piano, lui se ne restò da solo su quella panchina per diverso tempo. Lei fumò un certo numero di sigarette e i due non si scambiarono una parola. Come fossero due estranei. Due macchie nere tra i pini secolari del parco.
Avrei voluto avvicinarmi, dirgli qualcosa, insomma l’ho visto crescere. Era un ragazzo simpatico, gioviale, uno con la battuta pronta. Ora lo vedevo appesantito e depresso, e non era la morte della madre a renderlo così, c’era dell’altro. Ma rimasi al mio posto. La riservatezza, quando ci vuole, è la prima cosa. È il tratto distintivo di un buon portiere. Persino una confessione deve rimanere un segreto, e in questa guardiola, credetemi, me ne hanno fatte.
Stefania è la più piccola. Ho sempre avuto un debole per lei, forse perché mi ricordava Ilaria, hanno la stessa età. Quarantun anni spaccati. Era la tipica adolescente irrequieta di buona famiglia, che amava viaggiare, fare nuove amicizie, diceva che avrebbe fatto il giro del mondo con due uomini: – Come Catherine! Catherine di Jules et Jim. Non sembrava affatto una Santi, altre idee, altre aspirazioni. Al contrario dei fratelli si circondava di gente strampalata, figli di papà con la vena artistica. Con loro organizzava letture nel box che poi finivano, non so perché, sempre con qualche scazzottata. Io li lasciavo fare, sebbene parecchi condomini si lamentassero. Li ho protetti finché ho potuto. Si diceva che facessero uso di droghe, che ogni tanto qualcuno rubava e lo sbattevano dentro, ma lei non c’entrava nulla con tutto questo. Era di una vitalità travolgente. Nessuno di loro, dei Santi, aveva quella vitalità. A diciotto anni disse ai genitori che sarebbe andata alla London Film Academy a studiare cinema. Aveva superato le selezioni. Loro non ne furono contenti. Girò alcuni piccoli film, poi le cose non andarono per il verso giusto. Un matrimonio sbagliato, una figlia. A quel tempo stava a Parigi, si manteneva facendo la cameriera, e per un po’ riuscì ad andare avanti, ma poi decise di tornare. Ora vive a Savona, fa la mamma a tempo pieno. Il suo nuovo compagno è uno stimato architetto industriale, anche lui separato, con una figlia.
Mi sorprese quando li sentii discutere. Ero lì, non potevo certo dissolvermi nel nulla, né loro si preoccuparono della mia presenza. Me ne sarei potuto andare, ma mi avrebbero sentito, avrebbero sospettato che io mi fossi appostato per spiarli. Erano infervorati, anche se cercavano di contenere i toni. Aldo fumava e con il suo fare saccente interrompeva di continuo, soprattutto Matteo.
– Che stupidaggine – disse. – Dobbiamo assolutamente fare qualcosa. È assurdo!
– Sì. Ma è la volontà di mamma – rispose Matteo.
– E con questo?
– Forse dovremmo rispettarla. Se è questo che vuole, che ha scritto.
– E se non fosse così? Se si fosse lasciata convincere?
– Sì, può essere, rimane il fatto—
– Vaffanculo. Con te è inutile.
– In fondo noi non le siamo stati troppo vicino in questi anni – disse Stefania.
– Ti ci metti anche tu?
– È la verità.
– Però, noi siamo i figli. E questa, se ben ricordo, è la nostra casa. Siamo cresciuti qui, giusto?
– Si tratterebbe solo di un periodo, fino a quando Maria—
Qui intervenni, non potevo non farlo. Mi mossi appena e le foglie sotto i miei piedi scricchiolarono.
– Vi attendono di sopra.
Matteo sbuffò. – Che situazione – disse.
– Vi prego, non aggiungete una parola. Non in mia presenza almeno.
Aldo chinò il capo, fece un altro tiro di sigaretta e la buttò via.
– Scusa, ma non è con te che ce l’abbiamo, – disse – solo che è strano. Non pare anche a te?
– Sì, un po’ lo è – risposi.
Eravamo solo noi in quel punto del parco, immersi in un piccolo silenzio imbarazzante. E anch’io in qualche modo mi sentii in colpa. Lungo il viale passarono delle persone che Stefania salutò. Ci girammo tutti quando sentimmo il pianto di una signora. Matteo provò a metterci una pezza, ma non fece altro che peggiorare le cose.
– Non capisco perché ci tieni tanto – disse al fratello. – Hai tutto, non hai bisogno anche di—
– Matteo, non essere patetico, anche tu non mi sembra che te la passi male.
– No, rigraziandoiddio. Per questo dico che se mamma vuole così, così sia.
– Cos’è tutto questo buonismo?
– Non è buonismo.
– E allora cos’è? Non capisco.
– Diamoci una calmata – disse Stefania. – C’è gente.
– Sai che mi interessa. Allora?
– Non so che dire.
– Non hai mai saputo che dire, questa è la verità. Quando c’è da prendere qualche decisione, tu non sai mai che dire. Sei sempre stato così. Un pavido, anche con papà.
– Cosa c’entra papà adesso? Che tiri fuori? Vuoi litigare, è questo che vuoi?
– Lascia perdere, ne avrei cose da dire.
– E dille, dài, tira fuori il rospo!
– Come va con Betta, eh?
– Ma che ti viene in mente? Che dici?
– Non andate d’accordo, si vede. È da un pezzo che il vostro matrimonio sta andando a rotoli, che aspetti a mollarla?
– Non è come credi. Che ne sai tu com’è il nostro rapporto. Mica le sai le cose che sono successe.
– E allora dille, perdio!
– Non mi va. Tanto meno dirle a un coglione come te.
– Mi avete rotto! Siete i soliti, non fate altro che litigare!
– Tu sta’ zitta che è meglio. Te ne sei sempre sbattuta.
– E tu allora? Che hai fatto?
Quante se ne dissero. Tirarono fuori il peggio. Quando gli animi si calmarono, mi limitai a dire che ne avrei parlato a mia moglie, avrei fatto in modo che tutto si risolvesse per il meglio. Maria avrebbe capito, in fondo che dovevamo farcene di quella casa? Noi due soli, in una casa così grande, con terrazzo e panorama. Avremmo continuato a starcene nella nostra, come sempre, la nostra vita non sarebbe cambiata di una virgola.
– Maria ha servito vostra madre per più di trent’anni, e negli ultimi tempi le è stata accanto giorno e notte.
– Sì, ma l’abbiamo pagata per questo.
– Certo.
– Voglio dire, è stata magnifica, non so come avremmo fatto senza di lei, ma—
– Vi aspettano di sopra – dissi. Poi mi allontanai.
E pensare che lei non sapeva nulla di tutta questa storia. La signora Santi confidò solo a me quali fossero le sue volontà.
– Voglio farle una sorpresa – disse. – I miei figli capiranno.
L’idea di andare ad abitare in quella casa non mi allettava, naturalmente ci sarei andato, se Maria avesse voluto, ma questo non cambia le cose.
Maria morì due giorni dopo, di crepacuore. Non aveva retto al dolore.
Non ebbi neppure il tempo di dirglielo.
FINE
Ivan Polidoro si diploma come attore presso l’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica “S. D’Amico”. Intanto si laurea in Lettere alla II Università di Roma. Lavora a teatro con Luca De Filippo, Mario Missiroli, Armando Pugliese, Federico Tiezzi e al cinema con Paolo e Vittorio Taviani, Antonietta de Lillo, Vincenzo Terracciano. Nel 2003 con il cortometraggio “Rapina” ottiene la menzione per la sceneggiatura ai Nastri d’Argento. Nel 2006 firma la regia e la sceneggiatura del film “Basta un niente” presentato in vari festival nazionali e internazionali, e premio del pubblico MaremetraggioFF 2006. La sceneggiatura “Amore catodico”, tratto da un suo testo teatrale “Boh”, ottiene il Premio del Pubblico al MitreoFF 2009. Nel 2011 pubblica il suo primo romanzo “Le coincidenze” per i tipi della 66thand2nd. Nel 2015 scrive e dirige il suo secondo lungometraggio “La sorpresa”.
Illustrazione: Giardino con casa rossa di Edvard Munch.









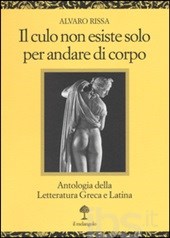

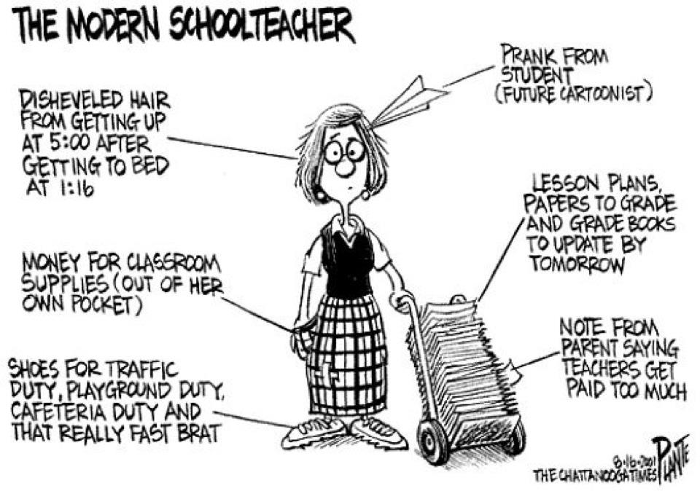

 poesie di Azzurra D’Agostino
poesie di Azzurra D’Agostino