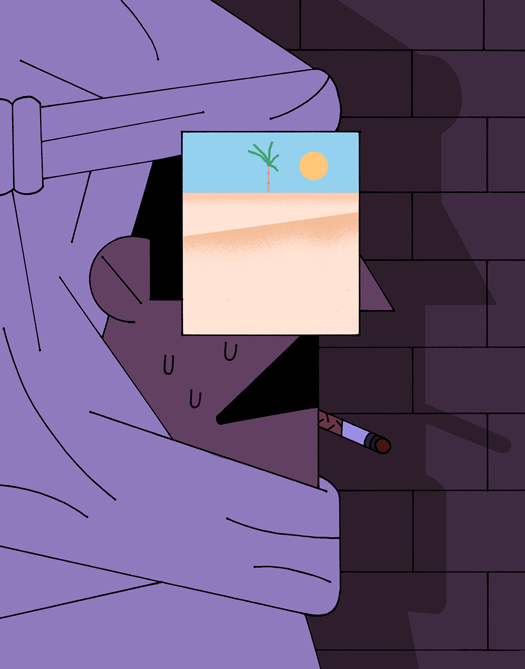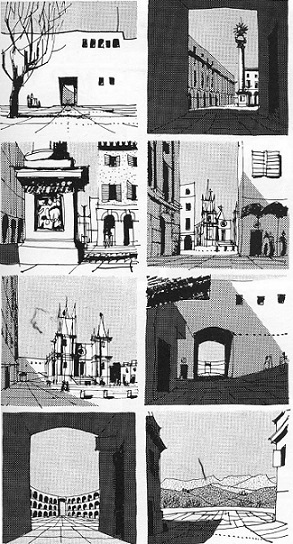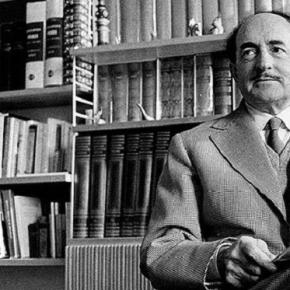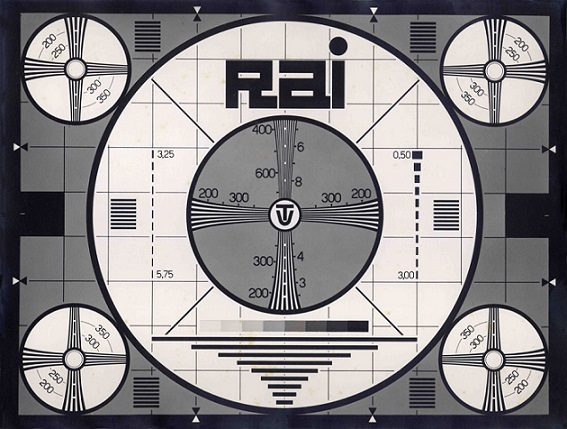di Massimo Parizzi
La prima malattia, da cui Čechov sembra muovere per sviluppare progressivamente – ma anche a svolte – il suo censimento, la sua topografia di quello che nell’uomo è stato chiamato “spirito”, “anima” (ed è anche, ma non solo, psichismo, mente, sistema nervoso, riflessi), è una malattia sociomorale, ed è il servilismo (con il suo complementare: l’alterigia).
Nei primi racconti (con un’eccezione), da La morte dell’impiegato (2 luglio 1883) a Messa di suffragio (15 febbraio 1886),1 a dominare è una “critica di costume”.2 E si tratta d’un costume fondato su, omologo a, e che accompagna una gerarchia (quella dei gradi della burocrazia russa dell’epoca, soprattutto, ma anche una gerarchia morale: onore/disonore, abiezione/dignità ecc.). Tutto si svolge tra superiori e inferiori.
L’eccezione è La figlia di Albione (13 agosto 1883).3 Il «maresciallo della nobiltà del distretto», Otcov, si reca in visita dal proprietario terriero Grjabov. Lo trova che pesca in riva al fiume insieme con «la figlia di Albione», la governante inglese. Segue un crescendo di schiamazzi e insulti del protagonista, Grjabov, «un uomo alto e grosso, con una testa enorme», contro l’inglese: «questa befana… questo pesce lesso… questa diavolessa… uno spaventapasseri… una zitella… baccalà che non è altro» ecc.
È che Grjabov si sente disprezzato dallo sguardo della governante («Guarda tutto con disprezzo… È superiore, lei, alla gente comune! Eh! Non ci considera neanche uomini!»); e quanto più si sente ed è disprezzato, tanto più si mostra disprezzabile, volgare. Come se la sua volgarità venisse chiamata dallo sguardo di lei.4
Ma da che cosa è caratterizzato questo sguardo che rivela la volgarità creandola, che la crea rivelandola, e che nello stesso tempo indica il suo opposto, il suo al di là, una dimensione “superiore”, “umana” («Sembra che dica: sono un essere umano e dunque il re della natura»: Grjabov sull’inglese)?5 Da immobilità, silenzio, incomprensibilità, alterità. Un vuoto contrapposto al pieno degli schiamazzi di Grjabov. Quasi un buco vuoto: «…mai che dicesse una parola! Sta immobile… non dice neanche una parola in russo!…». All’apice della scena, quando Grjabov si spoglia nudo per entrare in acqua a liberare l’amo «impigliato in qualche pietra», «Miss Tfajs, imperturbabile, cambiò l’esca, sbadigliò e gettò la canna».
Si può essere tentati di leggere in questo racconto una concatenazione di metafore. La governante inglese potrebbe essere: 1. lo scrittore silenzioso Čechov («i personaggi dei suoi racconti esprimevano a non finire commenti, giudizi, osservazioni, opinioni. Lo scrittore non esprimeva commenti. Non dava torto né ragione ad alcuno. Così era Čechov nei suoi primi racconti e così fu negli ultimi. Uno scrittore che non commentava mai» scrive N. Ginzburg nel «Profilo biografico» posto all’inizio della Vita attraverso le lettere. E Čechov stesso consiglia al fratello Aleksandr, nella lettera del 20 febbraio 1883: «Buttar se stessi a mare sempre e dovunque, non intrufolarsi nei protagonisti del proprio romanzo»); 2. lo sguardo, il raggio della letteratura, della scrittura, della parola, che rivela creando e crea rivelando, che fa essere reale ciò che altrimenti “si limita” a essere; 3. il terzo – muto, immobile, alieno – polo che s’insedia, nei racconti di Čechov successivi al 1886, di fronte alla dialettica tra irrealtà esteriore e irrealtà interiore in cui sembra essersi trasformata e scissa la dimensione sociomorale (sociale/morale) dei racconti precedenti.6
Un film: Prima della pioggia, di M. Manchevski, regista macedone (della Repubblica di Macedonia, ex Iugoslavia). È a “episodi” (almeno così si annuncia: ma si scoprirà che di episodi non si tratta, in nessun senso). I tre titoli da cui è diviso compaiono sullo schermo: prima il numero, con il suo punto, poi le parole. Una grafica nitida, pulita, che, in collaborazione con i titoli, introduce la presenza d’un autore. Cioè induce – e induce ad aspettarsi – meno un’illusione di realtà, “realismo”, e più apologo, racconto, discorso.
Sta per piovere. Padre Kirill, un adolescente che per un voto non parla da due anni, interrompe la raccolta dei pomodori e rientra nel monastero. Nella sua stanza trova, che si nasconde, una ragazza albanese: adolescente come lui, minuta, con i capelli tagliati corti e i pantaloni larghi alla turca; sembra un ragazzo. Un gruppo di macedoni armati entra nel monastero: la stanno cercando: la «puttana albanese» ha ucciso, dicono, uno dei loro. Il giovane padre Kirill non la tradisce.
Si insinua la scena d’un funerale: nella bara un uomo tra i quaranta e i cinquant’anni, robusto, con una grande barba. Staccata, in disparte dal gruppo delle donne che piangono, del pope che prega, una donna alta, esile, che il vestito e l’espressione fanno subito definire straniera, per loro (ma “dei nostri” per noi: si scoprirà che è inglese), si toglie gli occhiali scuri. «È pazzesco»: non dice altro.
Sono i monaci a scoprire la ragazza albanese insieme a padre Kirill nella sua stanza, e li scacciano dal monastero. Kirill, non più “padre”, ora può parlare: promette alla ragazza di portarla a Skopje, e poi a Londra, da un suo zio «fotografo famoso». Ma lui non parla e non capisce l’albanese, lei non parla e non capisce il macedone.
Per i campi, nel loro andare, incontrano il padre della ragazza, i suoi fratelli, amici, che le chiedono se ha compiuto il suo dovere, se l’ha ucciso. Il padre la prende a schiaffi: «T’ho tagliato i capelli, t’ho legata perché non uscissi di casa». E poi: «Chi è quello lì?», indicando Kirill. «Mi vuole bene.» Allora ordinano a Kirill di andarsene; lui raccoglie la sua roba, si volta, s’incammina. Ha già fatto una ventina di passi quando la ragazza lancia un grido e si mette a correre verso di lui. Suo fratello le spara. Le spara e poi grida «no!», e piange.
Il secondo episodio si svolge a Londra. C’è la titolare d’uno studio fotografico (la stessa donna in disparte al funerale del primo episodio). C’è un famoso fotografo macedone – ha vinto il premio Pulitzer – appena tornato dalla Bosnia (lo zio di cui Kirill ha parlato alla ragazza albanese). In studio la donna scorre fotografie di guerra: Bosnia, Croazia? Il fotografo la lascia: ha deciso di tornare al suo paese.
Ci torna, in Macedonia. Ritrova la sua casa, anche se cadente, i vecchi amici. Ma ad accoglierlo sulla collina, prima di arrivare in paese, è un ragazzo con un mitra. Lo riconosce – è il figlio d’un amico – e glielo strappa di mano come un coltello a un bambino.
Poi: vuole rivedere un’amica, un tempo forse amata: Hana, albanese. Gli amici gli consigliano di dimenticarla: suo padre, dicono, non potrà permetterle di frequentare uno, come lui, macedone. Tuttavia ci va: dei giovani di guardia al paese, o al quartiere, albanese lo fermano, gli fanno delle domande, poi lo lasciano passare. Vede il padre di Hana e vede Hana, in chador, entrare, salutarlo, servire il tè, uscire. Ma tornerà; andrà lei a trovarlo di notte a casa, per dirgli: «Tu non fai niente contro tutto ciò; aiutami».
Intanto, uno degli amici viene ucciso, forse da una ragazza albanese, che forse lui ha cercato di violentare. Gli altri si armano e vanno a cercarla. In casa, il fotografo tira fuori delle fotografie – un uomo che spara, un altro che muore – e le straccia. In Bosnia aveva detto a un soldato che non era ancora riuscito a scattare delle buone foto, non aveva ancora assistito a niente che valesse una foto. Allora il soldato aveva fatto uscire un prigioniero dalla fila: «scatta adesso», e gli aveva sparato.
Il fotografo esce e raggiunge l’ovile, in campagna, dove i suoi amici tengono prigioniera la ragazza albanese. Entra, la trova, la prende per mano e la porta fuori: è un’adolescente, minuta, con i capelli tagliati corti e i pantaloni larghi alla turca; sembra un ragazzo. Gli amici cercano di fermarlo: «Tu non capisci, da troppo tempo non vivi qui». «Smettetela; non vedete che è una ragazzina?» E s’allontana per i campi mentre uno degli amici gli grida: «Non farlo, guarda che ti sparo.» Il fotografo si volta: ha tra i quaranta e i cinquant’anni, è un uomo robusto, con una grande barba. «Spara» risponde. E l’amico spara, poi grida «no!» e si mette a piangere. Intanto la ragazza albanese scappa. La inseguono gridando: «Puttana albanese…» Sta per piovere. Padre Kirill, un adolescente che…
Il protagonista, l’eroe di questo film è un fotografo: uno sguardo. C’è qualcosa di cruciale – adesso è più chiaro – in cui Prima della pioggia di Manchevski e certi racconti di Čechov sono, nella distanza di tutto, molto vicini.
Nella distanza di tutto? 1. Se Čechov parla di crimini dell’“anima”, o morali, questo film parla del crimine che non ha bisogno di aggettivi: lo spargimento di sangue, l’assassinio; 2. il minimo che si possa dire dei racconti di Čechov – e che dice chiunque li abbia appena scorsi – è che sono “disillusi”, “disincantati”;7 questo film è disperato: la soluzione che il protagonista dà alla storia è la sua morte, che non la risolve, ma la fa iniziare (come i racconti di Čechov, tuttavia, anche questo film non è la storia che racconta; a farlo concorrono altri “personaggi” che sono decisivi “livelli del testo”: lo sguardo dell’autore, lo sguardo dello spettatore); 3. soprattutto, padre Kirill è “muto” come, nel racconto di Čechov, la governante inglese e, quando può parlare, lui e la ragazza albanese non si capiscono come non si capiscono “la figlia di Albione” e Grjabov: parlano lingue diverse (la maggior parte dei “personaggi positivi”, nel film, è “straniera”: l’inglese in disparte al funerale, il fotografo – «tu non capisci: da troppo tempo non vivi qui» – una donna, Hana…).
Radicalizzando: il male (e la mancanza di verità) stanno nella società, nel “commercio tra gli uomini”, nella dimensione in cui i corpi convivono e, anche, si guardano, si parlano, si toccano, ma che non è la dimensione dello sguardo, della parola, del tatto; anzi, la nega: corpi di ombre? Corpi di ombre: realtà “di tutti i giorni”.
La realtà, la verità, il bene – per Čechov, per Manchevski; per noi? – sono fuori dalla lingua comune, dalla società quindi? Portati dalla distanza dello sguardo – della governante inglese, di Čechov, del fotografo, dello spettatore – dall’impossibilità di capirsi? Ma portati lì, su quella riva di fiume, in quel paese macedone-albanese.
Perché, comunque, bisogna stare lì, nel “commercio tra gli uomini”, corpi tra i corpi. La ragione – si fa chiara, finalmente? – dell’insistenza di Čechov nel descrivere “le cose come stanno”, e insieme della pietà con la quale sempre si china al capezzale dei suoi personaggi (stupendamente notata da Cristina Campo8), è questa: l’amore per esse, (che è) la loro necessità.
Sviluppando un censimento, una topografia del campo morale e sociale, interiore ed esteriore, Čechov disegna i contorni d’una malattia, d’una irrealtà e, insieme, del campo, l’unico, il solo.9 E lo sguardo immobile, silenzioso, incomprensibile, “altro” di cui s’è parlato a proposito della Figlia di Albione, il suo vuoto, che indica una condizione superiore, umana – rispetto ai “corpi di ombre”, alla “realtà di tutti i giorni” – è anche davvero vuoto.
Se l’impossibilità di capirsi, nella irrealtà, nella falsità, nel male che segnano la lingua comune, la società, diventa “portatrice” di realtà, di verità, di bene, non ne è tuttavia il luogo, non è un luogo: è un’impossibilità di capirsi. Non si può vivere così, non si può sentire così: questo dice Čechov. Cioè: 1. la salvezza dal male sociale non è né nell’interiorità del sentire (e anche del pensare), malata anch’essa, né “altrove”, da dove provengono, anche se rivelatori, solo silenzio, vuoto, impossibilità; 2. è necessario vivere e sentire diversamente. Come? Čechov non lo dice perché sicuramente non lo sa, ma sa e mostra che è necessario, ed è necessario questo: non altro, non di meno. Ed è anche possibile, se è possibile vederlo: siamo tutti Čechov.
In alcuni dei suoi racconti più tardi, è chiarissimo. Prendiamo La saltabecca (1892).10 Qui la contrapposizione, dichiarata dall’inizio, è tra la professione di sognatrice, tra gli empiti “artistici” di Ol’ga Ivanovna (che «venerava le persone illustri, ne era orgogliosa e ogni notte le sognava»), e l’apparenza prosaica, dimessa di suo marito, il medico Osip Stepanyč Dymov, «un uomo semplice, comunissimo, senza niente di particolare».
Ol’ga è patetica: non c’è amico e conoscente di cui si circondi che non passi «per una celebrità»: «un attore di teatro… un cantante d’opera… poi alcuni artisti… poi un violoncellista che faceva piangere il suo strumento…». Quando mette su casa con Osip, ricopre le pareti «con schizzi suoi e altrui», dissemina le stanze di «una quantità di ombrellini cinesi, di cavalletti, di fronzoli variopinti, pugnali, buste, fotografie…».
E Osip? «Era medico e aveva il grado di consigliere titolare. Prestava servizio in due ospedali… Ogni mattina, dalle nove fino a mezzogiorno, riceveva i malati, e lavorava in corsia, dopo mezzogiorno andava in tram nell’altro ospedale… I guadagni con la clientela privata erano minimi… Ecco tutto. Cos’altro si poteva dire di lui?»
Qualcosa di lui, quando sta per morire, al termine del racconto, diranno i suoi amici: «“Che perdita per la scienza!… che uomo grande era, fuori del comune! Che talento! Che speranze dava a noi tutti!… uno di quegli scienziati che non si trovano più, oggi”… “Sì, un uomo raro!”»
Per Ol’ga è una rivelazione, ma una rivelazione di che cosa? «All’improvviso capì che era stato davvero un uomo fuori dell’ordinario, raro… veramente grande… capì che tutti loro vedevano in lui una futura celebrità.» Una “celebrità”! Anche qui, come in Dopo la pioggia di Manchevski, la soluzione della storia non la risolve, ma la fa come ricominciare: «Ognuno [degli amici e conoscenti di Ol’ga] passava per una celebrità… Lei venerava le persone illustri, ne era orgogliosa…».
E non è Osip a portare, in questa storia, verità. Anche lui, nella sua sottomissione, nel suo anonimato, nel suo convenzionalismo, è patetico: quando Ol’ga gli presenta il brillante Rjabovskij, sedicente artista, non trova di meglio che, «sorridendo con espressione ingenua e bonaria», tendergli la mano dicendo: «Molto lieto. Insieme a me si laureò un certo Rjabovskij; è forse un vostro parente?». E quando Ol’ga lo rimprovera di non interessarsi di arte, di musica, pittura, «non le capisco», risponde, «ma penso così: se certi uomini intelligenti dedicano a queste cose tutta la loro vita, e degli altri uomini intelligenti pagano per esse somme enormi, ciò significa che sono necessarie».
Ma il massimo del patetico Osip lo tocca quando raggiunge la moglie «nella villa in campagna». «Non la vedeva già da due settimane e ne aveva forte nostalgia. In treno, e poi tra quei grandi boschi, mentre cercava la sua villa, non l’aveva mai abbandonato una sensazione di fame e di stanchezza e sognava il momento in cui, in libertà, avrebbe cenato con la moglie e poi si sarebbe sdraiato a fare una buona dormita. E si rallegrava a guardare il suo cartoccio, nel quale c’erano caviale, formaggio e salmone.»
Arrivato alla villa, invece di sua moglie vi trova «tre uomini che non conosceva»: uno, che «sembrava un attore», guardandolo «in cagnesco» gli chiede: «Cosa volete?»; un altro lo fissa «con aria assonnata e indolente». Quando finalmente Ol’ga ritorna, gli dice di avere dimenticato a Mosca un indispensabile «vestito rosa». Bisogna che Osip vada a prenderglielo. «“Bene”, disse Dymov, “domani mattina prenderò il treno e tornerò subito”. “Come, domani?… Come farai a tempo, domani?… No, tesoro mio, è necessario che tu parta oggi, oggi assolutamente… vai…, il diretto dovrebbe essere qui a momenti.” “Bene.”» «Dymov bevve in fretta un bicchiere di tè, prese una ciambella e, sorridendo dolcemente, si avviò verso la stazione. E il caviale, il formaggio e il salmone furono mangiati dai due giovanotti bruni e dall’attore grasso.»
Se Čechov, in questo racconto, mette in rilievo il “non” – la non verità, la non realtà – da cui è costituita Ol’ga, non è per contrapporle, non le contrappone, in Osip, realtà, verità, bene. Non ci sono, qui, “eroi” di cui si possa dire: ecco, è questo. Non è questo, invece, si dice, e non è quello. Non è Ol’ga, non è Osip. Sono alla pari. Il mondo di superiori e inferiori dei primi racconti è, ora, un mondo di fratelli nel male. E nel possibile bene. Non si tratta più di servilismo, si tratta di conformismo.
Ol’ga recita una propria parte. Succede che intrecci una relazione amorosa con Rjabovskij, e: «Una volta disse a Rjabovskij, a proposito del marito: “Quell’uomo mi opprime con la sua grandezza d’animo!” Questa frase le era piaciuta tanto che, incontrando i pittori che sapevano del suo romanzo con Rjabovskij, ogni volta diceva del marito, facendo un gesto energico con la mano: “Quell’uomo mi opprime con la sua grandezza d’animo!”».
Ma anche Osip ha un suo copione. Poche righe dopo averci parlato della frase che a Ol’ga «era piaciuta tanto» (e «ogni volta diceva…»), Čechov racconta che ai «piccoli ricevimenti» di ogni mercoledì a casa sua: «Invariabilmente, mezz’ora prima della mezzanotte, si apriva la porta che dava nella sala da pranzo», e Osip, come un anno prima, con le stesse parole, «sorridendo, diceva: “Prego, signori, a fare uno spuntino.”».
Perché Ol’ga e Osip recitano una parte, un copione? E in che cosa consiste il loro conformismo? Proprio in questo, forse: nel recitare una parte, un copione. Cioè: nel fare propria interiormente ed esteriormente, nei loro pensieri, sentimenti, emozioni come nelle loro parole e nei loro gesti, un’irrealtà, una teatralità che li trascende. Che è anche una forma di vita di e per tutti. A essa si conformano ed è essa che li conforma.
Ma allora, paradossalmente, non possono più apparire soltanto patetici; e infatti non muovono a un compatimento leggero, a un facile sorriso, a un’alzata di spalle, bensì a una pietà profonda. Perché sono anche figure di verità e di amore. Rappresentanti d’una vita irreale, teatrale, sì, ma che è quella di tutti, quindi l’unica vera. E verso la quale si può essere spinti anche dal desiderio, d’amore, di essere come e con gli altri. In un conformismo, in una forma comune. Per questo, forse, Čechov «non dava torto né ragione ad alcuno» dei suoi personaggi, come scriveva Natalia Ginzburg: perché avevano tutti torto e ragione insieme. Per questo «non esprimeva commenti»: perché di fronte alla loro condizione umana era rimasto senza parole («noi rappresentiamo la vita com’è, punto e basta…»). Qui stanno il paradosso e la tragedia. Ancora nostri.
Ma allora un’affermazione da cui si è partiti, quasi fosse scontata, quella secondo cui Čechov avrebbe sviluppato un censimento, una topografia «di quello che nell’uomo è stato chiamato “spirito”, “anima”», va ormai – è già stata – radicalmente corretta o precisata. Non si tratta di questo. Non si tratta delle profondità dell’io come, parlando di vita “esteriore”, non si tratta dei tentacoli delle convenzioni.
Le due figure proteiformi e contrapposte i cui contorni ci sono così familiari – l’individuo e la società, l’interno e l’esterno, il soggetto e l’oggetto e così via – hanno contribuito a lasciare nell’indistinzione, senza un nome, mentre esse ce l’hanno, un’altra dimensione. Una forma. Quella che risponde alla domanda: chi, che cosa siamo? Di essa parla Čechov dicendo: siamo questo: Ol’ga, Dymov.
O meglio, o anzi: è lo sguardo di Čechov – e il nostro – che, Ol’ga e Dymov, li consente e insieme li confuta, offre loro un teatro e, per ciò stesso, li rende solo degli attori. Senza Čechov e il lettore, essi, è ovvio, non esisterebbero, ma, nello stesso tempo, non sarebbero questo. Come senza lo sguardo di Manchevski, del fotografo macedone – e dello spettatore – il “teatro di guerra” albanese-macedone non sarebbe un teatro. Sarebbe “solo” una guerra, senza scampo.
Eppure questo sguardo non è il classico punto di vista esterno che, fuori del gioco, solo può svelarlo. Nel mondo della fine della trascendenza – quello di Čechov, il nostro – nel mondo dei pari e del conformismo, a differenza che in quello di inferiori e superiori e del servilismo, un punto di vista esterno non ha cittadinanza.
Che cos’è allora questo sguardo? Lo sguardo di chiunque sempre altro per chiunque. Se tutto il mondo, tutta la vita sono divenuti un teatro – una dimensione, come s’è detto, in cui i corpi si guardano, si parlano, si toccano, ma che non è la dimensione dello sguardo, della parola, del tatto – siamo tutti sempre attori, e siamo tutti sempre spettatori. Dei chiunque sempre altri per chiunque. Degli sguardi sempre altri per chiunque.
Ed è in questa alterità insieme attiva e passiva, in questo incrociarsi di sguardi che inverano e confutano, che l’altra dimensione, la forma né interiore né esteriore, e interiore ed esteriore ad un tempo, cui s’è accennato, viene presa. «Riconosciamo loro [agli altri]», scrive Merleau-Ponty, «il potere esorbitante di vederci».11
È davvero questo allora, questo sguardo di chiunque sempre altro per chiunque, il “terzo polo” di cui s’è parlato all’inizio: quello che s’insedia nei racconti di Čechov tra irrealtà esteriore e irrealtà interiore. Di cui la “figlia di Albione” non è che intuizione e figura. E anch’esso, come quest’ultimo, è alieno, e pure letteralmente tra noi, qui.
È il nostro altrui sguardo sempre già anche di spettatori, narratori, registi, fotografi; che percorrendo le superfici dei nostri altrui corpi li salva dall’essere soltanto “io”, li confuta, nello stesso spazio, nello stesso tempo, nello stesso atto in cui li testimonia, li invera. Uno sguardo che insieme è già, ed è ancora e anche un compito. In questo doppio senso, di constatazione e di invito: siamo tutti Čechov.
Note
1 A.P. Čechov, Racconti, I, Milano, Garzanti, 1988, pp. 1-76; le date, qui come oltre, sono quelle della prima pubblicazione.
2 «… un intreccio e la dovuta denuncia del costume»: da una lettera a N.A. Lejkin, 18 aprile 1883, in A.P. Čechov, Vita attraverso le lettere, a cura di N. Ginzburg, trad. di G. Venturi e C. Coïsson, Torino, Einaudi, 1989, p. 12.
3 A.P. Čechov, Racconti, cit., pp. 4-7 (trad. di S. Vitale).
4 «Se tu avessi invece descritto» rimprovera/consiglia Čechov al fratello Aleksandr in una lettera del 20 febbraio 1883 (Vita attraverso le lettere, cit., p. 6), «com’era volgare il tuo protagonista…».
5 «Sottolinea ciò che è vitale, ciò che è eterno, ciò che agisce non sul sentimento meschino, ma sul vero sentimento umano» consiglia Čechov al fratello nella stessa lettera citata alla nota precedente.
6 È una tentazione, una lettura legittima? «Scrivendo, mi studiavo in tutti i modi di non esaurire nel racconto le immagini e le scene che mi erano care e che, Dio sa perché, custodivo e tenevo gelosamente nascoste» scrive Čechov il 28 marzo 1886 al celebre (allora) scrittore D.V. Grigorovič in una lettera in cui afferma (credibilmente o no) di considerare per la prima volta il suo lavoro come letteratura. Non è escluso che qualcosa che gli era caro fosse custodito e tenuto gelosamente nascosto nei racconti stessi.
7 «Gli scrittori che noi diciamo immortali o semplicemente buoni e che ci inebriano tanto hanno, ricordatevelo, un contrassegno comune e assai importante: essi procedono in una data direzione e v’invitano a seguirli, e voi sentite non con la mente ma con tutto l’essere che hanno uno scopo… I migliori fra di loro sono realisti e ritraggono la vita com’è, ma per il fatto che ogni loro riga è impregnata, come da un succo, dalla consapevolezza dello scopo, voi, oltre a sentire la vita com’è, la sentite anche come dovrebbe essere, ed è questo che vi avvince. E noi?! Noi rappresentiamo la vita com’è, punto e basta… Più in là non ci farete andare, nemmeno con la frusta. Non abbiamo scopi né immediati né lontani, e nella nostra anima c’è il vuoto assoluto. Non abbiamo concezione politica, non crediamo nella rivoluzione, non abbiamo un Dio, non temiamo i fantasmi e, quanto a me, non temo neppure la morte e la cecità… Voi e Grigorovič trovate ch’io sono intelligente. Sì, sono intelligente, lo sono per lo meno tanto da non dissimulare a me stesso la mia malattia, da non mentire a me stesso e nascondere il mio vuoto sotto gli stracci altrui.» Da una lettera di Čechov a A.S. Suvorin, 25 novembre 1892 (ibid., pp. 145-146).
8 «L’incomparabile simpatia umana di Čechov, ciò che ne rende così amabile e consolatrice l’apparizione è veramente la simpatia del medico: di colui che… siede al capezzale di ognuno e vi rimane. Egli porta con sé il solo farmaco vero: lo sguardo inconfondibile di chi è pronto a vegliare con noi… di chi ha imparato a ricordare di continuo, a sé e agli altri, quel che possa valere il dolore quando lo raccolga lo specchio di un amore senz’ombre» (C. Campo, Gli imperdonabili, Milano, Adelphi, 1987, p. 197).
9 Della «cité d’ici-bas», della «comune condizione umana», come scrive Cristina Campo (ibid., p. 195), che aggiunge: «Lo sguardo che avvolge questo mondo e ne ricompone dall’alto i significati dispersi […] è il muro di cinta della città di Čechov».
10 A.P. Čechov, Racconti, cit., pp. 612-638 (trad. di L. Celani).
11 Senso e non senso, Milano, Il Saggiatore, 1962, p. 56. Il corsivo è di