testo e fotografie di Danilo De Marco
Scelgo un passo terribile da La guerra del Peloponneso di Tucidide. Nel 416 gli abitanti dell’isola di Melo, alleati di Sparta, si ribellarono agli ateniesi:
testo e fotografie di Danilo De Marco
Scelgo un passo terribile da La guerra del Peloponneso di Tucidide. Nel 416 gli abitanti dell’isola di Melo, alleati di Sparta, si ribellarono agli ateniesi:
 di Francesca Fiorletta
di Francesca Fiorletta
Ti svegli per partire, vuoi continuare a dormire, decidi di non fare proprio niente.
Ti prepari per lavorare, rimanda quell’appuntamento, ti alzi di corsa dal letto e non capisci dove sei.
Asciuga gli occhi senza un senso, si lacera l’abbraccio, quel sogno fatto all’alba l’hai già dimenticato.
Traduci piano l’abc, i bugiardini elettrici, la luce sul display sbarra il supermercato del futuro.
C’è tanta strada davanti, le teche di vetro ancora vuote, fai lunghe code alla toilette, un grissino come piccolo sostegno.
Fingere il suono delle api.
(Il testo compare come Nota all’edizione nel sito www.princesa20.it)
“Qualcosa abbiamo già nello scaffale. Un giorno li ricorderemo come piccoli classici della letteratura immigrata”: così iniziava l’articolo pubblicato in controcopertina sul primo fascicolo della rivista “Caffè. Per una letteratura multiculturale”, nel settembre del 1994. Tra i “cinque o sei libri” cui si alludeva, Princesa, vent’anni dopo, non ha finito di dire quel che aveva da dire; se ciò non basta a farne un classico a tutti gli effetti [1] giustifica però la previsione formulata in quell’occasione. In altre parole, sembra giunto il momento di istruire ed avviare il processo di canonizzazione per un’opera che, inizialmente, sembrava dover esaurire il proprio raggio di azione e ricezione entro i ristretti ma mobili confini delle cosiddette “scritture migranti”. Se, nel frattempo, quelle scritture hanno compiuto la maggiore età, [2] il libro di Fernanda Farias de Albuquerque e Maurizio Iannelli ha incontrato lettori ben oltre la cerchia degli addetti ai lavori [3] e, in particolare, ha contribuito a creare l’habitat idoneo al fiorire attuale dei “nuovi realismi italiani” [4]. Ha affermato recentemente Bruno Racine, direttore della Bibliothèque Nationale Française, a proposito delle 120 giornate di Sodoma – un classico che, al pari di Princesa, intra–vide la luce in carcere: “È senz’altro un testo atroce e radicale ma bisogna riconoscerne il valore storico e culturale”, tale da costituire “patrimonio nazionale” [5]. Del resto, era stato Michel Foucault a portare ad esempio proprio la figura del marchese de Sade, nelle celebri pagine dedicate alla questione Che cos’è un autore:
Se un individuo non fosse un autore potremmo dire che ciò che egli ha scritto o detto, ciò che egli ha lasciato fra le sue carte, ciò che è stato riportato dai suoi commenti potrebbe essere chiamata un’ opera? Finché Sade non è stato un autore che cos’erano le sue carte? Solo dei rotoli di carta sui quali, all’infinito, durante le sue giornate in carcere, egli elaborava i suoi fantasmi [6]
Maurizio Iannelli è oggi certamente un autore, premiato e riconosciuto per alcune serie di docufiction televisiva costruite intrecciando vita reale, documenti processuali, cronaca nera e finzione narrativa. [7] Quando riordinava, trascriveva e rielaborava, nel carcere romano di Rebibbia, i manoscritti di Fernanda, tuttavia, era consapevole di maneggiare un materiale grezzo cui forniva, oltre ad una veste linguistica apparentemente standard, lo scheletro diegetico atto a sostenerne la forma editoriale. Non per questo avrebbe sottoscritto le parole di Cesare Lombroso, prefatore dei Palimsesti del carcere:
Se, nel fingere il linguaggio dei demoni, il Poeta non poté non esprimersi in versi sudici, a me, ch’ero il paleografo, il trascrittore dei pensieri di questa specie di demoni terrestri, non era certo dato far meglio [8]
La relazione coautoriale, infatti, era fondata sulla condivisione dello stato di detenzione e sulla consapevolezza di un’affinità che, al di là delle apparenze, univa la condizione esistenziale di un detenuto politico in “piena crisi d’identità” con quella transessuale di un criminale comune. Prima ancora del diritto all’autorialità, perciò, Iannelli riconosceva all’estensore di quei manoscritti il diritto alla biografia. “Non tutti gli individui che vivono in una determinata società hanno diritto ad una biografia. Ogni tipo di cultura elabora i suoi modelli di uomini senza biografia” [9], ce lo ha insegnato Jurij Michailovič Lotman il quale ci fornisce pure una minima tipologia delle relazioni tra testo e contesto che, di volta in volta, nei vari frangenti storico-culturali, decidono dell’artisticità di un’opera letteraria. Si dà, per esempio, il caso di uno scrittore che “non crea il testo come opera d’arte ma il lettore lo recepisce come opera d’arte”: qual è la posizione del lettore di Princesa, venti anni dopo, rispetto all’avantesto che finalmente viene reso disponibile nell’archivio del sito [10]? Posto che “il quadro offerto dalla storia della letteratura ai diversi stadi del suo sviluppo è considerevolmente più complicato” [11] dello schema elementare cui ci si richiama, si potrebbe qui ipotizzare un caso di “artisticità retroattiva” poiché è evidente – a scorrere appunti, interviste, pagine di diario, trascrizioni di favole nordestine, anamnesi oniriche, schizzi di mappe prodotti da Farias de Albuquerque in un biennio di pratica scrittoria coatta – che l’aura di letterarietà acquisita dal racconto della vita di Fernandinho / Fernanda / Princesa nei due decenni della sua storia editoriale [12] riverbera oggi sui manoscritti accumulati in carcere.
*
Sia detto però fin da ora che l’eccezionalità di un’eventuale inclusione di Princesa nel canone della nostra letteratura – quella che un tempo si definiva italiana, nazionale e che oggi, nel contesto dei processi di globalizzazione culturale, è talvolta detta italòfona – è più apparente che reale, se ci si riferisce alle peculiari caratteristiche genetiche dell’opera. Raccontare le proprie esperienze “migratorie” ad un compagno di prigionia che le trascrive in un altro codice linguistico (letterariamente codificato), in cui filtrano però dall’oralità alcuni dialettismi, prima che quel racconto vada incontro a nuove versioni, riscritture e riduzioni, è precisamente ciò che fece Marco, alla fine del Duecento in un carcere genovese, al cospetto di Rustichello da Pisa, compagno di sventura. Ne sortì Le divisament dou monde, ovvero la redazione in lingua d’oïl del libro che, in versione toscana, è meglio noto come il Milione di Marco Polo, classico della letteratura nazionale.
*
Quanti hanno riflettuto sull’antica e nobile tradizione della “letteratura carceraria”, provando in qualche caso ad estrarre le invarianti di un “genere” che, da Cervantes a Mandel’stam, annovera alcuni tra i maggiori scrittori di tutti tempi, concordano sulla ragione primaria che conduce alla scrittura nelle istituzioni “complete e austere”, come le definiva L.P. Baltard nel 1829, o “totali”, secondo la più recente definizione foucaultiana: “far sopravvivere la propria integrità, in tutti i sensi”. [13] Era questo il progetto alla base dei laboratori di scrittura organizzati a Rebibbia, da cui prese le mosse l’attività editoriale di Sensibili alle foglie, e lo stesso Giovanni Tamponi, che per primo esortò Fernanda a mettere nero su bianco i propri ricordi, aveva autonomamente sperimentato e propagandava le potenzialità terapeutiche di una tale pratica. Iannelli che quelle carte contribuì a suscitare, raccolse e manipolò, ultimo arrivato nel trio di “funamboli” [14] della scrittura a Rebibbia, riuscì a neutralizzare l’“individualizzazione coercitiva” che fonda l’istituzione carceraria [15] – aggirata dai primi due grazie ai benefici di mobilità derivanti dalle mansioni svolte tra i reparti – in modi talvolta rocamboleschi (per esempio comunicando attraverso la grata che dava sul passeggio dei transessuali, limitrofo alla cappella della casa di reclusione). Insomma, come è stato notato, “Voler raccontare tutta la storia è un’altra forte motivazione per lo scrittore imprigionato”, ciò che non inficia la riuscita dell’opera dal momento che “l’autenticità della voce del narratore contribuisce alla buona qualità della letteratura”. [16] Ma al di là dell’attendibilità di una voce che, nel caso di Princesa, si dimostra essere la risultante di una miscela polifonica (quando non di un atto di vero e proprio ventriloquismo), ciò che di autentico si sperimenta in condizioni di restrizione coatta è innanzitutto “il modo in cui i rapporti di potere possano passare materialmente nello spessore stesso dei corpi senza che neanche debbano essere trasformati nella rappresentazione dei soggetti”. [17] In una storia di vita transessuale come quella di Princesa aleggia minacciosa, ben al di là dei pur frequenti ed espliciti episodi di violenza privata e di repressione poliziesca, la sovradeterminazione biopolitica di ogni scelta di genere. Se la sessualità è coestensiva al potere – Foucault afferma e Judith Butler conferma [18] – sono proprio gli individui in transizione intersessuale, oltre ogni retorica di liberazione, a pagare il prezzo più alto:
En réalité, il en va des catégories qui organisent notre monde, soit de l’ordre sexuel et de sa violence, tant symbolique que physique, dont les personnes intersexes sont le révélateur en même temps que l’emblème [19].
Da questo punto di vista non cessa di stupire, per il grado di consapevolezza politica implicata, il corto circuito che connette, nell’intervista rilasciata da Farias e Iannelli per il citato primo fascicolo del “Caffè”, condizione transessuale e condizione postcoloniale o migrante [20]:
Come che è una scrittura bella, chi lo leggerà [Princesa] troverà un po’ di sentimento perché è una storia di realtà, una storia di vita transessuale ma anche di vita con tutta l’esperienza al mondo maschile, il fatto di come vive un transessuale in mezzo alla società, per affrontare le varie conseguenze che esistono […] con il problema che accade ai confronti di queste persone che sarebbe le persone del terzo sesso, o persone del terzo, diciamo, mondo [21].
*
Il bello della scrittura in Princesa, appunto. Chi ha analizzato il libro fin qui ha più spesso parlato di tradimento, da parte del coautore italiano, rispetto alla ricchezza non omologabile dell’impasto linguistico originario, del resto pressoché sconosciuto ai più, se non per un paio di brevi stralci pubblicati nel ‘94. Si è detto della standardizzazione imposta da un editing invasivo, della medietà di un dettato depurato da scorie dialettali o allofone. Per descrivere una lingua così – disanimata, ossificata – si potrebbe utilmente recuperare il giudizio espresso da Leonardo Sciascia nella relazione di minoranza alla commissione parlamentare d’inchiesta sulla strage di Via Fani:
Gli esperti sono stati invece adibiti a studiare il linguaggio delle Brigate Rosse: e non c’era bisogno di esperti per scoprirlo poveramente pietrificato, fatto di slogan, di idées reçues dalla palingenetica rivoluzionaria, di detriti di manuali sociologici e guerriglieri […] L’italiano delle Brigate rosse è semplicemente, lapalissianamente, l’italiano delle Brigate rosse. [22]
oppure quello, analogo, rilasciato in occasione di un incontro del 1978 con i militanti di Lotta continua: “Ma a me sembra una cosa proprio ossificata, senza vita, disanimata, una specie di burocrazia del fanatismo. Questo loro amore per le sigle…” [23]. Allo stesso Iannelli, del resto, come ad alcuni leader storici dell’organizzazione terroristica, quel linguaggio era destinato ad apparire, col senno di poi, indigeribile:
Già allora [sequestro Moro] quel linguaggio mi appariva tremendo. Rileggendoli a posteriori, mi sono chiesto non tanto come avevamo fatto a scriverli [i comunicati] – non li rinnego, un senso lo avevano, eccome… Certo non ne ho conosciuto uno, di compagno, che sia entrato nelle Br perché conquistato dalla lettura di una Risoluzione strategica. [24]
Per questa ragione Sciascia indovinava, tra le fila dei brigatisti, una scarsissima confidenza col romanzesco: “Quelli che hanno scritto quei comunicati sono sicuramente gente che non ha mai letto un romanzo…”, al punto da “condannarli” per contrappasso ad un severo apprendistato letterario: “Che romanzi consiglieresti alle Br? Per contrasto un po’ di Proust andrebbe bene. Ma certo se leggessero un po’ di Voltaire e un po’ di Diderot, non sarebbe male… Poi anche il Vangelo” [25]. Prende forma qui, tra l’altro, un’imprevista ma suggestiva analogia: ne Il bacio della donna ragno, fortunato romanzo dell’argentino Manuel Puig (pubblicato nel 1976 e prontamente tradotto in Italia nel 1978), all’immaginario hollywoodiano e mélo grazie al quale l’omosessuale Molina riesce a dimenticare la dura realtà della detenzione, il compagno di cella Valentìn, guerrigliero incarcerato per motivi politici, oppone gli slogan del materialismo dialettico – “I miei ideali… Il marxismo, se vuoi che ti definisca tutto con una parola” – al punto da provocare questa reazione stizzita:
non gli racconterò neanche più una parola delle cose che mi piacciono, se la rida pure che io sono uno smidollato, vedremo se lui non molla proprio mai, non gli racconterò più nessun film di quelli che mi piacciono, me li tengo per me, nel mio ricordo, che non me li rovinino con parole sporche, ‘sto figlio di puttana e la sua porca merda di rivoluzione. [26]
Ma l’incontro tra Farias e Iannelli non è letteratura; la vita, per dirla con Zeno Cosini, “non è brutta né bella, ma è originale!” e forse per questo le cose a Rebibbia sono andate diversamente. Alla fine, proprio colui che era sospettato di non aver mai letto romanzi ne ha scritto uno. Bisogna, insomma, riaprire il caso Princesa, proprio a partire da quella scrittura che alla protagonista del racconto era parsa bella.
Tanto per cominciare, la “nuova lingua”, inaugurata nel libro del 1994, risulta dalla chimica di tre lingue materne. Il portoghese, l’italiano e il sardo [27], e il coautore non esclude che “mani e provenienze culturali diverse [siano] forse rintracciabili anche nella sua stesura ultima.” Se il libro deriva da un brogliaccio cui non si fatica ad attribuire le peculiarità dell’art brut, insieme autentica e unadorned (ma già disposto in fabula da Iannelli, in quella “copia iniziale di lavoro conforme all’originale manoscritto” che porta il sottotitolo “Sono venuta di molto lontano”), almeno una traccia della stesura originale di Farias è rimasta nel Glossario stampato in appendice al volume edito da Sensibili alle foglie. Burití, caatinga, caboclo, cajù, urutu: vale la pena di notare che le cinque voci elencate erano già presenti nel glossario che Edoardo Bizzarri allegava alla sua traduzione del Grande Sertão di João Guimarães Rosa (la traduzione è del 1970 mentre il romanzo risale al 1956) e che si tratta di definizioni relative ad aspetti naturali del territorio nordestino. Nel fitto epistolario che lo scrittore brasiliano intrecciò con Bizzarri [28] si legge dell’imbarazzo per quanto di “esotico” transita nella versione italiana e resiste tuttavia alla traduzione: “Quel che deve aumentare i grattacapi del traduttore è che la parte concreta è esotica e mal conosciuta” [29]. È stato lo stesso Iannelli ad indicare nel fluviale racconto di Guimarães Rosa – che narra della storia d’amicizia e d’amore tra Riobaldo, un guerrigliero jagunço [30] e il suo compagno Diadorim che, caduto in battaglia, rivelerà la sua natura femminile – una fonte preziosa per il suo primo ed unico libro. [31] Inoltre, la figura dello jagunço o cangaço era ben presente alla stessa Fernanda che, richiesta da Maurizio, ne offre una definizione nell’intervista sul Carnevale (la trascrizione che segue è incompleta a causa delle sottolineature accumulate da Iannelli in questa zona del testo): “M – Invece gli uomini come erano vestiti? F – Gli uomini si vestivano come cangaçeiros […] M – Ah, il cangaçeiro è una specie di bandito-rivoluzionario. F – Sono [illeggibile] dei banditi che combatevano contro la polisia” [32]. L’influenza del capolavoro di Guimarães Rosa è riconosciuta però limitatamente all’acquisizione dell’immaginario legato al folklore nordestino e, in particolare, alle leggende connesse col fantastico e demoniaco paesaggio della caatinga. Non sorprende perciò riconoscere in Princesa la traccia di detti popolari, come il seguente, letteralmente estratto dal romanzo: “Ragazzini-roba del diavolo” (Princesa); “Non c’è forse il detto: ragazzino – roba del diavolo?” (Grande Sertão ). Il riferimento al vitello che compare in uno dei primi paragrafi di Princesa, inoltre, variando riecheggia l’incipit del Grande Sertão. Il romanzo del ’56 si apre infatti all’insegna di un bestiario – “un vitello bianco, erratico, gli occhi che manco un cristiano – che era apparso; e con faccia di cane” – che ricorre nei giochi d’infanzia di Fernandinho ed assume, nella trascrizione di Iannelli, coloriture diaboliche estranee all’originale manoscritto:
Io ero la vacca. Genir il toro, Ivanildo il vitello. Camicette e pantaloncini sfilavano via in mezzo al bosco. Lontano da tutti, era il segreto. Genir muggiva e m’inseguiva. Una fantasia di spinte, toccamenti e fiato grosso. Montava la vacca, indiavolava sopra di me.
A chi scrive, tuttavia, il debito contratto da Iannelli con l’ipotesto brasiliano pare investire anche il versante stilistico, della scrittura. A tratti, sembra quasi che l’italiano abbia introiettato il metro sul quale si dispiega la saga latinoamericana, quel procedere per densi fiotti estratti dal parlato e come rigurgitati. Così la prosa del brasiliano nella traduzione di Bizzarri: “Faccia di gente, faccia di cane: decisero – era il demonio”. “C’erano tutti, e con loro la mia diffamazione: Signor Diaz, ha visto Fernandinho! Cammina come una femmina! Rildo vociava come un forsennato”; “È pericoloso andare solo per il bosco, c’è il gatto selvatico, il serpente! Povero Francisco, la sua ingenuità”; “Lui abbassa il finestrino, lei entra tutta spalle e natiche in esposizione. Lui si accorge e urla di spavento: Vattene, mostro”; “Mi confondo nella folla. Sono tuttapposto e passo liscia, presente e invisibile nella distrazione della gente: una donna”: così quella dell’italiano, che dissemina il testo di tessere prosodicamente calcate sulla traduzione del prototipo nordestino. Oltre l’apparenza di una superficie linguistica livellata sugli standard veicolari di un italiano ipermedio, perciò, la scrittura di Iannelli nasconde un doppio fondo. Quella “nuova lingua” è il risultato di negoziazioni condotte a vari livelli, dalla reale consistenza del parlato, attraverso una normalizzazione della meccanica comunicativa (che può conservare memoria di usi linguistici legati alla trascorsa militanza politica), alla frequentazione di un modello letterario di seconda mano. Una lingua costruita per dare conto di vicende intimamente connesse coi contemporanei processi di globalizzazione e che trova il proprio modello nella traduzione di un idioma postcoloniale. Scrive Giuliana Benvenuti: “la traduzione è il luogo privilegiato della mediazione e della negoziazione e la sua funzione interseca questioni legate al genere, alle migrazioni, all’informatizzazione e alla biopolitica” [33]. In questo senso, l’operazione di Iannelli va ripensata nel quadro dei processi di denaturalizzazione dei legami tra lingua, cultura, nazione e cittadinanza in atto in epoca globale. Era, del resto, lo stesso Guimarães Rosa il primo ad esserne consapevole e a rivendicare per sé l’utilizzo di un codice letterario come lingua seconda:
Quando scrivo un libro, mi comporto come se lo stessi ‘traducendo’ da un altro originale, esistente altrove, nel mondo astrale o sul piano delle idee, degli archetipi, per così dire. Non so mai se sto riuscendo o fallendo in questa ‘traduzione’. Perciò, quando mi ‘ri-traducono’ in un altro idioma, non so mai, in caso di divergenze, se non è stato il traduttore che di fatto ha azzeccato, ristabilendo la verità dell’originale ideale che io avevo distorto [34].
Quel registro traduttese sul quale è giocata la prosa di Princesa, perciò, denuncia innanzitutto una relazione non lineare del coautore con la propria lingua nel momento in cui questa è chiamata a farsi carico di esperienze, biografiche e culturali, non autoctone, di migrazione, in una parola: postcoloniali.
*
Edoardo Albinati col suo Maggio selvaggio. Un anno di scuola in galera (Mondadori, 1999) sta di diritto, insieme a Walter Siti, Edoardo Affinati, Antonio Franchini e altri, nel canone degli autori cui si attribuisce la paternità dei “nuovi realismi italiani”, quella galassia narrativa intorno alla quale il dibattito è stato inaugurato sulle pagine della rivista “Allegoria” [35]. Il diario di Albinati contiene un appunto, datato fine estate 1998, che funge da cavallo di Troia per il trasferimento di Princesa dentro la nuova temperie. Si tratta di un episodio nel quale l’insegnante riveste il ruolo di mero spettatore, al punto di dover chiedere lumi ad un detenuto circa l’identità di un personaggio osservato al passeggio. Questa pagina, che contribuisce a focalizzare la presenza transessuale in carcere, registra pure la fortuna cinematografica del carcere romano, a testimonianza di un “ritorno al reale” che non investiva, alla fine del primo millennio, la letteratura soltanto:
In questa fine estate infuriano le polemiche riguardanti il carcere, soprattutto Rebibbia, a leggere il giornale pare che la metà dei film presentati al festival di Venezia siano stati girati lì – come dice la canzone, “apposta per scandalizzare”. Ammetto di essere infastidito e preoccupato di questa spettacolarizzazione permanente, un paiolo di frasi fatte in cui il giornalismo rimesta stancamente la sua lunga pertica. […] A quello girato da Fioravanti & Co. si aggiunge un documentario su un trans brasiliano, Princesa, ricordo il giorno che a Rebibbia la riprendevano in pose molto glamour, piantata in mezzo al piazzale, tutti gli occhi puntati addosso a lei, aveva un culo magnetico e somigliava, non a Sonia Braga come dicono sul giornale, bensì a Florinda Bolkan (giustamente me lo fece notare Croccolo seduto accanto a me), una Bolkan pompata e assai più donna dell’originale, mito androgino dei film morbosi di quando stavo alle elementari, Metti, una sera a cena ecc. Ricordo che ero seduto sugli scalini insieme a un gruppetto guardando, con un lieve sorriso sulle labbra, la scena, il set fotografico […] sicché mi permisi di chiedere all’orecchio del vecchio Croccolo chi fosse quella fata, e lui che conosce i peccati del mondo mi raccontò la storia di Princesa, cominciando così: “A lei ruppero il culo che teneva solo sei anni…”
L’autore non pare consapevole dell’esistenza del libro dedicato alla Princesa ripresa al passeggio, o almeno sceglie di non dar peso alla cosa, nonostante l’omonima canzone di De André e Fossati avesse nel frattempo dato vasta popolarità al personaggio, né poteva conoscere regista e titolo del documentario delle cui riprese si era trovato ad essere involontario testimone: Le strade di Princesa di Stefano Consiglio (1997).
Uno dei modi narrativi in uso in molti esemplari riconducibili alla recente voga reali(ty)sta [36] è quello dell’autofiction, col quale elementi autobiografici vengono liberamente immessi in un tessuto di invenzione romanzesca, talvolta su uno sfondo ostentatamente cronachistico, nel quale è dato riconoscere luoghi, vicende e personaggi reali, anche grazie all’uso di documenti (carte processuali, pagine di diario ecc.). Ebbene, con qualche anticipo sulla manifestazione della nuova tendenza a livello di mainstream editoriale, procedimenti non dissimili erano in opera nell’ambito delle scritture migranti, in particolare quando, nella prima metà degli anni Novanta, si rendeva ancora necessaria la collaborazione di un coautore italiano.
In libri come Princesa, appunto, o Immigrato di Mario Fortunato e Salah Methnani la proiezione autobiografica sulla narrazione risulta, se possibile, più complessa ancorché non sempre consapevole, derivando da ben due biografie spesso inopinatamente miscelate. Così Mario Fortunato nella premessa alla riedizione del 2006:
Lui raccontava, io facevo domande. Qualche volta prendevo appunti. Quasi mai abbiamo usato il registratore. La storia che si dipanava aveva per me un valore innanzitutto romanzesco, narrativo Per me si trattava di un romanzo il cui contenuto aveva realmente avuto luogo […] In un secondo momento me ne andai da solo in Calabria […] In quattro settimane di lavoro ininterrotto, il testo era scritto. Lo avevo scritto come si trattasse di una storia interamente mia […] sciorinavo la storia di Salah come fosse la mia propria storia. [37]
Anche Maurizio Iannelli ricorda come il processo creativo prese slancio nel momento della separazione da Fernanda: “Perché il testo, il dialogo col testo di Fernanda, è iniziato nel momento in cui ci siamo separati. Nel momento in cui mi hanno trasferito in un altro istituto”. Così Iannelli, ancora nel 1994, nell’intervista al “Caffè”:
La mia scrittura è un’altra scrittura. È indubbio che alla fine, e non solo tecnicamente come scrittura, penso che ci sia molto di me. Anche se introdotto in un modo del tutto clandestino, in un gioco di assunzione di ruoli, e di costruzione poi del personaggio […] Insomma, Princesa è stato anche un libro di rapina se volete. […] Scrivere un’autobiografia in due implica un cortocircuito. [38]
Analoghe riflessioni proporrà, nel 2008, intervistato a proposito della sua docu-soap Reparto Trans (girata insieme a Marco Penso) e, più in generale, della nuova attività di regista e autore televisivo:
in ogni caso, con le scelte di regia, il posizionamento della macchina , il montaggio, l’autore parla sempre di sé, anche quando parlano gli altri, la sua presenza non si risolve nel mero artificio stereotipo della voce narrante. La presunzione di poter rappresentare oggettivamente l’altro è un’illusione (neanche l’altro si conosce realmente per come è). Il regista, e così l’autore, racconta alla fine se stesso ed il lettore-spettatore è innanzitutto chiamato a decifrare questo. [39]
Appartengono certamente al coautore italiano, e alla sua storia personale durante gli “anni di piombo”, le scelte espressive che portano ad enfatizzare costantemente gli episodi di violenza poliziesca registrati nei manoscritti di Farias, dove tuttavia vengono spesso risolti con un breve giro di frase. Sono suoi gli innumerevoli riferimenti al diavolo che, pur presente nell’immaginario nordestino esemplato dal Grande Sertão, non sono estranei alla nostra tradizione cattolica. Riguardano l’esperienza del terrorismo pure alcune particolari consonanze con la fonte brasiliana: Iannelli che avrebbe sottoscritto, nella lettera a Rossana Rossanda pubblicata sul “Manifesto” nel 1987, l’auspicio di uno “sbocco politico e sociale” della lotta armata, non poteva non leggere nelle pagine del romanzo dedicate al pentimento di alcuni guerriglieri jagunços l’eco di avvenimenti che stavano caratterizzando il destino carcerario di alcuni ex appartenenti alle Brigate rosse. La scelta, infine, di terminare il racconto di Princesa con l’arresto della protagonista è, nella sua natura omissiva (gli appunti di Fernanda riguardano anche la quotidianità carceraria), un gesto che pertiene alla responsabilità dell’autore:
Senza sforzo, nelle braccia del demonio, in Europa, ci si arriva a bassa voce, silenziosamente. Qui da voi, non si muore fragorosamente. Sparati o di coltello, tra urla e sforbiciate. Qui si sparisce zitti zitti in sottovoce. Silenziosamente. Sole e disperate. Di aids e di eroina. Oppure dentro una cella, impiccate a un lavandino. Come Celma, che vorrei ricordare. Dormiva nella cella a fianco, dentro quest’altro inferno dove ora vivo e che ho deciso di non raccontare.
Mai come in questo caso diventa palese l’avvenuta sovrapposizione della voce di Iannelli, mediatore autoctono, a quella di Farias, testimone immigrata. Sotto finale, insomma, l’implicita doppiezza della prima persona nella quale la vicenda è narrata resta allo scoperto, essendo quella di Iannelli l’unica cui ragionevolmente attribuire le ultime parole del libro: “ho deciso di non raccontare”. E, come detto, omettere è, almeno quanto raccontare, specifico compito dell’autore. Se un lettore d’eccezione come Fabrizio De André attribuiva integralmente la paternità di Princesa – che la coautrice brasiliana apertamente definisce nel documentario di Stefano Consiglio: “questo mio libro”- al coautore italiano: “ho tratto [Prinçesa] da uno splendido, breve romanzo [di Iannelli] in effetti una biografia”, allo stesso modo Cesare Segre sottolineava il carattere uno e bino dell’autore del Milione, senza che questo interferisse, peraltro, con il dato acquisito del valore artistico dell’opera. [40]
Quanto il laboratorio di Princesa sia risultato decisivo per certi sviluppi della docufiction in Italia, ovvero per la variante televisiva del “ritorno alla realtà”, è dimostrato poi dalla più recente stagione professionale del coautore di Princesa. Dopo aver ideato, diretto e prodotto le docu-story Residence Bastoggi (2003), Liberanti (2006) e Reparto trans (2008) – ancora gravitanti, queste ultime, intorno all’universo carcerario di Rebibbia – Iannelli è oggi autore di un fortunato format televisivo (ideato insieme a Matilde D’Errico e Luciano Palmerino). La serie RAI Amore criminale (in onda dal 2007), che ha contribuito a portare all’attenzione dell’opinione pubblica la drammatica realtà del “femminicidio”, ripropone, per diretta ammissione del regista, [41] il medesimo metodo di lavoro inaugurato all’epoca della stesura di Princesa: costruire la narrazione attraverso l’uso integrato e la contaminazione tra materiali documentari e invenzione letteraria.
*
La forma comunicativa che sta all’origine di Princesa è la conversazione, sebbene nei modi necessitati e precari che il carcere tollera o consente dentro uno stringente disegno di “individualizzazione coercitiva”. Questa nuova edizione, annotata on line, del libro di Fernanda Farias de Albuquerque e Maurizio Iannelli restituisce innanzitutto l’opera ad un ambiente comunicativo fondato sull’ “oralità di ritorno” tipica dei media elettronici. [42]
La nuova struttura dialettica dell’ipertesto finirà per spingerci come sottolinea Derrida, a “rileggere gli scritti del passato secondo una differente organizzazione dello spazio”. Non soltanto è oggi possibile trasferire in una forma compatibile con il computer testi scritti originariamente a mano o a stampa, ma anche dare loro strutture ipertestuali. In qualche caso questa operazione di traduzione restituirebbe loro l’antico tono di conversazione. [43]
Proporre oggi l’edizione critica di un “piccolo classico” della scritture migranti, per ratificarne e insieme promuovere l’inte(g)razione col canone letterario nazionale, comporta perciò l’immediata apertura ad un orizzonte digitale, capace di contenere e restituire la dimensione intertestuale e transmediale. Solo in questo modo è possibile radunare come “braci di un’unica stella” [44] gli elementi della costellazione audio- video-testuale di nome Princesa. Se il potenziale di un libro “così poco letterario”, come il Milione di Marco Polo si misura, infatti, secondo Cesare Segre, sulla varietà di letture e riscritture che ne hanno fatto la fortuna (almeno fino alle Città invisibili di Italo Calvino) [45], nel mutato contesto culturale [46], la fortuna della “così poco letteraria” Princesa consiste nell’attitudine a migrare, non soltanto tra testi, ma tra media diversi. La fortuna, appunto, di migrare.
[1] In Perché leggere i classici (1991), Italo Calvino offre la seguente come sesta definizione del genere: “Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire”.
[2] Cfr. Leggere il testo e il mondo. Vent’anni di scritture della migrazione in Italia, a cura di F. Pezzarossa, I. Rossini, Bologna, CLUEB, 2011.
[3] Anche grazie alla riscrittura in forma di canzone – Prinçesa – realizzata da Fabrizio De André e Ivano Fossati nel 1996.
[4] Cfr. Ritorno alla realtà? Narrativa e cinema alla fine del postmoderno, a cura di R. Donnarumma, G. Policastro, G. Taviani, in «Allegoria», 57, gennaio-giugno 2008. Del tema si continua a discutere, in Italia e all’estero: cfr. Les nouveaux réalismes dans la culture italienne, Colloque international, 12-14 juin 2014, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3.
[5] La dichiarazione è stata riportata in: A. Ginori, Il testamento maledetto. Un intrigo internazionale per il manoscritto di De Sade, “la Repubblica”, 1.6.2013, p.39.
[6] M. Foucault, Scritti letterari, a cura di C. Milanese, Milano, Feltrinelli, 1971, pp. 4-5.
[7] Iannelli ha visto premiato il proprio lavoro di documentarista al Torino Film Festival (Un bel ferragosto, 2001) e al Roma Fiction Fest del 2008 per Città criminali. Ha girato nel carcere di Rebibbia la docu-soap Reparto Trans (Sky, 2008) ed è attualmente autore e regista della trasmissione RAI Amore criminale.
[8] Scriveva Cesare Lombroso nella nota “Al lettore” premessa ai Palimsesti: “Il volgo […] crede che il carcere sia muto ma [ …] quest’organismo parla […] sulle mura del carcere, sugli orci da bere, sui legni del letto, sui margini dei libri che loro si danno nell’idea di moralizzarli, sulla carta che ravvolge i medicamenti, perfino sulle molli sabbie delle gallerie aperte al passeggio, perfino sui vestiti, in cui imprimono i loro pensieri col ricamo” (C. Lombroso, Palimsesti del carcere, Torino, Fratelli Bocca, 1888. La citazione nel testo deriva dalla pagina 38 dell’edizione curata da G. Zaccaria per l’editore fiorentino Ponte alle grazie nel 1996).
[9] J. M. Lotman, La semiosfera. L’asimmetria e il dialogo nelle strutture pensanti, a cura di S. Salvestroni, Venezia, Marsilio 1985, p. 181.
[10] Brevi stralci del materiale sono stati pubblicati sulla rivista “Caffè. Per una letteratura multiculturale”, nel 1994. Il dattiloscritto intitolato Princesa. Sono venuta di molto lontano, copia iniziale di lavoro sulla quale Iannelli ha elaborato la forma testuale definitiva di Princesa, è stato pubblicato per la prima volta in allegato alla tesi dottorale: A. Proto Pisani, Dans une autre langue. Écrire l’altérité : femmes, migrations et littérature en Italie (1994 – 2010), Doctorat d’Aix-Marseille Université, 2013.
[11] J. M. Lotman, La struttura del testo poetico, a cura di E. Bazzarelli, Milano, Mursia, 1972, p. 336.
[12] Dopo essere stato pubblicato o per i tipi di Sensibili alle foglie nel 1994, e concesso in licenza prima a CDE Milano, nel 1995 e, due anni dopo, all’editore Tropea (col richiamo in copertina: “da questo libro Fabrizio de André ha tratto ispirazione per Princesa”ed il sottotitolo Dal Nordeste a Rebibbia: storia di una vita ai margini), il libro viene periodicamente stampato on demand, in tirature limitate, dalla casa che ne detiene i diritti.
[13] Così Sioban Dowd nell’introduzione a Scrittori dal carcere, Milano, Feltrinelli, 1998, p.261.
[14] Così Iannelli nelle citate Brevi note di contesto premesse all’edizione di Princesa: “Come tre funamboli ci inseguimmo incerti lungo il filo di una spirale epistolare che ci portò oltre le mura, oltre il carcere. Così Princesa è nata. Da un incontro irregolare, da tre storie, tre persone che approdano al carcere lungo itinerari diversi: la lotta armata delle Brigate rosse il mio, la prostituzione transessuale quello di Fernanda, la vita pastorale e la rapina quello di Giovanni”.
[15] M. Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino Einaudi 1976, p. 261.
[16] S. Dowd, Introduzione, Scrittori dal carcere, cit., p. 21.
[17] M. Foucault, Dalle torture alle celle, Cosenza, Lerici, 1979, p. 122.
[18] Cfr. J. Butler, Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell’identità, Roma-Bari, Laterza, 2013 [1990].
[19] E. Fassin, Le vrai genre, in Herculine Barbin dite Alexina B., Paris, Gallimard, 1978, p. 237.
[20] Sandro Mezzadra nel suo La condizione postcoloniale (Verona, Ombre Corte, 2008), rintraccia l’eredità del colonialismo nelle politiche europee di controllo delle migrazioni. A proposito di colonialismo, ecco quanto afferma Fernanda (foglio 25 dell’ Intervista sul Carnevale rilasciata a Iannelli e disponibile nell’Archivio del sito): “nella colonissasione del Brasile come lo sai che la popolasione brasiliana era indios e ogni rasa aveva un nome come qui in Italia c’è i napoletani sardi sisiliani”.
[21] La figura di una donna, “Caffè. Per una letteratura multiculturale”, 1, settembre 1994, p. 4 (miei i corsivi).
[22] L’estratto è citato in esergo a G.Bianconi, Mi dichiaro prigioniero politico, Torino, Einaudi, 2003.
[23] L. Sciascia, Incontro con Lotta continua (1978), “Lo Straniero”, 173, novembre 2014, p. 8.
[24] M. Moretti, Brigate rosse. Una storia italiana, Milano, Anabasi, 1994, p.141.
[25] L. Sciascia, Incontro con Lotta continua (1978), “Lo Straniero”, cit., p. 13. Per onore del vero – e in omaggio alla teoria degli opposti estremismi – Sciascia diagnosticava la stessa incompatibilità romanzesco-proustiana alla casta degli aristocratici ancien-régime: “Perché non ho mai letto un romanzo. Il romanzo è una sconvenienza, una volgarità […] non ricordo Marcel Proust. Anche in certi luoghi alti, che lei ancora non conosce, e dove mi aspettavo di dover rispondere dell’amore e dell’odio, la prima e sola domanda che mi hanno fatto è stata questa: ‘si ricorda di Marcel Proust?’. No, non mi ricordo: sono un’anima persa” (il brano è tratto dall’ Intervista a Maria Sofia ultima regina di Napoli, testo elaborato da Leonardo Sciascia per la serie radiofonica delle Interviste impossibili).
[26] M. Puig, Il bacio della donna ragno, Torino, Einaudi, 1978, p.87.
[27] Si parafrasa qui quanto è scritto nelle Brevi note di contesto premesse al racconto: “Per comunicare con Fernanda partecipai e contribuii al farsi della nuova lingua. Alla variazione, scritta e orale, che risultò dalla chimica delle nostre lingue materne. Il portoghese, l’italiano e il sardo”.
[28] La relazione epistolare con Guimarães Rosa ebbe inizio nel 1959 e durò per otto anni. Nel 1981 le lettere furono pubblicate con il titolo João Guimarães Rosa: correspondência com o tradutor italiano Edoardo Bizzarri.
[29] Il passo si legge nella traduzione di Vincenzo Barca e deriva dall’articolo “Che Dio protegga il traduttore” di Davi Pessoa, ora in http://strademagazine.it/2013/01/20/che-dio-protegga-il-traduttore/
[30] Si riporta qui la definizione offerta da Bizzarri nel citato Glossario annesso alla sua traduzione del Grande Sertão: “Fuorilegge in un contesto socioeconomico che non permetteva il funzionamento effettivo della legge […] il jagunço presenta, quale figura umana, un’assai ricca gamma di situazioni umane, dall’idealista difensore degli oppressi al mero bandito di strada”.
[31] “Poi sono andato a leggermi subito, d’un fiato, il Grande Sertão” dichiarava Iannelli a pagina 5 del citato fascicolo del “Caffè”.
[32] Foglio 13 della citata Intervista sul Carnevale.
[33] G. Benvenuti, R. Ceserani, La letteratura nell’età globale, Bologna, il Mulino, 2012, p 160.
[34] La citazione, tratta da João Guimarães Rosa: correspondência com o tradutor italiano Edoardo Bizzarri , è riportata da Davi Pessoa nel citato articolo: “Che Dio protegga il traduttore”.
[35] Nel fascicolo intitolato al “Ritorno alla realtà”, numero 57 del gennaio- giugno 2008
[36] Realitysmo è un’altra definizione proposta, per gli esemplari narrativi coinvolti nel “ritorno alla realtà” negli anni zero del 2000 ed è presente, ad esempio, nel Manifesto del nuovo realismo di Maurizio Ferraris del 2012.
[37] M. Fortunato, S. Methnani, Immigrato, Milano, Theoria, 2006 [1990], p. 6
[38] La figura di una donna, in “Caffè. Per una letteratura multiculturale”, cit., p 5.
[39] Trascrivo dall’intervista rilasciata nell’incontro organizzato presso “Il Cassero”, LGBT Center di Bologna, l’undici novembre del 2008 (disponibile in rete all’indirizzo:. http://www.puta.it/blog/2008/11/11/queer/reparto-trans-al-cassero)
[40] Sulla questione si veda: C. Segre, “Introduzione”, M. Polo, Milione. Divisament dou monde, Milano, Mondadori, 1982, pp. XII-XIII; V. Bertolucci Pizzorusso, “Introduzione”, M. Polo, Milione, Milano Adelphi, pp. IX-XXI
[41] Ancora dall’intervista bolognese per il Cassero del 2008: “sul piano del montaggio le docu-storie hanno una struttura narrativa che vuole applicare al documentario le scansioni narrative della fiction”.
[42] Più di trenta anni fa, Walter J. Ong prefigurava la comunicazione culturale del futuro all’insegna di una oralità di ritorno : “Solo ora, nell’era dell’elettronica, ci rendiamo conto delle differenze esistenti fra oralità e scrittura; sono stati infatti le diversità fra i mezzi elettronici e la stampa che ci hanno reso consapevoli di quelle precedenti tra scrittura e comunicazione orale. L’era elettronica è anche un’era di oralità di ritorno, quella del telefono, della radio, della televisione, la cui esistenza dipende dalla scrittura e dalla stampa”: W. J. Ong, Oralità e scrittura, Bologna, il Mulino, 1986 [1982], p 21.
[43] J. D. Bolter, Lo spazio dello scrivere. Computer, ipertesti e storia della scrittura, Milano, Vita e pensiero, 1993, p. 150.
[44] Si cita qui il verso della canzone Prinçesa.
[45] Né è mancata, tra le forme di riscrittura, la canzone: è del 1984 Marco Polo, il concept album del cantautore romano Flavio Giurato.
[46] “Con il concetto di rimediazione (remediation) da un decennio ci si riferisce alla necessaria interpenetrazione dei media in un contesto storico dove la digitalizzazione ha imposto la sostanziale convergenza di tutti i mezzi di trasmissione, di tutti i format comunicativi e dei codici semiotici entro un sistema interconnesso, interattivo e integrato, al punto che il contenuto dei media digitali sono tutti gli altri media” (S. Calabrese, Il romanzo della Globalizzazione, Enciclopedia Treccani on line, http://www.treccani.it/enciclopedia/il-romanzo-della-globalizzazione_%28XXI-Secolo%29/
Il peso della parola / su Nannetti di Paolo Miorandi
di Mariasole Ariot
BIANCHI RUMORII,associati,
radiali
passaggi
sopra la tavola
con il messaggio-nella bottiglia
(P. Celan)
Un libro come un muro lungo 180 metri per 2, perché lo spazio non è una questione di dimensioni. Tre voci o forse una : come Nannetti graffiava l’intonaco con la fibbia degli internati per costruire una parola – quando le voci interne possono uscire dalla gola per potersi finalmente pronunciare – così la penna di Miorandi incide piano la pagina bianca, per ogni parola uno scavo preciso, non ferita ma feritoia : non una scena che si mette in scena ma un invito alla sospensione, come sospesa è la punteggiatura. Solo i nomi restano maiuscoli.
Nannetti Oreste Fernando N.O.F 4 : reparto Ferri del Carcere di Volterra.

Se il messaggio-nella-bottiglia di N.O.F.4 ha rotto i vetri che lo costringevano, sconfinato e tracciato un nuovo confine attraverso i tratti delle sue parole, così Paolo Miorandi, riprendendo nuovamente la poesia di Celan si ascolta, porge/ascolto a un mare/lo beve/per giunta, e disvela/le mal praticabili/bocche.
Il narratore torna nei luoghi, entra nelle zone interstiziali, piega l’occhio per affondare la vista, parla con Aldo l’infermiere, custode della parola e traduttore : l’uomo che ha trascritto l’intero muro su carta, segno dopo segno, riconoscendo, traducendo lettere, simboli, stelle, onde radio, compagno di viaggio di un austronautico ingegnere minerario del sistema mentale, alieni con il naso ad Y, e ancora segni, e ancora lettere, e dichiarazioni, e simboli, e onde radio, e mani minerarie e stelle – e le tre voci diventano unico suono che restituisce non il racconto di un uomo ma il racconto di un racconto, che inclina la testa da parte a parte ad ascoltare il mondo dell’altro, dell’altro-dell’altro e del proprio.

Se Nannetti incideva le lettere attorno al bordo dei compagni seduti sulla panchina (tre vuoti che segnano l’ombra antica di tre corpi), così la scrittura dell’autore non chiede all’altro di piegarsi, non spinge strattonando per aprire uno spazio forzato ma circonda con la parola il vuoto necessario al lettore per appoggiarsi a quel muro. Le sagome date per sottrazione comportano così una doppia testimonianza : la testimonianza di chi scrive, la testimonianza di chi legge.
La voce di Miorandi – come pure si dispiega nella realtà fisica quando parla : pacata, cadenzata, una grazia ipnotica – restituisce così l’ostinazione di un urlo che per poter urlare ha bisogno della pazienza e dell’incisione lenta.
Ogni parola porta un peso specifico : non una pietra che cade ma un muro che, non potendo cadere, decide di parlare.
***
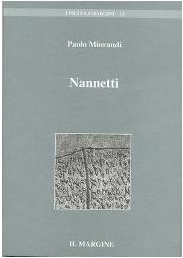 Estratti da Nannetti, Paolo Miorandi, il Margine 2012
Estratti da Nannetti, Paolo Miorandi, il Margine 2012
[1]
la prima volta che si sale per la stretta strada nel bosco dopo essersi lasciati alle spalle il pomeriggio estivo ed essere piombati di colpo in un precoce imbrunire, passata una curva, i padiglioni appaiono senza preavviso, come visioni venute dal nulla, o come gigantesche carcasse d’automobile abbandonate lungo il bordo di certe strade del sud e ormai diventate elementi del paesaggio naturale, rocce, sassi e tronchi seccati; la prima volta che si va avanti non facendo caso al divieto d’accesso e si supera quella che doveva essere la guardiola della portineria generale, e che, parcheggiata la macchina nello spiazzo, si prosegue a piedi guidati dal richiamo dei corvi, da quel loro gridare e scappare come bambini impauriti al sopraggiungere dell’oscurità; quando, entrati nel cortile del Ferri, adesso stanco e remissivo come una cittadella sconfitta, aperta al termine dell’assedio, e senza riuscirci si prova a vedere, e allora si avanza ancora di qualche passo guardando con maggior attenzione, come se in quella luce ombrosa e spessa gli occhi facessero fatica a distinguere i contorni delle cose e le tracce umane si confondessero in perfetta mimesi con i segni naturali, con la corteccia rugosa dei tronchi, l’ondeggiare dei rami, l’intreccio delle sterpaglie; quando poi, diradata la nebbia dallo sguardo, prima davanti e solo in seguito ai lati, si cominciano a percepire i richiami delle cicatrici di pietra, fratelli e sorelle, fratellastri e sorellastre, come tracce di antichi tagli, 1927, Nannetti Mara, alta un metro e settantacinque, sorellastra, nonna e madre; Nannetti Oreste Fernando, il nome che più di ogni altro hai inciso sul muro, alto un metro e sessantacinque, fratellastro; e ancora, cugini, bocca stretta, cuginastri e cuginastra, nonnastra, 1900, sempre bocche strette; Nannetti Oreste Fernando, il nome che ti hanno consegnato quando sei arrivato qui, lungo da scrivere e che un’altra volta hai scritto sul muro, questo muro che adesso si apre come un libro di fronte agli occhi; N.O.F. 4, grado colonnello, nato nel 1925, 1927, ventinove, trentadue, nato a Roma, capitale dell’Impero, nella congiunzione astrale tra il triangolo e il rame, il triangolo della faccia, il rame dei fili elettrici; assieme agli altri uscivi da quella porta, in fila indiana come uno scolaretto alla ricreazione, esco da quella porta e vengo in questo cortile, porta, cortile, muro, ogni giorno, anche se piove
[2]
basta che non piova a dirotto perché in tal caso non ci portano all’aria e allora non posso scrivere; quando piove dobbiamo girare tutto il tempo attorno al tavolo del refettorio come piccoli pianeti dall’orbita stretta, saturno, mercurio, nettuno, questa tua ossessione per i nomi degli astri e dei minerali, sole uranio, stella uranio, rame, luna urania, lancio su stella 2040, visioni dell’era spaziale che sta per venire; se piove a dirotto, quando giriamo attorno al tavolo del refettorio, accade sempre che qualcuno prima o poi diventa nervoso, attacca briga e si azzuffa, per questo l’infermiere di turno è costretto a intervenire; ma anche se ci chiamavano infermieri, a quei tempi noi ci sentivamo più che altro guardiani, perché questa in fin dei conti rimaneva pur sempre una prigione, sbarre, celle di contenzione, filo spinato; gli stessi superiori ci consideravano guardiani, soldi per loro ce ne davano pochi, noi dicevamo, con i soldi che ci date non potete mica pretendere che li curiamo, ma chi v’ha detto che dovete curarli, voi dovete sorvegliarli, punto e basta; di matti non ne sapevamo nulla, obbedivamo agli ordini, oggi turno al secondo piano, domani turno alle serre, si obbediva agli ordini dell’ispettore generale e del medico, poi ognuno si regolava come meglio poteva; allora l’infermiere di turno dice, la volete piantare sì o no, poi dice, ve l’ho detto già una volta di piantarla, poi è costretto a chiamare l’altro infermiere di turno e portare via quello che dà noia e non vuole più girare attorno al tavolo del refettorio; allora gli infermieri devono prenderlo per le braccia, uno per un braccio e uno per l’altro, devono riportarlo in camerata e se necessario usare le fasce, una da una parte e una dall’altra parte del letto, ma è certo che non sono io quello che gli infermieri devono portare via, io continuo a girare attorno al tavolo del refettorio seguendo il cerchio della mia orbita, non do noia a nessuno, non attacco briga, sto zitto e aspetto che la pioggia finisca; se era bel tempo si usciva in cortile, ognuno faceva le sue cose, lui stava sempre per conto suo; conosciuto? sì l’ho conosciuto, per come era possibile conoscere uno come il Nannetti; ne sono passati di anni, adesso non ci vengo quasi più, è come se questo posto mi mettesse paura, anche se paura non è la parola corretta, ha visto com’è ridotto? lasciato andare in rovina, le racconto volentieri quello che so, no, non si preoccupi, il tempo non mi manca
[5]
ma di certo io non scoppio, ho il muro, ho la fibbia del gilet che è la mia penna e la mia matita e non ho bisogno d’inchiostro; gli altri si fanno l’acciarino con la fibbia del gilet, acciarino è una parola piena di stranezza, li ho guardati, usano la fibbia del gilet e un bottone di madreperla, usano la scatoletta di latta delle pastiglie per la gola, un filo e un cencio bruciacchiato; io non faccio gli acciarini, tolgo la fibbia dal panciotto, ce l’abbiamo tutti qui dentro, e la uso per scrivere sul muro, è la mia penna e la mia matita; posso indossare il panciotto anche senza fibbia, per me fa lo stesso, gli infermieri lo sanno e non mi dicono più, dove hai ficcato la fibbia del panciotto? non farai mica scherzi vero? sanno che non faccio scherzi; hai scritto, sono l’uomo invisibile armato di fibbia catodica, i fantasmi sono formidabili, dopo la seconda apparizione prendono sembianze materiali; adesso vai dall’Aldo e gli chiedi una cicca, e lui te la dà se è di luna buona, gli dico, Aldo me la dai una cicca, e lui me la dà, ma non tutti i giorni, e se non me la dà non insisto, avrà i suoi motivi, mi dico, l’insistenza è una brutta cosa, per il resto me ne sto per conto mio, non parlo con nessuno e nessuno parla con me; qui tutti erano soli, ma se c’era qualcuno ancora più solo degli altri, quello era il Nannetti; non aveva nessuno, non possedeva nulla; quando l’hanno condotto in fagotteria per la consegna degli effetti personali non aveva niente con sé eccetto i vestiti che indossava;
[6]
se loro non mi parlano arrivano le ombre, strisciano lungo le pareti del corridoio, entrano nella camerata e si accostano al mio letto, gli dico, andate via, ma non vanno via, alzo la mano, la sposto e la ruoto per migliorare la ricezione, ma non sento niente, dico, uno, due, tre, qui Forte Forestal, ricevente attivata, parlate, ma non è in corso nessuna trasmissione, loro non parlano, ci sono solo le ombre; hanno attraversato le inferriate della finestra, non sono certo le inferriate che possono fermarle, sono entrate nella camerata, hanno strisciato lungo il pavimento e si sono accostate al mio letto, gli dico, andate via, ma non vanno via, sono nere e lucide come petrolio e possono passare anche sotto le porte, entrano da ogni buco, mi tappo le orecchie con le mani e sto fermo senza respirare, ma poi devo respirare e allora faccio un respiro corto come un singhiozzo, quando riapro gli occhi sono ancora lì, qui Forte Forestal, Volterra, Pisa, pronto pronto, ricevente attivata, ma ci sono solo disturbi catodici, telequadrante a scariche cosmiche, nubifragi elettrici, e freddo, freddo come in inverno; le ombre sono vive, dopo la seconda apparizione prendono sembianze materiali, la luna nel pozzo è sparita, Saturno, Mercurio, Nettuno, sole uranio, stella urania, luna urania, andate via per favore, dico, stella pazza, due soli fanno due ombre, rispondetemi; aiutami Milena, cara cugina Bianca, rispondimi e mandami mille lire che qui di tutto abbiamo bisogno, in questa casa della misericordia mentale, avamposto nucleare, mia cara Milena, la tua bocca di madreperla, un manicaretto domenicale per il tuo bambino, aiutami, lancio da Forte Forestal, divisione territoriale inglese, lancio su stella 2010 (duemiladieci), lancio su Urano, settore natalizio; trasmissione nel sistema telepatico da base missilistica di San Finocchi, Ospedale Psichiatrico di Volterra, reparto giudiziario, quarta sezione, settore territoriale della svizzera sovietica, lancio su stella 2040, Nannetti Fernando, Ferri, Ferruccio, ferroviere, fischietto, sezione quarantaquattresima, Parigi, possedimenti coloniali francesi d’oltremare, possedimenti coloniali franco-spagnoli, linea costiera, trasmissione notturna da Forte Forestal, base missilistica neuronale, ricevente attivata su frequenza catodica, trasmissione, uno due, pronto, pronto? nel silenzio non si sa, meteorismo cosmico, non sento niente, nessun rumore nella camerata, nemmeno il respiro grasso di Pampana, non sento passi nel corridoio, tintinnare di chiavi, né rumore di padelle in cucina, non sento gorgogliare l’acqua nei tubi, non è la pioggia, sento solo il latrare di un cane, ma so che non è un cane
#
Turner alla Tate Britain
In un punto centrale del tragitto
tra il molle autoritratto a ventiquattro
anni e la maschera secca che lo ferma
morto anni dopo e dopo molti venti,
nebbie e tempeste, un acquarello
ritrae due tinche, un persico e una trota
composte in lieto stile e in armonia
di cose morte che sono state vive.
Chiaroscuro aggraziato, quasi non
reminds the gap che esiste tra i due stati.
#
Bambina senza madre in campo santo
Diceva di piante come razzi accesi
sullo slancio di ossa che frantumano
l’essere morta nel domani ossigeno,
diceva come sempre svagato
e masticava sussurri, forse songs
che non sopporto, maledetto lui
e l’inceppo che dice reologico
perché è impossibile, diceva
e lo diceva a modo, ridendo
con la rima labiale, con poche rughe
serrate come bocca divina
imperscrutabile o almeno di santo,
per me che sono stupida e stupisco
per poco più di niente, per mani,
per dita che mi tengono la testa
lungamente leggiadre, che l’accolgono
come piaga leggiadra, diceva,
sì, nobilmente diceva che è impossibile
e la preghiera della mia faccia
storta che amaramente allunga
sorrisi, come non bastasse
stare qui storta in caritatevoli
mani e perlomeno non nell’anima,
mentre stare lì sotto, dare fili
alla pianta, oltre il prato che decide
l’ossigeno ed i fiati a menadito,
diceva benedetto e la mia testa
pregava insieme a lui e a lui diceva
che questo dire di mani è impossibile
e sono mute le labbra, le rime,
diceva a me che non so stare viva
se non barcollo, se non scuoto l’albero
diceva di mia madre e non sa dire
cosa che non mi manchi e non mi dolga,
tu lasciami se puoi, gli dissi, fammi
tenere dritto il capo e poi riprendimi.
#
Dodici finestre
Alcuni edifici sono per stare quali
facce di pietra negli angoli diversi.
La rifrazione mite esegue l’ordine
di dare luce eterna per un attimo.
La strada, il frontespizio, lo specchiarsi
ineluso che fugge dallo sguardo
non so dove si arrampica. Ogni cella
opera buiamente. Nell’umano
abita l’invisibile. L’opaco
tiene profilo d’ape oltre la tenda.
#
Vento Cardinale
Sera d’estate, torna il peso rapido
delle nubi all’ingrosso, che si stingono
nella gamma del grigio, gonfie d’acqua.
Passano e vanno via, mentre dispiega,
eretto all’abitudine del vento,
magre dita un palmizio.
E’ la pazzia dell’aria,
che l’isola prosciuga, l’energia
del sale sconfinato del Tirreno,
di quello anidro e scuro confinato
nelle saline. Si gonfia
d’aria, magnifico, il tuo scialle
tinto di giallo, e pare che respiri.
Tu, per tuo conto, tieni il fiato, aspetti
l’urto da capra dell’ottavo
scoglio che asciutto ti sibila tra i denti,
mentre serri le ciglia, mentre,
imprudente, dilati le narici.
Parleremo, stanotte, del poeta
che di venti siffatti fu geometra.
#
Angelo del Pontormo
Nube. Nubesco. Potenza delle ali.
Testa rivolta ai venti della volta.
Un gran soffione d’aria nel vestito.
Sono nube di guerra. Non sorrido.
Vento che ti schiaffeggia. Non mi vedi.
Arrivo nel gran peso delle ossa.
Non c’è buco che tenga la caduta.
Angelo dell’intonaco, sono orma
della grazia sul ponte, sono inchino
di veleggi rigonfi al paradiso
chiuso nella navata.
#
Su Rosso e sul Pontormo a casa Strozzi
È dunque tripartita la ventura
terrena – ma non solo – dei gemelli
diversi, sortiti, come uova virgiliane,
dal sedere del Sarto e senza errore.
Romani nel ritratto a mano lenta.
Ubriachi nel decoro cortigiano.
Voluttuosi e perduti nelle chiese.
Il Rosso vira al nero, somigliando
al Novecento per le sue brutture,
solo che lui, nel nero, spruzza a pieno
pagliuzze d’oro d’irrappresentabile.
Pontormo va per cieli, ha più paura
dei peccati e dei gravi.
A sera muore
un’ombra affumicata.
Arriverà,
nel superare cortesi appagamenti,
lo smalto successivo del Bronzino.
#
Moon and bat
(landolfiana)
Sei il battito o la luna che da lontano guarda?
Il pipistrello cammina esattamente
col tuo battito d’ali sul selciato.
Ed all’inizio, anzi, non ti vidi
se non nel fremito battente di quel sangue,
nell’ovale notturno di quel viso.
La luna o il pipistrello? Quale cielo?
#
Nimbus
Nimbus water pregnant
standing in the sky.
It’s going to rain.
Between the nimbus
and solid ground
drops and drops
of sound.
Le immagini:
Eugenio Lucrezi, Nimbus. 100 esemplari in piccolo formato, numerati, firmati e personalizzati da interventi a mano dell’autore sulla copertina di ciascun esemplare.
Info: EUREKA Edizioni c/o Associazione Culturale EUREKA, via T. Tasso, 30 – 70033 Corato (BA) e-mail: eureka.corato@gmail.com rossanabucci@libero.it oronzoliuzzi@hotmail.com
Eugenio Lucrezi (1952) è di famiglia leccese, vive a Napoli, fa il medico, il musicista e il giornalista. Ha pubblicato cinque libri di poesia: Arboraria, Altri termini, Napoli 1989; L’air, Anterem, Verona 2001; Freak & Boecklin (con Marzio Pieri), Morra-Socrate, Napoli 2006; Cantacaruso : Lenonosong (con Marzio Pieri), libro + CD musicale, La finestra, Lavis, Trento 2008; Mimetiche, Oèdipus, Salerno-Milano 2013. Ha pubblicato il romanzo Quel dì finiva in due, Manni, Lecce 2000. Suona nel quartetto “Serpente nero blues band”, il cui ultimo disco, intitolato Frieda e altre storie, è uscito nel 2013. Già redattore della rivista internazionale di letteratura Altri termini, diretta da Franco Cavallo, è attualmente responsabile della rivista di poesia e arte Levania, che pubblica inediti di autori italiani e stranieri, privilegiando le esperienze di intersezione tra discipline artistiche diverse e il dialogo tra letteratura, filosofia e scienza.
di Elena Frontaloni
Singolare, da rileggere, da ristampare: sono alcuni degli epiteti che Maurizio Salabelle, scrittore nato a Cagliari nel 1959 e morto a Pisa nel 2003, di professione insegnante, s’è guadagnato spesso negli anni passati, e che sono tornati a visitarlo con più frequenza negli ultimi mesi grazie alla pubblicazione per Quodlibet, a febbraio, de La famiglia che perse tempo, il suo primo romanzo rimasto fino ad oggi inedito. Gli epiteti nel fondo sono tutti giusti, perché davvero Maurizio Salabelle fu scrittore “singolare”, dotato di una voce riconoscibile, pudica, per questo non troppo intonata alle mode del suo tempo e del nostro – con autori sempre nel mezzo delle storie che raccontano, tirannici rispetto all’espressione che il volto del lettore deve prendere quando si trova davanti un loro testo (riso, pietà, avvilimento, adesione, pianto); e poi perché i suoi cinque romanzi pubblicati in vita sono tutti piuttosto difficili da reperire e varrebbe la pena di metterli a disposizione di chi li vuole leggere o rileggere. Per chi ha già letto e per chi comincia con La famiglia che perse tempo, in ogni modo, adesso c’è questo racconto di una famiglia colpita da una recrudescente e oscura malattia, proposto da Salabelle ad almeno tre editori, lavorato dalla fine degli anni Ottanta fino alla metà degli anni Novanta, mai pubblicato anche per volontà o preferenze del momento da parte dello stesso autore (che propose in seguito altri testi a chi glieli stampò) e giustamente presentato da Ermanno Cavazzoni nella quarta di copertina come “il più tipico, forse, della sua fantasia”, “scritto in modo limpido, scintillante e impercettibilmente comico”.
C’è da dire che Salabelle scherzò parecchio in vita sui recensori che parlavano solo vagamente dei libri, usando metafore e trucchetti vari perché li avevano appena sfogliati (fece ad esempio una serie di memorabili recensioni fisiognomiche in forma di ritratti a partire da foto inventate di autori inventati anch’essi: se ne può leggere uno qui). E forse non sarebbe troppo contento di chi, per parlare di un libro ne riporta per cominciare la quarta di copertina. Però in questo caso partire dalla quarta della Famiglia che perse tempo e da Cavazzoni mi sembra quasi un movimento igienico: perché a Cavazzoni spetta il miglior ritratto complessivo di Salabelle scrittore (posso consigliare di leggerlo qui); perché Salabelle, scrittore “singolare” e a suo modo orgogliosamente isolato, prese parte all’esperienza del “Semplice”, una rivista che ebbe tra i suoi animatori appunto Cavazzoni, del quale fu amico e che fu uno dei primi (dopo Giuseppe Pontiggia) a scoprirlo e a proporre di pubblicarlo a Giulio Bollati (ne uscì L’assistente inaffidabile, 1992); infine perché comicità e fantasia sono forse le due parole che andrebbero tenute a mente per capire qualcosa della sua scrittura esatta e cangiante, tanto padrona della lingua (d’uso e letteraria) quanto capace di prendersene gioco, tanto abile nell’individuare i luoghi esatti in cui la grande e piccola letteratura s’incontra spesso dolorosamente con la grande e piccola vita di ciascuno (famiglia, malattia, lavoro, scuola), quanto pronta a fare dell’una e dell’altra, e dei loro punti d’incontro, una velenosa parodia.
Dunque secondo me vale la pena di osservarle meglio, la fantasia e la comicità di Salabelle, anche al prezzo di dire banalità o ripetere cose note o già dette da altri. Per quanto riguarda la fantasia, può tornare utile una definizione da enciclopedia (Treccani, per la precisione) secondo cui sarebbe la facoltà della mente umana di creare immagini, corrispondenti o no alla realtà. La definizione, per quanto ampia (serve anche a individuare temi ricorrenti in questo autore, e ne parlerò un po’ ora e un po’ dopo), aiuta a cogliere una qualità profonda della fantasia Salabelle, e cioè la sua esattezza nel creare immagini grazie a una lingua e un periodare di insolito nitore, che rendono oggetti persone e luoghi plausibili alla visione interiore di chi legge e fors’anche in odore di cinematografabilità, ma nello stesso tempo, e inesorabilmente, fanno urtare queste immagini con il senso comune, l’idea vulgata di normalità, di realtà, di immagine, di racconto o evento che proceda in qualche direzione, a colpi di cause e di effetti. Si può leggere al proposito l’avvio del romanzo, che sembra fare il verso alla documentatissima chiacchierata stenografica di Natalia Ginzburg nella Famiglia Manzoni, ma contemporaneamente getta il lettore in un’atmosfera che ingloba, burlandosene impietosamente, l’opera omnia di Buñuel: “in quel periodo, che denominammo successivamente ‘Periodo del tempo veloce’, nostro padre restava sempre chiuso in camera a sperimentare con i suoi liquidi. A quell’epoca abitavamo in una casa dal portone privo di vetri. Con l’arrivare dell’estate entravano mazzi di strani fiori, che ci stupivano sempre di più e ci mantenevano in uno stato letargico. Per proteggerci da ciò provavamo a indossare cappotti scuri, foderati di pelliccia o coperti di fitta lanugine, ma succedeva in egual modo che ci accasciassimo sulle sedie”. Più avanti, quando uno dei figli, che è medico, fa un lungo discorso sulla situazione del padre malato, con varie ipotesi sul suo stato tra cui una che lo vorrebbe “liscio come una parete, abraso”, “simile a una fotografia che pare piena di rilievi ma che vista di profilo smette di esistere”, l’effetto sulla famiglia viene così descritto: “Mentre mio fratello enunciava […] queste sue teorie complicate, qualcuno di noi osservava la faccia di nostra madre mentre assisteva alla conferenza. A tutti noi sembrava che cercasse di seguire seriamente quei ragionamenti intricati, pensando ora a una voragine e subito dopo a un deserto piatto, mentre in realtà (come capimmo tempo dopo in seguito a una sua confessione) guardava la barba di mio fratello che risultava per lei un’allucinazione”.
Certo queste righe sconcertano e insieme inclinano verso qualcosa che potremmo definire comico (Marco Ciriello in una recensione assai bella ha fatto il nome di Aki Kaurismaki e va bene, salvo togliere a Salabelle molta partigianeria per le vicende umane degli strambi); e senz’altro la fantasia di Salabelle è comica. Ma per capire meglio a che tipo di comicità le sue immagini vadano incontro, per evitare sovrapposizioni con doloranti umorismi (Pirandello) o realismi magici velati di malinconia (Cortázar) e ritrovare i padri conclamati di questo autore (sono tutti o quasi in epigrafe ai suoi libri: Svevo, Tozzi, Flaubert, Walser, Perec), è il caso per un verso di rileggere un suo testo molto chiaro, che si trova in rete, e per l’altro di ricorrere ancora una volta a Cavazzoni, a un suo pezzo del 2012, Il comico senza strategia. Qui si dice che l’uomo, a differenza degli angeli (che non ridono, si leggono reciprocamente nella mente, sono intelligenze integrali senza difetti, non sbagliano le parole e la pronuncia delle stesse), è un essere multiplo, pieno di pensieri dubbi e fantasticazioni, simile in questo a un cestino dell’immondizia, dal quale se si prova a tirar fuori qualcosa è verosimile che non si tragga una cosa sola, ma vi rimanga casualmente appiccicato qualcosa d’altro, o più scarti d’altro. Dunque quando l’uomo prova a cavare delle fantasticazioni da sé, per parlare e scrivere, questi diversi pensieri tutti appiccicati e scomposti che escono dalla pattumiera possono collaborare (e vien fuori l’inizio della Divina commedia), oppure i pensieri possono urtarsi, contrastarsi, o anche dare l’impressione che “dietro al discorso ci siano due rotaie” le quali, più o meno leggermente, divergono. Nel primo caso abbiamo uno stile alto e forte, che dice l’uomo e l’epoca quasi senza smagliature, con una serie di complessità radunate dentro ogni parola che prova a dire il pensiero; nel secondo caso entriamo nel comico, che ha questo d’istruttivo: “mostra che c’è qualcosa di dissociato interno alla parola e al pensiero”, fa vedere che nel fondo stesso del linguaggio c’è qualcosa di comico, anche quando produce frasi solenni e forti.
Il comico di Salabelle mi pare rispondere del tutto a quest’ultimo pensiero; e forse fa anche qualcosa di più: si colloca, molto umilmente, in un limbo senza nome, tra i cieli degli arcangeli, di cui pare misteriosamente consapevole, e le pattumiere umane di cui sembra aver fatto parte in un tempo lontano. Per questo diverte e angoscia insieme, per questo è sempre spiazzato e spiazzante. Nelle storie di Salabelle infatti ci sono voci che “stanno” con incredibile candore e però “non si trovano” nei propri luoghi, nella propria epoca e neppure nella razza umana; sono dissonanti, vivono nella dissonanza, la prendono come regola, registrano quel che succede o si fanno registrare nei loro movimenti dal narratore; e forse non sono nemmeno uomini ma loro residui, o residui d’angeli, se si vuole, che hanno dimenticato come si fa la lettura del pensiero: somigliano a spettri, morti fantasmi, smorfie nemmeno troppo simpatiche di burattini che ricordano però il linguaggio, le storie, le immagini umane: un po’ vagamente. Dunque non parlano e non pensano veramente, ammiccando al lettore, ma piuttosto fanno il verso al linguaggio e al pensiero umani; con maggior distanza, certo, ma non con minor possibilità di dire che le cose, i fatti, le epoche (La famiglia che perse tempo racconta anche molto del secolo passato: i suoi tabù, le sue storture, i suoi mezzi di intrattenimento: radio, riviste, fumetti, cinema, televisione), le mappe dei luoghi ci sono, eccome: però non tornano, non sembrano avere un qualche senso, anche se qualche personaggio, insieme al lettore, s’affanna a trovarne uno. Di questo scarto tra la parola e il pensiero, tra come si potrebbero dire le fantasticazioni e come nei fatti le si dicono, tra il posto in cui il testo è gettato (il lettore) e quello da cui si getta (la voce che racconta, che interna o esterna al racconto è sempre decentrata e sonnolenta rispetto alle pastoie umane in cui si trova a vivere), è fatta, mi sembra, la scrittura di Salabelle, e dunque anche le prime righe citate della Famiglia che perse tempo e giù giù tutto il romanzo, dove arbìtri, rigidità del discorso (sinonimi, omografi, metafore morte) e del quotidiano (stranezze e regole interne a un nucleo familiare) suggeriscono continuamente spostamenti di senso, sospetti sulla realtà delle cose e linee di fuga alla ragione e all’immaginazione. Sono queste linee di fuga e sospetti i regali migliori che Salabelle fa al lettore, che può vedere la sproporzione, il difetto e riderne, oppure trovare la dismisura che avvolge ogni piccolo atto nostro, sorprendersene, amareggiarsene e sapere di non poterci far nulla, trovando così l’ultimo dono di questa scrittura: la libertà davanti a un testo, la forza liberatoria di un testo che non vuole darci ragione, torto, consolazione o rendersi in altri modi interessante, nonostante la triste condizione di essere tutti incatenati al linguaggio e ai limiti terrestri.
Il titolo stesso del romanzo è insieme descrittivo e fuorviante, se La famiglia che perse tempo è la storia di una famiglia che, tecnicamente, in ogni riga ed in ogni episodio del testo, perde il tempo. Ciò accade perché il tempo si è ammalato, e a lungo e in modi differenti la famiglia di rimando s’ammala, s’imbambola e s’angustia – a partire dal padre infetto per primo fino a coinvolgere tutti i membri, gli oggetti, le varie dimore abitate nel corso della storia –, per via di “perdite di periodi”, che hanno come primo malato il padre e come primo sintomo lo sporcarsi degli orologi da muro a da polso. Si tratta, per provare a dire più nel dettaglio, di momenti che sembrano rispondere a una teoria della relatività e dei quanti imperfette (un richiamo in questa direzione è all’interno del romanzo, a p. 114, in chiave ironica, tra i nuovi saperi che la famiglia rifiuta, ed è stato colto da Marco Belpoliti). In questi momenti difatti lo scorrere del tempo all’interno delle case e delle stanze abitate – il succedersi delle ore, la consistenza delle medesime, lo spessore del passato e del presente – si spazializza e insieme impazzisce, rallenta, ritarda, si disperde, si rintana in angoli della casa come un animale selvatico o spaurito; infine non coincide con quello convenzionale del “fuori”, che è un’imprecisata città di mare, con i suoi quartieri o meglio zone malamente conosciute dalla famiglia (“zone nere”, “zone dei germi”, per esempio; ma anche il quartiere di Sassa – vicino Montecatini e nelle prossimità di Pisa in Toscana c’è una Sassa con cento abitanti, forse un lieve riferimento autobiografico). Con il tempo e le residenze della famiglia, che ne cambia almeno sei nel corso del libro, s’appannano anche i percorsi d’autobus della città, le sue mappe e vie: diventano misteriosi e solo vagamente collocabili anche per qualche avventore della storia (il conducente d’autobus Obhes, ad esempio), oltre che per i componenti della famiglia. Questi, alla fine del romanzo, sperduti nella loro stessa casa, sapranno peraltro che la misteriosa città (città-fumetto o borgesiana mappa consunta, a dimensioni reali, di una città vera?), ha subìto un trauma irrimediabile. Poco prima, la voce della madre si era fatta sentire, riportata con complice e perfida austerità dal narratore: “Nostra madre mi confessò uno di quei giorni di non capire più la realtà del mondo. ‘Mi sembra di essere perennemente ubriaca,’ borbottò più di una volta poco prima di mettere in tavola. Dopo cena, un attimo prima di ritirarci per andare a leggere in camera, tutti e due ci scambiavamo delle occhiate con cui ci interrogavamo sull’esistenza”. Vale la pena di aggiungere che è Italo Svevo, La coscienza di Zeno, ad esser citato in epigrafe di La famiglia che perse tempo (“quella malattia mi procurò il secondo dei miei disturbi: lo sforzo di liberarmi dal primo”), e Salabelle dice così, come fa anche in altri romanzi con Walser (le sue storie che danno da pensare), Tozzi (il suo manierismo ruvido, con qualche traccia di ferocia), Flaubert (la ricerca vera e un po’ finta della parola giusta) Perec (la sua capacità di creare spazi dove non ce ne sono), di dover qualcosa a quest’autore, all’ironia disarmata del triestino. Però lì c’è un’analisi mancata e un’apocalissi sognata in prima persona; qui, e lo si capisce subito, un referto spaurito sulle tante analisi possibili di un male e sull’accadere di una apocalissi che nella scrittura si danno per certe o forse no, e che il lettore può supporre, se vuole, come solo sognate o più vere del vero, e più tremende del vero che riesce tutti i giorni a percepire.
La voce che ci racconta la storia della Famiglia che perse tempo, lo spettro o fantasma in vestiti d’uomo di cui si diceva prima, è anche quella attraverso cui conosciamo il resto dei personaggi. Si tratta del figlio maschio Phatrizio Gerdy, già cronista come la sorella di questo brano di storia familiare in due diversi manoscritti, entrambi perduti e disprezzati dal padre (ancora una nota: Manzoni e De Amicis possono venire in mente, ma Salabelle ci avverte subito che la strada è breve e si può cambiar direzione, perché non ci sono documenti di partenza da controllare e non c’è padre premuroso a riscrivere; e inoltre il tema della scrittura scoraggiata è un altro dei suoi rovelli – si legga lo strepitoso passaggio dell’Assistente inaffidabile in cui lo zio propone al nipote spiantato che ha scritto un romanzo a suo modo di vedere brutto (“non avevo mai letto niente di più insensato”) di prendere un nuovo lavoro: “cercano uno scrittore alle prime armi. Deve semplicemente produrre racconti. Potrebbe essere la soluzione del tuo problema, un modo per smettere di perdere tempo”, gli dice). Phatrizio racconta quasi tutta la vicenda in una prima persona plurale ondivaga che a volte prende il punto di vista dei figli, a volte quello dell’intero nucleo familiare: “inizia il giorno in cui la prima affezione colpì la casa dove abitavamo, e finisce quando su di noi si abbatté una catastrofe alquanto insolita”, spiega impersonalmente nella Prefazione; ma aggiunge anche, dopo qualche pagina, di esser entrato una volta in cucina e di essersi sentito “un essere straniero penetrato per sbaglio nell’appartamento”. Il suo nome e le sua attività possono destare un qualche interesse, specie se confrontati con quelli degli altri personaggi che vivono insieme. Phatrizio infatti a quanto pare non fa nulla, non sappiamo bene che età abbia, si aggira spesso per casa con una grossa radio sotto l’ascella, lavorerà per poco come conducente d’autobus, perdendosi in città e forse portando a casa malattie sconosciute, così che i genitori ad un certo punto lo scoraggiano dal proseguire il lavoro. L’altro fratello della storia (tutti i componenti della famiglia come si diceva vivono sotto allo stesso tetto) è medico, uno dei tanti medici capaci di far diagnosi e conferenze ma non di guarire che s’incontrano nei romanzi di Salabelle, e si chiama più semplicemente Federico; la sorella cronista e scrittrice, non si sa se in formazione per diventar madre di famiglia sua o per sostituire la madre della famiglia di partenza, è, vezzosamente, Maria Paola (ad un certo punto si dice che “russava in modo intermittente che ricordava lo stile della sua cronaca”); il fidanzato per una stagione della sorella (compare in un capitolo del romanzo pubblicato come racconto su “Riga” 6, dedicato a Delfini) è qualcosa di simile ad un intellettuale, forse dotto di materie scientifiche: porta il biblico o anche evangelico nome di Giuseppe. Il padre mischia liquidi, legge giornali o li sposta; la madre infine non ha nome, ma come tante donne di Salabelle si segnala per le sue notevoli dimensioni, per il suo avere in mano o brandire qualcosa quando entra in scena (un mestolo, una patata, una rivista), e per i suoi commerci piuttosto oscuri con un proibito di bassa lega, un po’ provinciale (sigarette d’incerta provenienza, donate a chi fa l’uomo di casa in quel momento; biglietti con su scritte scommesse familiari sul prossimo film che si proietterà in cucina). Ecco dunque, per restare sulle generali, si può dire che diversi personaggi di Salabelle hanno nomi e attività come quello di Phatrizio, tra il verosimile lontano, il fallimento previsto e l’assurdo anche rispetto a quelli di altri personaggi dello stesso libro; in molti nomi di questi personaggi disutili l’acca è aggiunta e sottratta con minimo capriccio (il protagonista dell’Assistente inaffidabile si chiama Filip; c’è poi il Lhardo del Mio unico amico e il Philippo dell’Altro inquilino, per fare qualche esempio). Ed è forse questo un altro modo per ricordare da lontano il linguaggio e il fare umani, attaccandoli per così dire nelle loro zone più arbitrarie, i nomi propri e le occupazioni, e insieme per ribadire il meccanismo garbatamente ma puntualmente deragliante nei confronti dei saperi ricevuti e delle convenzioni narrative che Salabelle pone a presidio della sua scrittura e dei suoi racconti.
Sul trattamento di queste convenzioni e saperi la Famiglia che perse tempo contiene tutta una serie di luoghi noti alla letteratura e ricorrenti nelle opere di Salabelle, tanto che il libro si dà, oltre che come testo da leggere per sé, come una sorta di atlante di temi sviluppati altrove da questo autore in modo simile eppure differente (è il segno o no di un grande scrittore esercitarsi su temi non nuovi, mantenendo il proprio tono e la propria riconoscibilità di visione in tanti plot che sono sempre diversi?). Il tema della malattia, per esempio, tanto frequente nelle sue scritture, è qui come in altri libri affrontato nella chiave di un positivismo ridotto ai minimi termini ed estremizzato, spesso messo in bocca a un medico o a una persona che evidentemente riporta pareri tecnici di medici o specialisti un po’ meccanicamente e un po’ mettendoci del suo, di certo senza aver letto nessuno dei libri cui questi specialisti in genere attingono. Oggetti, posti e uomini democraticamente s’ammalano alla stessa maniera, e se sono sempre gli oggetti e i luoghi ad avere, nell’idea dei personaggi, il potere infettivo iniziale, anche oggetti e luoghi davanti agli occhi del lettore muoiono, si bucano, vanno in autocombustione – il fratello medico Federico esaminerà un giornale, ad un certo punto, verosimilmente infetto: “Questo giornale è già morto”, la sua diagnosi, “inizierà a puzzare tra due o tre ore; bisogna provvedere immediatamente”. La famiglia, poi, è un microuniverso chiuso, una fragile gabbia che per tenersi insieme si protegge dal fuori e infine lo contagia e ammala. Questo microcosmo ha le proprie regole arbitrarie, pazze e tuttavia scalfibili solo dall’interno (“dentro la stanza di nostro padre l’avvicendarsi delle ore seguiva un ritmo piuttosto rapido, a causa del quale gli orologi si muovevano come impazziti. Chiamavamo questo fatto semplicemente ‘l’ora legale’ sottintendendo che eravamo noi nella legge”). E dunque la famiglia è del tutto simile, nel concetto, ad altri luoghi chiusi prediletti di Salabelle: il negozio d’abbigliamento in rovina dove si può organizzare un omicidio per sbaglio come ordinare un abito fatto interamente di tabacco per provare a smettere di fumare; o ancora la scuola, questo mondo alla rovescia dove vige un linguaggio ignoto al resto del mondo (“fare” e non “leggere” Foscolo; “finire” il programma; “segnare” su un “registro”), dove si trovano oggetti infettivi in sommo grado e fatiscenti (banchi, lavagne, cattedre), e infine dove s’impara, specie grazie alle materie letterarie, a “dire l’esatto contrario di ciò che sarebbe normale dire” per esprimere invece ciò che l’istituzione accetta che al suo interno venga detto. È in posti come questi che il “dentro” arbitrario riesce a prendere il peggio dell’arbitrarietà e delle provvisorietà del “fuori”, a masticarle e ributtarle nel mondo come morbo dilagante, fino all’esplosione atomica. Esplosione che negli altri romanzi di Salabelle non c’è o viene smorzata, e che invece nella Famiglia che perse tempo avviene e viene descritta con un pudore e una ferocia introvabile nella letteratura di quegli anni e di questi nostri. Nell’ultimo capitolo del romanzo si legge del disastro tutto intorno, della fine del tempo interamente consumato e fatto nullo tra le pareti domestiche, del trionfo della televisione che prima proietta film scialbi (meno belli di quelli che la famiglia proiettava in cucina tempo prima) e che adesso fa posto a immagini di città distrutte, poi a uno speaker che dice non c’è più niente da fare: salvatevi da soli. Phatrizio cerca di scrivere un saggio sullo spazio e sul tempo, non ha più voglia di leggere, il padre che era scomparso per esser troppo malato ritorna in casa, lui subito dopo s’ammala, viene visitato da un medico anziano “con alcuni apparecchi lucenti, la cui assurda inutilità mi si rivelò nel giro di un attimo” (“Non deve bere acqua dal rubinetto per perlomeno una settimana. E non deve fare sforzi non necessari”, la diagnosi dell’attempato luminare). Dunque il tempo è finito, i giornali sono morti, la televisione è scappata, le voci della radio e le immagini del cinema non ci sono più: la vita malata della famiglia però continua, una volta buttati gli orologi nel cestino. Al lettore, s’è già detto, spetta di scegliere cosa fare di queste parole, vetri affilati che deturpano vecchio e nuovo, mostrando come trionfante solo il peggio. Salabelle, per parte sua, mette punto. E senza scomporsi troppo, com’è sua natura, ci consegna una delle più limpide e disturbanti storie della morte e dell’orrida, immediata resurrezione degli ingranaggi del mondo scritta (descritta?) negli ultimi quarant’anni.
di Roberto Pozzetti
![]() 1. Lo sguardo che diagnostica la follia
1. Lo sguardo che diagnostica la follia
La clinica ci insegna come il rapporto di un soggetto con lo sguardo si dimostri di capitale importanza. Già da Freud, in Pulsioni e loro destini, la psicoanalisi ha studiato la coppia antitetica guardare-mostrarsi al cui cuore vi è lo sguardo. Come quest’ultimo è caratteristico degli svariati tratti della perversione voyeurismo-esibizionismo, così al centro dei tratti perversi sado-masochistici si ritrova la voce. La sessualità umana si organizza sempre intorno a delle vie perverse senza fare di questo un verdetto moralistico né tantomeno psicopatologico.
Focalizziamoci su come cambia la posizione nei confronti dello sguardo, sulla base di modificazioni sociali e della storicità dell’inconscio.
Nell’epoca “liquida”, per dirla con un’azzeccata quanto inflazionata espressione di Bauman, vi sono ancora una serie di istituzioni che costituiscono dei resti, dei residui della logica normativa tradizionale. Tali contesti erano i luoghi deputati da un’organizzazione disciplinare alla correzione, prevalentemente residenziale, di soggetti che deviavano dalla regole nei modi più svariati. Come ci ricorda Marc Augè, il luogo antropologico si costituisce come un ambito nel quale viene a sedimentarsi una memoria, una cultura condivisa, una storia per quanto drammatica. Avevamo il Carcere come spazio di reclusione per i cosiddetti antisociali, l’Ospedale Psichiatrico e la stultifera navis come luoghi di segregazione per l’anormalità psichica, Il berretto a sonagli pirandelliano quale distintivo del malato di mente, i ghetti ove isolare gli ebrei, gli alloggi in cui ammassare i proletari nei quartieri dormitorio.
Stultifera navis è il titolo del primo capitolo del famoso libro di Michel Foucault Storia della follia nell’età classica. Al declino del Medioevo scompare la figura maggiormente temuta, quella del lebbroso. Di conseguenza i lazzaretti e i lebbrosari, nei quali i malati venivano reclusi, si svuotano. La tesi di Foucault è che l’esperienza della segregazione dei folli continui quella avvenuta con i lebbrosi. A partire dal XVII secolo le strutture architettoniche dei lebbrosari vengono recuperate come luogo di internamento dei folli. Lo sguardo che si dirigeva sulla follia nell’età classica era – dice Foucault – “uno sguardo affascinato, nel senso che la riconosceva come indefinitamente vicina e indefinitamente lontana”.
Tra la il Settecento e l’Ottocento Pinel, Esquirol e Falret, alla Salpetrière, restituiscono alla malattia psichica uno statuto di dignità tale per cui l’asilo non è più soltanto una forma di marginalizzazione ma ha un obiettivo più dichiaratamente medico e terapeutico. Tuttavia lo la clinica dello sguardo situa in secondo piano la dimensione della parola. Ciò che conta nella clinica medico-psichiatrica classica non è l’ascolto di quanto dice il paziente ma è lo sguardo del medico che, sulla scorta della semeiotica, classifica in termini nosografici gli internati. La diagnosi basata sullo sguardo lascia ben poco spazio alla parola ed al discorso del paziente. Nella psicoanalisi sono indispensabili linguaggio e parola, come si può notare con la regola dell’associazione libera in cui si è invitati a dire tutto ciò che passa per la mente, senza pudore e senza ritegno.
2. Lo sguardo che giudica
Lacan, già nello Scritto sulla criminologia del 1950, aveva fatto un riferimento ironico all’utilitarismo di Bentham e alla contraddizione dei giuristi di tale impostazione. Essi sostenevano il diritto di punire chi compie un crimine per trarne un profitto mentre esitavano dinanzi a crimini che non rientrano nella logica del principio di piacere: “Sicuro di sé, persino implacabile, quando appare una motivazione utilitaria il pensiero dei penologi esita di fronte al crimine in cui appaiono istinti la cui natura sfugge al registro utilitaristico in cui si svolge il pensiero di un Bentham”.
E’ tuttavia Foucault a porre in risalto il Panopticon nel suo celebre Sorvegliare e punire. Bentham scrisse una lettera ai governanti europei di fine Settecento in cui proponeva, in collaborazione col fratello ingegnere, il dispositivo dell’istituzione panottica. Nel 1977, anche il giovane J.A. Miller ne parla nel testo La macchina panottica di Jeremy Bentham.
Il dispositivo panottico è un edificio circolare al cui centro si trova una torre di sorveglianza. Lungo la circonferenza, su ciascun piano, si trovano le celle (quali le sezioni a forma di raggio di San Vittore). Il panottico viene proposto da Bentham non solo per le carceri ma anche per i manicomi, gli ospedali, le scuole, gli alloggi per i poveri.
Il punto essenziale è che dalla torre centrale è possibile sorvegliare senza essere visti. In termini che ricordano il Super-Io come interiorizzazione di un oggetto imperativo come può essere lo sguardo, Bentham suppone che, essendo sempre guardati, i sorvegliati interiorizzeranno la funzione del controllo divenendo virtuosi per il solo fatto di essere guardati. Lo scopo è quello di reinserire il sorvegliato nel sistema produttivo in modo tale da poter utilizzare il suo tempo in termini operativi, senza dissiparlo. E quale risparmio comporterà il panopticon in termini di superamento del castigo e del dolore corporale. Infatti la guardia carceraria interviene senza armi e senza strumenti di coercizione fisica. Tutto questo perché, come sottolinea Miller, “non c’è nessuna crudeltà in Bentham. A questo riguardo è senza dubbio il filantropo che voleva essere. La crudeltà infatti è gratuita, improduttiva”. La crudeltà contrasterebbe con la pragmatica dell’utile.
Tutti sono sorvegliati dallo sguardo tranne l’ispettore del Carcere. Per la cronaca, Bentham si propose lui stesso come ispettore di un panopticon, a coronamento del suo progetto delirante.
Sia nel trattamento della follia sia nel carcere panottico, lo sguardo ha una funzione correttiva. Lo sguardo giudica, controlla, sorveglia. Lo sguardo rende virtuosi.
3. Il dispositivo dell’esibizione
Nel suo ultimo intervento pubblico, in un convegno dedicato a Foucault, Deleuze si domanda: Che cos’è un dispositivo ? “I dispositivi hanno come componenti linee di visibilità, di enunciazione, linee di forza, linee di soggettivazione, di fenditura, di incrinatura, di frattura che si intrecciano e si aggrovigliano tutte, e di cui le une ricostruiscono le altre o ne suscitano di nuove attraverso variazioni di concatenamento”.
Nell’epoca del declino del Padre, non troviamo quasi più istituzioni centrate sulla dimensione segregante e di esclusione. Le istituzioni psichiatriche tendono ad aprirsi dopo la Legge Basaglia, con la chiusura dei manicomi; le comunità per tossicodipendenti accolgono utenti che non avrebbero mai accettato fino a pochi anni fa (pazienti in terapia metadonica, giovani cocainomani per moduli brevi); l’eterno problema del sovraffollamento carcerario, dovuto soprattutto alla reclusione di extracomunitari, per la scellerata legge Bossi-Fini, viene gestito con gli indultini.
E’ l’effetto di una serie di cambiamenti sociali e dei dispositivi. Vi è un’apparente inclusione in un clima individualistico di libertà e di benessere là dove la funzione marcatamente disciplinare e normativa del Padre viene ad incrinarsi. La società propone sempre più un piano di conformismo orizzontale, fra pari. Sostiene Lacan: “in una civiltà in cui l’ideale individualista è stato elevato a un grado di affermazione prima sconosciuto, gli individui si trovano a tendere a uno stato in cui penseranno, sentiranno, faranno e ameranno esattamente le stesse cose alle stesse ore in porzioni di spazio strettamente equivalenti”.
In questa variazione del dispositivo, si passa dallo sguardo che sorveglia, che giudica, che controlla, che osserva, che spia, ad un nuovo situarsi nei confronti dello sguardo. Oggi prevale l’apparire a tutti i costi, la visibilità viene ricercata postando di continuo stati inediti su Facebook, cambiando foto su Whatsapp, pubblicando video su YouTube, scattandosi un selfie. Il soggetto ha l’impressione di esistere se fa tutto questo. Ha un posto se posta una descrizione di sé e ottiene un riconoscimento nella forma dei followers e del like. Prendiamo l’esempio eclatante della ragazza che si è fatta fotografare dinanzi ad un’automobile incendiata, in occasioni dei fatti di Milano del recente Primo Maggio. Dinanzi a un evento del genere questa avvenente giovane (forse una turista proveniente dall’Est Europa) non trova di meglio che farsi riprendere in una logica analoga a quella del selfie, sia pur tecnicamente diversa. Si consideri l’interesse suscitato, ormai da oltre un decennio, dal programma TV Il Grande Fratello e dai numerosi reality più recenti alle cui selezioni molti fanno la fila per partecipare. Nell’epoca dell’eclissi del Padre abbiamo il riferimento al testo di Orwell per caratterizzare le dinamiche di un gruppo infarcito di un bieco esibizionismo ma anche di una feroce istanza superegoica.
Ecco La Società della trasparenza descritta da B. -C. Han. L’esigenza di trasparenza e di correttezza si ripresenta ciclicamente, anche in Italia, in occasione di indagini giudiziarie e quale chiarificazione il cui apice è costituito dalle dirette in streaming delle riunioni fra partiti. La formula della trasparenza ha trovato una diffusione inusitata grazie a Gorbaciov, negli anni Ottanta. Egli propose la glasnost (termine russo tradotto con trasparenza) come una parola d’ordine fondamentale. Discutere apertamente dei problemi sociali, delle contraddizioni del sistema, rivelare i segreti dell’apparato burocratico del PCUS che si opponeva al rinnovamento, costituiva un punto basilare di ordine tattico-strategico. Sorprende che un intellettuale colto e raffinato come B.-C. Han non vi faccia riferimento, asserendo che “il sistema della trasparenza abolisce ogni negatività” in riferimento alla dialettica negativa di matrice hegeliana. Si rintracciava forse tale dialettica nelle riunioni a porte chiuse del PCUS ? Credo vi sia ben poco da rimpiangere della società pre-glasnost.
Si dice, forse a ragione, che nel mondo occidentale prevale il narcisismo e se ne colgono le implicazioni cliniche in problematiche ad insorgenza adolescenziali come i Disturbi Alimentari. Anche il panico ha spesso una correlazione con una difficoltà nei confronti dello sguardo.
Dobbiamo distinguere il vedersi allo specchio dallo sguardo altrui. Lo sguardo non sta nel vedersi, nel riflettere la propria immagine à la Narciso: implica lo sguardo dell’Altro.
In effetti lo stadio dello specchio stigmatizzato da Lacan non è senza rapporto con lo sguardo, quello dell’adulto che sostiene il bambino dinanzi allo specchio stesso.
E’ questa la tesi essenziale cui giungo: il narcisismo apparente, nell’esibizione senza pudore e senza timore del giudizio, costituisce un appello allo sguardo dell’Altro (del padre, della madre, del fidanzato e così via). Questo avviene in una dialettica che implica sempre il riconoscimento dell’Altro. Non vi è, in effetti, autostima: è la stima dell’Altro che porta a stimarci. E’ essere desiderati e amati dall’Altro che ci fa esistere come soggetti.
di Vincenzo Pardini
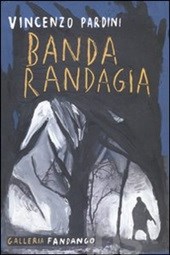 Nessuno, da tempo, apriva i cassetti dell’antico canterano che si trova in una stanza del mia antica casa. Lo specchio che lo sormonta mostra chiazze e sbavature che paiono i sedimenti di una ragnatela. In passato ci si ammiravano le mie ave, e anche mia madre ragazzina. Ora non sarebbe più possibile. Deforma le immagini. Quasi volesse farsi beffa delle vanità,o fosse deluso del suo ruolo.
Nessuno, da tempo, apriva i cassetti dell’antico canterano che si trova in una stanza del mia antica casa. Lo specchio che lo sormonta mostra chiazze e sbavature che paiono i sedimenti di una ragnatela. In passato ci si ammiravano le mie ave, e anche mia madre ragazzina. Ora non sarebbe più possibile. Deforma le immagini. Quasi volesse farsi beffa delle vanità,o fosse deluso del suo ruolo.
Una a una ho aperto le cantere del comò. Stridevano come animaletti disturbati nel sonno. Erano vuote, con l’odore del legno tarlato. Nell’angolo di una, ho veduto un grosso insetto dalla testa lucente: era un coltellino di appena quattro dita. Il manico di legno nero mostrava cavità irregolari grandi come teste di formica. Il tarlo. L’ho aperto. La molla ha emesso uno scatto ch’era voce. La lama, un po’ consunta, denotava un lieve strato di ruggine. Ma i bottoni d’ottone brillavano. Sembrava un piccolo essere liberato da un’ingiusta, quanto lunga prigionia e sentivo che voleva starmi appresso. Me lo sono messo in tasca. Era una calda giornata d’estate, quando i sassi dei muri hanno la febbre, tanto scottano e le persone cercano refrigerio. Una calura che può essere anche desolazione; la campagna è muta e solitaria e le cicale emettono il canto senza fine delle prefiche. Nondimeno nei vicoli dei paesi montani, il sole non arriva mai con la sua irruenza; ci sono addirittura angoli, esposti alla tramontana, dove il muschio è verde e fresco come d’inverno. Spifferi di vento escono dalle cantine. I vecchi, se non sono in casa, li troviamo al fresco negli orti. Stanno lì, dentro un tempo che sentono tutto loro: li ha risparmiati e non ancora traditi. Non lo temono più. Andai a far visita a una mia parente, quasi centenaria. Mi raccontò che il paese, una volta, sembrava un castello. Racchiuso tra le mura, aveva quattro porte. Ve n’è rimasta una, con la feritoia dell’arciere, simile alle altre, demolite per far passare i muli. Nel paese c’era vita. Pullulava di gente, di voci e rumori: le filande giravano e i telai delle tessàndore (le tessitrici), con dei brevi contraccolpi di legno, intessevano gli orditi. Quando le ho mostrato il coltellino, ha esclamato:«Oh perdinci, era quello di tuo nonno. In du l’hai trovo? Tientene di conto: un bel ricordo!» Fatta una pausa, guardata la campagna, ha ripreso: «Mi pare di rivederlo nelle sue grosse mani. Tutti, a quei tempi, portavano il coltello. Serviva per diversi lavori, tra cui affettarci il pane e il companatico, o per ammezzare i sigari Toscani, come faceva anche tuo nonno. Sarà stato nel Venti. Io una ragazza, lui un uomo. Insieme andavamo alle pecore.»
Il coltellino fu dunque impiegato per usi diversi. Ne reca i segni: oltremodo affilata, la lama è un poco allentata come avesse trafitto un corpo; due scalfitture sfregiano i bottoni d’ottone. Un coltello leggero, per rapidi e piccoli lavori che accompagnano la vita di ogni giorno. Quando vado in un luogo antico, poniamo una chiesa, sento mi si riversano dentro sensazioni che, se chiudo gli occhi, possono trasformarsi in immagini. Non è vero che il passato si cancella. L’abbiamo intorno e dentro, ma non si lascia vedere, solo percepire. Il coltellino, quasi la sua lama avesse liberato trapassate memorie, mi ha riportato ai giorni del nonno. Dolori e angosce sopraffanno i momenti lieti. Ho ereditato le sue malinconie, solitudini e ire. Peraltro la sua vita non fu granché lunga. Il coltellino assecondava i suoi umori col silenzio proprio degli oggetti che vivono con noi.
Molti dei suoi coetanei viaggiavano con coltelli ben più grossi. Alla bisogna li usavano non soltanto nei lavori, ma anche come strumento di difesa o offesa. Sebbene lui fosse turbolento, era sicuro di sé. Aveva una gran forza fisica e gli bastava. Il coltellino era un accessorio, non un’arma. Felice d’averlo resuscitato da un limbo che gli durava da oltre mezzo secolo, lo impiego in piccole mansioni. Sento che unisce la mia vita a quella del nonno, riportandomi ai suoi sogni e progetti. I medesimi che la mente, nel momento in cui si muore, lascia in sospeso alla stregua di sogni. Uno di questi potrebbe essermi giunto proprio tramite il coltellino. Mi ha infatti sollecitato ricordi svaniti. Mostratolo a un amico, saggiatone con un dito il taglio, ha detto:«Potrebbe far male, molto male.»
Bambino, un pomeriggio d’inverno, la nonna mi mandò alla bottega a comprare una bottiglia d’olio. Al centro della stanza, alcuni paesani attorniavano due vecchi. I quali, con scatti improvvisi e veloci, muovevano un braccio riportandolo all’altezza del mento. Mi sembrava giocassero, quando m’avvidi impugnavano un coltello col taglio rivolto all’esterno. Avevano la faccia immobile e tesa; a uno gli sanguinava. Un po’ si fissavano negli occhi, poi sferravano il colpo emettendo un sospiro. «Spartiteli, che sennò s’ammazzano!», implorava la bottegaia. Tutti tacevano e, nell’aria, c’era odore di sugna. D’improvviso, come quando il vento spalanca una finestra, entrò il parroco con un lembo della veste in mano. Andò dai vecchi. Fui allontanato, non ricordo da chi. Troppo tardi. Avevo visto come si usa un coltello. E non l’avrei dimenticato.
[questo magnifico racconto di Pardini è tratto da “Banda Randagia”, Fandango, 2010; e intendiamoci, la mia non è una particolare affinità con il mondo (seppure altamente evocativo) contadino/rurale spesso descritto dall’autore, e nemmeno con il suo registro linguistico (seppure bellissimo) non è questo; quello che mi colpisce è la potenza, la singolarità e l’intelligenza dello sguardo, la sua profondità; se ci fosse qualche autore che riesce a fare la stessa cosa anche con “materiali attuali”, con una lingua “più contemporanea”, prego di segnalarmelo; ma ci sarebbe molto da dire, e molto da ragionare; però partendo appunto dalla qualità dei testi, dalla loro potenza; confesso che ogni altro approccio e/o tentativo di cartografia, anche se molto intelligente, anche se profondo, e ho in mente vari esempi, mi sembra – e parlo alla luce della mia “pratica di scrittura” – vano]
di Ornella Tajani
Come ricorda André Breton negli Entretiens, Robert Desnos fu l’unico a tingere di un “gusto romantico del naufragio” le sperimentazioni del sonno ipnotico: fu il poeta che, provando a sondare in profondità il meraviglioso surrealista, finì con l’essere risucchiato in una sorta di vortice. Del resto non di rado le conseguenze di quegli esperimenti di oscillazione tra la veglia e il sonno diventavano estreme: Breton racconta ad esempio di un post prandium a casa di Paul Éluard, in cui Desnos addormentato inseguì il suo ospite per tutto il giardino con un coltello in mano.
I tre componimenti che seguono sono tratti dall’antologia Corps et biens, pubblicata nel 1930 (oggi Gallimard, 1968) e inedita in italiano.
Il primo, Ti ho sognata talmente, è dedicato alla cantante e attrice belga Yvonne George, per la quale sembra che Desnos provasse un amore non ricambiato.
Dell’ultimo, Il trucco degli Argonauti, propongo per ora soltanto le prime strofe.
Desnos è morto nel 1945 nel campo di concentramento di Theresienstadt, a quarantaquattro anni.
[Trad. mia]
—
Ti ho sognata talmente
Ti ho sognata talmente che ormai perdi realtà.
Ancora posso raggiungere quel corpo vivo e poi baciare sulla bocca la nascita della voce che mi è cara?
Ti ho sognata talmente che le braccia abituate stringendo la tua ombra a incrociarsi sul mio petto non si piegherebbero al profilo del tuo corpo, forse.
Talmente, che davanti all’apparenza reale di quello che mi infesta e mi governa da lunghi giorni e anni diverrei probabilmente un’ombra,
care bilance d’ogni sentimento.
Ti ho sognata talmente che è probabilmente tardi per svegliarmi. Dormo in piedi, il corpo esposto a tutte le apparenze della vita e dell’amore e tu, la sola che conti oggi per me, è più difficile toccarti fronte e labbra che toccare le prime labbra e fronti capitate a tiro.
Ti ho sognata talmente, e camminato, parlato, dormito con il tuo fantasma che forse non mi resta più, eppure, che essere fantasma fra i fantasmi e ombra cento volte più dell’ombra che avanza e allegra avanzerà sulla tua meridiana della vita.
[Da À la mystérieuse, 1926]
—
Al mocassino il verbo

Tu mi suicidi, così docilmente
Eppure un giorno ti morirò.
Io conosceremo la donna ideale
e lentamente le nevicherò in bocca
E forse pioverò anche se io è tardi, anche se
io è bel tempo
Noi amate i nostri occhi così poco
E scoppierò una lacrima senza
ragione è chiaro e senza tristezza.
senza.
[Da Langage cuit, 1923]
—
Il trucco degli Argonauti
Le puttane di Marsiglia hanno sorelle oceano
Che con baci malsani vi imputridiranno.
Nella taverna il valzer di un gruppo zigano
Fa danzare le ninfe al rumore del mare.
Naviganti che intonate un motivo nostalgico,
Partiti su galere o battelli a vapore,
Sperate che un sistro o un violino magico
Incanti i marinai troppi inclini al terrore?
La leggenda sonnecchia altera e antiquata
Nel lugubre bronzo che fu trono al passato
Degli Argonauti che in epoca remota
Partirono alla conquista del vello orientale.
Sulle vostre tombe i funghi sornioni
Loderà Nerone in un’orgia claudiana
O forse una sera gli sguatteri osceni
Scopriranno i vostri occhi nel corpo dei pesci.
Partite! arpa eolica, la tempesta geme…
[…]
[Le fard des Argonautes, 1919]

Un estratto dal libro NarcoGuerra. Cronache dal Messico dei Cartelli della Droga (Odoya, 2015).
En Guatemala, señores, cobraron la recompensa
allí agarraron al Chapo las leyes guatemaltecas
un traficante famoso que todo el mundo comenta
de la noche a la mañana el Chapo se hizo famoso
encabezaba una banda de gatilleros mafiosos
con un apoyo muy grande del güero Palma su socio
el Chapo tenía conectes con los narcos colombianos
y traficaba la droga de Sudamérica en grano
al norte del continente donde tenían el mercado
In Guatemala, signori, hanno riscosso la ricompensa
là hanno catturato il Chapo le leggi guatemalteche
un trafficante famoso che sta sulla bocca di tutti
dalla sera alla mattina il Chapo è diventato famoso
era a capo di una banda di pistoleri mafiosi c
on un sostegno molto grande del biondo Palma, suo socio
il Chapo aveva agganci coi narcos colombiani
e trafficava la droga dal Sud America in granelli
nel nord del continente dove avevano il mercato
Dal narcocorrido “El Chapo Guzmán” della band Los Tucanes de Tijuana.
 «Messico e nuvole» cantavano Jannacci, Paolo Conte e tanti altri, ognuno con la sua cover. La cocaina, che per il Messico deve transitare, a volte solcando le nuvole, altre navigando o strisciando nella polvere, è musica. Cocaine è un classico del cantautore americano J.J. Cale, scomparso il 26 luglio 2013. Nel mio anno di nascita, il 1977, Eric Clapton fece una cover della canzone e la consacrò alla storia: «La coca non mente / se vuoi cadere per terra / cocaina» diceva. Il Messico ne è il principale esportatore e rifornisce più dell’80% del mercato usa. Gli oltre tre milioni di consumatori statunitensi di “Biancaneve” ringraziano. La cocaina è anche parola. Questa polvere così ambita è il tema centrale di ZeroZeroZero: viaggio nell’inferno della coca, libro di Roberto Saviano che, a sette anni da Gomorra, amplia il discorso sulla criminalità organizzata e sposta da Napoli al Messico, dall’Italia al mondo, il fuoco dell’attenzione. In primo piano sullo sfondo nero della copertina spiccano tre strisce brillanti di coca, tre zampilli di petrolio bianco. Il triplo zero, 000, allude alla farina migliore per fare la pasta. E la coca non è solo una pianta, una droga, musica o letteratura, ma è soprattutto la “pasta del mondo”, una delle materie prime che muovono il capitalismo globale.
«Messico e nuvole» cantavano Jannacci, Paolo Conte e tanti altri, ognuno con la sua cover. La cocaina, che per il Messico deve transitare, a volte solcando le nuvole, altre navigando o strisciando nella polvere, è musica. Cocaine è un classico del cantautore americano J.J. Cale, scomparso il 26 luglio 2013. Nel mio anno di nascita, il 1977, Eric Clapton fece una cover della canzone e la consacrò alla storia: «La coca non mente / se vuoi cadere per terra / cocaina» diceva. Il Messico ne è il principale esportatore e rifornisce più dell’80% del mercato usa. Gli oltre tre milioni di consumatori statunitensi di “Biancaneve” ringraziano. La cocaina è anche parola. Questa polvere così ambita è il tema centrale di ZeroZeroZero: viaggio nell’inferno della coca, libro di Roberto Saviano che, a sette anni da Gomorra, amplia il discorso sulla criminalità organizzata e sposta da Napoli al Messico, dall’Italia al mondo, il fuoco dell’attenzione. In primo piano sullo sfondo nero della copertina spiccano tre strisce brillanti di coca, tre zampilli di petrolio bianco. Il triplo zero, 000, allude alla farina migliore per fare la pasta. E la coca non è solo una pianta, una droga, musica o letteratura, ma è soprattutto la “pasta del mondo”, una delle materie prime che muovono il capitalismo globale.
La coca partorisce cocaina, dalla ricchezza originaria sbocciano valori e capitali, si moltiplicano come pani e pesci che rifocillano l’economia. Infatti oggi i cartelli del narcotraffico sono più simili a frammenti coordinati di ciclopiche multinazionali, o meglio a enti gestori di enormi reti di produttori e distributori decentralizzati, piuttosto che alle mafie di un tempo. Le idealizzazioni romantiche di pellicole leggendarie come Scarface, Goodfellas, Il Padrino, Car- lito’s Way e Donnie Brasco hanno ceduto il posto a organizzazioni più o meno integrate verticalmente, dal produttore al consumatore, e orizzontalmente, cioè diversificate su più divisioni o linee d’affari: dal commercio di stupefacenti alla tratta di esseri umani, dal furto di combustibile al contrabbando di animali esotici e pietre preziose, dall’estorsione e il riciclaggio al traffico d’armi, dal furto d’auto alla contraffazione e al sequestro di persona. Sempre più spesso i giovani pushers legati a una gang loca- le o direttamente a un cartello nazionale possono assumere le sembianze del piccolo commerciante, dell’esperto in logistica e trasporti, del venditore sagace o dell’imprenditore. Il “fattore violenza”, o la semplice minaccia del suo uso, è una costante e differenzia il business legale dall’illecito.
 Dal Messico arrivano alcune rappresentazioni cinematografiche attuali e suggerenti sul mondo del narcotraffico e del crimine. Titoli come Amores Perros di Alejandro González Iñarritu, vincitore del Premio Oscar nel 2015 con Birdman, La zona di Rodrigo Plá, El Infierno di Luis Estrada, Colosio: el asesinato di Carlos Bolado, Miss Bala di Gerardo Naranjo, Bala Mordida di Diego Muñoz. La lista, le locandine e qualche recensione di produzioni decisamente meno internazionali e più trash, per esempio El pistolero, El comando del diablo, Narcoguerra e Welcome to Tijuana, si trovano sul sito www.narcopeliculas.net.
Dal Messico arrivano alcune rappresentazioni cinematografiche attuali e suggerenti sul mondo del narcotraffico e del crimine. Titoli come Amores Perros di Alejandro González Iñarritu, vincitore del Premio Oscar nel 2015 con Birdman, La zona di Rodrigo Plá, El Infierno di Luis Estrada, Colosio: el asesinato di Carlos Bolado, Miss Bala di Gerardo Naranjo, Bala Mordida di Diego Muñoz. La lista, le locandine e qualche recensione di produzioni decisamente meno internazionali e più trash, per esempio El pistolero, El comando del diablo, Narcoguerra e Welcome to Tijuana, si trovano sul sito www.narcopeliculas.net.
20.000 milioni di dollari. Una delle cifre che descrivono il flusso globale del narcotraffico. L’1,5% del PIL mondiale e sempre più contendenti che provano a spartirsi il bottino. I capi assomigliano sempre più a imprenditori e non solo a sicari spietati. Senza idealizzare troppo gli aspetti manageriali del narcotraffico, ben illustrati in film come Savages e Traffic o in serie come Breaking Bad e la colombiana El cártel de los sapos, resta pur vero che nel capitalismo globalizzato a ogni mercato e a ogni domanda corrispondono offerte e stimoli per la produzione connessi a livello internazionale. L’uso della violenza è strutturale, vista l’assenza di garanzie contrattuali e legali, per cui gli affari si basano su equilibri instabili, sul potere di minaccia, sui vincoli familiari e sul rispetto, ma anche sulla permeabilità e connivenza delle istituzioni e delle forze di polizia. La differenza con altri commerci è banale ma essenziale: la cocaina è illegale, e lo sono la sua produzione, distribuzione e consumo. Pertanto, l’uso della forza e il potenziale di fuoco diventano determinanti per “regolare” le transazioni nel mercato, non essendoci altro sistema “legale” o condiviso per farlo.
La foglia di coca si coltiva praticamente solo in Colombia, Bolivia, Perù ed Ecuador. Nell’ultimo lustro la Colombia ha perso la sua tradizionale leadership in favore del Perù. Secondo i dati del think tank Insight Crime, nel 2010 i 53.000 ettari peruviani di coltivazioni di coca assicuravano 325 tonnellate di cocaina pura, 60 in più rispetto a quanto si ricavava dai 100.000 ettari coltivati in Colombia. Nel 2012 l’estensione delle coltivazioni in Colombia è scesa del 50%, mentre in Perù la cifra arrivava a 60.000 ettari. L’Ecuador è defilato rispetto agli altri. Il ciclo del denaro originato da una foglia, convertita in stimolante per trecentotrenta milioni di potenziali consumatori, comincia nell’illegalità e poi rientra nel sistema, circola, si ripulisce e si ricicla. La produzione totale s’è stabilizzata intorno alle mille tonnellate all’anno.
Il Messico è diventato il centro del mondo, il nucleo dei flussi che lo attraversano passando per le Ande, gli Stati Uniti, l’Europa, la Russia, l’Africa, l’Oriente e l’Oceania. Le principali vie della droga, segnalate da Ameripol e la UE, sono almeno sei. La ruta settentrionale parte dal Sud America, passa dai Caraibi e finisce in Spagna e Portogallo, porte d’Europa. Quella centrale è simile ma più diretta, dato che dal Venezuela alla penisola iberica c’è solo uno scalo alle Canarie o a Capo Verde. La via africana va dal Sud America, specialmente dal Brasile, a paesi come la Liberia, la Nigeria, la Costa d’Avorio, il Ghana, il Togo, la Sierra Leone, la Guinea, la Guinea Bissau e il Senegal per poi tagliare il Sahara e il mar Mediterraneo verso nord.
La via nordamericana attraversa l’America centrale, con scali e ponti aerei in Nicaragua e nel “triangolo della morte”, formato da Guatemala, Honduras ed El Salvador, e arriva negli usa percorrendo il Messico. Altri flussi circumnavigano l’Africa e, toccando il Capo di Buona Speranza, nella Repubblica Sudafricana, e il Madagascar, imboccano il Canale di Suez e sboccano in Europa e in Russia passando dalla Turchia. Altri ancora prendono la via del Balcani: dalla Turchia, la Romania e la Bulgaria all’Italia, la Russia e agli stati nordeuropei. Le sostanze si mimetizzano come medicine e pastiglie comuni, si nascondono in pacchi inviati per posta e nei container, s’occultano nei bagagli o negli stomaci delle mulas, cioè di persone al soldo delle narco-organizzazioni. Infine ci sono vie aperte dall’Asia. I punti di partenza sono i paesi coltivatori di papavero della mezzaluna d’oro, cioè l’Afghanistan, l’Iran e il Pakistan, e quelli del triangolo d’oro, Birmania, Laos e Tailandia.
Le strade che prendono i loro oppiacei d’esportazione passano dal Medio Oriente, dalla Turchia e dai Balcani per giungere in Europa meridionale e settentrionale. Altre scendono a sudest verso l’Australia oppure vanno a nord per arrivare alle grandi città della Russia attraverso le repubbliche ex sovietiche del Turkmenistan, Kazakistan e Uzbekistan. Infine le vie asiatiche portano anche in Africa, dove confluiscono in quelle dirette verso l’Europa, e in India, Cina e Giappone. Per chiudere il cerchio, esiste un flusso interessante che solca il Pacifico: dal Sud America specialmente la coca viaggia verso Australia, Nuova Zelanda, Cina e Giappone e dal Sudest asiatico agli Stati Uniti.
Le transnazionali mafiose sono globali. Il valore della blanca, la falopa o el polvo, come è chiamata in spagnolo, s’incrementa esponenzialmente nei vari passaggi della catena: tra il contadino delle Ande, la mula che ingerisce e tra- sporta, il boss di una zona o di una plaza, il parigino di classe media o il magnate post-sovietico ci sono differenze che spiegano le plusvalenze della coca nel suo avventuroso cammino verso le narici. Lo status di pressoché totale illegalità di cui “godono” la marijuana, gli oppiacei come la morfina e l’eroina o le metanfetamine, definito da norme proibizioniste e punitive della produzione, della vendita e del consumo, sommerge i traffici nella clandestinità e procura extra benefit importanti ai padroni del mercato, ai più efficienti e violenti.
Un periquito o escopetazo, cioè una “striscia” in spagnolo, con un grammo di polvere di buona qualità costa sui 2-3 dollari a Cali, Colombia, e 6 in Argentina, al dettaglio. Aumenta a 10 dollari in Messico e arriva a 120 e oltre negli usa. Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (Unodc, United Nations Office on Drugs and Crime), il grammo viene sui 100 dollari in Italia e 96 in Svizzera, mentre in Brasile ne costa solo 12. I paesi più cari sono la Nuova Zelanda e l’Australia con cifre altissime di 311 e 285 biglietti verdi rispettivamente. A seconda della purezza e del target può arrivare fino a 700 dollari. Ciononostante si registra un boom della domanda in quelle terre.
Mass media alternativi, movimenti sociali, settori dell’accademia e dell’opinione pubblica cominciano a discutere dei narco-capitali che irrorano la finanza statunitense, della corruzione che la permea e della possibilità della regolazione come passo avanti rispetto al proibizionismo assoluto, un cammino seguito dagli stati del Colorado, dell’Alaska e Washington che hanno legalizzato l’uso ricreati- vo della marijuana. Paradossalmente, mentre negli States s’implementano misure in senso antiproibizionista senza troppi scandali, piovono critiche a iosa contro l’Uruguay che decide di fare più o meno la stessa cosa. Ed è invece poco lo spazio mediatico dedicato alle responsabilità del sistema e alle vittime dei conflitti che la repressione e la guerra alle droghe, impulsata in primis dagli usa, provocano.
Soprattutto riguardo al caso messicano sono tanti i pezzi del puzzle da sistemare: gli abusi della polizia a tutti i livelli, il tema della narcoguerra, la lotta militarizzata ai cartelli della droga intesa come catastrofe strategica e umanitaria, la compenetrazione tra narcos e apparati statali, i diritti umani calpestati e le ferite sociali degli ultimi anni, l’ipocrisia della guerra alle droghe, della DEA e della CIA, la corruzione dei giudici, dei politici, dei funzionari, degli agenti di frontiera e dei burocrati messicani e statunitensi, che hanno stimolato la crescita del “problema” e s’arricchiscono alla faccia della retorica ufficiale.
Il filo rosso che lega i punti più remoti dei cinque continenti e le storie di volti più o meno noti della mexican mafia, della Colombia, dell’Italia e di altri paesi è la coca. Sono le metanfetamine che si consumano e diffondono sempre più e collegano luoghi, nomi, territori, vicende e personaggi che sembrano isolati e invece sono ingranaggi, spesso inconsapevoli, di un meccanismo globale. Oltre alle denunce relative alla narco-trama mondiale, in Messico il giornalismo narrativo e di ricerca si scaglia soprattutto contro i sistemi politico e giudiziario, contro la corruzione di esercito e polizia, criticando altresì le ingerenze esterne nella “guerra alle droghe”. Le voci della società civile denunciano la mancanza di controlli sociali, legali e patrimoniali, così come le protezioni e le complicità che costituiscono lo sfondo comune di tutte le storie e le tragedie messicane dagli anni Ottanta a oggi.
—
Fabrizio Lorusso, NarcoGuerra. Cronache dal Messico dei Cartelli della Droga (Odoya, 2015).
Il prologo del libro, di Pino Cacucci si può leggere su Carmilla.
di Giovanni Dozzini

Non siamo avvezzi a pensare a Jonathan Coe come a un autore di racconti, e accogliere con qualche sospetto il suo nuovo libro, una raccolta di racconti, appunto, e per lo più già pubblicati fuori dai confini italiani nell’arco di quindici anni, era un esercizio non privo di qualche fondamento. Di operazioni simili ispirate alle logiche del mercato editoriale più che a quelle del sacro fuoco della creatività, d’altronde, se ne vedono tutti i giorni. Ebbene, per sgombrare subito il campo dai dubbi: in realtà si tratta di un buon libro. Si intitola Disaccordi imperfetti (traduzione di Delfina Vezzoli, Feltrinelli), e contiene sette brevi storie oltre a un articolo su Billy Wilder, o meglio sul suo non fortunatissimo film La vita privata di Sherlock Holmes, commissionato una quindicina di anni fa dalla rivista cinematografica francese “Cahiers du Cinéma”.
Coe, scrittore dalle nostre parti piuttosto popolare e in grado di penetrare efficacemente le questioni sociali e politiche della Gran Bretagna dagli anni Settanta in qua attraverso il ricorso a un immaginario spesso molto pop e molto ancorato a certi stilemi ben precisi, quasi di culto, musicali e cinematografici, in questi racconti sembra concentrarsi in maniera pressoché esclusiva sul proprio versante più intimista. La malinconia dell’infanzia e del tempo che sfugge, le occasioni perse e irripetibili, la rassicurante e sciocca ingenuità di una vita piccolo borghese svelatasi impietosamente con lo scorrere delle stagioni: è uno dei canoni da sempre sfruttati più a fondo dal cinquantaquattrenne scrittore inglese, e qui finiscono per fagocitare pressoché ogni altra cosa.
Non è un Coe politico, quello che scrive racconti, come se il passo breve chiami per forza di cose il respiro corto, l’impressione dilatata a schema narrativo, la suggestione eletta a bussola quasi esclusiva. Semmai a reclamare vigorosamente la propria parte ci sono le già citate grandi passioni dell’autore della Banda dei brocchi e La famiglia Winshaw, il cinema e soprattutto la musica. Giochi di note, accordi balzani e scale pentatoniche, più un ibrido perfetto come un autore di colonne sonore invitato a sedere al tavolo della giuria di un piccolo festival horror francese. La materia abbonda.
E poi c’è un percorso trasversale che comincia e prosegue altrove, come rivela lo stesso Coe in una nota di prefazione. Tre dei racconti fanno parte di un progetto più ampio, intitolato Unrest, che comprende anche i romanzi La pioggia prima che cada e il recente Expo 58 e vuole raccontare la storia di una famiglia borghese delle Midlands nel corso del ventesimo secolo: “Forse potrebbe esserci una manciata di lettori là fuori che ha letto questi libri abbastanza attentamente da individuare alcuni collegamenti”.
Tornando al punto da cui eravamo partiti, Disaccordi imperfetti è insomma un buon libro. Senza la sua carica più impegnata, o perlomeno lasciandola intendere molto lontanamente, Coe dimostra un’abilità narrativa pura, come succede con i migliori autori di short stories. Gli incastri tra nostalgie ed entusiasmi, in particolare, gli riescono benissimo, c’è sempre qualche amore intuito e mai lasciato esplodere, e per questo incorrotto e incorruttibile, specie nei ricordi, c’è sempre qualche sliding door su cui rimuginare, qualche vecchia notte in una casa rigonfia di affetti e piccoli misteri irrisolti. Jonathan Coe, al netto delle sue conclamate e non di rado soddisfatte ambizioni storicizzanti, ha soprattutto questa indubbia capacità di simpatia ed empatia col lettore, che gli consente di riempire le poche pagine di un racconto di sensi e di immagini incisive. Uno scrittore di talento a cui non vergognarsi di volere un po’ di bene.
i volti tra le frasi il poco
dei giorni succede chiaro
le parole arrivano viene il mondo
una volta erano le voci
un che di cicoria e limoni
o terra a patire
e il gas falciava i prati
in un altrove dove le spine
dove noi e nulla –
scrivi sulla morte
lì cadono i bambini i fiori
che pensiamo per sempre
e senza le tue parole c’è altro
come se restasse il sangue di tutti
e tutta la vita per niente –
ma il male credimi il male
guarda se siamo soli
se siamo figli padri
qualcun altro –
ricordati chi rideva chi
disse cosa a chi
e non tornava risposta
ma un’eco
l’osso cranico
(io non sono la domanda)
“avvicinamento“
Eraclito
quando il giorno finisce sono un passeggero
biglietto n. 1
i fiori e altri fiori
un solo fiore e fiorire
il gelo e gli occhi non sanno
non sanno com’è nei fiori
e i passeri i rami – campagne.
la mia vita coi fogli e poi senza
nella grandezza della sillaba tutto parlavo
le cose prese
come un grano
sono la cosa viva –
curo gli occhi curo la morte
piccolo passa il sole.
biglietto n. 2
i fiori dove esistono le nostre vite
tutto questo – siamo qui a cercarci
le parole la terra l’orecchio
ascolta come dice sì.
le scarpe i fogli le sere nelle buche
di terra le sere che mastichi il pane
l’azzurro è tutta la vita
gli occhi sono la casa
avrai segno come i più piccoli
quelli vuoti di sé che non sanno mai
non sono mai altri.
scrivere è quello che sta nell’aperto
c’è un posto
dove accade di vivere
sugli alberi la luce
va coi germogli
i panni gelano di notte
per un vento di lago
aperto.
basta poca morte
una polaroid da Luino
il vecchio atlante
la pagina è l’erba
del mio nome.
questa povera cosa di amare
millimetri il mondo – gli altri stanno
negli altri e pare sia solitudine
un sangue preso.
nel bello della vita non so
più lavoro – cresce breve un dire
salverò i quaderni il libro più limpido.
l’incendio quando abbatte la realtà
i petali più nudi di una rana
gli ossi un perimetro –
era di paglia il futuro
anche la coda
il tempo non siamo più noi.
finito e infinito sono parole
di avanzi: tutta
la vita nella vita
se guardi nascere
(quello è sempre).
dei versi bisogna
spaventarsi.
i piatti vuoti manciate d’erba sono di ieri le braccia che chiedevano l’avvento
nella postura di dopo
noi siamo io vivo
come ognuno vive
accanto
nell’ora che la luce toglie
nebbia torna il campo
i versi e la mia bocca
tornano voce
il tavolo e il campo
sono la voce
potrei sottovoce
fare assenza.
la nostra vita è vedere tutto
siamo noi la pianura il km morto
il mazzo di fiori sulla statale
che aspetta la neve e un’altra neve.
l’inverno è dove immagini ogni ora
nel grammo dei vetri.
– noi siamo incolti e piccoli. perché ogni albero perché la luce. ricordiamo. perché la foglia. perché c’è il nome. perché nulla è veramente nulla. né veramente. perché nei fiori. perché nell’ombra. perché nel giorno i giorni. il mondo l’alba la sera. perché il male. perché il bene. perché un bambino. perché conta sulle dita. perché aspetta. perché dove. perché non è abbastanza se immagini o pensi. perché pensiamo la fine perché l’inizio. perché due. perché tre. perché quattro. e uno è un pesce. uno canneto. uno ricomincia. uno abbandona. perché –
biglietto n. 5
a lungo pensiamo la poiana
starà nella sera migrerà in noi
come il piccolo muscolo del fiore
ma il geco lunare dà la caccia
fermo sul portone nella grande notte
nulla di sé frantuma
nel fazzoletto un po’ ci cura la parola.
Testi tratti da Nadia Agustoni, Lettere della fine (Vydia 2015)
*
Dalla Prefazione
di Renata Morresi
Di cosa è fine la fine di Lettere della fine? Una fine reiterata in quasi ogni titolo di sezione di questo libro, numerata e declinata in una varietà di luoghi e modi, scomposta e rifratta quasi a smentire che possa bastarne una, la definitiva fine, per dire di quanto è sottratto al continuo, all’incompleto (quindi aperto), al resistere. Una fine quasi mai ‘naturale’: che riguardino la catastrofe delle alluvioni in Liguria o l’alienazione (e il pericolo) del lavoro in fabbrica, l’isolamento degli anziani in una clinica o la marginalità dei poveri, le fini di Agustoni sono fatte di cessazioni specifiche, incarnate nell’esperienza dell’autrice (nella biografia, nel lavoro operaio, nella sua pluriennale ricerca, in poesia, nell’attivismo e in saggistica, delle storie omesse e dimenticate dalla tradizione culturale) e processate in una poesia di creaturale compassione, che ogni volta riporta in presenza della caducità, della dissoluzione inerente a ciò che vive, e ne elabora un lutto candido. Esse sono, allora, in molti casi, riconoscibili come fini prodotte dall’incuria, dallo sfruttamento o dall’infamia, tuttavia la lingua poetica che le dispiega è una festa del contatto e del respiro.
Le Lettere sono dunque lettere di resistenza, e, proprio come le lettere dei giovani eroi della Resistenza italiana, sono fresche e struggenti, desolate per la fine prossima e insieme attraversate da una celebrazione pura, senza retorica, della vita. Le Lettere sono anche lettere dell’adesività, che unisce i rigettati e i senza mondo, nella schiettezza di chi sa che “siamo vivi per la vita intera ma non c’è l’intero” (115), nell’abbandono al divenire di chi sta accanto alle cose, se ne lascia attraversare, o le ama pensandole: “a lungo pensiamo la poiana / starà nella sera migrerà in noi / come il piccolo muscolo del fiore” (94).
Nelle note conclusive Agustoni ci dice, citando Giuliano Mesa, che siamo sempre alla “penultima fine”, come a dire che, dopotutto, la fine non c’è mai, quasi proponendo, in controluce, un rovesciamento ironico di quella fine che a più riprese il Novecento promise (la fine della storia, la fine della guerra fredda, delle guerre, o, ancora prima, riandando a Roosevelt, la fine del bisogno, la fine della paura). L’ironia è leggerissima, e lontana dalle asprezze del sarcasmo o dal cinismo dei delusi. Alla retorica del progresso continuo dell’ultimo fin de siècle, tosto seguita da quella dell’urgenza e del superamento della crisi economica, l’autrice risponde con la severità (e il sollievo) del pensiero apocalittico, che risponde alla crisi e produce la crisi giacché non si può pensare – non si può tollerare – che essa non abbia fine.
In tale tensione è costruito il libro, che, per la coerenza dell’ispirazione e del dettato, per la coesione del suo palpabile tessuto di frammenti, biglietti, righe, allusioni e citazioni, si configura più come sequenza poematica che come raccolta. I testi appaiono come mobilissimi mandala, per i simboli che si compongono e spariscono in un soffio, per lo sfuggire e continuare e aderire alla stessa vocazione di custodi della fragilità:
sottovento qualcosa i pini la
nostra vita – la pioggia col giornale
la nuca come cicoria
quando il sole avrà tempo –
nella giacca la nostra forma
usata – o il modo in cui
pensiamo il mondo.
(143)
Nel suo dipanarsi la scrittura disegna le tracce di una lunga elegia per gli ultimi e, insieme, la delicata grazia della mobilità, anzi, della motilità che inerisce gli umani, e li rende – loro, così spesso inclini alla ferocia verso ciò che è diverso da sé – disponibili alla trasformazione, allo stupore. Questa disposizione morale vive nel corpo della poesia: l’irregolarità della sintassi, simile alla spontaneità del parlato, le frasi sospese, le spezzature incompiute, le ellissi, gli anacoluti, si associano a un lessico fatto spesso di nomi concreti, bisillabi, primari (osso, bocca, acqua, neve, roggia, mela, palla, bosco, terra, ecc.), ma dall’alta densità metaforica. Si produce così un testo disseminato, sospeso tra l’instabilità della lingua orale e l’appunto, tra il fiato fresco della corsa e la voglia di registrare l’impulso subitaneo, come pure l’incongruo di simboli che si addensano e sciolgono nell’attimo della visione. È una indeterminatezza che commuove ed inquieta. Perché nei messaggi timidi e abbozzati che questa poesia manda sentiamo vibrare la precarietà: “i fiori e altri fiori / un solo fiore e fiorire / il gelo e gli occhi non sanno / non sanno com’è nei fiori” (24). Perché l’instabilità nel fissare per certo un soggetto o un complemento oggetto produce una fusione col mondo naturale, ma nelle forme di una campagna della provincia italiana che sappiamo ormai quasi estinta. Perché vi rinveniamo il disordine benefico dell’infanzia, ma anche il male possente d’ogni volta che, bambini, ci hanno tradito, beffato per sfregio, risposto che eravamo bruttezza. Perché lì sentiamo la minaccia che incalza quel che è minuto, indifeso, sensibile, “lì cadono i bambini i fiori / che pensiamo per sempre” (21).
[…]
un inedito di Marosia Castaldi
Dogville burning vide sulla corolla dei girasoli il volto atroce di Osiride la maschera di un Tirannosaurus Rex dal volto bifronte, il volto sperduto di un cane bifronte che l’azzannava alle caviglie le rodeva le spalle
[Pubblichiamo cinque testi tratti da Fermata del tempo in uscita questo mese per Marcos y Marcos.]
di Stelvio Di Spigno
.
Trentasette primavere
Dicono che fu uno stillicidio in mare aperto,
il capitano di corvetta Costigliola fu preso dall’Egeo
che goccia a goccia gli instillò la morte
sul viso, tra i capelli, nell’amore, i ricordi, le parole.
di Fabio Franzin
Per Francesco Sgroi, con pietà
Quel che l’é ‘ndat in tilt tea tó testa
te chea stanza da lèt del condominio
Ater, ‘na dómenega sera de caldo
infernàe, te ‘ò sa sol che tì, caro Sgroi,
o forse no te ‘o capirà mai. Ma mì so
che quel che i ‘à scrit i giornài: omicida,
‘ssassìn, sora ‘e foto de tì e dea tó pòra
mare, no’ le ‘é ‘e paròe juste, nianca una,
e soratut manchéa l’unica che podhéa
provàr a ‘vizhinàrse un fià aa verità.
Mostro, caomai, l’é ‘sto tenpo rùdhene
e senza cuor, ‘sta epoca poca, viliàca.
di Giacomo Sartori
 Uno dei pregiudizi più duri a morire è che gli scrittori scrivano. Che cioè si mettano lì, e ticchettino sulla tastiera qualcosa che detengono e antecede lo scritto, come si trasferisce una serie di pacchetti di banconote da una cassaforte a una valigetta da viaggio. Niente di più lontano dalla realtà. Il testo che si materializza sullo schermo non preesiste né nella scatola
Uno dei pregiudizi più duri a morire è che gli scrittori scrivano. Che cioè si mettano lì, e ticchettino sulla tastiera qualcosa che detengono e antecede lo scritto, come si trasferisce una serie di pacchetti di banconote da una cassaforte a una valigetta da viaggio. Niente di più lontano dalla realtà. Il testo che si materializza sullo schermo non preesiste né nella scatola
La Francia ha chiuso la porta di casa.
Migranti disperati sugli scogli, Ventimiglia.
Inviati speciali, elicotteri, forse anche droni.
Serve un piano europeo, dice Renzi.
Ma intanto l’Italia “ha perso le tracce” di 50.000 persone.
Sono sbarcate in Italia e non si sa dove sono, dove sono andate.
Un certo numero di esse le ritroviamo a Ventimiglia, appunto.
Si sono materializzate lì, prima non c’erano.
In questa contemporaneità fatta di “percorsi” non rintracciamo “strategie”.
Non realizziamo che il tragitto dal sud del nostro paese fino alla frontiera francese non è “un percorso” fatto una volta sola – come in un talent show – da un numero ristretto di migranti.
Non realizziamo che quello è un flusso, che quella strada i migranti la prendono da mesi, anni.
Ci accorgiamo del fatto solo perché il flusso è stato interrotto.
Non ci domandiamo cosa è successo e cosa non è successo nel tragitto.
Ecco cosa è successo: queste persone, sbarcate nel sud Italia, non sono state accolte in Italia.
Hanno pagato una montagna di euro per avere una scheda telefonica, e un’altra montagna per raggiungere la frontiera settentrionale in incognito.
Le autorità italiane hanno lasciato fare. Non hanno applicato il regolamento di Dublino, che prevede l’identificazione e l’eventuale ricezione della domanda di asilo politico.
Le autorità italiane hanno chiuso gli occhi, e alimentato un traffico: andiamo ad affondare le barche in Libia – facendo accordi con alcuni fra i peggiori manigoldi del Mar Mediterraneo – ma non blocchiamo gli scafisti di terra “a casa nostra”.
E questo, secondo la vulgata, sarebbe “gestire” i “nostri interessi”.
Le autorità italiane non hanno fatto tutto questo perché armate di buone intenzioni, perché portano avanti i diritti di quei migranti ad andare dove vogliono, perché hanno a cuore gli “interessi nazionali”.
Lo hanno fatto per scaricare il peso altrove, senza assumersi alcuna responsabilità, e magari portando a casa qualche accordo sotto banco.
Mentre il mondo della politica (da Renzi a Salvini a Berlusconi), parassitando, utilizzava la cronaca delle tragedie per tematizzare un scontro elettorale altrimenti privo di una qualsivoglia tensione.
Perdendo credibilità di fronte a coloro contro cui, in Europa, ora abbaia.
***
Il regolamento di Dublino è un’infamia, va abolito.
I migranti hanno il diritto di usufruire di Schengen, è necessario dirlo.
Ma l’Italia non dice questo, l’Italia sta facendo un gioco sporco, perché nel regolamento di Dublino ci sguazza fino a quando trova la cosa utile.
Poi quel regolamento lo trasgredisce deliberatamente.
La Francia sta reagendo con strumenti altrettanto irrituali – d’accordo – ma codificabili e leggibili: “Se tu non applichi Dublino io non applico Schengen”.
Intanto “il popolo” dice, pilatescamente, “lasciateli andare, accoglieteli in Francia”.
E questo fa gioco, fa gioco a tutti almeno sul brevissimo periodo.
Stupidi egoismi su stupidi egoismi. All’italiana o alla francese, ma il problema non si risolve in questo modo, né si risolverà da solo.
Ci vogliono soldi, strutture, piani. Ci vogliono numeri, statistiche, informazioni.
Bisogna togliere la cosa dalle mani di mafiosi, faccendieri, fascisti.
Qui in Italia, non altrove, o anche altrove ma soprattutto in Italia, perché se i migranti sbarcano qui c’è un motivo: la silenziosa e ipocrita “deroga” al regolamento di Dublino, prima della prossimità geografica.
Una prossimità che viviamo come una specie di sventura, negando chi siamo, dove siamo, qual è la nostra storia, la nostra vocazione, percependoci come pigs e agendo come tali.
Il problema è italiano. Questo è un grossissimo problema italiano.
Non ci vogliono schizofreniche dichiarazioni renziane. Lacrime di coccodrillo e muti ruggiti sullo sfondo di una furbata da italietta con le scarpe di cartone. In cui torme di razzisti nuotano felici, preparandosi a prendersi questo paese (e culturalmente sono già molto avanti).
I migranti arrivano in Italia, dobbiamo sapere chi sono, cosa hanno in mente. Dobbiamo sapere se possiamo aiutarli e, nel caso, dobbiamo aiutarli.
Ad andarsene o a rimanere.
Sì, va bene, dobbiamo “aiutarli a casa loro” ma non basta, non basterebbe.
Le guerre, i tiranni, la fame hanno le nostre facce, non prendiamoci in giro.
E poi gli esseri umani sono nati liberi di muoversi, e basta.
Dobbiamo desiderare che arrivino e anche che si fermino, perché ciò significherebbe che l’Italia è un bel paese in cui stare, in cui immaginare un futuro.
Un futuro cui i migranti pensano ogni giorno, al contrario di noi.
Non ci sono scorciatoie, dobbiamo tenerli qui, i migranti. Io li voglio qui.
Sono la Storia che bussa, sono l’unica vera luminosa possibilità di futuro capitataci in sorte.
Dovremmo ritenerci fortunati, sempre che un futuro ci interessi.
E invece, senza forse nemmeno credere alle nostre stesse parole, ci riscopriamo francofobici – e via con la storia del bidet o altre facezie – sperando che davvero la Francia sia il problema.
Apprendistato sentimentale di un padre e di una figlia
di
Seia Montanelli
Se io fossi il biografo di Paolo Nori, sceglierei il titolo del suo primo libro, “Le cose non sono le cose” (Fernandel, 1999) quale paradigma della sua intera produzione letteraria. Perché se da un lato è difficile raccontare a qualcuno che non l’ha mai letto, cosa scrive, o meglio, sarebbe semplice dirgli «in pratica, in quasi tutti i suoi libri, racconta più o meno i fatti suoi adoperando ora uno pseudonimo, ora un altro, come voce narrante», ma una cosa così non renderebbe giustizia al suo lavoro, perché le cose appunto non sempre sono le cose; dall’altro è semplice dire cosa non sono e cosa non c’è nei suoi scritti: non sono romanzi, non sono racconti, non sono reportage, non sono biografie, né autobiografie, non c’è auto-fiction, ma nemmeno fiction (per dirla come quella che scrivono ora sui giornali a proposito di libri, e non si fanno capire, perché non lo sanno nemmeno loro quello che c’è nei libri di cui parlano).
La cosa migliore sarebbe prendere dalla libreria un suo titolo a caso e prestarlo a ogni lettore che non l’ha letto, ma allora non avrebbe senso nemmeno che io sia qui ora a scrivere questo pezzo per parlare de “La piccola Battaglia portatile” appena uscito per Marcos y Marcos, ma io ci terrei davvero a scrivere di questo libro quindi ci provo, a dire di cosa parla.
E’ il racconto, frammentario, aneddotico e apparentemente destrutturato, del rapporto dello scrittore con la Battaglia, sua figlia di dieci anni. Ci dice l’autore che a un certo punto si è messo a segnare «le cose, ma piccole, minuscole, che mi sono successe nello star vicino alla Battaglia, quando era piccola, segnarmele tutte su un quadernetto con su scritto Battaglia che poi è diventato due quadernetti poi tre quadernetti poi quattro quadernetti poi cinque quadernetti e così via, ecco io, dicevo, segnarmi queste cose io adesso mi tornano in mente delle cose che altrimenti me le sarei scordate», stilando una sorta di diario in cui annotare tutto ciò che la riguarda sin fa quando è nata, per cui nel testo ci sono episodi che risalgono anche a quando era più piccola, quasi a ricostruire una – sentimentale e del tutto personale – cronologia della paternità.
Tra tutti i suoi libri, questo è il più intimo forse, anche senza voler aderire all’idea dell’autobiografismo estremo nella sua opera. Persino restando nella definizione di pseudo-autobiografia, che spesso lo stesso Nori – cedendo forse a reiterate domande di qualche intervistatore – ha utilizzato per parlare delle sue cose, “La piccola Battaglia portatile” sembra il suo libro più autentico (sebbene egli scriva: «quella di cui provo a parlare in questo libro non è esattamente mia figlia, cioè mia figlia è poi un’altra cosa, e io, anche io non sono esattamente io, io sono il Babbo della Battaglia» (perché le cose non sono le cose, no?). Il testo, rispetto ad altri suoi, è meno giocato sull’Io ipertrofico dello scrittore spesso insoddisfatto e con un carattere quantomeno ostico (cosa di cui è consapevole: «quando qualcuno mi invita a cena», osserva, «è come se mi offendesse, Ma pensa che non abbia niente da fare?, mi vien da chiedermi»). C’è un padre e c’è una figlia, e non c’è alcuna retorica.
Scrive del rapporto con sua figlia, o meglio del rapporto della Battaglia e del suo Babbo (diciamo così per farlo contento), dei viaggi che hanno fatto insieme, dei musei che hanno visitato, della loro vita quotidiana. E in questo c’è un Nori ancora più esposto, che guarda il mondo attraverso gli occhi “nuovi” e stupefatti della bambina e finisce per stupirsi anche lui; e ci sono delle piccole tenere reticenze («una volta mi ha detto Sei gentilissimo, mi sono imbarazzato») nelle parole di affetto per quella bimba che è diventata il suo «intellettuale di riferimento» (le darebbe il premio Oscar e il premio Nobel tutti e due insieme), e che non è semplicemente sua figlia – «se mi chiedessero Ma la Battaglia è un tuo parente?, io risponderei No, la Battaglia non è un mio parente, la Battaglia è la Battaglia, che discorsi sono?» – , e che lui amerebbe anche se non fosse suo padre, semplicemente perché lei è come è.
“La piccola Battaglia portatile” è una dichiarazione d’amore in centoquarantatré pagine suddivise in centonovanta paragrafi che sembrano non arrivare mai da un punto A al punto B, perché si perdono in centinaia di digressioni e citazioni, e osservazioni, quasi a inseguire la vita mentre scorre e si presenta davanti all’autore. Ma è anche una sorta di trattato di pedagogia perché Nori si interroga su cosa sia il suo ruolo di “babbo”, anche rispetto alla tradizione che conosce, quella emiliana del “buon capofamiglia”, che forse è anacronistica, ammette, salvo poi raccontare che un giorno dopo aver sgrida la Battaglia dicendo «Secondo me non va bene, che fai così», lei si ferma lo guarda e gli dice «Tu non devi dirmi Secondo me, tu devi dirmi Non va bene». E poi in relazione al mondo che oggi accoglie sua figlia e alle aspettative che la società ha verso i genitori, ecco che tira fuori una riflessione illuminante sulla questione dei valori da infondere ai propri figli: «io penso che ognuno i valori, dovrebbe trovarseli per conto suo» – e ancora «è questo l’unico modo, secondo me, in cui sono capace di influenzare i valori di mia figlia, facendo come se non li influenzavo e per via della scuola io forse preferirei che a scuola le dessero degli strumenti, anziché dei valori».
Ovviamente anche “La piccola Battaglia portatile” stilisticamente ruota intorno alla musicalità della lingua come tutti i libri di Paolo Nori; il testo si presta moltissimo a essere letto ad alta voce, con periodi lunghi, pieni di subordinate che sembrano a volte girare a vuoto, ma che alla fine trovano una direzione. E soprattutto ci sono suggestioni e citazioni e rimandi ad altri libri, ad altri autori e quando chiudi il libro hai comunque imparato qualcosa di nuovo, che non sapevi e che vuoi approfondire (di quanti libri si può dire lo stesso?).
Per esempio si scopre in questo libro che l’uso che spesso Nori fa di riprendere cose già scritte in altri libri suoi già pubblicati, non è mica una cosa così, che fa con leggerezza o come riempitivo: dipende dall’effetto Kulesôv, ossia da un esperimento raccontato da questo regista sovietico in libro del 1941 in cui spiega come il significato che si attribuisce a una cosa, cambia a seconda delle cose che la circondano.
Di nuovo le cose non sono le cose con Paolo Nori, e mi viene in mente che il libro inizia con una dichiarazione di impotenza quasi, «Non so bene come chiamarmi, non so bene come vestirmi, non so bene cosa sono, che spazio occupo, da che parte sto, a cosa servo», ma più in là nel testo, man mano che il suo apprendistato di Babbo si arricchisce di esperienza, i dubbi si dissipano e l’unica certezza che conta è che lui «è il Babbo della Battaglia», con tutto quello che questo comporta di responsabilità e porta con sé come dono quotidiano, e alla fine tutto torna.