di Jamila Mascat
Sulla Settimana enigmistica c’era un gioco, che forse esiste ancora: “Aguzzate la vista”. Si trattava di scovare i 20 particolari che distinguevano due vignette molto simili e densamente popolate, disposte una accanto all’altra.
Io, che non ho un talento per la visione e sono sempre stata miope, ci mettevo un sacco di tempo, poi spesso mi spazientivo al quinto particolare. Ma chissà perché non demordevo e ogni settimana sceglievo di provarci di nuovo. Del resto, si sa, ci vuole pazienza con i dettagli.
Di Charlie Hebdo
Ora non è facile soffermarsi sui dettagli mentre l’orrore e la commozione per le vittime dell’attentato alla redazione di Charlie Hebdo, e poi ancora l’orrore delle ultime ore per gli altri morti e gli altri ostaggi, ci stringono in un raccoglimento corale senza se e senza ma.
Siamo tutti sotto choc; siamo tutti inorriditi per l’attentato più letale che Parigi abbia mai subito dalla fine della seconda Guerra Mondiale – le decine di persone uccise il 17 ottobre 1961 durante una tristemente famosa manifestazione pro-Algeria – all’epoca ancora francese – morirono, come ricorda Libé, non per mano dei jihadisti ma sotto i colpi della polizia; dicesi repressione quindi, non attentato). Siamo tutti ragionevolmente con la plume contro i kalashnikov. E nel giro di qualche ora siamo diventati tutti Charlie (perfino il Nasdaq).
Confesso che je ne suis pas Charlie (senza hashtag, e fuori da twitter, dove pare che la formula sia stata recuperata con intenti ben diversi da quelli di questo post), non lo sono oggi più di quanto non lo fossi una settimana fa e sarebbe perfino ipocrita fare finta del contrario. Avevo un debole per Charb, a cui devo uno dei migliori funerali a cui ho assistito (si trattava in realtà della commemorazione della morte di Daniel Bensaïd, filosofo, docente universitario, fondatore della Ligue Communiste Révolutionnaire e, tra le altre cose, co-autore insieme a Charb di Marx, mode d’emploi). Mentre nella sala della Mutualité Edwy Plenel, Alain Badiou e molti altri ricordavano Daniel e i suoi trascorsi, Charb lo disegnava in diretta riuscendo perfino a strappare qualche risata contagiosa, che per un’occasione del genere è un risultato niente male. Ma a parte questa affezione personale, je n’ai jamais été Charlie da quando in modo più o meno intermittente vivo a Parigi, dal 2001. Erano gli anni di Philippe Val alla guida del giornale (1992-2009), gli anni del dopo-11 settembre, gli anni bui che conosciamo e che in Francia sono stati ulteriormente rabbuiati dai Lumi del laicité di stato.
Le vignette, le più sconce e le più blasfeme, non mi hanno mai offeso; ridere è un’altra storia e io fatico un po’ a farlo con cazzi e culi, e putes e pédés, per indole, più che per inclinazione al politically correct. Per intenderci: questo finto-Maometto qui, sul set di un film hard costretto a scoparsi una testa di maiale “per mancanza di troie di 9 anni” non mi piace un granché, ma non perché è Maometto, fosse anche il Maresciallo Rocca o Lino Banfi sarebbe lo stesso.
Allora preferisco Maometto affranto, con le mani nell’immancabile turbante, che deplora la qualità dei suoi proseliti – C’est dur d’être aimé par des cons (e ancora più tosta, forse, è essere odiato dai coglioni, così coglioni che un giorno vengono a trovarti a sorpresa e finiscono per farti secco).

Non ho avuto nessun sussulto per le illustrazioni di Charia Hebdo, per le vignette danesi ripubblicate da Charlie, né di fronte alle consuete caricature dei miei correligionari, ritratti di solito in versione barbus (gli uomini) o niqab (le donne, generalmente maldestre, impossibilitate a farsi la ceretta come si deve, incapaci di trovare il punto G, e più spesso incinte per meglio procacciarsi i sussidi destinati alle famiglie numerose).
Ma CH non è e non è stato negli anni solo un giornale di vignette di buono e cattivo gusto. È stato anche un giornale di editoriali (come questo di Val, che nel 2002 rimproverava Chomsky di essere un traditore della patria, alias “l’un de ces Américains qui détestent le plus l’Amérique) e di prese di posizione (come questa, sempre Val, all’epoca della guerra in Libano nel 2006 :”Se guardiamo una carta geografica, muovendoci verso Est, [vediamo] che oltre le frontiere dell’Europa, cioè oltre la Grecia, il mondo democratico cessa di esistere. Resta solo un coriandolo in Medio Oriente, lo Stato di Israele, e poi nulla fino ad arrivare in Giappone. Tra Tel-Aviv e Tokyo regnano solo poteri dispotici, che riescono mantenersi in piedi alimentando, presso popolazioni analfabete all’80 per cento, un odio feroce nei confronti dell’Occidente, perché composto di democrazie”); parole che non condivido oggi, più di quanto non riuscissi a condividerle ieri.
Non ero Charlie nemmeno nel 2006 quando il giornale pubblicava il Manifeste des douze contro il totalitarismo islamico, firmato dal direttore (Val), insieme a Bernard Henry Levy, Ayan Hirsi Ali e Caroline Fourest tra gli altri – per chi non li conoscesse googlare per credere.
Né ero Charlie quando, a luglio del 2008, Val, sempre lui, decideva di licenziare Siné, un collaboratore storico della testata, per colpa di una chronique pubblicata due settimane prima, che commentava così le nozze di Jean Sarkozy, figlio di Nicholas, con Jessica Sarah Fanny Sebaoun, ereditiera della famiglia Darty.
“Jean Sarkozy, digne fils de son paternel et déjà conseiller général de l’UMP, est sorti presque sous les applaudissements de son procès en correctionnelle pour délit de fuite en scooter. Le Parquet a même demandé sa relaxe ! Il faut dire que le plaignant est arabe ! Ce n’est pas tout : il vient de déclarer vouloir se convertir au judaïsme avant d’épouser sa fiancée, juive, et héritière des fondateurs de Darty. Il fera du chemin dans la vie, ce petit !”
Il vignettista, accusato di antisemitismo, era stato immediatamente espulso dalla redazione. L’iter giudiziario avrebbe scagionato Siné e condannato Charlie a risarcirlo cospicuamente, ma intanto un gesto del genere, da parte di un giornale che si è sempre vantato di cantarle a tutti e non risparmiarle a nessuno, avrebbe suscitato più di qualche reazione sgomenta in redazione e fuori. Alcuni già allora rimpoveravano a Val, di lì a poco destinato a essere nominato dall’allora presidente Sarkozy alla guida di France Inter, di aver punito l’antisarkozismo di Siné piuttosto che il suo presunto antisemitismo. E nel momento in cui CH progressivamente scompare dalla rassegna stampa dell’emittente radiofonica France Inter, lo stesso Charb se la prende con il suo predecessore accusato di obbedire supinamente ai precetti dell’Eliseo: “Da quando la rassegna stampa [….] è in mano a sarkozisti impomatati, Charlie Hebdo non è più stato citato. Boycottaggio quasi totale.[…] Si vede che non serve essere iscritti all’albo dei giornalisti per fare la rassegna a France Inter, basta avere la carta dell’UMP».
Nato sulle ceneri di Hara Kiri, censurato dal ministero degli interni nel 1970 per una copertina poco ossequiosa pubblicata in occasione della morte di De Gaulle, e cresciuto all’indomani del maggio francese con spirito anarco-rivoluzionario, persecutore irriverente dei potenti e del potere, CH è stato un settimanale di culto per una generazione, e forse più di una, di gauchistes impenitenti che preferiscono ricordarlo per come era agli inizi.
L‘hebdo che ho conosciuto io, invece, è stato un giornale più controverso e più chiacchierato. Al punto che nel 2013 Charb, ormai da quattro anni alla guida del settimanale, mentre le polemiche montavano e le vendite precipitavano, era stato costretto a ribadire dalle colonne di Le Monde che Non,Charlie Hebdo n’est pas raciste !
E in effetti non credo neanch’io che CH sia un giornale razzista. Credo solo che in diverse circostanze abbia abdicato alla tanto celebrata inclinazione dei bei tempi andati, l’inclinazione ad assumere una voce fuori dal coro. Strano a dirsi, mi rendo conto, a proposito di un giornale la cui redazione è stata orribilmente decimata tre giorni fa, per aver osato rappresentare l’irrapresentabile e sfottere l’insfottibile. Ma la Francia non è l’Arabia Saudita e questo dettaglio dovrebbe consentire di prendere le misure.
Della République
La questione del coro e delle voci è un altro dettaglio non trascurabile.
Il quotidiano online Mediapart (il cui direttore, Edwy Plenel, ha pubblicato pochi mesi fa un inatteso plaidoyer Pour le musulmans) riporta sul blog Indisciplines un’intervista a Michel Houellebecq, originariamente apparsa sulla Paris Review, e rara nel suo genere per il tono insolente (e apprezzabile) delle domande rivolte all’autore in occasione dell’uscita del suo libro Soumission, di cui si parla ovunque in questi giorni. Il titolo scelto da Sylvain Bourmeau – Un suicide littéraire français – fa volutamente eco al tanto dibattuto Suicide français di Eric Zemmour, il bestseller-scandalo del giornalista francese licenziato meno di un mese fa da I-Télé per le dichiarazioni espressamente razziste rilasciate al Corriere della sera e poi a distanza di qualche tempo rimbalzate in Francia per suscitare un putiferio (tra queste l’auspicio di una prossima cacciata dei musulmani francesi dal territorio nazionale).
Se nel suo saggio Zemmour addita il pensiero debole e il decostruzionismo, rei di aver eroso “le fondamenta di tutte le strutture tradizionali: famiglia, nazione, lavoro, stato, scuola” fino a rendere “l’universo mentale dei nostri contemporanei ….un campo di rovine” e cedere il paese in pasto all’insolenza delle minoranze, il romanzo di Houellebecq immagina la Francia del futuro che inverosimilmente capitola nella mani dell’islam politico, tanto da ritrovarsi a fronteggiare nel 2022 un deuxième tour presidenziale Le Pen vs Ben Abbes (nome, quest’ultimo, inventato di un immaginario leader carismatico del partito della Fraternité Musulmane). Dopo la vittoria schiacciante del partito religioso, la nazione cambia volto: le donne smettono i pantaloni e cominciano a coprirsi, lasciano il lavoro e si rintanano in casa, le scuole e le università vengono islamizzate e progressivamente tutti sono costretti ad arrendersi e sottomettersi.
E così Bourmeau incalza Houellebecq:
-Pourquoi tu as fait ça?
-Je n’aime pas le mot mais j’ai l’impression que c’est mon métier.
E più avanti:
– Peut-être oui. Oui il y a un côté peur. J’utilise le fait de faire peur.
-Donc tu utilises le fait de faire peur à propos du fait que l’islam devienne majoritaire dans le pays ?
-En fait, on ne sait pas bien de quoi on a peur, si c’est des identitaires ou des musulmans. Tout reste dans l’ombre.
-Tu t’es posé la question des effets d’un roman qui contient une hypothèse comme celle- là ?
-Aucun. Aucun effet.
-Tu ne crois pas que cela va contribuer à renforcer les portraits de la France que j’évoquais et pour lesquels l’islam pèse comme une épée de Damoclès, comme la chose la plus effrayante ?
-De toute façon, c’est déjà à peu près la seule chose abordée par les médias, ça ne peut pas être plus. C’est impossible d’en parler plus qu’aujourd’hui, donc cela n’aura aucun effet.
-Ce constat ne te donne pas envie d’écrire autre chose ? De ne pas t’inscrire dans ce conformisme ?
-Non ça fait partie de mon travail de parler de ce dont les gens parlent, objectivement. Je suis inscrit dans mon temps.
Houellebecq dichiara di volersi esimere dal dovere di scegliere di cosa parlare e come farlo. Pare nascondersi dietro un dito e dire: parlo di ciò di cui si parla. Come se il mestiere di scrivere si riducesse al compito miserabile di ricopiare dal mondo tel quel, contentandosi di straparlare di quel di cui già si parla.
A poche ore dal primo attentato, ad esempio, la leader del Front National, Marine Le Pen, ventilava l’ipotesi di un referendum sulla pena di morte. Suo padre Jean-Marie suggeriva con un tweet una soluzione assai più composta: Keep calme and vote Le Pen (e sullo sfondo una bella foto di sua figlia che sfoggia un gran sorriso).
Nel frattempo il Parti Socialiste ha tentato con successo di resuscitare dal torpore autunnale sotto l’egida del repubblicanesimo. La République per bocca del presidente Hollande e del premier Valls ha chiesto a tutti di raccogliersi in silenzio e rendere omaggio alle vittime innocenti di questi morti atroci.“Dans ces moments-là, le débat doit être un peu au-dessus et pas dans les petites polémiques”, ha ribadito il primo ministro, sapientemente abile in queste ore a dosare le parole e redarguire ogni eccesso, ineccepibile ago della bilancia nazionale.
Anche il filosofo Bernard Henry-Levy dalle pagine di Le Monde ha cavalcato l’onda repubblicana rilanciando la posta un gradino più su: “C’est le moment churchillien de la Ve République”, ha scritto, “è l’ora del dovere implacabile della verità di fronte a una prova che s’annuncia lunga e terribile. E’ l’ora di tagliare corto con il discorso lenitivo che ci propinano da tanto tempo gli utili idioti [fautori] di un islamismo che si risolverebbe nella sociologia della miseria”.
E Sarkozy gli fa eco: “La nostra democrazia è sotto attacco, e dobbiamo difenderla senza esitazioni. … La Francia è stata colpita al cuore, la Repubblica deve riunirsi; chiamo tutti i francesi a […] un fronte unico contro il terrorismo, la barbarie e gli assassini”.
A tutti noi è richiesto di associarsi (e ai musulmani di dissociarsi e espiare, prima di associarsi) per prendere parte a questa santa alleanza politica che formalmente mantiene a debita distanza solo il FN per evitare di conferire una patente di rispettabilità a un partito pericoloso e a cui in questa fase i consensi non mancano di certo.
Chiunque tenti di opporsi all’ “impératif d’unité nationale” invocato da Sarkozy, obiettando che il guaio della Repubblica è che predica male e razzola peggio, non disdegnando di impugnare all’occorrenza liberté-égalité-fraternité come un’arma letale di discriminazione e d’oppressione, di guerra e di conquista, viene accusato di islamogauchismo, di giustificare l’ingiustificabile o anche solo di non saper tacere in un momento così tragico e ostinarsi cercare il pelo nell’uovo.
Con che coraggio ci si può sottrarre al Je suis Charlie, intonato dal coro polifonico repubblicano che si vuole erede e depositario delle ultime volontà di Charb, Wolinski, Cabu, Tignous e degli altri, e in cui ahimè sono confluiti il dolore, la paura, lo sdegno e la sacrosanta determinazione a resistere di milioni di francesi?
Le Monde per la copertina del dopo-attentato ha scelto un titolo rivelatore: Le 11-septembre français, un titolo confermato dalle parole di Valls che poco dopo ha prontamente evocato l’impresa di una nuova “guerra contro il terrorismo”, une guerre pour nos valeurs. Un altro dettaglio non insignificante. Infatti, se davvero si tratta di un nuovo 11 settembre, allora ripensiamo al precedente e meditiamo: per una crociata lanciata ormai 14 anni fa, e combattuta con tanto dispiego di mezzi ed energie, bisogna ammettere che si è trattato di un fiasco colossale. Il terrorismo, a quanto pare, non è mai stato meglio.
Domenica prossima a Parigi sfileranno anche Merkel, Renzi, Rajoy, Cameron e altri leader politici europei. Vedremo l’Europa di destra e sinistra prendersi per mano “Pour la liberté de la presse, pour la république, pour la liberté de conscience et d’opinion, pour lutter contre l’obscurantisme, pour ne pas capituler face au terrorisme…”. United we stand si diceva all’indomani di 9/11. Con le conseguenze che tutti conosciamo e abbiamo ancora modo di toccare con mano.
Dell’apocalisse
C’è un breve saggio di Derrida intitolato Di un tono apocalittico adottato di recente in filosofia (1983) che fa il verso a uno scritto di Kant di duecento anni prima pubblicato sulla Berliner Monatsschrift – D’un tono da signori assunto di recente in filosofia (1796).
In questo saggio Derrida punta il dito contro le retoriche dell’apocalisse per gli stratagemmi che adottano; per le “astuzie criptiche” che mobilitano, per la fine imminente che annunciano e a cui poi non tengono fede, per quell’annichilamento distruttivo che promettono e non mantengono al solo scopo di garantirsi una sopravvivenza più duratura.
Al pari di un’accorta strategia di comunicazione, infatti, i toni apocalittici sottintendono più di quel che narrano esplicitamente, e agitano lo spauracchio della fine proprio allo scopo di poter preservare le cose come stanno. Nulla insomma finisce davvero con l’Apocalisse e molto si perpetua immutato, a discapito delle apparenze.
E allora, Derrida si domanda cui prodest: “Quale beneficio? Quale premio di seduzione o di intimidazione? Quale vantaggio sociale o politico? Vogliono fare paura? Vogliono far piacere? A chi e come?” Vogliono terrorizzare? Far cantare? Attirare in nuove promesse di godimento? È contraddittorio?”
Nelle ultime ore ovunque ci hanno raccontato l’apocalisse. L’attentato, e poi la fuga dei colpevoli, e lo spettacolo terrificante delle squadre speciali che li inseguono. I volti e le storie degli assassini, microcrimnali, macrocriminali, convertiti, bramosi di uccidere e pronti a morire per Isis o per Al Qaeda non importa. Lo Yemen un condimento onnipresnte, l’Afghanistan pure, mentre le vittime innocenti si moltiplicavano tra un attentato e un braccaggio. La fine della rincorsa, l’uccisione dei fratelli Kouachi e del loro complice Amedy Coulibaly, le loro (incredibili ma vere?) interviste in diretta con i giornalisti di BFM Tv in cui rispondono alle domande come fosse un gioco a quiz, dichiarano i moventi e i mandanti. Il mistero di Hayat Boumedienne. E ancora il récit allarmato della procura, gli istigatori di odio che scorrazzano sui social network, i plausi al coraggio degli attentatori morti per una buona causa che arrivano dai soliti sciroccati criminali. I sondaggi d’opinione, le risposte a scelta multipla. Le prevedibili ripercussioni quotidiane – meno eclatanti, ma certo non meno preoccupanti – dalle scuole alle moschee passando per le banlieue dove non sono mancate fin da subito le intimidazioni, gli insulti contro l’islam e l’islam contro tutti.
Quando pareva che le cose andassero già molto male, sono andate peggio (cosa c’è di peggio di una prise d’otage qualsiasi? Una prise d’otage orchestrata da un musulmano in un épicerie kosher, tanto per gradire). E quando è così, è peggio per tutti.
Il problema di atti indifendibili come gli attentati dei giorni scorsi è che oltre a lasciarci in bocca il gusto amaro dell’apocalisse, non ci lasciano via di scampo. Non ci permettono di rigettare la logica binaria, ma poi al fondo monopolistica, del ritornello “chi non salta terrorista è”. Ci tolgono le parole di bocca. Ci condannano, nel migliore dei casi, a ingoiare più sicurezza, più vigipirate e più panopticon per sentirci protetti o, nel peggiore dei casi, a fare il tifo per le teste di cuoio affinché catturino i criminali (e non importa che le forze dell’ordine tre mesi fa abbiano ucciso per sbaglio con una granata un giovane manifestante ecologista a Sivens, e che il ministero dell’Interno dopo l’omicidio di Remi Fraisse abbia vietato qualsiasi manifestazione di protesta e promosso arresti e condanne a gogo per punire chi osasse infrangere le regole; quella ormai è acqua passata, riscattata dalle prodezze dei blitz di ieri). Ci spingono a schierarci con quelli che non possono essere i nostri alleati (il governo Valls e l’opposizione Sarkozy). Ci costringono a blaterare in ritirata che il razzismo, che l’islamofobia, che la discriminazione nei quartiers populaires, che la guerra in Mali e la Françafrique, che l’imperialismo, che lo sfruttamento, che la povertà e la disoccupazione, che Gaza, che quel che resta del colonialismo, che non solo i musulmani, ma anche gli altri, che un salafita non è un terrorista, che Obama e Guantanamo…e così via in dissolvenza. E chiunque replicherà, con ragione, che non ci sono scuse che tengano.
Le scuse in effetti non servono, servono antidoti a una strategia della tensione – tu-mi-uccidi-a-casa-mia/io-ti-uccido-a casa-tua – inscenata tra terroristi jihadisti e politica del terrore globale, che evidentemente giova alle parti in causa più che a chiunque altro in questa storia. Servono strumenti per sottrarsi alla morsa infernale del “con noi o contro di noi”, che puntualmente si ripropone. Per questo la libertà d’espressione deve consentire la libertà di sottrarsi all’amalgama dell’union sacrée per soffermarsi sui dettagli – che alla fine non sono un dettaglio e fanno la differenza – senza che nemmeno questo costituisca un atto blasfemo né criminale.








 di: Francesca Fiorletta
di: Francesca Fiorletta 
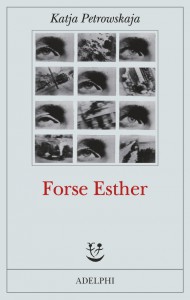



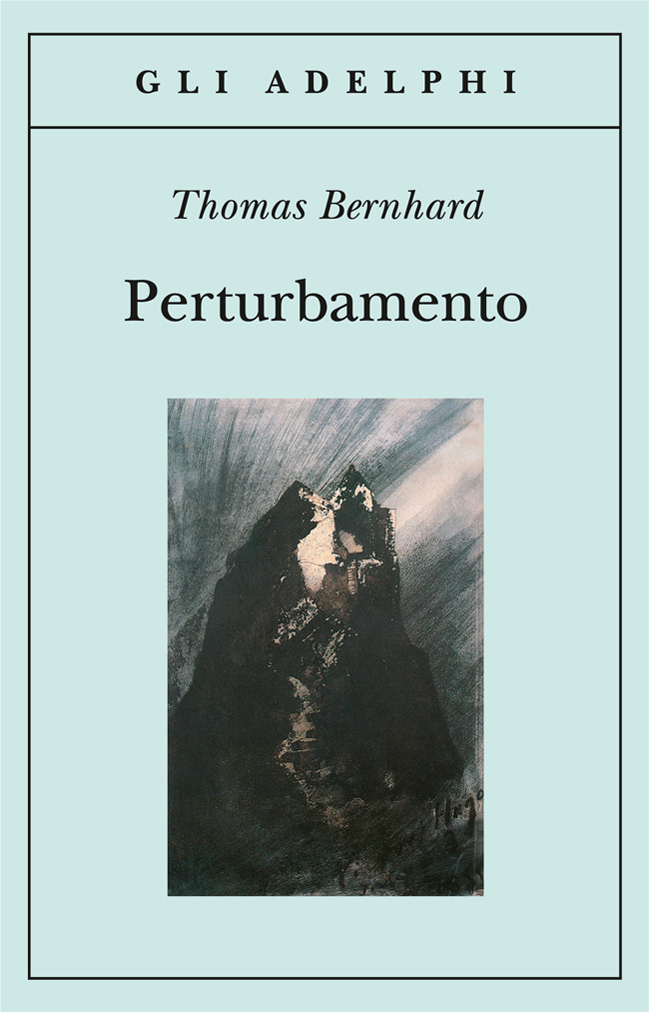
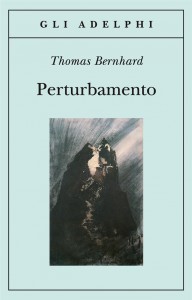

 assenza di videocassette, dvd, youtube e streaming, quando ero piccola dovevo affidarmi al capriccio dei canali televisivi per vedere un film o i cartoni animati. Oggi la mia collezione di dvd è ampia, ma qualcosa non diverrà mai acquistabile o scaricabile: la sorpresa, l’imprevisto di certi pomeriggi infantili in cui il piccolo schermo del televisore poteva davvero riversare una magia nel mio sguardo. Uno dei film che mi capitò di vedere era
assenza di videocassette, dvd, youtube e streaming, quando ero piccola dovevo affidarmi al capriccio dei canali televisivi per vedere un film o i cartoni animati. Oggi la mia collezione di dvd è ampia, ma qualcosa non diverrà mai acquistabile o scaricabile: la sorpresa, l’imprevisto di certi pomeriggi infantili in cui il piccolo schermo del televisore poteva davvero riversare una magia nel mio sguardo. Uno dei film che mi capitò di vedere era 




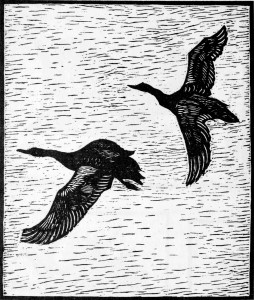 Il paesaggio si è raggelato e qua, sulle colline, gli alberi si sono finalmente bruniti del tutto – è caduta perfino un po’ di neve, poi lavata via dalle piogge. Quindi benvenuto inverno che spingi i gatti dentro le case e lontano dalle loro mappe campestri, che fai proliferare le tazze di tè e cioccolate calde e sognare stufe antiche, ciocchi di legno nel caminetto, mondi polari di silenzio e occhi selvatici. Benvenuti libri di favole crudeli, Natali stregati, leggende del nord.
Il paesaggio si è raggelato e qua, sulle colline, gli alberi si sono finalmente bruniti del tutto – è caduta perfino un po’ di neve, poi lavata via dalle piogge. Quindi benvenuto inverno che spingi i gatti dentro le case e lontano dalle loro mappe campestri, che fai proliferare le tazze di tè e cioccolate calde e sognare stufe antiche, ciocchi di legno nel caminetto, mondi polari di silenzio e occhi selvatici. Benvenuti libri di favole crudeli, Natali stregati, leggende del nord.