di Mia Lecomte, Rosanna Morace, Pina Piccolo
Julio Monteiro Martins era un poeta, un sognatore, uno scrittore. Costruiva utopie possibili e le alimentava con il suo meraviglioso entusiasmo. Questo grande piccolo guerriero delle lettere ci ha lasciato pochi giorni fa. Tre amiche Pina Piccolo, Mia Lecomte, Rosanna Morace lo ricordano oggi su Nazione Indiana.
IL CAPPELLO

Oggetto: Primi giri con gomme da pioggia
Da: “Julio Monteiro Martins”
A: “Mia Lecomte”
Data: Sabato, 29 novembre 2014, 11:26 AM
Ciao Mia,
ti mando questa bella traduzione del racconto “The Other Barack”, fatta da Gioia, che può servirti in Francia o negli USA per quelli che non leggono in italiano, o la potranno utilizzare a lezione con gli allievi stranieri.
Chiamami, quando puoi, sono ancora a fare la chemio, prima, ieri, all’ospedale, e ora a casa, con una tecnologia tipo un “biberon portatile tecnologico” che devo portare dappertutto fino a domani alle ore 21,00, quando andrò a Pisa a ritirarlo e ripulire gli aghi e i tubi interni del port.
Gli effetti collaterali per ora sono sopportabili, dei singhiozzi, lunghe sequenze, e un po’ di bruciore allo stomaco, poi la medicina specifica li mette a posto. Ma sono stato ben avvertito che la parte pesante inizia domenica e lunedì. Mi sono già procurato anche una cuffia di lana nera. Ma se trovi un bel cappellino a Parigi, me lo prendi tu? Così sarei un elegante e raffinato testa d’uovo.
Quando vuoi chiamarmi, oggi sarò solo a casa dopo l’una.
Un bacio
Julio
Oggetto: Primi giri con gomme da pioggia
Da: “Mia Lecomte”
To: “Julio Monteiro Martins”
Data: Sabato, 29 novebre 2014 11:33 AM
Ci sentiamo dopo. Ti prenderò una francesissima parrucca Luigi XIV, con boccoli fino alle spalle (e un bastone con il pomo d’oro, e lunghe calze di seta…). Sarai uno schianto! M.
Oggetto: Primi giri con gomme da pioggia
Da: “Julio Monteiro Martins”
Data: Sabato, 29 novembre 2014, 11:44
A: “Mia Lecomte”
Un guerriero della tribù degli xavante, con la sua immensa borduna in pugno, non può travestirsi da cicisbeo settecentesco, vero? Ma che xavante sarebbe?
Un cappellino da intellettuale francese della Nouvelle Vague? Così sarei uno xavante moooolto acculturato… Guerriero per altri metodi e strategie.
Baci
Julio
* il cappello te l’ho portato in ospedale: nero e intellettual-francese al punto giusto. Ora fa la sua figura sulla bella testa capellona di Lorenzo (M.L.)
IL GUERRIERIO XAVANTE
Gli xavantes sono una popolazione di guerrieri originaria del Mato Grosso, in Brasile, e furono l’ultimo popolo ad essere stato ridotto in schiavitù dall’esercito brasiliano, nel XVIII sec.; da allora, vivono per lo più lontani da ogni contatto con la globalizzazione, mantenendo la propria lingua e i propri riti, le proprie tradizioni e i propri modelli di organizzazione sociale e religiosa.
Ciò che rende Julio Monteiro Martins un grande guerriero xavante non è solo l’origine brasiliana, ma l’orgoglio fiero, la ferrea volontà di non piegarsi a compromessi, di lottare in prima persona e a suo rischio per ciò che intimamente avvertiva come sopruso o ingiustizia, sia a livello personale che sociale/politico, salvo poi la strabiliante capacità di risorgere dalle proprie ceneri e di prepararsi ad una nuova sfida.
Tengo a precisare che, nonostante potrebbe sembrarlo, questa non è retorica dettata dal dolore del momento: basti leggere l’ultimo scambio di mail che Julio e Mia hanno avuto − e che Mia ci ha gentilmente regalato −, in cui è davvero condensata tutta la tempra dell’uomo, il coraggio, l’ironia e la leggerezza con i quali è riuscito a sfaldare un momento così drammatico, pur nella lucida consapevolezza della gravità della situazione, mai minimizzata.
Un ultimo atto che è il degno compimento di un’intera vita da guerriero: dall’attivismo politico e letterario durante la dittatura brasiliana, quando non era ancora ventenne; alla capacità di mettersi in gioco, in quegli stessi anni, aprendo una casa editrice attenta alla pubblicazione di opere prime,1 fino alla co-fondazione del partito verde brasiliano e all’attività di avvocato per i Diritti umani per la difesa dei meninos de rua, nel processo seguìto alla «Strage della Candelaria».2 Poi, l’arrivo in Italia nel 1995, quando si era oramai reso conto che la caduta della dittatura non aveva comportato un reale rinnovamento del Brasile, ma addirittura il crollo di quegli ideali che avevano animato il dissenso.
E, anche nella nuova patria, il medesimo impegno politico, la medesima attenzione agli autori emergenti e alla promozione della letteratura mondiale, la lungimirante rivendicazione della forza della letteratura della migrazione: tutti aspetti confluiti nella creazione della rivista online «Sagarana», fondata, diretta e curata da Julio a partire dal 2000.
D’altronde, anche la ricca produzione in prosa e in poesia, italiana e brasiliana,3 di Julio Monteiro Martins è specchio di quanto si è fin qui detto, e testimonia con incisività quanto la scrittura sia sempre stata, per lui, strumento attivo di conoscenza, partecipazione, denuncia, fino a farsi vero e proprio ethos (in questo senso, lui precisava che scrivere «non è un ‘fare’, è un ‘essere’»): il confronto diretto con il presente e le sue reali condizioni storiche, politiche e sociali passa così dalla denuncia delle aberrazioni umane durante la dittatura brasiliana, alle riflessioni sul berlusconismo e sul «pensiero unico dominante» della globalizzazione nelle opere italiane, pur nella costante tematizzazione dei tre grandi motivi con cui tutta la letteratura, in maniera esplicita o implicita, si confronta da sempre, ovvero la morte, il vuoto e l’amore.4 Vi è, dunque, una netta continuità tra la produzione artistica nella madrepatria e quella nella terra di adozione, nonostante la nuova lingua e l’esperienza migratoria abbiano comportato l’approfondimento di certi temi e l’affievolirsi di altri. Tra tutti, emerge certamente quello dello strappo-rinascita.
Julio parlava, infatti, della sua emigrazione come di un «suicidio amministrato»: un sintagma molto particolare il cui significato è chiarito nel frammento 58 della «Seconda parte» di Cronache di gloria e disperazione (inedito):
Perché tante persone emigrarono, da sole o con le loro famiglie, verso terre lontane e sconosciute? La prima risposta è che non c’erano più le condizioni perché rimanessero dove abitavano. Ma molti altri erano rimasti, vivendo la miseria, il pericolo, aspettando la morte certa o impazzendo per le speranze eternamente rimandate. Quindi, da dove viene il coraggio di quelli che se ne vanno? Il coraggio viene da un’intuizione: emigrare è anticipare la morte in una forma benigna. Cosa ci aspetta dopo la fine? Il cielo? L’inferno? Quindi, che venga subito, ed in questa vita.
Come nella morte vera, l’emigrante lascia tutto dietro di sé: i paesaggi, gli amici, i propri morti, il proprio passato e la propria unica identità. Egli abbandona il proprio corpo materiale, nella forma della sua storia personale, ed emigra sprovveduto, inerme, solo, etereo e spoglio come uno spirito, verso l’ignoto assoluto. L’emigrante ha ingannato la morte come un torero inganna il toro. Egli si è visto condannato e, prima dell’esecuzione lenta e brutale della sentenza, si è costruito la propria morte, ha assunto volontariamente il controllo della propria fine e così ha guadagnato la possibilità di una nuova vita.
L’emigrante è colui che sceglie il proprio oltre. Egli fugge dall’oltretomba verso l’oltremare, l’oltre frontiera, l’oltre foresta, l’oltre deserto. L’emigrante, così come un morto, ha perduto ormai tutta la paura, perché qualunque cosa succeda a partire da quella rottura cruciale è pur sempre qualcosa, può essere anche il peggior qualcosa, ma è qualcosa, ed egli sarà libero per molto tempo dal fantasma del nulla, che rendeva la sua vita ogni giorno meno sopportabile.
Emigrazione come morte prima imposta, poi voluta. Emigrazione come rinascita scelta, volontaria, compiuta da colui che ha perso la paura del vuoto e cerca un nuovo oltre. L’emigrante è quindi colui che ha ingannato la morte e ha avuto il coraggio di anticiparla «in forma benigna».
L’emigrazione come l’atto di un guerriero che rifiuta di vedersi morire senza combattere.
E siamo certi che anche in questa seconda emigrazione Julio abbia saputo e saprà fuggire «dall’oltretomba verso l’oltremare, l’oltre frontiera, l’oltre foresta, l’oltre deserto», avendo «perduto ormai tutta la paura, perché qualunque cosa succeda a partire da quella rottura cruciale è pur sempre qualcosa, può essere anche il peggior qualcosa, ma è qualcosa, ed egli sarà libero dal fantasma del nulla, che rendeva la sua vita ogni giorno meno sopportabile».
Rosanna Morace
La rivista Sagarana
La rivista Sagarana, trimestrale di letteratura mondiale online, ideata e diretta da Julio Monteiro Martins, e in esistenza ininterrotta dall’ottobre 2000, una tra le più longeve in Italia, è stata uno dei progetti più apprezzati e di maggiore impatto nei suoi 20 anni di intensa attività letteraria in Italia. Nel corso degli anni la rivista si è costruita un seguito di migliaia di lettori assidui sparsi nei 5 continenti, che ogni tre mesi aspettavano di leggere gli assaggi di saggistica, narrativa, poesia scelti da Julio e proposti da una rete internazionale di collaboratori. Nel loro insieme tali assaggi costituivano una specie di antidoto al pensiero unico che Julio tanto disdegnava e considerava il male più subdolo dei nostri giorni.
L’impegno a contrastare l’uniformazione ideologica e letteraria ai modelli imposti dal mercato veniva affrontato in modo esplicito negli editoriali del Direttore, che erano una sorta di “terza pagina” rivolta a chi si occupava di letteratura e politica. Oltre agli editoriali, di suo Julio contribuiva spesso con brevi racconti, di cui ho sempre apprezzato uno stralunato senso del grottesco, tutto suo, feroce e tenero nel contempo. Sia nei pezzi che sceglieva che in quelli che scriveva, Julio non si limitava ad essere un cultore di una certa estetica letteraria ma tentava anche di costruire una “epistemologia” della letteratura alla scoperta di certe verità sull’animo umano che solo i diversi generi letterari contengono e possono rivelare. E su questo ci siamo spesso scontrati, nel senso che mi rimproverava una visione eccessivamente utilitaristica della letteratura in chiave militante, e mi incoraggiava a un maggior rigore nel cercare il quid rivoluzionario insito nella scrittura stessa.
Per onorare la sua memoria vorrei proporre un brano tratto dal «Prologo» del romanzo L’ultima pelle (scritto in portoghese e tradotto dall’autore), proposto nella rivista alla pagina «Il Direttore», che ci dà un assaggio di questa sua ricerca:
[…] Così come nei rettili e negli uccelli, certi colpi inaspettati, certe ferite, certe angosce, possono anticipare la muta a un momento imprevisto. Il nostro canto tace, le nostre piume cadono, e noi tremiamo dal freddo sul ramo più remoto della voliera. Ma allora il ciclo si completa, inaspettatamente come è cominciato. Il personaggio è già un altro, integrato al mondo che lo circonda e dal mondo ogni volta più celebrato. Noi torniamo a cantare ancora meglio, a strisciare più veloci tra i cespugli e le pietre. Sono i cicli della nostra provvisoria pienezza. Noi ci sentiamo interi nuovamente. Ci sentiamo come sempre fummo, poiché le trasformazioni spariscono tra i due anelli estremi della catena, che si uniscono nella memoria. Non ricordiamo niente che non sia il momento abbagliante, il personaggio completo, e nella meraviglia di una pace attiva nemmeno percepiamo che il nostro canto adesso è differente, che la nostra pelle è un’altra.
[…] Quello che è rimasto sul cammino, piume, pelle, identità, non sono spoglie o reminiscenze, sono parti perdute della materia che ci costituisce, sono fossili della nostra essenza, sono ego sottratti, che in un giorno qualsiasi del futuro ci lasceranno con un’unica piuma, con un’ultima pelle, con un ultimo e monocorde canto, con il personaggio definitivo. Abbiamo bisogno di cominciare ad amarlo molto presto, molto prima del primo cambio di pelle.
Pina Piccolo
1 La casa editrice «Anima», fondata e diretta da Julio Cesar Monteiro Martins, ha pubblicato il maggior numero di opere prime di autori brasiliani tra il 1983 e i 1987, nonché numerose traduzioni di testi inediti in portoghese.
2 La strage della Chacina da Candelária, avvenuta a Rio de Janeiro il 23 luglio 1993, fu compiuta da una squadra di poliziotti in borghese, che uccise nel sonno a colpi di mitra i bambini orfani che dormivano in strada.
3 Mi limito qui a citare i volumi. In portoghese: Torpalium, São Paulo, Ática, 1977 (racconti); Sabe quem dançou?, Rio de Janeiro, Codecri, 1978 (racconti); Artérias e becos, São Paulo, Summus, 1978 (romanzo); Bárbara, Rio de Janeiro, Codecri, 1979 (romanzo); A oeste de nada, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1981 (racconti); As forças desarmadas, Rio de Janeiro, Anima, 1983 (racconti); O livro das diretas, Rio de Janeiro, Anima, 1984 (saggi politici); Muamba, Rio de Janeiro, Anima, 1985 (racconti); O espaço imaginário, Rio de Janeiro, Anima, 1987 (racconti).
In italiano: Il percorso dell’idea, Bandecchi e Vivaldi, Pontedera, 1998 (poesie), Racconti italiani, Nardò, Besa, 2000 (racconti); La passione del vuoto, Nardò, Besa, 2003 (racconti); madrelingua, Nardò, Besa, 2005 (romanzo); L’amore scritto, Nardò, Besa, 2007(racconti); La grazia di casa mia, Milano, Rediviva, 2013. Di prossima pubblicazione per Besa è La macchina sognante.
4 Su ciascuno di questi temi sono incentrate le tre raccolte di racconti pubblicate in Italia: Racconti italiani (sulla morte), La passione del vuoto, L’amore scritto.






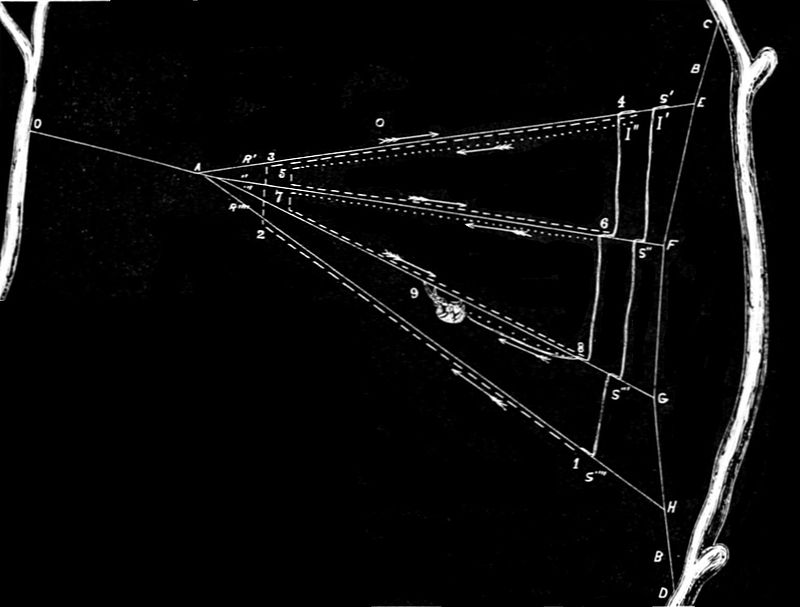

 Alla voce “Chi Siamo” della nuova rivista settimanale on-line edita da Mimesis Edizioni, si legge:
Alla voce “Chi Siamo” della nuova rivista settimanale on-line edita da Mimesis Edizioni, si legge:






 Piazza Dante.
Piazza Dante.
