
Ho chiesto a Erri De Luca di poter pubblicare questo racconto, in questa mia rubrica dedicata al tema della scuola. Di recente l’ho letto insieme ai miei ragazzi al Liceo francese di Torino, dove insegno filosofia, e mi ha colpito il mondo (modo) in cui hanno reagito ai temi affrontati. Qui la sua risposta. effeffe
Ciao, nessun problema anzi grazie per far camminare quella storia fuori dallo scaffale offrendolo a chi è giovane ora, buona giornata,erri
Il pannello
di
Erri De Luca
Brano tratto dal volume In alto a sinistra, Feltrinelli 2007
Era stato staccato un pannello della cattedra per guardare le gambe della supplente. Eravamo una classe maschile, seconda liceo classico, sedicenni e diciassettenni del Sud, seduti d’inverno nei banchi con i cappotti addosso. La supplente era brava, anche bella e questo era un avvenimento. Aveva suscitato l’intero repertorio dell’ammirazione possibile in giovani acerbi: dal rossore al gesto sconcio. Portava gonne quasi corte per l’anno scolastico 1966-1967.
Si era accorta della manomissione solo dopo essersi seduta accavallando le gambe: aveva guardato la classe, la mira di molti occhi, era arrossita e poi fuggita via sbattendo la porta. Successe il putiferio. In quel severo istituto nessuno si era mai preso una simile licenza. Salì il preside, figura funesta che si mostrava solo in casi gravissimi. Nell’apnea totale dei presenti dichiarò che esigeva i colpevoli altrimenti avrebbe sospeso l’intera classe a scadenza indeterminata, compresi gli assenti di quel giorno. Significava in quei tempi perdere l’anno, le lezioni e i soldi di quanti si mantenevano agli studi superiori con sacrificio delle famiglie. Non esisteva il TAR, quel tribunale amministrativo cui oggi si sottopongono ricorsi per ristabilire diritti. Non c’erano diritti, le scuole superiori erano un privilegio. C’era la disciplina caporalesca degli insegnanti, legittima perché impersonale e a fin di bene. Il preside uscì, si ruppe quel gelido “attenti” che avevamo osservato. Non riuscimmo a sputare una parola.
Accadde una cosa impensabile: sottoposti all’alternativa di denunciare due nostri compagni o patire conseguenze gravi nello studio, quei ragazzi si zittirono a oltranza e nessuno riuscì a estorcere loro quei nomi. Nessuno parlò. Questo è il racconto del comportamento ostinato di un gruppo di studenti uniti solo dal fatto di essere iscritti alla sezione B, secondo anno di liceo, dell’Istituto Umberto I di Napoli nell’anno scolastico 19661967. Tranne una combriccola composta da ragazzi di agiata famiglia con residenza al centro, o un altro gruppo di ragazzi di pochi mezzi che si trovavano nel pomeriggio per studiare insieme, tranne qualche partita a pallone la domenica, niente univa quei ragazzi. Però è vero che niente ancora li divideva sanguinosamente, come sarebbe accaduto in pochi anni. Non ho più visto i compagni di quella classe, non fummo amici né soci, solo membri di un’età costretta a essere seme delle successive, inverno delle altre. Di colpo quei ragazzi spaventati si irrigidirono in un silenzio impenetrabile.
Quando il preside uscì non avevamo più freddo. Cominciava la tensione di un assedio ancora senza parole tra noi. Parlò il solo che si era opposto, quel mattino prima dell’inizio delle lezioni, allo svitamento del pannello. Era il più ligio di noi e spesso veniva preso in giro per quel suo impulso all’ordine. Quel mattino era stato zittito, ora recriminava perché aveva ragione e perché quel provvedimento contro tutta la classe era un’ingiustizia ai suoi occhi. Molti non erano ancora saliti in aula quando il pannello era stato tolto. Protestava accorato con voce che sbandava tra l’acuto e il grave come succede agli adolescenti. Stavolta non faceva ridere. Non so dire perché non si rivolse mai ai due colpevoli, non li additò alla classe che ancora ne ignorava i nomi, invece se la prendeva con noi, quei pochi presenti che non l’avevano aiutato a impedire quel gesto. Si sentì solo la sua voce in quell’intervallo. Ognuno cercava di rendersi conto delle conseguenze. Qualcuno aveva la famiglia povera che non gli avrebbe permesso di ripetere l’anno. Tutti temevamo la reazione che l’episodio indifendibile avrebbe prodotto in casa. C’era chi sarebbe stato promosso a occhi chiusi e che vedeva sfumare il diritto alla borsa di studio, chi aveva già fatto spendere soldi per le lezioni private. Ognuno aveva un grado nel pericolo. Eppure nessuno denunciò gli autori dello svitamento, neppure sotto la nobile causa di salvare gli altri. Nessuno chiese ai due compagni di denunciarsi. Questi si rimisero alla decisione della classe e la classe li coprì. Avrebbero altrimenti patito punizione esemplare, sarebbero stati espulsi da tutte le scuole. Questo sembra incredibile a chi conosce quello che è successo nelle aule d’Italia solo pochi anni dopo, eppure le cose stavano così: la scuola italiana un quarto d’ora prima di essere sovvertita dagli studenti era saldamente in mano alla gerarchia docente.

Eravamo ancora zitti quando entrò il professore dell’ora successiva. Squadrandoci fieramente pretese di conoscere immediatamente i nomi dei colpevoli. Alzò la voce. Diede agli sconosciuti il titolo di vigliacchi e a noi che li coprivamo attribuì colpa ancora più grave, degna del più severo provvedimento. Richiese i nomi un’altra volta. Dopo il secondo silenzio applicò la rappresaglia: interrogò alcuni di noi che nella sua materia tentennavano, li confuse con domande difficili e atteggiamento sprezzante, li congedò annunciando, cosa mai prima accaduta, il pessimo voto riportato. Quella palese ingiustizia fece del bene a tutti. Era iniziato un assedio, ne andava della vita scolastica di ognuno, che era tutta la nostra vita pubblica di cittadini.
Sotto il duro ricatto di denunciare dei compagni o incorrere in provvedimenti disciplinari spuntò d’improvviso uno spirito di corpo. Ragazzi che avevano in comune la frequentazione di un’aula per alcune ore al giorno diventarono un organismo disposto a cadere tutto intero pur di non consegnare due suoi membri. Passò nelle fibre di uno scucito gruppo di coetanei una di quelle scariche elettriche che su scala più grande trasformano varie genti in un popolo, molte prudenze in un coraggio. C’è una soglia segreta di pazienza passata la quale ci si oppone di colpo alla disciplina quotidiana. Occasione è spesso un motivo all’apparenza insignificante. Anni dopo, partecipando a lotte operaie, avrei appreso con stupore che la lunga catena di scioperi spontanei e di aperte rivolte di fabbrica cominciarono alla FIAT, nel 1969, con richieste semplici come nuove tute da lavoro o la distribuzione di latte nelle lavorazioni tossiche. Piccole occasioni di rottura della pazienza quotidiana contengono grandi scosse: di colpo le strade si riempiono di scontento che sembra nato di pioggia come un fungo.
Non fu una rivolta, non chiedevamo niente, ma uno scatto di reazione contro chi voleva perquisirci dentro.
Fuori di scuola quel giorno si discusse. In mezzo all’assembramento notammo la strana presenza dei bidelli. Qualcuno di noi chiedeva almeno di sapere a chi doveva il rischio di rinunciare all’anno scolastico. Lì fuori venne zittito. Alla fine questa curiosità per vie traverse venne esaudita al nostro interno, ma in quel primo scambio di battute prevalse una spontanea disciplina. Il più ligio di noi trasferì il suo impulso all’ordine a servizio di quel silenzio. Qualcosa tra lui e la gerarchia scolastica si era guastato per sempre.
Quel giorno nelle nostre case si ripropose intero l’assedio. L’atmosfera fu inquisitoria come e più che a scuola. L’unico scampo: rifugiarsi nell’impossibilità di fare nomi di compagni senza esserne certi. Nessun retroterra familiare si mostrò comprensivo nei confronti della colpa, nessuno sostenne almeno un poco i diritti al silenzio di fronte al ricatto. Nessuno: tempi tutti d’un pezzo, non era solo a scuola il campo del dovere, esso si estendeva a tutta la piccola vita privata. Da adulto ho visto le famiglie difendere figli colpevoli di stupro e di linciaggio, un tempo invece stavano dalla parte dell’accusa. Se un ragazzo non si trova di colpo solo al mondo, mai cresce. Forse era difficile essere giovani in quei tempi anche se, per misericordia, non lo sapevamo. Molte più cose di oggi, in quegli anni erano considerate importanti, molto del futuro di ognuno si decideva sui banchi di quelle scuole.
Nei giorni successivi si ripeté in classe la richiesta di denunciare i colpevoli, fino al limite dell’ultimatum. Arrivarono al preside anche diverse lettere anonime coi nomi dei presunti responsabili, ma discordanti tra loro. La faccenda però non era più ferma ai colpevoli, si voleva rompere quell’inaudita ostinazione. Ma non ci fu verso di farci denunciare quei compagni. Penso che ci sentissimo tutti colpevoli, quelle gambe avevano emozionato ognuno. Fu perciò un po’ di immedesimazione verso quel gesto, anche se ce ne vergognavamo. La giusta linea di condotta proveniva da alcuni di noi che avevano già qualche relazione amorosa e trasmettevano agli altri un senso di superiorità da adulti nei confronti di quel gesto da guardoni nel buco della serratura. Ci piaceva credere di essere superiori agli scopi di quel sabotaggio, anche se non era così. Ma questo non contava più, stavamo andando dritti verso le conseguenze inevitabili. Ci eravamo irrigiditi dentro, pur mostrando all’esterno la costernazione dei malcapitati. Sotto quell’assedio eravamo diventati soldatini, imparando a difenderci tutti allo stesso modo.
C’era già in quegli anni una specie minore di solidarietà tra studenti che stava nel non farsi avanti a dare al professore una risposta che un altro non era stato in grado di fornire. Nessuno chiedeva di rispondere al posto del compagno. Forse era un comportamento legato al pudore di mostrami saputelli ed è troppo pretendere che fosse solidarietà. Questa era voce che si applicava a grandi cause come quelle dei terremotati, degli affamati e degli alluvionati. Però quel trattenersi dal dare la risposta era una pratica che insegnava a non mortificare il proprio compagno, a rivolgergli perciò un’attenzione non solo scolastica. Ovunque simili usanze sono sparite.
Prima dell’ora di scadenza dell’ultimatum entrò a fare la sua lezione il professore di greco e latino. Erano già passati alcuni giorni e non ci aveva detto una parola sulla faccenda, tranne al suo primo ingresso in aula dopo il putiferio. Era entrato, si era seduto, ma invece di aprire il registro ci aveva guardati tutti quanti a lungo, poi aveva giunto le enormi mani in preghiera e le aveva agitate in avanti e indietro, secondo quel gesticolare che sta per: “Cosa diavolo avete combinato?» Era un gesto semplice, temperato di sollecitudine, con un piccolo accento buffo mischiato al rimprovero muto. L’accogliemmo con gratitudine. Subito dopo diede inizio alla sua lezione. Bisogna ora che io nomini quest’uomo: Giovanni La Magna. Siciliana, completo conoscitore della lingua greca della quale aveva redatto una grammatica e un vocabolario, mostrava un corpo massiccio, dal passo pesante. Il volto era aperto, cordiale e i tratti gli si spianavano quando con la sua grave voce di basso compitava i versi greci e latini facendo cadere l’accento sulle sillabe con suono incalzante di zoccolo di cavallo sul selciato. Ci innamorò di Grecia antica perché ne era innamorato. Gli piaceva insegnare: questo verbo per lui si realizzava nell’accendere nei ragazzi la voglia di conoscere che sta in ognuno di loro e che aspetta a volte solo un invito sapiente. Era alla fine della sua carriera, mostrava anche più dei suoi sessanta. Aveva il gusto sicuro della battuta folgorante che detta dal suo faccione imperturbabile faceva esplodere la classe in una risata improvvisa, come un colpo di frusta. Non ne ha mai ripetuta una due volte, non le pescava da un repertorio, le inventava. Credo che nessuno abbia saputo raccontare i dialoghi tra Socrate e i suoi discepoli meglio di lui. Nemmeno Platone, che li scrisse, poteva essere così bravo.
Incitava a essere leali con lui: non teneva conto di una insufficiente preparazione se lo studente gliela dichiarava spontaneamente prima della lezione. A chi si avvicinava alla cattedra per bisbigliare le sue giustificazioni, prestava a volte ascolto con gesto scherzoso, appoggiando la mano all’orecchio e strabuzzando gli occhi per manifestare il suo stupore. Lo amavamo: di quel cupo Olimpo di numi da cattedra era il nostro buon Zeus. Quel giorno dell’ultimatum entrò nell’aula e togliendosi il cappotto annunciò che non avremmo parlato né di greco né di latino. Si sedette, accantonò il registro e ci parlò. Confido di non tradire il suo tono di voce e i suoi argomenti provando a ripeterli con le parole che ricordo: “Voi sapete che sono siciliano. Nella mia terra c’è un costume che vieta di denunciare i colpevoli di reati: si chiama omertà. Voglio parlarvene per stabilire i punti di contatto e quelli di differenza tra questo costume e lo spirito di solidarietà. L’omertà nasce dal bisogno di difendersi da un regime sociale di soprusi in cui la giustizia è applicata con parzialità e favoritismi, ma contrappone malauguratamente a questo un altro regime di soprusi: la mafia. L’omertà è un comportamento radicato in tutta la popolazione quando considera l’intero apparato statale un grande sbirro. La mafia che è nata da questa silenziosa protezione popolare, l’ha trasformata in legge di sangue sicché oggi l’omertà è frutto principale della paura. Essa non distingue tra chi si ribella a un sopruso e chi agisce da criminale, copre tutti, il povero cristo e il malfattore. L’omertà è diventata cieca ed è al servizio di un’altra prepotenza.
“Lo spirito di solidarietà è invece un sentimento che onora l’uomo. Non è una legge, come l’omertà, sorge di rado. Spunta di colpo tra persone che si trovano in difficoltà, comporta il sacrificio personale, non si nasconde dietro il mucchio formato da tutti gli altri. Nel vostro caso la solidarietà può essere quella di tutti per proteggere due, ma potrebbe anche essere quella di due che si fanno avanti per proteggere tutti gli altri. La solidarietà è opera preziosa di un’occasione, appena compiuto il suo dovere rompe le righe, lasciando in ognuno la coscienza tranquilla. Se siete d’accordo con me su queste differenze, allora potrete meglio conoscere quello che vi succede in questi giorni. Io non credo che gli svitatori di pannelli della seconda B abbiano intimorito tutti gli altri inducendoli a tacere. Credo invece che sia sorto tra voi in questi giorni uno spirito di squadra contro un provvedimento che ritenete ingiusto.
Pensate forse di stare subendo un sopruso: il ricatto di denunciare i vostri compagni oppure essere sospesi a tempo indeterminato. Ma non è stato un sopruso far arrossire di vergogna una donna che è entrata in quest’aula per insegnare e che, per poter accedere al privilegio di mostrare a voi le sue gambe, ha studiato per anni ed è appena giunta all’occasione che ha tanto aspettato? Un sopruso, una prepotenza di molti contro una donna, questo è accaduto qui dentro. Non siete. innocenti, nessuno qui è innocente. Il torto è spesso meglio distribuito di quanto ci piace credere.
“Io faccio parte di questo regime scolastico contro il quale avete fatto muro. Anzi sono il più vecchio insegnante di questa scuola. Noi siamo insegnanti, voi studenti, siamo per questo più forti di voi, possiamo bocciarvi, sospendervi tutti, compromettere i piani scolastici forse irrimediabilmente per alcuni di voi. Ma vogliamo farlo? Credete che vogliamo rovinarvi? Noi che siamo i più forti ci stiamo in verità difendendo da voi. Ritenete vostra facoltà levare un pannello di cattedra per vedere le gambe di un’insegnante? Presto riterrete vostra facoltà abbassarle la gonna per ammirarle intere. Perché non l’avete fatto con me? Perché sono un uomo o perché non sono un supplente? Noi ci stiamo difendendo da voi, voi da noi: così le aule diventeranno campi di battaglia, vincerà il più forte, ma la scuola sarà finita. È con profonda tristezza che vedo questo accadere. È contro tutto quello che ho fatto nei miei molti anni di insegnamento. Mi accorgo di non avere più un posto in un’aula ridotta a schieramento, di non poter fare più niente per voi. Mi state licenziando voi, i miei colleghi, tutti. Questo spirito di ostilità che scorgo in loro e in voi mi avvisa di tempi in cui non avrò parte.
“Non approvo un provvedimento così drastico nei vostri confronti, non lo farò applicare per quello che potrò, ma non so approvare nemmeno la vostra caparbietà. Ce l’ho con tutti voi: il vostro spirito di corpo è la cosa più preoccupante alla quale assisto da quando vivo nella scuola. Il vostro serrare i ranghi è il gesto più duro da intendere per uno come me che pensava di stare in una classe e si ritrova a visitare una barricata. Non credo che il vostro silenzio sia omertà, che stiate diventando una mafia. Però so che questo guaio può scaturire da ogni ostilità di parte. Se c’è ancora una lezione che posso permettermi di darvi è quella di insegnarvi a distinguere nella vostra vita l’omertà e la solidarietà. Siate pure oggi leali tra voi fino a sopportare il sacrificio di un duro provvedimento disciplinare, ma non imparate domani a proteggere l’ingiusto, il prepoténte, il vendicatore. Prima che siate sospesi in blocco dalle lezioni, propongo a voi di fare le più sentite e solenni scuse all’insegnante che avete offeso. Fate questo senza aspettarvi niente in cambio, fatelo solo perché è giusto. Fatelo prima che il vostro silenzio si indurisca troppo contro di noi, si avveleni di avversione, distrugga il mio lavoro con voi e la vostra possibilità di trarre profitto dalle ore trascorse insieme in queste aule”.
Mi perdoni, lì dove riposa, l’uomo al quale attribuisco queste parole e del quale provo a ricordare una lezione. Essa fu certamente più intensa ed efficace di quella che posso ricostruire. La sorreggeva una voce che rimaneva paterna anche nel tratto amaro, grave senza severità. Era voce di uomo che si spogliava della dignità della cattedra per parlare da pari ad altri pari. A una classe di sedicenni pieni di brufoli e di barbe ancora a chiazze sul viso, si rivolse come a un’assemblea, svolgendo un ordine del giorno. Ci sentimmo spaesati, ma più grandi, senza parole, certo, ma finalmente spogli del bisogno di difenderci. Quell’uomo ci trattò da uomini. Nessuno di noi lo era ancora, ma tutto dentro di noi in quei giorni spingeva a diventarlo. Ci fece provare la responsabilità di persone che intendono l’ora e il luogo in cui sono. Disfece con i suoi modi leali il rozzo campo di battaglia nel quale ci sentivamo rinchiusi. Non ci additò una scappatoia, sgomberò semplicemente l’assedio mostrando il male di quell’ostilità, addossandosene una parte. Accese in noi il desiderio di rispondere, come già altre volte aveva incitato il nostro desiderio di apprendere. Uno di noi si alzò, il più mite, e uno tra i più diligenti, disse a nome di tutti che le nostre scuse erano il passo minimo che ci sentivamo di fare e che l’avremmo già fatto se solo ne avessimo avuto la possibilità. Nessuno disse cosa contraria o diversa.
Le scuse vennero accettate. Le lezioni ripresero con la palese disapprovazione di alcuni insegnanti insoddisfatti della riparazione e contrari a quella composizione “a tarallucci e vino”. Il partito della fermezza contava i suoi effettivi in vista delle future prove. Noialtri ci considerammo scampati, rompemmo subito le righe piegando ancora di più il collo sui libri. Ancora per poco l’atteggiamento prevalente dei professori fu di rappresaglia, poi lo spirito dell’insegnamento prevalse e ritornò in vigore la bilancia dei meriti e dei profitti. Quell’anno fummo promossi in molti, compresi i due svitatori. Solo allora quella pagina di calendario fu per noi voltata del tutto.
L’anno seguente, stagione scolastica 1967-1968, avremmo affrontato la maturità. Prima di quell’appuntamento il professore Giovanni La Magna mancò a una lezione per la prima volta in tre anni. Si era rotto il cuore del nostro buon Zeus, fermate le mani enormi che ci avevano aperto le vie della Grecia classica, zittita la voce che aveva calcato per noi i versi più soavi della terra. Salimmo alla sua casa sulla collina del Vomero come un gregge disperso. Era disteso eppure sembrava ritto in piedi, manteneva anche così tutta la forza della sua presenza. Aveva le grandi mani intrecciate in grembo, gli occhi molto chiusi. Per la prima volta un ragazzo tra i tanti ebbe misura dello spreco insensato contenuto nella morte di un uomo. Tutta quella Grecia svisceratamente amata da un siciliano, tutta quella sapienza si perdeva, a nessuno poteva più trasmettersi. Ne trattenevamo frammenti lucenti da un vaso in frantumi, noi suoi allievi. Ma se tutti gli studenti che aveva avuto, avessero potuto mettere insieme i loro pezzetti, non avrebbero ricomposto l’interezza da lui posseduta. Le lacrime che ad alcuni di noi vennero agli occhi se le era guadagnate con quello che gronda dal cuore.
Morì in quei primi mesi dell’anno di subbuglio 1968, senza vedere le aule abbandonate sotto i colpi di una guerra che aveva intravisto e aveva scongiurato di evitare. La scuola finiva e non solo per i maturandi di quell’anno. Dopo di lui la Grecia tornò a essere la patria di una grammatica molto esigente. Ci sono uomini che morendo chiudono dietro di loro un mondo intero. A distanza di anni se ne accetta la perdita solo concedendo che in verità morirono in tempo.
 Nella pausa delle domeniche, in pomeriggi verso il buio sempre più vicino, fra equinozi e solstizi, mentre avanza Autunno e verrà Inverno, poi “Primavera, estate, autunno, inverno… e ancora primavera“, riscoprire film rari, amati e importanti. Scelti di volta in volta da alcuni di noi, con criteri sempre diversi, trasversali e atemporali.
Nella pausa delle domeniche, in pomeriggi verso il buio sempre più vicino, fra equinozi e solstizi, mentre avanza Autunno e verrà Inverno, poi “Primavera, estate, autunno, inverno… e ancora primavera“, riscoprire film rari, amati e importanti. Scelti di volta in volta da alcuni di noi, con criteri sempre diversi, trasversali e atemporali.




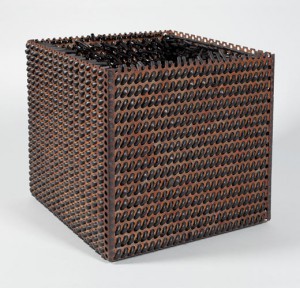










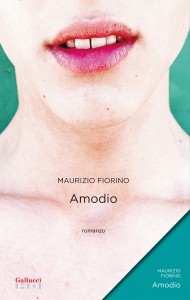 Forse non poteva essere più spigliato l’esordio letterario di Maurizio Fiorino, giovane talento della fotografia italiana ma che per anni ha vissuto a New York. Amodio (Gallucci, pp. 176, 16,50 euro) narra infatti la storia d’amore tra Armando e il figlio di uno dei boss più temuti della ‘ndrangheta, l’immaginario Carlo Costa, il quale scoperta la relazione è costretto ad appellarsi alle leggi mafiose, spietate quanto necessarie, e la cui violazione può sancire una condanna a morte.
Forse non poteva essere più spigliato l’esordio letterario di Maurizio Fiorino, giovane talento della fotografia italiana ma che per anni ha vissuto a New York. Amodio (Gallucci, pp. 176, 16,50 euro) narra infatti la storia d’amore tra Armando e il figlio di uno dei boss più temuti della ‘ndrangheta, l’immaginario Carlo Costa, il quale scoperta la relazione è costretto ad appellarsi alle leggi mafiose, spietate quanto necessarie, e la cui violazione può sancire una condanna a morte.
 di Mariasole Ariot
di Mariasole Ariot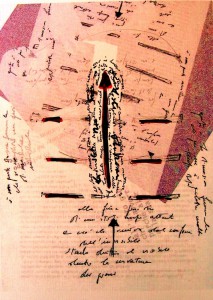

 Il 23 marzo 2013 viene inaugurata ad Ancona la statua Violata, monumento in ricordo “di tutte le donne vittime di violenza”, voluto e finanziato – senza alcun bando di concorso, ma accettando la proposta di una statua già realizzata in gesso dallo scultore Floriano Ippoliti – dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Marche in accordo con alcuni altri enti e associazioni femminili locali. La statua, che rappresenta una donna con borsetta di ideale bellezza dalle vesti succinte e stracciate in modo da scoprirne, mettendoli in tutta evidenza, il seno e il sedere, suscita immediatamente incredulità e sdegno. Una rappresentazione che viene giudicata da troppi semplicistica e inopportuna, se non offensiva della dignità delle donne vittime di violenza. Ne derivano diverse lettere di protesta (consultabili qui:
Il 23 marzo 2013 viene inaugurata ad Ancona la statua Violata, monumento in ricordo “di tutte le donne vittime di violenza”, voluto e finanziato – senza alcun bando di concorso, ma accettando la proposta di una statua già realizzata in gesso dallo scultore Floriano Ippoliti – dalla Commissione Pari Opportunità della Regione Marche in accordo con alcuni altri enti e associazioni femminili locali. La statua, che rappresenta una donna con borsetta di ideale bellezza dalle vesti succinte e stracciate in modo da scoprirne, mettendoli in tutta evidenza, il seno e il sedere, suscita immediatamente incredulità e sdegno. Una rappresentazione che viene giudicata da troppi semplicistica e inopportuna, se non offensiva della dignità delle donne vittime di violenza. Ne derivano diverse lettere di protesta (consultabili qui: 






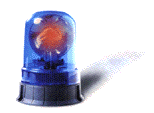


 Immaginate una principessa che proprio non ne vuole sapere di prendere marito, a meno che non sia tanto abile da arrivare a lei senza farsi scoprire.
Immaginate una principessa che proprio non ne vuole sapere di prendere marito, a meno che non sia tanto abile da arrivare a lei senza farsi scoprire.