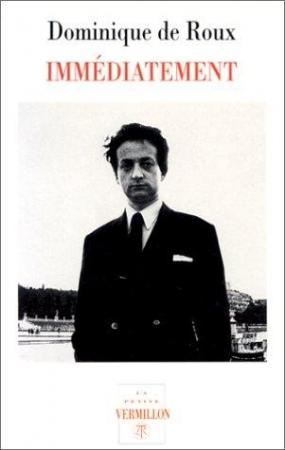Il 31 ottobre 2014 la Corte d’Appello di Roma ha assolto per insufficienza di prove tutti gli imputati – medici, infermieri e agenti di polizia – del processo per la morte di Stefano Cucchi, avvenuta il 22 ottobre del 2009 nel reparto protetto dell’Ospedale Sandro Pertini, sei giorni dopo il suo arresto. In primo grado nel 2013 erano stati condannati cinque medici su sei per omicidio colposo, ma ora la giustizia ha assolto anche loro. La famiglia Cucchi ha annunciato che farà ricorso alla Corte Suprema di Cassazione e farà causa al Ministero della Giustizia.
Class enemy : Kant torna in cattedra
di Mattia Maistri
 L’opera prima di Rok Bicek ha una trama piuttosto semplice: un professore di tedesco, Robert Zupan, sostituisce una collega in congedo di maternità in un liceo sloveno.
L’opera prima di Rok Bicek ha una trama piuttosto semplice: un professore di tedesco, Robert Zupan, sostituisce una collega in congedo di maternità in un liceo sloveno.
Da quel momento in poi, tutto il film ruota attorno al difficile rapporto tra l’uomo e la classe, esasperato dal tragico suicidio di una studentessa e dalla ribellione degli studenti che attribuiscono al docente la responsabilità dell’accaduto. Il conflitto acuisce la sua asprezza giorno dopo giorno, nella completa incapacità dell’istituzione scolastica di trovare il bandolo della matassa.
Matassa che si sbroglia da sola in un finale che non ha nulla di epico o eclatante, ma che pone i due soggetti (classe e docente) per la prima volta a confrontarsi su un orizzonte comune, benché conciliante nell’inevitabile separazione.
Se il film offrisse soltanto la narrazione di un’amara vicenda generazionale, potrebbe tranquillamente finire nel calderone dei film sulla scuola, senza infamia e senza lode. Ma è proprio la sua capacità meta-narrativa a renderlo un’opera apprezzabile e stimolante.
Lo scenario è così inquadrato: sullo sfondo gli studenti, divisi nelle loro peculiarità e bassezze adolescenziali, privi di riferimenti che non siano le etichette del “si dice” o del “si deve” – i trasgressivi e gli obbedienti – e, davanti a loro, la sfilata dei veri padroni della scena, gli adulti, che il regista è riuscito a trasformare in efficaci metafore dei portatori di senso, con i quali gli studenti si incrociano in una caotica e inconsapevole ricerca di risposte.
Le caratteristiche degli adulti sono costruite al fine di delineare dei “tòpoi”, alle prese con un reale al quale attribuire significato.
Troviamo così l’utilitarismo cinico di una preside che si affanna per far tornare la calma apparente che accontenti tutti; il sentimentalismo ottuso della docente in maternità che, da perfetta anima bella, crede che basti un poco di zucchero per far ingoiare l’amara pillola dell’esistenza; la schizofrenia etica dell’insegnante di educazione fisica che alterna rigore e pettegolezzo, distacco e seduzione, in un’alternanza priva di coerenza e soggetta agli istinti del momento; l’egoismo autistico dei genitori, incapaci di affrontare i figli senza essere autoreferenziali.
Infine, l’illuminismo prussiano del professore di tedesco: perfetta immagine di un Kant redivivo, giunto in una classe del XXI secolo a gettare un sasso che non sia preda dei flutti della cosiddetta società liquida.
Al pari del romanticismo esistenziale del professor Keating ne “L’attimo fuggente” e del sociologismo tragico (figlio di Adorno e Marcuse) del professor Wenger ne “L’onda”, l’illuminismo kantiano del professor Zupan supera i confini del lungometraggio e diventa strumento per scardinare la realtà del senso comune.
Mentre tutti gli altri personaggi, studenti in primis, sono preda di condizionamenti, sia interni che esterni, che ne offuscano la capacità analitica, generando un crescendo incontrollabile di drammi e frustrazioni, il rigore razionale di Zupan, fedele alla lezione kantiana, non mostra segni di cedimento, anche quando è facilmente equivocabile, anche quando impedisce qualsiasi forma di empatia, anche quando, masticando uno “stronzo” che riemerge dal lontano vissuto scolastico, ti fa trasalire sulla sedia del cinema.
Zupan è il vessillo della ragione decarnificata, libera dagli orpelli individuali che producono alibi, moventi e paraventi alle nostre dipendenze.
La forza con cui prende forma l’imperativo categorico della ragione soffoca le emozioni che – in poche scene – il professore sembra provare.
Perché non c’è spazio per i condizionamenti ma solo per la riflessione pura, scevra da buonismi o isterismi e svincolata da odio o pietà.
E al pari del filosofo sbeffeggiato e, infine, ucciso nel platonico mito della caverna, il kantiano Zupan offre agli studenti una lezione di libertà, capace di tracciare una via d’uscita alla cultura del nozionismo (utile alla carriera) o del miope relativismo per cui “tutti la pensano come cazzo vogliono”.
Acquisire la consapevolezza che, nonostante gli avvenimenti che singolarmente ci colpiscono, sia possibile vivere da uomini tra uomini, è più di uno spiraglio di luce per coloro che ogni giorno entrano in classe. E’ il filo di Arianna grazie al quale scoprire che una comunicazione è sempre possibile. Senza dover invocare roghi o ghigliottine.
Non perdiamo la testa. Il doveroso e vano tentativo di difendervi da Allam e le firme de Il Giornale
di Lorenzo Declich
E’ venerdì 24 ottobre, ho fatto una ricerchina su “Non perdiamo la testa” partendo dalla copertina, su cui si trova scritto “Controcorrente.it”.
Trattasi di un editore che promuove in questi giorni “Eurasia, Vladimir Putin e la Grande Politica” di Alain de Benoist e Aleksandr Dugin.
L’ultimo evento promosso da Controcorrente.it è il “XXII Convegno Tradizionalista della Fedelissima Città di Gaeta”.
Com’è di moda presso una certa qual destra, questo editore millanta un’operazione culturale “contro” il pensiero dominante.
Invece, come vedremo nel libro curato da Marco Zucchetti, mira alla pancia dei lettori, un luogo del corpo che spesso comanda su cuore e cervello.
E fa sfracelli.
***
Il libro è uscito martedì 21 ottobre.
Il titolo gioca sull’idea che quelli di Daesh (IS, ISIS, ISIL, Stato Islamico) siano principalmente “tagliatori di teste”.
Vedremo poi come alcuni autori maneggeranno il tema.
La pubblicità del libro, il cui claim recita “2014 l’anno dei tagliagole”, ritrae James Foley in ginocchio vicino al boia britannico di Daesh.
Ieri, giovedì, Diane, la madre del giornalista giustiziato, ha querelato “Il Giornale”: “La decapitazione di mio figlio usata come pubblicità di un libro”.
Poteva bastarmi, in effetti. Potevo fermarmi qui, dicendomi: “gli sta bene”*.
E invece no, non mi è bastato.
Mi sono messo in testa di leggere il libro.
Ma pur essendomi piegato all’idea di acquistarlo e avendo poi effettivamente raggiunto l’edicola col denaro necessario (l’idea di doverlo comprare era già una sconfitta per me), ho trovato che era esaurito.
Parliamo di edicola di Testaccio, uno di quei leggendari “bastioni della sinistra” della città di Roma.
L’edicolante era distrutto, mi ha guardato con mestizia, io ho voluto specificare la mia posizione di lettore critico, mi ha detto che forse ristampano il volume e ciò ha prodotto in me una lacerazione interiore.
Ho pensato all’Italia.
Oggi, venerdì, ho cercato in un’altra edicola. Esaurito.
Poi in un’altra edicola ancora, e un’altra ancora.
***
Eccolo qua, ‘sto libro.
La copertina recita “Non perdiamo la testa, il dovere di difenderci dalla violenza dell’islam”, Magdi Crisiano Allam e le firme de il Giornale.
Giro il libro.
Firme, in ordine alfabetico: Francesco Alberoni, Magdi Crisiano Allam, Fausto Biloslavo, Luca Fazzo, Vittorio Feltri, Stefano Filippi, Alessandro Gnocchi, Giordano Bruno Guerri, Paolo Guzzanti, Ida Magli, Gian Micalessin, Fiamma Nirenstein, Alessandro Sallusti, Marcello Veneziani, Stefano Zecchi.
Avrò un bel da fare, temo.
***
Prima che iniziate a leggere questa mia esamina voglio che sappiate che non è la prima volta che mi avventuro in un’impresa del genere.
Anzi, guardo a questo libro con occhi stanchi.
Ho tenuto un blog per diversi anni in cui mi occupavo anche di ciò che definivo “islam percepito“.
Di Magdi Allam ho scritto, eccome, cercando di non essere cattivo ma, a volte, non riusciendovi.
Di Fausto Biloslavo ho annotato qualche attività, fra cui quella di intervistare Gheddafi durante i giorni della guerra in Libia.
Anche Vittorio Feltri compare nel mio vecchio blog perché, oltre a essere Vittorio Feltri, è anche autore di un libro dal titolo “Il Corano letto da Vittorio Feltri”.
Ida Magli per me è una vecchia conoscenza, in effetti.
Gian Micalessin ha iniziato a comparire sul mio radar già nel 2011 ma mi si è manifestato in tutto il suo fulgido strabismo destrorso più avanti, quando ha iniziato ad andare in Siria da embedded, sposando in toto la versione della realtà fornita dalla propaganda di regime.
Conosco bene la prosa di Fiamma Nirenstein, per me fino a ieri era roba passata.
Posso dire con certezza che le persone qui citate sono parte di una banda di haters abbastanza ampia, la cui sociologia è ancora tutta da scrivere ma che ha i propri santi e santini.
OrianaFallaci, prima di tutto. Poi Bat Ye’or, Geert Wilders, Ayaan Hirsi Ali e tanti altri.
E’ un mondo popolato di borghezi di vario genere, entrando nel quale prima o poi si arriva a parlare del boia di Utoya, Anders Behring Breivik e di una destra parafascista che pullula di “controjihadisti” e lancia l’allarme “Eurabia“.
Al tempo avevo deciso di collocare le mie osservazioni nella categoria “destre e islam“.
E’ un tema ampissimo, spinoso e posso dire di non essere riuscito a tracciarne confini certi, anche perché – udite – la melma tracima a sinistra.
A un certo punto ho chiuso il blog per motivi di pulizia mentale.
Ho la certezza, però, che “Non perdiamo la testa” rappresenta una rassegna dei temi principali usati da questi haters, quindi mi sento quasi in dovere di fare ciò che sto per fare, cioè leggere questo libro e commentarlo, anche se farlo è per me una tortura: conosco i miei polli, le loro manipolazioni, so quanto riescano a offendere le intelligenze, quanto letali siano le tossine che rilasciano, quanto senso di malessere trasmettano.
***
Ancora un preliminare.
Grazie alla mia pregressa attenzione sul tema ho imparato a far buon uso di alcune parole.
Non userò “islamofobia” perché il concetto, se inteso in maniera generica, è scivoloso e offre molti appigli retorici non sempre controllabili.
Vedremo come ci gioca Magdi Allam, ma è bene sapere che diversi sono gli attori politici e culturali che lo usano.
Fra di essi ci sono anche musulmani retrogradi, reazionari, maschilisti che ponendosi come vittime dell’islamofobia cercano di dar leggittimità, in chive politica, alla loro specifica e sordida idea di islam.
***
Bene, indossato lo scafandro dell’espertone di haters controislamici entro dentro.
So quando entro, non so quando esco, soprattutto non so se e come ne esco vivo.
Secondo la presentazione:
l’Occidente che si era illuso di poter convivere pacificamente con l’islam, ha riscoperto il terrore dell’estremismo, ma sembra aver rinunciato a combattere” (Occidente maiuscolo e islam minuscolo).
Perché, effettivamente, questa chiarissima entità chiamata “Occidente” è dotata di sentimenti, dunque è capace di illudersi, riscoprire e rinunciare.
Un’entità che, seguendo il filo del copertinista, è una “civiltà” di nome Occidente.
Una “civiltà” che “soffre” di tanti “mali”, proprio come una persona soffre di epicondilite acuta, reumatismi, demenza senile.
Ci collochiamo alla fine dell’800, insomma, e la globalizzazione proprio ci rifiutiamo di prenderla in considerazione.
Pensiamo che esistano delle civilità, che queste civiltà abbiano una nascita, un’apogeo, un declino.
Nel caso della civiltà occidentale questo declino sembra interminabile, da più di un secolo viviamo nel crepuscolo “dei valori” e “delle identità”.
E tutto ciò avviene a causa di strani “mali” emersi come cancri nelle nostre coscienze: il politically correct, la paura di passare per razzisti, la sudditanza psicologica del relativismo culturale.
***
La prefazione di Alessandro Sallusti ci annuncia che c’è una vittima, Magdi Cristiano Allam.
Quest’uomo ci aveva avvertito, ci aveva detto che dietro le “primavere arabe” si celava il mostro, e che il mostro ora ci vuole mangiare.
Non dovevamo farci ingannare dai sinistrorsi: il levantino che chiede libertà, giustizia sociale e democrazia è un truffatore, ha un secondo fine, anche se poi muore per mano di un altro levantino sotto un barile bomba o sparato da un militare o un poliziotto anch’essi levantini.
E a dircelo era proprio uno che lì ci è nato.
Ma noi non l’abbiamo voluto ascoltare.
Siamo stati buonisti.
Ora nel “mondo arabo” (non islamico, proprio arabo) l’odio verso l’Occidente è soverchiante dobbiamo difenderci perché in pericolo siamo noi e i nostri figli.
E questo libro, al quale contribuiscono un manipolo di eroi della nostra cultura, della nostra identità e della nostra democrazia, vuole rappresentare un piccolo ma significativo passo in difesa dei nostri paesi.
E, testuale, del mondo intero.
Un libro che insomma va Controcorrente (anche se è esaurito in 8 edicole su 9 a due giorni dalla sua uscita).
Nessuno, tranne questa nostra pattuglia di indomiti combattenti, ha detto niente, nessuno ha scritto niente.
Invece loro erano lì, asserragliati nel fortino, mentre orde di buonisti morbosi svendevano la loro identità, la loro cultura, la loro democrazia.
E processavano Magdi Cristiano Allam.
***
Ci siamo, qui impatto il capitolo 1, in cui Allam spiega di dover addirittura subire un processo per istigazione all’odio razziale da parte dell’Ordine dei giornalisti.
Secondo Allam, l’Ordine ha “recepito e fatta propria la strategia dei militanti islamici”.
Secondo Allam, che non è nuovo a un particolare genere di elucubrazione paranoica basata su una distorta percezione dei fatti, una sua condanna presso l’Ordine dei giornalisti porterebbe in tempi brevi all’introduzione di una legge che punisce il reato di islamofobia in Italia.
Una legge di cui – è bene saperlo – non c’è assolutamente bisogno e che nessuno ha mai neanche immaginato di introdurre, perché in Italia esiste il reato di istigazione all’odio razziale (la legge Mancino, 205/1993), che basta e avanza.
E perché abbiamo una Costituzione, i cui articoli 2 e 3 (non, per dire, gli articoli 890 e 1247) parlano chiarissimo.
Una legge che, fra l’altro, potrebbe anche essere criticata perché delega al potere giudiziario la gestione di un problema multiforme e fenomenologicamente variegato che, di regola, dovrebbe essere combattutto nella società, cosa che non avviene.
Una legge che, in ultimo, permette ad Allam di farsi vittima, qualora qualcuno lo denunci.
Per lui, però, il fatto è un altro, e cioè che l’Organizzazione della cooperazione islamica, la lobby costituita dai governanti di 57 paesi a maggioranza musulmana presso l’ONU che Allam lega erroneamente e in malafede all’organizzazione dei Fratelli Musulmani, userebbe questa ipotetica legge per riuscire nel suo malefico intento: introdurre nel mondo il reato di blasfemia “che comporta la pena di morte per chiunque oltraggi il Corano e offenda Maometto”.
Cioè, in altre parole, un processo presso l’Ordine dei giornalisti italiano porterebbe all’introduzione della pena di morte per blasfemia nel mondo.
Secondo Allam questo processo è di rilievo “storico” e per lui è “un onore esserne protagonista”, perché in gioco c’è l’Italia di:
S. Benedetto, S. Francesco, Marco Polo, Dante Alighieri, Cristoforo Colombo, Leonardo da Vinci, Niccolò Machiavelli, Michelangelo Buonarroti, Galileo Galilei, Antonio Vivaldi, Alessandro Volta, Giuseppe Verdi.
Tutti combattenti per la libertà e la democrazia e l’identità, vien da dire.
Tutti personaggi processati dall’Ordine dei giornalisti.
Specialmente Marco Polo ma anche, e un bel po’, Cristoforo Colombo.
Nel delirio che segue, Allam spiega di essere stato il primo “a spiegare all’Italia” il rischio che correva, il primo a chiarire che “i musulmani possono essere moderati come persone se rispettano i valori fondanti della nostra comune umanità e le regole laiche della civile convivenza, ma che l’islam non è moderato come religione, è fisiologicamente violento e storicamente conflittuale”.
Aggiunge poi che questa è “una realtà” che conosce molto bene, essendo nato in un paese a maggioranza musulmana, da una famiglia musulmana, essendo stato musulmano per 56 anni, essendosi specializzato nello studio dell’islam. E, senza citare la sua conversione, conclude: “ecco perché è assolutamente infondato anche semplicemente ipotizzare che io possa essere islamofobo”.
Nel suo caso, dice, si può parlare di un “individuo anti-islam” non di un “islamofobo”.
Dice che il processo non è legittimo perché questo è un paese in cui tutti dicono quello che vogliono e anche lui può farlo, istigando all’odio razziale.
Dice che l’inquisizione islamica non lo fermerà e che è pronto ad affrontare il martirio (“inteso laicamente come il sacrificio della propria vita”) nel processo.
Dimostrando di non essere islamofobo, immagino.
E qui passiamo al secondo capitolo che Allam intitola – non sto scherzando – : “perché non possiamo non dirci islamofobi”.
***
La cosa fa ridere, oggettivamente.
Non so come si chiama una cosa del genere in drammaturgia ma un nome per questo ribaltamento ci deve essere.
Comunque: trattasi di roba d’accatto, un collage stile Anders Behring Breivik, autore di un memorabile copiancolla di 1518 pagine dal titolo: “2083 – Una dichiarazione europea d’indipendenza”.
Esordisce con un:
ricordiamo che la condanna dell’islam e di Maometto è parte essenziale della fede
Ma a me, che del cristianesimo conosco perlomeno i fondamentali, questa cosa proprio non risulta.
Scorrendo ad esempio il Credo, cioè la professione di fede (oltre che la preghiera cattolica più in voga da diverse centinaia di anni dopo il Padre nostro), non trovo citati islam e Maometto.
Chissà perché.
Seguono nel capitolo un elenco di citazioni di personaggi che hanno parlato male dell’islam, da San Giovanni Damasceno (650 d.C.) a Oriana Fallaci (2006 d.C), la più famosa cristiana della storia.
E’ da (Sant’)Oriana che riattacca Vittorio Feltri, nel capitolo 3.
Bel collegamento, complimenti.
***
Oriana Fallaci come dice il titolo, è lanciatrice di una “profezia”.
Feltri ricorda
il giorno in cui la Fallaci mostrò all’Occidente il volto feroce dell’islam
Era il 29 settembre 2001, pare.
Era stata zitta per un po’, Oriana, ma decise quel giorno di farsi di nuovo avanti.
Fu per lei “una nuova vita”.
Una donna che fino al 2001 si definiva “atea” e dopo il 2001 “atea-cristiana” (una definizione – questo lo dico io – in cui possiamo ritrovare, già da qualche anno, personalità del calibro di Giuliano Ferrara, “l’ateo devoto”).
Trovò in Ratzinger, così come fu per Allam che da questi fu battezzato, “il leader della riscossa” (anche in questo Oriana e Giuliano si somigliano).
Morì guardando la cupola di Santa Maria in Fiore.
Cosa ciò significhi non lo so. Sarà un’allegoria.
***
La lettura di Feltri ha lasciato molti danni in me.
Mi rivolgo dunque verso il capitolo 4 con fatica, imbattendomi in un’altra delle grandi donne italiane del XX secolo, Ida Magli.
Una studiosa secondo cui l’islam è “la religione della sopraffazione”, una religione in cui alberga un “significato sacrificale dell’uccisione degli infedeli”.
Magli si concentra sul taglio della testa in quanto cosa orribile e inumana e in quanto “cosa religiosa”.
Si concentra dunque su un’invenzione perché nell’islam non v’è significato sacrificale nell’uccisione degli infedeli.
Sempre che non si voglia cercare fra microscopiche sette che forse individueremmo.
Sono sincero: questo dire una scemenza proprio in principio di trattazione rende la lettura abbastanza indigeribile.
Ma allo stesso tempo mi autorizza a una certa superficialità, facendomi convergere sul tema “Magli in quanto antropologa“.
Un’antropologa “selezionista”, si direbbe, visto che per dimostrare le sue ipotesi seleziona dal Corano solo i “versetti della guerra” scartando tutti i “versetti della pace”.
Un’operazione torbida o forse soltanto stupida, portata avanti con un tono pseudo-accademico, che a un certo punto va terminando con questo enigmatico versetto profetico:
I nostri maschi stanno morendo. O quelli musulmani moriranno insieme ai nostri, oppure si uniranno ai combattenti che già premono su di noi e vinceranno.
***
Cado per inerzia sul capitolo 5.
Qui il legame associativo col capitolo precedente si perde, non c’è gancio, il libro perde ritmo. Il moto inerziale è destinato a terminare e la lettura si fa affannosa a prescindere.
Ci si mette poi di mezzo Fausto Biloslavo, che ricopre il lettore di masticatissimi luoghi comuni destrorsi-complottardi: gli americani hanno sempre sbagliato tutto, le “primavere arabe” erano una farsa, Gheddafi era buono, anche Asad è buono.
Contro Daesh ci sono due possibilità, “calare le braghe” stipulando un patto di non belligeranza “previsto dall’islam”, o raderli al suolo.
Notare l’astuzia: nel discorso il Nostro include “qualcosa di islamico”, ovvero un fantomatico “patto di non belligeranza previsto dall’islam”, per accreditare quelli di Daesh come interpreti certificati dell’islam stesso.
Ma il fatto è che nessuno ha intenzione di trattare islamicamente Daesh.
Questo trattare islamicamente Daesh è un qualcosa su cui sono d’accordo soltanto lui, i suoi amici-che-non-perdono-la-testa, e gli stessi militanti di Daesh.
Il resto del genere umano, invece, pensa che non si debba dare alcuna patente, islamica o meno, a Daesh.
Anche i grillini hanno ritrattato.
***
Arriviamo finalmente a Francesco Alberoni, nel sesto capitolo.
Ah, non aspettavo altro.
Qui leggiamo Il Sociologo – corbezzoli – scoprendo che:
il proselitismo islamico fa colpo in Occidente come il marxismo negli anni di piombo
Alberoni ci suggerisce, di conseguenza, che nel periodo storico che intercorre fra l’opera di Marx e gli anni ’70 del XX secolo il marxismo non aveva fatto colpo?
Non proprio: spiegherà più avanti che si trattava di un “revival marxista”.
Il capitolo esordice con un perentorio:
tutti i movimenti islamici nascono come risposta al declino dell’Impero ottomano, con l’occupazione dei suoi territori ad opera degli europei
Forse Alberoni, affermando questo, ci comunica che il wahhabismo, nato in tutt’altra maniera, non è un “movimento islamico”?
Scopriamo più avanti che per lui il wahhabismo nasce in Iraq, non nel Najd, e quindi facciamo due più due: Alberoni sta platealmente improvvisando, di movimenti islamici non ha alcuna seppur vaga conoscenza.
Purtroppo però il testo prosegue con una “storia dei movimenti islamici” la cui analisi – viste le premesse – risparmio a me e a voi.
La teoria, che se devo essere sincero ho fatto molta fatica a estrarre, è che il “jihadismo è una rivoluzione dei giovani musulmani” che ricorda il nazismo ma anche e soprattutto “la corsa dei giovani verso il comunismo dopo la rivoluzione sovietica”.
E’ per questo che attrae tanti giovani in Occidente.
***
Leggere Alberoni è stato brutto.
Sono ancora vivo, ma disossato.
Al capitolo 7 cozzo contro lo scoglio di un titolo che scimmiotta simpaticamente il titolo di un famoso romanzo: “il senso del califfo per barba e coltello”.
Il titolo del famoso romanzo è quanto di più scimmiottato vi sia al mondo e la cosa mi lascia addosso una sensazione di appiccicaticcio, aumentando di molto il fattore “stanchezza percepita”.
Il titolo introduce a meraviglia il pezzo di Stefano Zecchi, che si esercita nell’arte del ricamo sugli elementi della propaganda di Daesh per dirci con quello che ritengo egli pensi essere “stile”, quanto i barbari di Daesh riescano ad essere cattivi, inumani ed efferati.
Letteratura di appendice: il contenuto informativo non supera lo zero.
Non è una lettura facile, inizio a saltar pagine.
***
Di paura in paura incappo in Gian Micalessin, un giornalista che ha in comune con Biloslavo la passione per Gheddafi e Asad.
Lo spauracchio sventolato, stavolta, è il terrorista nascosto fra i migranti.
Altro vecchio tema, si dirà, ma stavolta trattato con materiali nuovi.
La Libia con Moammar era un posto civile dove si viveva bene. Oggi c’è il califfato.
Ci ritroveremo con bombaroli dappertutto.
***
Segue Fiamma Nirenstein, che si occupa, guarda un po’ che novità, di difendere Israele.
Anche qui sono messo alla prova: il tema è vecchio così come il personaggio e la prosa.
Avrò letto almeno una trentina di questi suoi concentrati di odio.
Sì, i materiali sono parzialmente nuovi: Nirenstein, al contrario di Micalessin e Biloslavo, cita i 240.000 morti fatti da Asad in Siria che, al contrario dei morti di Gaza, nessuno nota.
Una citazione strumentale, a lei di quei morti non interessa granché: il suo obiettivo è unicamente scagliarsi contro tutti i nemici di Israele, veri o presunti.
Ma stavolta c’è il problema che i nemici di Israele si sparano l’uno contro l’altro. E che Micalessin e Biloslavo, compagni di viaggio in questo libro contro-islamico, parteggiano per alcuni di questi presunti nemici di Israele.
Risultato: la difesa acritica di Israele di Nirenstein e la difesa acritica di Asad di Micalessin e Biloslavo fanno a pugni fra loro.
Come la ricomponiamo, questa cosa?
Niente paura, quando il nemico in costruzione (o in ri-costruzione) è così vago, e il desiderio di aderire alle teorie esposte è così alto, non si fa caso alle divergenze: si finisce sempre per puntare sulla comunione di interessi che ricompatta l’impasto, nonostante le contraddizioni.
Temo però che il lettore medio del libro che ho in mano non afferrerà il problema.
***
Avanti il prossimo.
Giordano Bruno Guerri che fa una descrizione orante di Ida Magli e recensisce un libro di Ida Magli.
Del 1996.
Interessante, davvero.
Fa il paio con la denuncia di Luca Fazzo sul presunto trattamento di favore riservato dalla magistratura ai terroristi islamici.
Mentre Marcello Veneziani ci parla di identità, che non è razzismo (tipica excusatio non petita).
Meglio: ci fa un’ode all’identità come panacea di tutti i mali.
Meglio ancora: ci fa un pippone illeggibile su questa @0éép di identità che, evidentemente, lo ossessiona.
Ok, basta, non ce la faccio più, è evidente.
Il libro ha vinto su di me, a pagina 97.
Ma avevo iniziato a cedere già prima, lo ammetto.
Non vado avanti.
Filippi che invoca una scuola islamicamente scorretta, Guzzanti che rutta su una sinistra ambigua, Gnocchi che ci insegna come connettere una vignetta anti-Maometto con l’incipiente istaurazione della legge coranica in Europa e il gran finale con “cronologia della mezzaluna insanguinata 2014” e “glossario” non sono alla mia portata.
Sono al di sopra della mia capacità di non lanciare insulti continuati e definitivi, procurandomi forse querele.
Sono già quattro ore che sguazzo in questa merda velenosa, lo scafandro dell’espertone fa acqua.
Il sistema immunitario della mia rete neuronale lancia segnali rossi.
Non posso chiedere di più a me stesso.
Devo uscire, guardare facce, respirare.
Decontaminarmi.
Lasciando gli haters e la loro paranoia nel pozzo a marcire.
***
Sabato 25 ottobre Luca Bauccio, l’avvocato italiano di Diane Foley ha diramato questo comunicato:
In qualità di difensore della Sig.ra Diane Foley, madre di James Foley, il reporter barbaramente ucciso dall’ISIS, ho inviato una diffida alla Società Editrice de il Giornale intimando di sospendere immediatamente la diffusione della pubblicità del libro a firma di Magdi Allam, Non perdiamo la testa.
Ho anche inoltrato nell’interesse della Sig.ra Foley una richiesta al Comitato di Controllo per la pubblicità perché ordini a il Giornale il ritiro di questa pubblicità.
La famiglia sta valutando ogni altra azione da intraprendere contro il Giornale.
L’aver messo in mostra la fotografia di James Foley pochi attimi prima della sua esecuzione per pubblicizzare la vendita di un libro, peraltro giocando macabramente con l’accostamento tra il titolo e l’immagine, oltre ad essere un indebito sfruttamento per fini commerciali e di propaganda dell’ immagine di James Foley è anche una mancanza di rispetto per la memoria e la dignità di uomo defunto e per la tragedia che la sua famiglia e la comunità delle persone che lo amavano stanno vivendo.
La famiglia Foley vuole sottolineare che non nutre odio e non ha propositi di vendetta ma chiede solo rispetto, chiede solo di poter vivere il proprio dolore senza subire altre umiliazioni, altre offese, altri turbamenti. James Foley è stato un bravo e appassionato reporter, amava raccontare, documentare, informare. James Foley amava la vita e credeva nella dignità degli esseri umani, e per questo ha voluto rivelare al mondo il dramma del popolo siriano. Per questo ha vissuto e per questo è morto.
James Foley non è la comparsa pubblicitaria di un libro del Sig. Magdi Allam. Il Giornale ritiri immediatamente la pubblicità del suo libro, per il rispetto e la dignità di un defunto e per la considerazione umana che merita il dolore della sua famiglia. Avv. Luca Bauccio (difensore della Sig.ra Diane Foley).
Il martedì seguente, 28 ottobre, apprendo che la pubblicità è stata ritirata.
Questo rende giustizia a Diane Foley ma non può bastare.
Il libro è stato ristampato.
Temo che diventerà un best seller.
Forse non farà il botto della Fallaci ma ne segue la scia in tutti i sensi.
Sì, sono nani pavidi che riposano sulle spalle di giganti di pezza.
Ma il danno è tangibile e vale la pena chiedersi dove siano e se vi siano nani o giganti in grado di opporvisi.
Sinistra_hegeliana #1 Piccolissimo
di Jamila Mascat
 Metalmeccanici a Roma, con la Fiom, 29 ottobre 2014
Metalmeccanici a Roma, con la Fiom, 29 ottobre 2014
Adorno rinfacciava a Hegel di non nutrire nessuna “simpatia per l’utopia del particolare (für die Utopie des Besonderen), sotterrato sotto l’universalità”. Eppure le tante e variabili declinazioni del rapporto tra la parte e il tutto – la scissione, la contraddizione, la mediazione, la conciliazione, per ricordarne alcune – sono state il tormento speculativo della sua filosofia.
La simpatia, in effetti, scarseggia, ma non si può certo incolpare Hegel di negligenza: il particolare – onnipresente nella costellazione del sistema, e riottoso a suo modo – è stato per lui oggetto di affannose tribolazioni. Posto, infatti, che “il vero è l’intero”, c’è bisogno di determinare come diventi anche fattualmente realizzabile. In altre parole: vogliamo tutto, ma come?
Così comincia il gioco delle parti, commedia degli equivoci e delle imposture, a cui Hegel si dedica con animo, pazienza e lucidità. Il particolare, infatti, è una mina vagante e pericolosa nonostante gli ingegnosi tentativi della dialettica di tenerlo a bada. Il tranello più insidioso è quello in cui precipita il formalismo – fautore del modello dell’universale astratto – ovvero entre autres la morale kantiana. Hegel descrive questo capitombolo nelle pagine del Saggio sulle maniere di trattare il diritto naturale (1802-03) più o meno in questi termini: per Kant la struttura formale della massima è suscettibile di accogliere solo quei contenuti che si prestano ad essere universalizzati senza incappare in alcuna contraddizione. Quindi la massima secondo cui “ognuno può negare di aver un deposito della cui consegna nessuno gli può dar prova” (leggi: ognuno può negare di aver ricevuto dei soldi in deposito da qualcun altro, se nulla dimostra il contrario) non è una massima e non può diventarlo, Kant dixit secondo Hegel, pena la deposizione del concetto stesso di deposito, il che equivarrebbe a un’impasse contraddittoria. Ma, obietta Hegel, se non ci fosse più alcun deposito (e nemmeno il suo concetto), non ci sarebbe propriamente nessuna contraddizione, a meno di considerare l’esistenza della proprietà (e del suo concetto) un presupposto assoluto, incontrovertibile e necessario. A ben vedere, allora, il problema si pone solo concedendo, in maniera del tutto arbitraria, la legittimità universale di un contenuto particolare (il deposito, per l’appunto). Hegel, che non è affatto un critico della proprietà privata, qui vuole solo evidenziare un vizio logico carico di ricadute pratiche: l’universale astratto, la massima, che a prima vista si mostra super partes e super inclusiva, si rivela in realtà troppo di parte e troppo esclusiva, perché presuppone implicitamente un contenuto specifico non dichiarato (alias, ancora una volta, il riconoscimento del valore inviolabile della proprietà).
A questo punto abbiamo di fronte un universale falso – nel linguaggio digitale un fake, che si nasconde surrettiziamente dietro a un’identità falsificata – non a causa di un’innocente metonimia, ma per colpa di un’usurpazione unilaterale: la colpa della parte che si impossessa del tutto di nascosto.
Hegel, va detto, non ce l’ha con la parte per partito preso, il vero guaio, come si diceva, è l’impostura; e il particolare, al contrario, deve saper fare la sua parte, deve cioè irrimediabilmente parteggiare.
E’ per questo che Aimé Césaire ebbe un colpo di fulmine per la Fenomenologia dello Spirito e, quando apparve la prima traduzione di Jean Hyppolite, entusiasta, volle subito mostrarla a Senghor: “Ascolta quello che dice Hegel, Léopold! Per arrivare all’universale bisogna immergersi nel particolare!”.
Fu così che l’autore del Cahier d’un retour au pays natal trovò a sorpresa in Hegel, colui che aveva confinato l’Africa nell’anticamera della Storia, un’ottima giustificazione per non rinunciare alla propria parte, alla négritude.
In un’intervista del 1997, Césaire torna a rendergli omaggio: “In Occidente ci hanno sempre detto che per diventare universali dovevamo partire dalla negazione del fatto di essere neri. Al contrario, io mi sono sempre detto che più siamo neri, più saremo universali”, e questo grazie alla lezione hegeliana.
Nella lettera a Maurice Thorez, con cui nel 1956 dice addio al Partito comunista francese (Pcf), Césaire precisa che esistono due distinte maniere di “perdersi”: per “segregazione” nel particolare o per “diluizione” nell’universale. Da parte sua ribadisce di non voler in alcun modo pietrificarsi in un “particolarismo stretto” né, altrettanto risolutamente, “dissolversi in un universalismo disincarnato”. Ma se il particolare si accredita positivamente come incarnazione dell’universale, la parte, che designa la posta in gioco non negoziabile del compromesso politico tra i comunisti delle Antille e i comunisti della métropole, è precisamente “la questione coloniale”, ovvero il voto favorevole dei 146 deputati del Pcf al conferimento di poteri speciali all’esecutivo dell’allora primo ministro Guy Mollet per sostenere l’intervento francese in Algeria. Su quella “parte” non è possibile transigere secondo Césaire, che pochi mesi dopo l’episodio presenta le dimissioni dall’incarico di deputato del partito.
Come tutti
Potrebbe sembrare controproducente, a giudicare dai tempi che corrono, la scelta di fare appello a Césaire e Hegel: uno (morto nel 2008) a malapena potrebbe aver visto o toccato un Iphone in vita sua, l’altro (nato nel 1770) appartiene a un’epoca in cui non esistevano nemmeno i telefoni a gettone. Ma l’appello, in effetti, vale poco più di un pretesto per provare a capire che fine ha fatto la Parte. O meglio, che brutta fine ha fatto la Parte: squalificata e sbeffeggiata – perché disonesta, faziosa, tifosa e soprattutto ideologica – dal pulpito del desiderio di essere come tutti – insignito dell’ultimo premio Strega.
Non sono riuscita a venire a capo di questa storia in modo sensato, in compenso mi sono venute in mente due storielle sentimentali. Due love stories, intendo, molto diverse tra loro: quella tra la parte e il tutto, e quella tra la parte e i tutti (quei tutti come tutti desidereremmo essere, secondo Francesco Piccolo).
Quando la parte incontra il tutto, è desiderio di riscatto e subito amore a prima vista. È un amore appassionato, collettivo, intenso, dialettico, faticoso, neorealista. Con la parte che ce la mette tutta e il tutto che non si concede; la parte che non si dà per vinta e il tutto che non molla. Un amore politicamente scorretto, irriverente, fatto di tattiche e strategie, prevaricazioni, battaglie, vertenze, assalti alla diligenza, agguati, occupazioni e scioperi generali; può durare una vita o culminare in una disfatta colma d’affetto: che funzioni o meno, c’eravamo tanto amati. Invece, tra la parte e i tutti (che non è plurale perché è un prototipo) non c’è amore che tenga, è ipocrisia, oltraggio, passione triste e crudele, spremitura a freddo, stillicidio, parossismo dell’incomunicabilità, veleno, nouvelle vague. Pensavi fosse amore e invece era un machete.
I tutti giocano con la parte come Leone Gala gioca con i gusci d’uovo nella pièce di Pirandello. Cioè così:
Leone: […] Tu devi guardarti di te stesso, del sentimento che questo caso suscita subito in te e con cui t’assalta! Immediatamente, ghermirlo e vuotarlo, trarne il concetto, e allora puoi anche giocarci. Guarda, è come se t’arrivasse all’improvviso, non sai da dove, un uovo fresco…
Guido: Un uovo fresco?
Leone: Un uovo fresco.
Guido: E se t’arriva invece una palla di piombo?
Leone: Allora ti vuota lei, e non se ne parla più.
Guido: Ma perché un uovo fresco, scusa?
Leone: Per darti una nuova immagine dei casi e dei concetti. Se non sei pronto a ghermirlo, te ne lascerai cogliere o lo lascerai cadere. Nell’un caso e nell’altro, ti si squacquererà davanti o addosso. Se sei pronto, lo prendi, lo fori, e te lo bevi. Che ti resta in mano?
Guido: Il guscio vuoto.
Leone: E questo è il concetto! Lo infilzi nel pernio del tuo spillo e ti diverti a farlo girare, o, lieve lieve ormai, te lo giuochi come una palla di celluloide, da una mano all’altra: là, là e là… poi: paf. Lo schiacci tra le mani e lo butti via.
La parte, dal canto suo, le uova le rompe, le sbatte e a volte magari le tira. I tutti si preservano (per evitare di farsi scquaquerare davanti o addosso) dilettandosi con i gusci vuoti; la parte si consuma, si sporca.
La parte non s’illude di essere più profonda dei tutti superficiali, ma rigetta il moralismo insulso che permea da capo a piedi questa infelice dicotomia e che esprime visibilmente ancora un altro desiderio, più perverso e più cristiano. I tutti, infatti, reclamano assoluzione, esigono di essere mondati del peccato originale di avere abdicato a quella responsabilità a cui Sartre inchiodava gli uomini e soprattutto gli intellettuali: il compito di “immischiarsi in quello che non li riguarda”. Sartre, lui, non avrebbe assolto proprio nessuno – “Je tiens Flaubert et Goncourt pour responsables de la repression qui suivit la Commune parce qu’ils n’ont pas écrit une seule ligne pour l’empêcher”. E ancora: “Non è affare loro, si dirà, ma il processo di Calas era forse affare di Voltaire? La condanna di Dreyfus era affare di Zola? L’amministrazione del Congo affare di Gide?”.
Ci avrebbe pensato, in compenso, la prima Leopolda del 2010, quando rottamazione rimava con assoluzione, a togliere tutti i peccati del mondo. L’ultima, la n.5, quella di governo, memorabile attestazione di arroganza e pessime maniere, ha superato se stessa cospargendo sindacati, lavoro, lavoratori & co. di una raffica di insulti sprezzanti (poi, dai gettoni a.C. ai manganelli DC c’è voluto poco, poco più di 48 ore).
Senza arte né parte
La parte incalza i tutti: “scegliete da che parte stare”, ma i tutti rispondono che stanno con tutti. La parte ripete che non è possibile. I tutti sfrontati canticchiano i Beatles, con l’inglese fracassato del premier: well, you know, we all want to change the world. I tutti pretendono spudoratamente che sia davvero così. La parte replica con l’International, invocando un tutto che rivendica consapevolmente il proprio essere di parte –– le monde va changer de base/ nous ne sommes rien, soyons tout! –.
I tutti confondono le carte in tavola, insistono che gli va bene tutto e il contrario di tutto, in onore del ‘pluralismo’, in spregio all’ ‘estremismo’, in virtù del ‘confronto’. Esibiscono con disinvoltura il loro tutto flaccido come un babà, e fieri di una rammollita nonchalance proclamano che al mondo c’è posto per tutti, in nome di quella ben nota ‘tolleranza’ che Marcuse preferiva chiamare con un altro nome: “confortevole, levigata, ragionevole, democratica non-libertà”.
La parte semplicemente difende gli interessi della sua parte, contro quell’altra parte che sventolando la bandiera del Partito della Nazione (e della Restaurazione) finge subdolamente di essere per tutti. Mentre la parte ha il coraggio di dire: “non siete roba mia”, i tutti preferiscono rappresentarsi come tutti per non perdere i consensi di nessuno.
E’ chiaro che bisogna dare un taglio a questa penosa vicenda sentimentale. Tra la parte e i tutti non si coltiva un amore impossibile, ma solo una crudele lotta (di classe) ad armi impari.
Io e Annie si chiude con quella famosa battuta di Allen/Alvy che, dopo aver rincontrato Annie a distanza di qualche tempo dalla loro separazione, si compiace della donna fantastica che ha di fronte e conclude che in fondo le storie d’amore – le più irrazionali, pazze e assurde – vanno avanti malgrado tutto perché ognuno di noi ha bisogno di uova (già, ancora uova).
Per questo siamo perfino disposti ad accettare che nostro fratello creda di essere una gallina e rifiutiamo di farlo curare. Ma le piazze, almeno, funzionano diversamente e, ribellandosi all’incantesimo dei fratelli che vestono i panni delle galline, per approvvigionarsi di uova alla fine preferiscono assaltare i pollai.
Il bello delle parti
Stamattina, rimasticando quello che ho letto nei giorni scorsi, dopo la piazza di sabato e le sciagurate manganellate del 29 ottobre contro gli operai delle acciaierie di Terni in corteo a Roma, ho pensato, d’accordo con quello che scrive Alessandro Robecchi, che tra gli alfieri delle fantomatiche due sinistre – inesorabilmente ritratte con la solita cantilena: la vecchia e la nuova, la pavida e la spericolata, la creativa e la retriva – nessuno dovrebbe avere ancora la sfacciataggine di dire “siamo della stessa parte” (né la stoltezza di ipotizzare che, al dunque, le due parti si equivalgono).
Che a pensarci bene diventa insostenibile anche il goffo binomio delle due sinistre se, come dice Luciano Gallino, una delle condizioni che, ieri come oggi, fanno la differenza tra destra e sinistra è quasi tautologicamente “la scelta della parte sociale da cui stare” – e a Firenze “c’erano soprattutto persone a cui l’idea di stare dalla parte dei più deboli e magari di dichiararlo appariva semplicemente repellente”.
C’è da augurarsi che salti agli occhi pure l’insensatezza degli argomenti generosamente dispiegati per suggerire che i discorsi di Renzi in garage e Camusso in piazza siano solo le due brutte facce della stessa medaglia, nel tentativo di reperire isomorfismi deformi, commensurare brutture incommensurabili, soppesare nuovi ottimismi e obsolescenze, supercazzole e Case del popolo (ma soprattutto, a che pro?). Con il risultato, ancora una volta, di non stare e non andare da nessuna parte.
La sensazione è che il revanscismo delle assoluzioni generazionali e le commisurazioni tanto scontate quanto forzatamente ricercate solleticano e seducono chi desidera essere come tutti – un orizzonte a dir poco angusto – e allo stesso tempo rivoltano lo stomaco di quanti reclamano di stare da una parte, con la propria parte. Una parte informe, una parte dissestata, una parte non unanime, ma una parte che con le sue tante anime può provare a immaginare un inverno più caldo dell’autunno, perché, sebbene la posta sia incerta, allo stato attuale c’è davvero poco da perdere.
Il bello di questa parte è proprio che non vuole essere come tutti, pur sperando che molt* siano con lei. Il bello è che preferisce le bandiere rosse e regala volentieri le cinquanta sfumature di grigiore agli editoriali e agli opinionismi, pillole avvelenate del giorno dopo.
Tutto il resto è noia – la noia letale di tutti quelli che, non avendo più un mondo da trasformare né un ordine da rovesciare, sono condannati a una quiete perpetua di prima classe per ricamare ovazioni impotenti al potere; erezioni tristi per coiti modesti. Tutto il resto è Piccolo (e simili). Anzi piccolissimo.
Assioma 10: la gita a Seul: sui compiti attuali della critica letteraria
[L’assioma 7 già postato qui; da Letteratura e controvalori. Critica e scritture nell’era del web, Roma, Donzelli, 2014.]
di Alberto Casadei
1. Con lo scopo di individuare valori estetici non scontati, la critica artistica, e in particolare letteraria, nasce tra Sette e Ottocento. Almeno fino agli anni settanta del XX secolo, l’intreccio di opera e poetica è sembrato indispensabile, così come il dialogo o lo scontro autore-critico. Persino la distinzione fra il versante accademico-storico-filologico e quello militante-attualizzante è stata in molti casi superata, prima in virtù di una contiguità in circoli letterari di grande autorevolezza (per esempio le Giubbe Rosse a Firenze), poi di una connessione sul terreno della teoria letteraria (per esempio durante la stagione strutturalista e semiotica).
Numanzia non può morire!
di Nicola Fanizza
La decisione del governo turco di chiudere la frontiera con la Siria mi ha fatto andare con la mente alla rivolta che nel 1863/64 investì il «Regno del Congresso» – così era chiamata quella parte della Polonia che nel 1815 si era deciso di assegnare ad Alessandro I. Nel corso della repressione, la polizia zarista non poteva, però, inseguire i ribelli polacchi al di là dei confini del regno. E pertanto lo zar Alessandro II stabilì col governo prussiano, da poco diretto da Bismarck, un patto che prevedeva un’azione comune contro i Polacchi nelle zone di frontiera.
L’Impero zarista, la Prussia e l’Impero asburgico erano contrarî alla ricostruzione della Polonia come Stato indipendente. Da qui la determinazione del Cancelliere di ferro di consegnare ai Russi i patrioti polacchi, che si erano rifugiati in Prussia.
I carri armati turchi schierati, recentemente, sulla frontiera siriaca rivelano una tacita alleanza fra il governo di Erdogan e i combattenti dell’Isis. Gli interessi della Siria, della Turchia, dei combattenti dell’Isis, dell’Iran e, persino, dell’Armenia sembrano essere sul campo coestensivi: ognuno, a suo modo, si attiva per impedire la creazione di uno Stato curdo indipendente.
Le due situazioni di cui sopra, pur essendo per molti versi analoghe, presentano, tuttavia, anche sensibili differenze.
Lo sdegno provocato dalla repressione della rivoluzione polacca suscitò nel 1864 in Francia e in Inghilterra un movimento di solidarietà negli ambienti democratici e operai, e proprio da esso si sviluppò l’Alleanza internazionale dei lavoratori, nota come Prima internazionale.
Viceversa oggi, a 150 anni dalla sua nascita, i sedicenti progressisti, con la loro falsa solidarietà nei confronti del popolo curdo- come si fa a dimenticare la “consegna indiretta” di Ocalan alla Turchia!- si apprestano a celebrare l’ennesimo funerale dell’Internazionale socialista. Verrebbe da dire con Ernst Kantorowitz- autore del saggio del 1957 I due corpi del re- l’Internazionale è morta. Viva l’Internazionale!
Questa figura di sapore hegeliano diventa intelligibile se si tiene presente la singolare metafora veicolata da Edmund Plowden, giurista elisabettiano, il quale fa coesistere in un solo essere- il sovrano- due realtà distinte, una concreta ( l’individuo soggetto alla morte) e una figurata ( il Re perpetuo). I re, infatti, non possono mai morire, in quanto il re è ciò che nega la morte e la loro messa a morte si configura come la più alta negazione della sovranità!
L’immagine del doppio corpo del re consente di riannodare nuovi fili ermeneutici intorno alle dinamiche che investono le aggregazioni sociali. Proprio perché la sovranità comprende due aspetti opposti eppure necessari che sono l’Ordine e la Potenza, il paradigma teologico-politico dei «due corpi» ci dice che le organizzazioni politiche, da sempre incentrate sull’ordine, periscono e le istanze creatrici, che rimandano, invece, alla potenza, sono eterne.
Non è inutile rilevare che mentre la Prima internazionale e l’Internazionale situazionista si sono configurate come associazioni di movimenti, le altre Internazionali – dalla II, III, IV fino a quella socialista –, sono state, invece, alleanze di partiti.
E non è una differenza da poco, poiché i partiti e i movimenti svolgono una funzione opposta e complementare: sono coestensivi nel senso che nei partiti prevale il rito (la ripetizione che rimanda all’ordine), e nei movimenti prevale il gioco (il nuovo che rimanda alla potenza del divenire). I movimenti hanno la straordinaria capacità di promuovere lo sviluppo dello spazio sociale, nonché nuove pratiche di liberazione. D’altra parte, i partiti, dopo la fase istituente, si trasformano comunque in strumenti di conservazione delle burocrazie e degli apparati.
L’effervescenza sociale e la creatività stentano a sopravvivere, specialmente, nel cono d’ombra dei partiti egemonizzati dagli epigoni di Marx. Questi ultimi hanno sempre manifestato la loro feroce avversione, la loro diffidenza nei confronti delle capacità mitopoietiche ed, in modo coestensivo, del mito. Tutto ciò ha impedito l’affermarsi di una ragione mitica, ossia di una ragione capace di raccontare, anche, la storia sacra degli oppressi. Una storia che, recuperando la valenza conoscitiva dell’esperienza, consente di rivendicare un senso nuovo e più largo di umanità. E qui non ci riferiamo all’esperienza quantificata che si dà nei numeri, nelle formule e negli strumenti e di cui non si può raccontare la storia, ma all’esperienza tradizionale, quella contraddittoria che si dà nei detti e nei proverbi, quella che comporta, comunque, il patema.
La sinistra marxista si é sempre attivata per bloccare gli ingranaggi della macchina mitologica, poiché ha sempre avuto paura dell’ombra: ossia è atterrita dalla paura di contaminarsi con l’irrazionale.
Non è un caso che, in riferimento alla ricorrenza rituale dell’Internazionale, non esiste un mito fondante. Quello dell’Internazionale è, per l’appunto, un rito senza mito!
Di tale mancanza se ne accorse, per primo nel 1937, Georges Bataille, un intellettuale irregolare che ha sempre pensato nel cono d’ombra della razionalità utilitaristica. Quest’ultimo, recuperando le sue capacità mitopoietiche, individuò nel sacrificio di Numanzia il mito fondante di una nuova comunità di individui sovrani. La leggenda racconta che la città iberica fu posta sotto assedio, a partire dal 134 a. C., dalle legioni romane guidate dal fascista Scipione l’Africano. Dopo sedici mesi d’assedio, i Numantini, quantunque sofferenti per la fame, indeboliti e decimati dalle malattie, rifiutarono di arrendersi e decisero di morire pur di non rinunciare alla loro sovranità. Tentarono, pertanto, un’ultima disperata sortita e i pochi superstiti – uomini e donne! –, dopo aver incendiato le loro case e distrutto le armi e i loro beni, si lanciarono fra le fiamme.
Mentre Bataille racconta un solo evento della storia sacra degli oppressi, Carlo Levi, in Cristo si è fermato a Eboli, parla delle innumerevoli sofferenze che i contadini hanno subito nel corso del tempo. Questo romanzo-saggio-memoriale, che egli scrisse a Firenze nel 1943/44, racconta la storia mitica, la storia sacra del mondo contadino come una storia biblica. E, per di più, sono gli stessi contadini a raccontare la loro storia recente e, insieme lontana, attraverso le rappresentazione teatrali.
Si tratta di un testo che può diventare intelligibile solo se tiene presente nel debito conto il saggio Paura della libertà, che egli aveva scritto, mentre era in esilio in Francia, nella tarda estate del 1939.
Sin dal suo arrivo in Francia, meta prediletta dei fuoriusciti antifascisti, Levi e si era immerso nel contesto tanto caotico quanto stimolante della Parigi della seconda metà degli anni Trenta, quella del fronte Popolare e delle riviste eretiche. La sua enorme curiosità lo porta a frequentare le mitiche conferenze del Collegio di Sociologia, che si tenevano ogni due settimane in una libreria del Quartiere Latino. Le comunicazioni che maggiormente lo interessano sono quelle di Roger Caillois, il quale si richiamava per sommi capi alla teoria del Sacro di Rudolf Otto. Il giovane studioso francese definiva il Sacro come ciò che atterrisce e, insieme, affascina e, per di più, rilevava la presenza del numinoso nella storia.
Per Levi la numinosità, intesa come valore sacro della liberta, viene negata dal fascismo. Da qui l’esigenza di individuare, in Paura della Libertà, le dinamiche sociali e psicologiche che generano il totalitarismo.
Allo stesso modo di Simone Weil, Levi riconduce l’oppressione totalitaria all’idolatria. Quella del totalitarismo gli appare come la linea dominante della storia occidentale. E se è vero che le forme assunte nel secolo scorso dallo stato totalitario erano del tutto nuove per quel che riguarda gli strumenti e le intenzioni, è altresì certo che a cambiare, per Carlo Levi, non è la logica complessiva che ha animato i vecchi e i nuovi totalitarismi: la creazione di una realtà artificiale in cui riconoscersi e, in particolare, la deificazione dello Stato; il paternalismo che inchioda gli individui in uno stato di minorità; le distruzioni di massa; l’annullamento dell’individuo; e, infine, l’abbassamento della facoltà dell’attenzione che produce l’incapacità di discernere i confini che separano il bene dal male.
Sulla scorta di tale riflessione, cinque anni dopo, Carlo Levi guarderà con nuove lenti alla sua permanenza nel 1935/36, come confinato, in Basilicata. Ritiene, infatti, che l’immaginario della civiltà contadina sia nella sua essenza mitico. Parla di un mondo magico, di un mondo in cui non c’era spazio per la razionalità. E tuttavia, in quel mondo in cui gli uomini dovevano fare continuamente i conti con l’ostilità senza volto delle forze naturali, le relazioni fra gli individui stazionavano nell’atmosfera del dono.
La «fraternità passiva» di cui parla Carlo Levi e l’«amore della propria somiglianza» evocato da Rocco Scotellaro consentivano ai contadini di ospitare persino il forestiero o l’«esiliato» di cui non conoscevano il nome. I contadini avevano la straordinaria capacità di contrapporre alla tendenza umana alla volgarità il senso sacro della politica: ossia rivendicavano la libertà come autonomia, come rispetto degli altri e come rifiuto della violenza. Il fascismo veniva da loro inteso come statolatria, nonché come deificazione della patria.
La patria dei contadini, infatti, non è il luogo in cui si è nati, ma lo spazio sociale in cui si è tutti sovrani. La Basilicata di Levi ci appare, pertanto, come una comunità di elezione e, insieme, come la terra del ricordo, la terra che ti difende dalla minaccia di restare apolide. Da qui l’esigenza di custodire un villaggio vivente nella memoria, a cui l’immagine e il cuore tornano sempre di nuovo, e che i poeti i riplasmano in voce universale.
Nel concludere queste brevi note, ripenso ai Curdi e all’assedio di Kobane, dove – uomini e donne! – combattono per non rinunciare alla loro sovranità. Numanzia non può morire!
Sul decentramento. Qualche ipotesi di applicazione dentro e fuori la traduzione
di Ornella Tajani
Tradurre è come andare in analisi, solo che costa di meno, scrive Henri Meschonnic. Probabilmente ha ragione, ma in realtà già leggere le sue opere di linguista e critico della traduzione, provando a spostarsi dalla traccia teorica all’esempio pratico, presenta difficoltà simili a quelle di un percorso terapico, nel momento in cui occorre passare dall’individuazione del sintomo all’applicazione di un metodo di trattamento.
Nelle sue Proposizioni per una poetica della traduzione, Meschonnic definisce la traduzione, in quanto scrittura di una lettura-scrittura, come l’avventura storica di un soggetto. Il percorso del soggetto può articolarsi intorno a due cardini opposti: il decentramento (décentrement) e l’annessione (annexion). Il decentramento è «un rapporto testuale tra due testi in due lingue-culture», mentre l’annessione è l’eliminazione di questo rapporto, come se il testo nella lingua di partenza fosse scritto nella lingua d’arrivo: è l’illusione del “come-se”. A suo avviso, un testo si pone sempre a una determinata distanza dal soggetto: una distanza che può essere esposta o nascosta. Non bisogna annullarla, importando l’universo dell’altro nel nostro o esportando il nostro nel suo, ma riconoscerla e rispettarla. Il decentramento porta a esporre la distanza, l’annessione invece a nasconderla. Decentrarsi significa spostarsi per collocarsi al centro della lingua-cultura dell’altro, al centro del suo testo, senza dimenticare il proprio universo di partenza.
Ma che significa, nel concreto, tradurre «decentrandosi»? Dato che l’esempio non è facile a trovarsi, procederò per tentativi: un aneddoto preliminare, un decentramento nella ricezione della traduzione e un ipotetico esempio più pratico.
In Le Coq et l’Arlequin Jean Cocteau racconta di una notte in cui, poco tempo dopo la scandalosa prima parigina di Le sacre du printemps, andò a fare una gita notturna al Bois de Boulogne insieme a Stravinskij, Nijinski e all’impresario Diaghilev. Mentre erano lì, Diaghilev iniziò d’un tratto a «biascicare in russo». I suoi connazionali lo ascoltarono estasiati e Cocteau, che non conosceva la loro lingua, scoprì infine che si trattava di una poesia di Puškin. Chiese agli amici di tradurgliela; Stravinskij ci pensò un po’ e poi concluse che era impossibile: «troppo russo». Altrove, in La difficulté d’être, Cocteau torna su quest’aspetto dell’intraducibilità di Puškin, scrivendo che, quando il poeta usa la parola “carne”, il termine non si limita più a significare “carne”, ma riesce “a fartene sentire il sapore in bocca”; per dirla con Meschonnic, è dunque all’interno della lingua-cultura di Puškin che la parola “carne” assume un particolare rilievo.
È stato notato che l’episodio della gita notturna è probabilmente un po’ infarcito della fantasia del narratore; tuttavia il Cocteau più Cocteau di tutti è forse proprio quello che, nei suoi appunti diaristici, aggiusta la realtà rendendola più affascinante. Considerate le etichette con cui classificava le sue opere – poésie de roman per i romanzi, poésie de théâtre per i drammi, poésie plastique per le sculture, ecc. -, alcuni suoi aneddoti potrebbero essere definiti poésie biographique. Al di là di questo, a me sembra che, proprio mentre delinea l’unicità del poeta russo, e la sua conseguente intraducibilità, Cocteau stia invece compiendo il primo passo verso una sua possibile traduzione: senza conoscere la lingua, dopo aver chiesto svariate volte ai suoi amici russi – piuttosto refrattari, come si è visto – di tradurgli le sue poesie, si è formato un’idea di cosa rende Puškin unico; nonostante il paradosso dell’ignoranza della lingua russa, ha saputo decentrarsi e comprenderlo. Non si spiegherebbe altrimenti la sua fissazione per un poeta che non poteva capire se non tradotto. Cocteau è infine riuscito a intendere cosa contiene la parola “carne” utilizzata da Puškin: il contatto è stabilito, la distanza riconosciuta, la traduzione possibile.
Passando alla ricezione, a un recente convegno sulla traduzione poetica cui ho partecipato l’intervento di chiusura verteva su traduzioni le cui lingue interessate erano l’inglese e il francese; come altri prima di lei, la relatrice aveva distribuito degli handout con i testi in versione originale e tradotta, divisi in due colonne. Nonostante lei avesse fatto sin dall’inizio i nomi dell’autore e del traduttore, entrambi noti, soltanto quando ha esplicitamente menzionato lo stratagemma adottato la platea si è accorta di avere davanti agli occhi la traduzione nella colonna sinistra della tabella e l’originale in quella di destra: André Frénaud a destra, tradotto da John Montague a sinistra, il che sovvertiva la divisione abituale per la quale, come in ogni edizione bilingue in commercio, il testo in lingua di partenza è a sinistra e quello in lingua d’arrivo a destra. Inoltre, all’inizio dell’handout compariva il nome del traduttore ma non quello dell’autore, e solo nell’ultima pagina, sotto la versione tradotta, c’era scritto “after André Frénaud”, “da (un testo di) André Frénaud”. Non più “traduzione di”, quindi, ma “originale di”.
Un cambiamento così apparentemente banale ha provocato una sotterranea sommossa: «non si fa così», «non si è mai fatto» oppure «non si può fare» è stato il pensiero, e non solo, di alcuni dei partecipanti al convegno. A me sembra proprio questo quel che c’è da intendere con decentramento: spostarsi dal centro di una lingua-cultura al centro di un’altra lingua-cultura, senza nascondere la distanza, ma palesandola – e mai distanza fu più palese che in una traduzione con testo a fronte. In questo caso, lo spostamento cui si faceva cenno prima è letterale: istintivamente, lo sguardo del pubblico ha considerato il testo a destra in un rapporto di dipendenza da quello a sinistra. Qualsiasi aller-retour fra le parole riportava al testo nella colonna di sinistra dove, però, c’era la traduzione invece dell’originale; stava al lettore invertire il suo andamento di lettura. La proposta era naturalmente provocatoria e volutamente, visivamente “disturbante”: l’invito era a considerare le due versioni della poesia come due scritture parallele, due creazioni di eguale valore, spostandosi da un centro all’altro.
Questo meccanismo di decentramento nella ricezione della traduzione mi sembra suggerire anche la strada per la sua produzione, o creazione. Bisogna tradurre quello che le parole fanno, scrive Meschonnic, non quello che dicono; e ricordare che in ogni caso spesso non capiremo ciò che le parole ci fanno, perché è lì che sta la poesia. Prendiamo una battuta della pièce L’aigle à deux têtes di Cocteau. Il dramma ruota intorno a una regina eccentrica e insopportabile che, dopo la morte del marito, ha deciso di non mostrarsi in pubblico se non col volto velato. Nella prima scena compaiono Édith, la sua dama di compagnia, l’unica alla quale lei continui a mostrarsi, e Félix, il conte suo amico. D’un tratto Félix rivela che un giorno, di nascosto, è riuscito a rivedere il viso della regina; racconta l’episodio e conclude: «Je n’oublierai jamais ce spectacle. Elle rayonnait de poignards comme une vierge espagnole» (alla lettera: «Non dimenticherò mai quello spettacolo. Irraggiava pugnali come una vergine spagnola»). Al di là della soluzione traduttiva che si vorrà scegliere, e nonostante fuori dal contesto sia più difficile apprezzarne il testo, è evidente che il potere di questa battuta sta nell’emanare luce: il riferimento a una probabile raffigurazione pittorica di una madonna arriva al lettore ben dopo il bagliore provocato dall’immagine della regina che, a volto scoperto, avanza nel corridoio dove si svolge la scena narrata da Félix; così come soltanto in terza o quarta battuta verrà da chiedersi perché Cocteau parli di pugnali. Mi sembra un caso in cui è semplice capire cosa intende Meschonnic quando parla di tradurre, prima del loro significato, «quello che le parole fanno». Se il decentramento sta nell’individuarlo, il riconoscimento della distanza serve a non riempire di senso quello che invece sfugge per il semplice motivo che noi non siamo Cocteau (riempire di senso, in questo caso, può significare anche solo provare a indovinare quale immagine avesse esattamente in testa Cocteau quando ha scritto questa battuta). Come nell’unione matematica di due insiemi, dato l’insieme X, cioè la lingua-cultura di partenza, e l’insieme Y, cioè la lingua-cultura d’arrivo, l’intersezione, cioè la parte comune, quella che alle elementari veniva colorata d’azzurro, sarà la traduzione, che non fingerà di ignorare la differenza simmetrica dei due insiemi, ossia le parti che restano al di fuori dall’intersezione.
L’abbattimento della centralità del soggetto-autore-critico è il fulcro di un dibattito che coinvolge vari studi, dall’antropologia, alla sociologia, alle letterature comparate; all’interno del campo letterario sono proprio i translation studies ad assumere un ruolo sempre più importante, in quanto disciplina trasversale, bidirezionale, che si fonda su un necessario “spostamento” del critico da quello che era il suo centro originario. Decentramento e distanza sembrano assumere un ruolo chiave nel ripensamento dell’identità attraverso il confronto con l’alterità, e il termine “traduzione” può dunque prestarsi a includere qualsiasi tipo di interpretazione dell’alterità: la lingua-cultura contiene un’idea di mondo. Anche per Meschonnic la teoria del linguaggio è un’avventura antropologica, e un testo in fondo è l’espressione scritta di un soggetto. In questo senso allora l’annessione può essere intesa come l’istinto di qualsiasi individuo a relazionarsi con l’altro unicamente sulla base di ciò che è la sua esperienza: sulla base cioè di un’esperienza pregressa, che mina – quando non esclude – l’incontro vero, la conoscenza. Un rischio dell’annessione, fuori e dentro la traduzione, è ad esempio quello dell’ossessività: ingigantire il dettaglio alla ricerca dell’equivalenza perfetta fra due parole (così come della completa comunione d’intenti fra due persone) porta a perdere di vista che gli insiemi, per quanto uniti, sono due – due mondi, l’identità e l’alterità o, sfruttando la dicotomia traduttologica, che rende particolarmente bene se applicata al processo di conoscenza dell’altro: il mondo di partenza e quello d’arrivo.
Il decentramento, che è in sé un viaggio, scongiura invece il rischio dell’ossessività, della parola (o del dettaglio) che contiene un mondo: il mondo è, semplicemente, l’altro, e il testo da lui prodotto – così come il suo essere intero – è la sua avventura, o narrazione. Il decentramento implica la presa di coscienza della distanza che separa un individuo dall’altro: è rispettando questa distanza che si può comprendere l’alterità nella sua completezza. Né importare, né esportare, come detto sopra, ma provare a capire l’altro dall’interno, per citare Antoine Berman.
È sempre Berman a creare un’espressione che di nuovo collega la traduzione alla sfera psicanalitica: la «distanza intima» è quella che permette di vedersi, di confrontarsi, vicini e paralleli – ma non sovrapposti – come testo e traduzione in un’edizione bilingue. Probabilmente, al di là di tutto, è un esercizio utile, quello di provare, di tanto in tanto, a ripensare la propria identità spostandosi nella colonnina di destra.
Su “Parole di Elisa” di Marco Mazzi
Di Alessandro De Francesco
[Marco Mazzi, Parole di Elisa. Storia di una ragazza dell’Europa dell’Est, Maschietto Editore, Firenze, € 8.00, 56 pagine]
Parole di Elisa è un libro importante, che dev’essere segnalato, letto e meditato. Parole di Elisa è frutto di ore di dialogo registrato tra l’autore, che si definisce in realtà “curatore” per sottolineare l’a-soggettività del dispositivo che caratterizza il libro, ed Elisa, una ragazza ucraina che ha accettato di raccontare la sua storia, dall’infanzia nel suo Paese di origine alla vita in Italia, segnata dalla prostituzione. Questo libro non è né un romanzo, né un documentario, si tratta piuttosto di un lavoro di scrittura concettuale o, nei termini pratico-teorici esplorati di recente da chi scrive, di un esempio magistrale di Language Art, ovvero di un’opera in cui il testo è trattato come un materiale plastico, salvo che di tipo unicamente verbale anziché oggettuale.
Roger Casement. Il colonialista ribelle amato dagli scrittori

di Davide Orecchio
Rare esistenze scintillano oltre la morte materiale e, mostrandosi nella chiarità di un aspetto biografico oversize, contaminano altre vite, costringono all’ascolto, al ricordo e al racconto. C’è davvero chi col morire s’incapsula in un’epica già commestibile perché uno di noi ubbidisca al piacere della testimonianza e prenda a trasmettere finché altri raccoglieranno il segnale per rilanciarlo nel mai farsi brace, né cenere, del fuoco che un tempo fu un uomo o una donna.
Miti Moderni/2: Il dovere della lamentela

di: Francesca Fiorletta
Si sa, siamo tutti figli della grande umanità che si lamenta. Chi non si è mai lamentato, scagli la prima pietra. Lamentarsi è certamente un diritto, ma ancora più spesso sembra diventato un dovere. Il dovere della lamentela.
Ci lamentiamo per la disoccupazione, ci lamentiamo per l’allarme ebola, ci lamentiamo per la Tasi, 11 euro pro capite, ci lamentiamo per i politici corrotti, per la Juventus che compra gli arbitri dall’82, per i jeans taglia 40 che ci vanno stretti dopo l’estate, per il prezzo maggiorato della benzina, per il prezzo del biglietto da pagare al casello, per il costo inclemente del pane e del tonno in scatola, per i riscaldamenti troppo alti, eppur si suda, per gli ascensori troppo stretti, salgo a piedi, per quel film che tutti quanti i nostri amici hanno già visto, e noi no.
Nonno di Panopoli – Dionisiache (I, 1-44)
trad. in esametri ritmici di Daniele Ventre
Narra tu, dea, la folata del fulmine, nunzia del chiaro
letto del Crònide, madre di doglie per torce nuziali,
e la saetta, l’ancella di Sèmele; narra del parto,
nascita doppia, di Bacco, che, intinto nel fuoco, Zeus tolse,
feto incompiuto di puerpera a cui non giovò levatrice,
quindi, segnando la coscia d’un taglio con mani ben caute,
chiuse in un grembo maschile, e fu padre e nobile madre,
chi nella testa feconda aveva provato altre doglie,
lui, che un arcano gonfiore già ebbe alla gravida fronte,
quando da sé proiettò fuori Atena fulgida in armi.
Voi a me offrite il nartece, agitate i cembali, Muse,
date alla mano voi il tirso, poiché celebriamo Dioníso.
Mentre m’unisco alla danza, nel prossimo scoglio di Faro,
Pròteo evocatemi, il dio molteplice, sì che m’appaia
vario mostrando il suo aspetto, perché tesserò vario canto.
Se striscerà come serpe, avvoltosi in cerchi di spire,
lotta di dèi canterò, di quando straziò con il tirso
d’edera irsute tribù di Giganti chiome di serpi;
se scuoterà, come irsuto leone, il suo crine sul collo,
inneggerò all’evio Bacco sul braccio di Rea veneranda,
mentre s’acquatta nel seno alla dea che alleva leoni;
se con lo scatto impetuoso dei piedi involandosi in alto,
si lancerà come pardo, mutando il molteplice aspetto,
celebrerò come il nato da Zeus sterminò l’orda indiana,
contro elefanti movendo sui carri trainati da pardi;
se di cinghiale avrà corpo e forma, il figliolo di Tione
io canterò –bramò unirsi con Aura che uccise i cinghiali,
con la Cibèlide, madre del terzo, dell’ultimo Bacco;
se a imitazione dell’acqua fluirà, canterò di Dioníso
che si tuffò in fondo al mare, poiché l’assaliva Licurgo;
se tremerà come fronda, destando un sussurro fallace,
ricorderò come a gara lo scatto dei piedi d’Icario
abbia premuto sull’uve, nel tino ricolmo d’ebbrezza.
Voi a me offrite il nartece, Mimàlloni, dietro le spalle
non il consueto chitone, la nebride, dorso screziato,
stretta sul petto, gettatemi, intrisa di nettare, essenza
cara a Marone, e che Idòtea signora d’abissi ed Omero
serbino per Menelao graveolenti pelli di foca!–
Datemi gli evii tamburi, le pelli di capra, e il soave
flauto a due voci ad un altro lasciatelo, ch’io non sconvolga
d’ira il mio Febo: egli spregia ogni eco soffiata da canne,
già sin dal tempo in cui vinse il rivale flauto di Marsia,
e denudò interamente le membra al pastore scuoiato,
quindi ad un albero appese la pelle, a gonfiarsi alle brezze.
Mario Negri. La solitudine dello scultore

di Gianni Biondillo
C’è sempre stato un prima e un dopo per te, Mario. Niente terre di mezzo, niente compromessi, zone ambigue. Un taglio netto: prima, dopo.
C’è la tua vita di ragazzo, di studente del liceo Manzoni, che al ginnasio modellava la creta di nascosto, come gioco, come inconsapevole tirocinio, come anelito. E c’è la morte di tuo padre e di tua madre, nel volgere di neppure due anni, nel mezzo dell’adolescenza. Ultimo di quattro figli hai seguito il consiglio di tuo fratello Bruno. Niente creta. Ti sei iscritto alla facoltà d’architettura. “Bisognava che io dessi l’assicurazione di una scelta a mio fratello, che fosse garanzia di un avvenire e di un mestiere” raccontasti. Concreto, pronto al sacrificio. Eri un valligiano, nato ai confini con la Svizzera, intransigente, etico, non moralista. Ci sono i tre anni al Politecnico e la frequentazione di «Corrente di vita giovanile» e di Giacomo Manzù. Poi c’è la guerra. L’8 settembre 1943 non hai avuto dubbi, non hai cercato compromessi. Avevi giurato come tutti per il Re, per la Patria, non per Mussolini, non per Hitler. Chiuso in un carro bestiame ti hanno portato in un campo di deportazione. Due anni di stenti e di fame. Luigi Carluccio era con te, ti ritrasse in un disegno. Il volto smagrito, lo sguardo spento. Tornasti a casa, a cinque anni dalla partenza, che pesavi neppure 44 chili. Per tutta la vita hai avuto problemi col cibo, mangiavi poco, sciapo, l’odore delle rape ti ricordava la prigionia. Ciò che ti tenne in vita, in quei giorni disperati – nei campi tedeschi o polacchi -, fu la volontà. Di diventare quello che dovevi diventare, senza compromessi. Uno scultore.
Eri di Tirano, Mario, eri un montanaro. “Non rinnego la mia origine di valligiano” dicevi. “Non si può prendere un abete e portarlo nel deserto. Le radici te le porti dentro fino alla fine.” L’arte si imparava dagli artigiani, pensavi. Il mestiere, prima di tutto. Imparavi a usare le mani, a capire la materia, la creta, il bronzo, nelle botteghe. Conoscesti Giuseppe “Pinella” De Andreis, fonditore alla MAF, in via Soperga, diventaste amici al punto che lo seguisti quando anni dopo aprì con i figli la sua fonderia d’arte. Avevi una parola, la rispettavi.

Lavoravi su commissione, scolpivi come un artigiano, non come un artista, perché ancora non ti sentivi degno di questo appellativo. A Lambrugo avevi fatto la tomba di Giancarlo Puecher, partigiano vigliaccamente ucciso appena ventenne negli anni della tua prigionia. E ci sei già, tutto. Ancora non lo sai, ancora non t’è chiaro, ancora ti porti dentro la storia dell’arte, la scultura rinascimentale, l’architettura classica. Ma ci sei. Devi solo trovare la tua voce, farla risuonare nelle tue opere. Anni dopo dirai, sorpreso, di aver cercato per tutta la vita la semplicità. “Ma non credevo che la semplicità fosse così complicata.”
C’è sempre stato un prima e un dopo per te, Mario. Avevi conosciuto Elda nel 1939. Poi c’è stata la guerra, la prigionia, il ritorno. Elda era scesa dal tram, in Piazza del Duomo. Aveva sbagliato, doveva scendere due fermate prima. Vi ritrovaste così, per caso. Era il 1946. Cinque anno dopo Carluccio fu il tuo testimone di nozze.
Non ti bastava il mestiere, occorreva il pensiero. Hai scritto per anni di arte, di scultura. Ti chiamò Giò Ponti per collaborare a Domus. Amavi Boccioni, amavi Modigliani, i più europei degli italiani, tu che non ti riconoscevi nella linea della scultura nazionale. Non era un atto d’arroganza il tuo. Era una constatazione. Amavi la sensibilità di Arturo Martini, la sua fantasia poetica, restituivi a Marino Marini la sua grandezza, riconosciuta all’estero più che in patria, scrivevi di Moore, di Medardo Rosso. Scrivevi di Giacometti. Che invitò l’anonimo redattore di Domus ad andarlo a trovare a casa sua, a Stampa. Ironie del destino. Montanari entrambi, vi divideva solo un crinale. E un confine. Le amicizie possono nascere anche così, con le parole. Giacometti per tornare da Parigi a casa iniziò a cambiare strada. Non passava più da Zurigo, ma si fermava a Milano. Insieme giravate la città. Sostavate di notte in piazza Vetra a contemplare quell’eruzione architettonica che è la basilica di San Lorenzo, e di giorno, nella cappella di Sant’Aquilino, ad ammirarne i mosaici. E così, di strada in strada, a Sant’Eustorgio, Sant’Ambrogio, San Simpliciano, Santa Maria delle Grazie. Mai in un museo, sempre in giro per la città. Tranne che per la Pietà Rondanini, da poco al Castello, dopo i restauri di BBPR come pellegrinaggio dovuto. E poi, sempre assieme, fuori porta: Morimondo, Chiaravalle, Viboldone. E su, al lago, e su ancora fino alla tua Valtellina, fin’oltre il crinale, a casa della madre di Giacometti.

C’è un prima e un dopo per te. Era ora di dimostrarlo. Andasti a chiedere un prestito ad una banca, di quelli che si concedono agli artigiani. Eri già sposato, eri già padre. Hai vissuto per due anni con quel prestito. Hai smesso di lavorare su commissione, hai chiuso la tua collaborazione con Domus. Dovevi solo scolpire. Dimostrare dove il tuo cammino ti aveva portato. Anni di lavoro matto e disperatissimo che ti hanno sciolto le mani e la testa. La solitudine non ti spaventava, era la tua condizione naturale. Eri un asceta, nel senso più autentico, originario, del termine. La tua era una ricerca della conoscenza attraverso l’esercizio. Ti allenavi di continuo per elevare le tue capacità, per, attraverso la materia, guardare oltre la materia. Fino a suggerire la figura umana, piuttosto che farla.
Un prima, un dopo. Nel 1957 esordisti con la tua personale, alla Galleria del Milione. Non eri più un artigiano, uno studioso, un critico. Eri un artista. Le tue sculture erano la tua voce, parlavano per te. L’esperienza del tuo travaglio, l’etica della tua visione, la rettitudine della tua vita. Non parole, opere. La mondanità non ti apparteneva. Non eri un animale di compagnia, non eri un’artista da bar Giamaica. Forse è anche per questo che ti hanno amato di più all’estero, che – dopo la sorprendente mostra del Milione dove sembrava fosse nato dal nulla un artista – le tue opere oggi si trovano nelle gallerie, nei musei, nelle collezioni private canadesi, israeliane, australiane, svizzere, giapponesi, tedesche. Hai avuto personali a New York, hai lavorato ad un monumento per una piazza ad Eindhoven. E a Milano te ne stavi chiuso nel tuo studio.

Prima, finita la guerra, in via Pellegrino Rossi, poi in via San Calocero e in via Pisacane. Fino ad arrivare in via Stoppani al 7. Avevi casa esattamente di fronte, dovevi solo attraversare la strada. Lì vicino abitava, in piazza Lavater, Gillo Dorfles, ma non lo andavi a trovare, preferivi passeggiare per negozi d’antiquariato, parlare con Giovanni Mazzaglia che aveva la bottega in via Stoppani, con Cesati, antiquario del ferro, in via Baldissera, con Carlo Ferrero in viale Regina Giovanna, o con Gustavo Mazzola, mercante d’arte, in via Nino Bixio. Oppure per rilassarti andavi al Cinema “Delle Stelle”, in via Frisi, da solo, ovviamente. Amavi Bresson e Dreyer. Il tuo quartiere era il tuo mondo, ti bastava.
Non era alterigia la tua, non era superbia. Eri un marito affettuoso, un padre tenero, le tue amicizie erano intense, profonde, gioiose. Venivano a trovarti in studio il creatore di gioielli Karl-Heinz Reister, oppure i fotografi Paolo Monti e Arno Hammacher, con Enrico Della Torre passavi lunghe estati a Teglio o ad Aprica, con Giovanni Testori facevi infinite telefonate all’ora di cena. Ma sapevi che unicamente nella solitudine si può esprimere un artista. Evitati trucchi, teorie, scorciatoie. L’artista doveva diventare anonimo, solo la sua arte doveva esprimersi. Te ne stavi nel tuo studio in via Stoppani – l’esternazione fisica del tuo mondo interiore, la sua concretizzazione – ascetico, simile a certe tue colonne di bronzo. Tu eri come la figurina che svettava in cima, un anacoreta dell’arte, un monaco stilita. Dall’alto della tua visione spirituale vedevi il mondo con umiltà e dedizione. Non cercavi approvazione, non volevi celebrazioni. Rifiutasti la realizzazione di un monumento ai caduti ad Aprica perché eri in disaccordo con i committenti e la loro concezione di “monumento”. Umili erano le tue sculture, come piccole pievi di campagna, eppure monumentali, non per dimensioni, ma per scala, per impeto. Rifiutasti di lavorare per la XI Quadriennale Nazionale di Roma, perché occupato a scrivere su Modigliani scultore. Di lui ricordavi le parole di Anna Achmatova. “Era circondato da un compatto anello di solitudine”. Quello dell’artista autentico. La tua solitudine, Mario.

Ti invitavano a concorrere in Germania, in Belgio ti nominavano accademico, in Austria inauguravano tue personali viaggianti, proprio negli anni della Milano da bere, del craxismo rampante così lontano dalle tue idee socialiste (“falce e scalpello” dicevano di te le compagne di scuola delle tue figlie) fatte di solidarietà, misura, riservatezza. Consigliavi ai giovani scultori di tendere all’assoluto, all’essenziale, al ‘Vero’. “Ogni scultore se è scultore è un primitivo”, dicevi a Franco Russoli, a Vittorio Sereni, a Vanni Scheiwiller.
C’è sempre stato un prima e un dopo per te, Mario. Tranne l’ultima volta, quando la proprietaria del tuo studio in affitto ti intimò di acquistarlo: “o lo compra o se ne va”. Non possedevi nulla, non avevi neppure la patente. Ma come smantellare l’intero tuo mondo, il tuo ritiro monastico, costruito anno dopo anno, pietra dopo pietra, proprio mentre eri preso dai preparativi per l’antologica a Palazzo Te, a Mantova? Troppe emozioni per il tuo animo sensibile. Ci fu la fitta al cuore, il ricovero al Centro Cardiologico Monzino, le ore d’attesa su un lettino. E poi, quando tutto sembrava passato, proprio mentre ti allacciavi le scarpe per tornartene a casa, l’infarto. Mancavano poche settimane all’inaugurazione della retrospettiva mantovana. Che non avevi mai cercato ma che era arrivata colpevolmente troppo tardi in un paese così ingrato. Tu non c’eri. Crudele e coerente, l’artista non c’era, parlavano le sue opere per lui. Con la tua voce.
[è on line Storie Milanesi, un progetto che raggruppa in un unico luogo virtuale le 14 Case e/o studio-Museo di artisti, architetti, scrittori, collezionisti di Milano. Sono quelle di: Franco Albini, Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi, Renzo Bongiovanni Radice, Antonio Boschi e Marieda Di Stefano, Alik Cavaliere, Vico Magistretti, Alessandro Manzoni, Francesco Messina, Nedda Necchi e Angelo Campiglio, Mario Negri, Gian Giacomo Poldi Pezzoli, Emilio Tadini, Ernesto Treccani. Di ognuna di queste ne ho fatto una narrazione. Sul sito si possono scaricare in pdf o ascoltare raccontate da una attrice. C’è molta altra roba, mappe comprese. Andateci e fate buon viaggio. G.B.]
Teotanasia (satura)
di Daniele Ventre
Incominciamo a cantare le esternalizzate -le Muse
che si sfrattarono già da Elicona chiaro di dèi-
gli hanno anche chiusa la fonte violacea -coreografie
non se ne tessono più -anche Zeus ha chiuso bottega:
fanno tuttora la doccia in stabilimenti al Permesso
(senza permesso al soggiorno) e all’Olmeio e al Rio del Cavallo
quindi da lì vanno via -da nessuna veste coperte
tutta la notte si vendono -o almeno in vetrina ci stanno-
e non inneggiano mica a Zeus -che dell’egida è nudo-
non ad Atena -il pensiero è debole -no, non ad Hera
-vende i suoi sandali d’oro ma il debito d’Argo è infinito-
né a Poseidone -e però qualche volta c’è lo tsunami-
non ad Apollo -si è spento e Artemide l’arco l’ha perso-
a Giovinezza e Afrodite un po’ -vende sempre la topa-
ma non a Leto né a Giàpeto -e Crono è da sempre in cantina-
e non a Temi poiché la legge è inuguale per tutti-
restano l’Alba e la Notte bordello e la Luna lucente
restano poi le Maldive e l’Oceano e il Sole cocente
-gli altri immortali però sono tutti andati in vacanza
Mica me l’hanno insegnato -li tagliano poi gli insegnanti-
io le ho incontrate per caso durante una fila alla posta
di malavoglia hanno detto così -la gest-line le sfrattava
loro -le Muse -le figlie di Zeus che ha dismesso anche il lampo:
-Forse sarebbe opportuno efficientizzare il sistema
monitorare il progetto e aggiornarsi e pianificare
la qualità -stabilire il merito -certificare-
Dissero questo le figlie di Zeus -lo sportello era chiuso
e se ne andarono via -così mi piantarono in asso
-io comparavo gli eventi che furono quelli che sono
e lo sentivo che ormai non avevo nulla da dire
e comprendevo che qui non c’è già più nulla da dire
Ora che è a terra la quercia -il diboscamento è una piaga-
anche la roccia è cemento -e ne fa buon uso la mafia
la finiremo oramai con le muse -loro che al padre
Zeus non allietano mica la mente in quel buco d’Olimpo
efficientizzano -loro- registrano certificando
monitoreggiano pure e spiano telefonate
quelle di Zeus quando chiama una sua ninfetta di turno-
il tabulato carpito però lo rivendono a Hera
-lui che si vanta di come ha sconfitto tutti i Giganti
-come ha mandato all’inferno la cosca avversaria i Titani
-poi le avventure passate le ninfe e le donne sedotte
e abbandonate con quei bambinetti da sistemare
-raccomandati al rettore o al re -che peraltro è lo stesso
-cantano sempre le muse -le assoldano da informatrici
-Zeus ha chiamato il suo killer -ma l’hanno assoldato le Muse
-Certo la colpa è anche sua se quelle hanno buona Memoria
Zeus se l’è fatta anche lei -la Memoria -allora le Muse
non esistevano -a Hera però le arrivò il tabulato-
erano figlie di quella Memoria -una buona Memoria-
un memoriale infinito di scandali sotto la terra
sotto le onde del mare nonché fra le nuvole in cielo-
E ne facevano feste con il Desiderio e la Grazia
-certo la topa tirava anche allora -andarono un giorno
anche dal padre -da Zeus -gli mostrarono il tabulato
-fece lo gnorri papà -perciò lo vendettero a Hera
-poi è venuta la crisi e te le hanno esternalizzate
-ora non rappano più come Zeus ha steso la cosca
del mandamento di Crono il Cannibale coi Titani
poi le tangenti le ha tutte divise e le ha date ai picciotti
nati da Crono e da Rea -gli dèi da sfilate di moda
quelli che sono fuggiti off-shore -sono andati in vacanza
con le tangenti divise e con le prebende e gli onori
Loro -le figlie del boss neomelodiche tutte spurie
Acleo e Anodinia e Penia e Monotonia
Drimicorea e Amegarte e Ametriche e Ipocoria
e Afonia -la più dark e la più underground che si trovi
quella che chiamano anche Scazusa ed è piena di scazzi
quella che poi non si ascolta che non se ne frega nessuno
-certo con tutti i proventi potevano darci qualcosa
la sinecura del posto per un dirigente di Stato
un contrattino a modino con un editore decente
-solo che adesso c’è crisi e non hai che piangere lutti
E se magari qualcuno ha l’esaurimento nervoso
imprenditore tassato o scafista pressurizzato
politicante colluso o sindaco già condannato
o paparazzo arrestato o navigatore spiaggiato
o commediante fallito o pianista esternalizzato
e se il pappone di turno gli vende una musa a modino
ecco che tutto ti passa e tu te ne vai più felice
mentre qualcuno ti spia -si rivendono il tabulato
Solo una cosa però non ce la cantate mai Muse
come finirla una volta con questa infinita commedia
questa tregenda di farse che mischiano dèi con la terra
come riuscire alle stelle a vedere il cielo spazioso
solo una cosa però non ce la cantate mai Muse
come ci siamo venuti a chiudere nella topaia
della sragione di Stato e di Banca -un buco d’Olimpo
dove non puoi far capire nemmeno al potere imbecille
quanto potrebbe mangiare di più -fosse meno indecente
cinéDIMANCHE #02 JAN ŠVANKMAJER “Qualcosa di Alice”
|
JAN ŠVANKMAJER Decalogo |
|
|
Francesca Matteoni
|
 Nella pausa delle domeniche, in pomeriggi verso il buio sempre più vicino, fra equinozi e solstizi, mentre avanza Autunno e verrà Inverno, poi “Primavera, estate, autunno, inverno… e ancora primavera“, riscoprire film rari, amati e importanti. Scelti di volta in volta da alcuni di noi, con criteri sempre diversi, trasversali e atemporali.
Nella pausa delle domeniche, in pomeriggi verso il buio sempre più vicino, fra equinozi e solstizi, mentre avanza Autunno e verrà Inverno, poi “Primavera, estate, autunno, inverno… e ancora primavera“, riscoprire film rari, amati e importanti. Scelti di volta in volta da alcuni di noi, con criteri sempre diversi, trasversali e atemporali.
900fest Festival Europeo di Storia del Novecento
Il progetto 900fest, il cui comitato scientifico è coordinato dal prof. Marcello Flores, nasce dalla comune considerazione della necessità di un costante approfondimento storico, accompagnato da un lavoro sulla memoria, di ciò che è successo nel secolo scorso in Europa
Quei bravi ragazzi
di Jamila Mascat
She knows there’s no success like failure
And that failure’s no success at all
(Bob Dylan, Loves minus Zero)
Qualcuno giorni fa mi ha rimproverato per essere arrivata con un quarto d’ora di ritardo, imputando alla “sinistra” un’allergia congenita alla puntualità. In effetti non avevo mai preso in considerazione l’ipotesi che potesse esistere un legame tra quella che ho sempre interpretato come una goffa idiosincrasia privata e l’eredità simbolica della falce e martello. A posteriori ho perfino ipotizzato che un qualche elemento di verità ci fosse in questa schematica ripartizione politica di vizi e virtù, rispetto all’anomalia del tempo vissuto e agito a sinistra (ma avevamo in mente la stessa sinistra?). Perché in fondo è vero che il tempo delle lotte intrattiene sempre un rapporto sui generis con il tempo presente: è impaziente, pressante, prende la rincorsa per forzarlo in avanti oppure gli sbandiera in faccia la memoria, gli spettri del passato, i fasti dei bei tempi andati; insomma non gli dà pace. È sempre intempestivo, come diceva il filosofo francese Daniel Bensaïd, e in un certo senso mai puntuale.
Ma sul momento, dopo essermi scusata per il ritardo, ho risposto fintamente piccata che non ero affatto d’accordo. Che era ora di finirla con queste sciocchezze, e che anzi la puntualità è di sinistra, come pure il merito e il talento. Io ovviamente stavo blaterando una cretinata qualsiasi, parafrasando un Renzi qualunque (in realtà quello della Festa dell’Unità di Bologna, lo scorso settembre), speravo fosse ovvio. Purtroppo, invece, la cretinata è stata presa per buona e interpretata come una tenace e sacrosanta rivendicazione del fatto che sì, è giunta l’ora, bisogna davvero riappropriarci di tutte queste belle cose. Ho annuito, era tardi per sanare l’equivoco, e ne ho dedotto che la sinistra ritardataria e quella dei grandi meriti non ridono né deridono allo stesso modo.
Onore al merito
Sulla e contro la meritocrazia, su come l’infelice incontro di merito e kratos che vorrebbe spazzar via burocrazia e clientelismo in vista di un futuro più giusto e democratico finisca per dar luogo a una società ispirata alla competizione di mercato e alla logica tecnocratica, hanno scritto in tanti e bene (per esempio Valeria Pinto, Valutare e punire, Cronopio, 2012), soprattutto in questa fase di lancio della grande consultazione sulla Buona Scuola che minaccia di essere sempre più meritocratica. Grazie a un articolo di Mauro Boarelli pubblicato su Lo straniero nel 2010, ho scoperto il destino immeritato toccato in sorte alla parola meritocracy, coniata, come molti invece già sapranno, dal laburista di sinistra Michael Young per raccontare una sorta di profezia distopica (The Rise of Meritocracy 1870-2033) che a distanza di qualche decennio sarebbe stata tristemente convertita in un manifesto per le riforme: l’avvento di una società in cui, una volta aboliti i privilegi di nascita, regnerebbero i meriti e i talenti naturali valorizzati da un sistema educativo capace di selezionare e coltivare le migliori intelligenze produttive misurate in base a criteri primariamente utilitaristici. È stato definito un libro di “fantasociologia”, che racconta la genesi di un nuovo mondo – ingiusto come o più del precedente – in cui all’aristocrazia di nascita o del denaro si sostituisce quella dell’intelletto. Ancor più straziante è un articolo di Young – pubblicato sul Guardian nel 2001, qualche mese prima di morire, e significativamente intitolato Down with meritocracy – in cui l’autore implora Mr. Blair “di espellere la parola dal suo vocabolario pubblico” e sollecita neanche troppo velatamente Blair e Brown a prendere le distanze dalla corsa al merito per perseguire obiettivi più meritevoli, come aumentare le tasse sui patrimoni, sostenere le amministrazioni locali e riattivare la partecipazione degli elettori alla vita del Labour.
Un articolo del 2006 dell’ex segretario della Fiom e poi della Cgil Bruno Trentin, apparso sull’Unità, mi ha fatto riflettere su un altrettanto immeritato destino, quello dei diritti di tutela, affossati in nome del merito e del nuovo che avanza, immancabilmente carico di reperti del paleolitico della modernità. Dalla prima rivoluzione industriale all’era fordista, infatti, l’appello al merito era lo strumento adoperato dalle direzioni aziendali contro l’unità dei lavoratori. Negli anni Sessanta, ricorda Trentin, “mi sono confrontato con la struttura della retribuzione, alla Fiat e in altre grandi fabbriche, e ho scoperto la funzione antisindacale degli “assegni” o “premi” di merito, quando questi, oltre a dividere i lavoratori della stessa qualifica o della stessa mansione, finirono per rappresentare un modo diverso di inquadramento, di promozione e di comando della persona […] che sigillava la garanzia del posto di lavoro e la fedeltà all’impresa. […] È questa concezione del merito, della meritocrazia, della promozione sulla base di una decisione inappellabile di un’autorità “superiore” che è stato cancellato con la lotta dei metalmeccanici nel ‘69 e con lo Statuto dei diritti del lavoro”. Contestata e sconfitta in nome del diritto al lavoro, la meritocrazia era un relitto sepolto, che ha finito per essere riesumato in grande stile anche dal più euforico dei rottamatori. E conclude Trentin: “Meriti e bisogni o capacità e diritti? Può sembrare una questione di vocabolario ma in realtà la meritocrazia nasconde il grande problema dell’affermazione dei diritti individuali di una società moderna. E quello che sorprende è che la cultura della meritocrazia […] sia riapparsa nel linguaggio corrente del centrosinistra e della stessa sinistra, e con il predominio culturale del liberismo neoconservatore e autoritario, come un valore da riscoprire”.
Bravate
In ogni meritocrazia che si rispetti i bravi vengono meritatamente premiati. La bravura del resto è una strana cosa. In inglese bravura è sinonimo di virtuosismo. In spagnolo uno bravo è feroce (perro bravo), in tedesco ein braves Kind è un bambino obbediente, mentre la ‘vecchia talpa’ di Marx, che ha ‘ben scavato’ (Brav gewühlt, alter Maulwurf!), è una che sa fare il suo lavoro come si deve. Per questo le brave ragazze vanno in paradiso, innocenti e senza macchia come gli italiani brava gente, mentre le ragazze brave fanno un master in digital journalism e poi, in mezzo a un oceano di precariato desolante, si inventano un lavoro strepitoso. Giulia di Vasco era brava perché si prendeva la vita che voleva, Mina, invece, era la più Brava, perché aveva “tanto di quel fiato che neppure una balena può resistere sott’acqua stando senza respirare tutto il tempo che io tengo questo ‘mi’!”. L’etimologia suggerisce un’origine diversa da Mina – dallo spagnolo bravo e probabilmente dal latino barbarus, ovvero “selvaggio, indomito”, forse contaminato da pravus “malvagio” – ma l’eco del termine nei secoli e nelle diverse lingue è riuscito a mescolare i significati: dal coraggio (un soldato bravo) all’abilità (un bravo attore) passando per la rettitudine (una brava donna).
I bravi ritratti da Manzoni (il Griso, il Nibbio, lo Sfregiato, il Tanabuso, lo Squinternotto e gli altri) non si comportavano esattamente da brave persone, ma si mostravano all’altezza dei compiti che gli venivano affidati. Sgherri prezzolati al servizio dei potenti, erano bravi a fare il loro mestiere. A distanza di meno di un secolo da I promessi sposi, Henry Ford avrebbe disambiguato una volta per tutte il lato oscuro della bravura: “Essere bravi non basta: bisogna essere bravi a fare qualcosa” (To be good is not enough; a man must be good for something). La bravura, in altre parole, implica sempre una conformità allo scopo. Ma se il fine giustifica i mezzi, chi giustifica il fine? – si domandava Norberto Bobbio da qualche parte. The answer is blowin’ in the wind, sta nel vento che soffia (non quello che fischia mentre la bufera infuria), nell’air du temps. E davvero non c’è bisogno di meteorologi per sapere da che parte spira il vento (you don’t need a weatherman to know which way the wind blows), Dylan, anche in questo, aveva ragione. Il fine si giustifica per la forza con cui s’impone, deve funzionare, proprio come il mezzo, e non c’è quasi più distinzione di rango. Allora quando la bravura non è virtuosismo, e cioè fine a se stessa, viene investita di un fine esterno, come intuiva Ford, e come notava Hegel, per cui il talento (Talent), opposto al genio, designa ciò che non supera mai i “limiti dell’abilità esterna”.
Figaro, bravo bravissimo, è un esempio paradigmatico. Non solo è un “barbiere di qualità”, acclamato (Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono/ donne, ragazzi, vecchi, fanciulle) e fortunato (Fortunatissimo per verità), ma è anche il factotum della città, “pronto a far tutto/ la notte e il giorno”. Uno bravo come Figaro, o come il bravo lavoratore preconizzato da Mr. Ford, è disposto a qualunque cosa e in questo è meritevole. I facchini della logistica che regolarmente bloccano i cancelli degli stabilimenti dove caricano e scaricano merci per protestare contro il trattamento lavorativo indecente (oltre che illegale) che subiscono e i dipendenti di Eataly che scioperano contro i licenziamenti e i contratti ultraprecari che gli vengono imposti, non sono bravi per niente; sono piuttosto ‘facinorosi‘. Quello bravo a fare affari (“è partito da zero e ora conta 4mila dipendenti in tutto il mondo”) e a restituire una candida e convincente narrazione di sè (“Avrei potuto giocare i miei soldi in finanza invece sono rimasto in Italia, pago il 50% in tasse e faccio uno sforzo immane per far quadrare i conti. Che qualcuno mi accusi di sfruttare i dipendenti è ingiusto e terribile: devo dire che ci rimango davvero male”), è Oscar Farinetti, l’imprenditore renziano più amato dalle amministrazioni locali italiane, che prima s’inventa Eataly e poi fa FICO. Renzi – che traina la vittoria del Pd alle europee con un 40% da record, ipnotizza 2 milioni e 350mila spettatori dal salotto di Barbara d’Urso, schiva uova marce col ‘sorriso’ nella piazza consacratagli da Internazionale a Ferrara, strega Valls e Sanchez con il magnetismo delle camicie bianche – non c’è che dire, è bravissimo; indubbiamente il più bravo di tutti. (E il futuro, ahimè, è solo l’inizio, con buona pace di Bob Marley).
Il metro di paragone, allora, disorienta e finisce per inibire i paragoni tout court. E quindi Rosa Parks? Quanto era brava Jeanne d’Arc, da 1 a 10, se lo era? E Frantz Fanon, lui era uno bravo? Le lotte (per non parlare delle rivoluzioni) sono sempre in fondo anche delle bravate, presuntuose e coraggiose (brave), che resistono al vento come possono e contrastano “l’insidiosa tentazione di abituarsi all’ordine delle cose” (Bensaïd), accontentarsi di farle funzionare e riuscire a funzionare in mezzo al loro. Ma se i bravi le bravate non le fanno, allora chi le fa? Forse i guastafeste, quelli e quelle che si lasciano tentare da altre insidie.
In direzione disordinata e contraria
Da bambina volevo gli occhi verdi e un uomo identico a Sandro Pertini, volevo che le guerre le vincessero i perdenti, inventare un vaccino contro la fame nel mondo e un album Panini tutto per me. Un album a tema, dedicato proprio a me. Impazzivo all’idea di trasformarmi in un centinaio di figurine da collezione in vendita in edicola per cui le ragazzine sarebbero state disposte a barattare soldi, merende e fermagli per capelli. C’era un unico neo, la triste sorte dei doppioni. Pensavo con orrore a che fine avrebbero fatto, magari appiccicati crudelmente sulle porte dei bagni e poi contraffatti e vandalizzati con il pennarello a suon di baffi e corna. Ma non importa più, a questo punto, perché tanto non ce l’ho fatta, ho fallito. Prima che Žižek rievocasse la parabola di Lenin e la montagna e trasformasse Worstward Ho (Try again. Fail again. Fail better) in un tormentone di consolazione per le rivoluzioni a (non) venire, l’etimologia ricorda che alla radice del fallimento (fallere) ci sono simultaneamente la caduta e l’inganno (e poi di conseguenza l’autoinganno, quello che ci induce in errore, ci fa sbagliare i calcoli e ci fa fallire come si deve).
Frances Ha di Noah Baumbach è un’ode (meritata) al fallimento, che incornicia amorevolmente i copiosi fallimenti accumulati da Frances Handley, 27 anni consumati al ritmo di cadute e innocue balle di compensazione. Con uno zaino ingombrante sempre in spalla che le permette di squattare all’occorrenza, Frances si agita goffamente in mezzo a giovani newyorkesi di successo. Corre e salta per strada scomposta, spesso inciampa, scivola e cade. Divora panini troppo grandi, beve sempre un bicchiere o una bottiglia di troppo, fa giochi con le mani da villani. Colleziona figuracce, debiti e piccole menzogne ordinarie, fingendo di avere più amici di quelli che ha, più lavoro, più futuro, più corteggiatori, più speranze. Vuole fare la ballerina, e balla, ma non è una promessa, non è poi così dotata; del resto non s’impegna neanche al cento per cento. Una sera, una cena, una tavolata di bravi professionisti, Frances morde e ingurgita pane senza tregua mentre inanella una gaffe dopo l’altra, svelando tutte le miserie del suo oroscopo: i soldi che non ha, il lavoro che non va, la famiglia che non vuole, l’amore che non cerca/trova. A un avvocato seduto accanto che le chiede che fai nella vita, risponde che è difficile da spiegare, e quando lui prova a capire – “Perché quello che fai è complicato?” (Because what you do is complicated?) – lei confessa con una punta di imbarazzo: “No, perché non lo faccio davvero” (No, because I don’t really do it).
Non è affatto brava, e ogni volta che lo ammette, senza nessun compiacimento, suscita curiosamente negli altri più imbarazzo di quello che prova, come alla vista di un residuo interdentale incastonato nelle gengive di chi ci sta di fronte che preferiremmo non vedere. I suoi scivoloni reali e figurati non sono un’arte, un dispositivo consapevole di sabotaggio, come ci piacerebbe che fossero (nessuna traccia della queer art of failure di Halberstam, in verità), ma solo il risultato di un’ostinata vocazione al misfitting. Frances doesn’t fit, non c’entra mai, è una creatura disadattata e recalcitrante che non dà neanche segno di essere in procinto di imparare e migliorare. A dispetto di tutto, rifiuta, perché l’idea di riuscire le costa più di quanto non le costi la consuetudine di fallire. Una buona a nulla, senza mezzi, dedita a sperimentare senza esito finalità non conformi, Frances non ha grandi meriti né ambizioni. Non ha neanche un figlio, non meriterebbe nemmeno l’assegno per le mamme.
Chissà che mondo sarebbe con più Frances e meno Renzi. Un altro genere di commedia.
Il sex appeal degli scrittori: Giacomo Leopardi (e Carver)
Francesco Forlani
«Così ho pensato di andare verso la grotta,
in fondo alla quale, in un paese di luce,
dorme, da cento anni, il giovane favoloso»
Anna Maria Ortese
C’è un sito in Italia, in cui è possibile sapere quale anniversario, di nascita o di morte, cadrà nell’anno in corso e in quello a venire degli uomini illustri. Si può chiedere di ogni anno, come se al venditore di almanacchi si potesse domandare ogni volta cosa fosse mai stato il passato ; e allora registi, scrittori, artisti ci propongono a seconda del peso dei defunti il loro personale memoriale nel nome della gloria di uno di essi o di un evento quando degno di essere ricordato. Così l’anniversario dei 150 anni dell’Unità d’Italia tre anni fa vide un vero e proprio florilegio di opere sul Risorgimento e l’anno in corso lo stesso per Enrico Berlinguer. Il conte Giacomo Leopardi, invece no, nato a Recanati, il 29 giugno 1798 e morto a Napoli il 14 giugno 1837, non incorreva in quello strano guasto della memoria e dunque, sdoganata l’opera dall’ingombrante idea dell’attavolino, possiamo almeno questo film, il giovane favoloso di Mario Martone, coglierlo in questa sua gratuità come un atto libero e consapevole del regista.
Quando più di u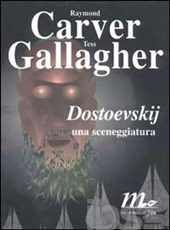 n anno fa ho letto delle riprese del film la prima cosa che ho pensato è stata quanto potesse essere difficile per un regista confrontarsi con la vita, e presumibilmente le opere, di uno scrittore. Non si prenda in considerazione il lavoro di adattamento di un romanzo, la sua trasposizione cinematografica, complessa e a giudicare dai risultati, spesso riuscita al punto che certi film sono di gran lunga più belli dei romanzi a cui s’erano ispirati ; in questo caso si parla invece proprio degli scrittori ed è per questo che ho immediatamente pensato a Raymond Carver. Come molti sanno allo scrittore americano Michael Cimino aveva all’inizio degli anni ottanta affidato la sceneggiatura della vita di uno degli scrittori-icona più grandi : Фёдор Михайлович Достоевский.
n anno fa ho letto delle riprese del film la prima cosa che ho pensato è stata quanto potesse essere difficile per un regista confrontarsi con la vita, e presumibilmente le opere, di uno scrittore. Non si prenda in considerazione il lavoro di adattamento di un romanzo, la sua trasposizione cinematografica, complessa e a giudicare dai risultati, spesso riuscita al punto che certi film sono di gran lunga più belli dei romanzi a cui s’erano ispirati ; in questo caso si parla invece proprio degli scrittori ed è per questo che ho immediatamente pensato a Raymond Carver. Come molti sanno allo scrittore americano Michael Cimino aveva all’inizio degli anni ottanta affidato la sceneggiatura della vita di uno degli scrittori-icona più grandi : Фёдор Михайлович Достоевский.
“Cimino disse che voleva fare un film su di un grande scrittore. Secondo lui, questo non era mai stato fatto. Citò Il dottor Zivago come esempio di quello che non voleva fare. Mentre parlavamo di quel film, mi ricordai che solo una volta Zivago, medico-scrittore, viene visto nell’atto di scrivere qualcosa.” Così scrive Carver nell’introduzione alla sceneggiatura, va detto assai scadente, scritta a quattro mani con Tess Callagher. Lo scambio di battute tra i due è quasi comico come quando ci racconta Carver: “Certo, la creazione di poesia o narrativa non è di per sé roba da sfondare lo schermo. Cimino voleva mantenere da cima a fondo visibile il Dostoevskij romanziere. La sua idea era che le circostanze drammatiche, spesso melodrammatiche, della vita di Dostoevskij, messe in rapporto con la composizione ossessiva dei romanzi, avrebbero offerto una meravigliosa occasione cinematografica.”
 Il comico diventa grottesco poi, quando sappiamo che ad aver scritto una prima stesura sia stato un russo e che in seguito due sceneggiatori italiani l’avevano tradotta in inglese tentando “di metterci un po’ di pepe”. Quando grazie a un amico sceneggiatore, Salvatore De Mola, ho cercato di saperne di più, sono venuto a sapere che il russo in questione era niente poco di meno che Алекса́ндр Иса́евич Солжени́цын, insignito dieci anni prima di quell’incontro, del premio Nobel. Allora ho sentito un altro amico del mondo del cinema, Gino Ventriglia, per cercare di sapere anche da lui se esistesse un modo di sapere il nome dei due sceneggiatori italiani, ma soprattutto per verificare quanto detto da Cimino sul fatto che non vi fossero stati nella storia grandi film su grandi scrittori. Certo non erano mancate ambizioni in quel senso, come quella di Visconti e del suo film su Proust. Progetto che non vide mai la sua realizzazione. Sappiamo però che quando si era sul punto di farlo il regista aveva immaginato un casting davvero recherché : Silvana Mangano per la duchesse de Guermantes, Marlon Brando nel ruolo di Charlus, Helmut Berger in quello di Morel, Alain Delon Marcel e Simone Signoret come interprete di Françoise. I produttori avrebbero parlato anche di Dustin Hoffmann, Brigitte Bardot, Charlotte Rampling e addirittura di Greta Garbo per una breve comparsa come Regina di Napoli.
Il comico diventa grottesco poi, quando sappiamo che ad aver scritto una prima stesura sia stato un russo e che in seguito due sceneggiatori italiani l’avevano tradotta in inglese tentando “di metterci un po’ di pepe”. Quando grazie a un amico sceneggiatore, Salvatore De Mola, ho cercato di saperne di più, sono venuto a sapere che il russo in questione era niente poco di meno che Алекса́ндр Иса́евич Солжени́цын, insignito dieci anni prima di quell’incontro, del premio Nobel. Allora ho sentito un altro amico del mondo del cinema, Gino Ventriglia, per cercare di sapere anche da lui se esistesse un modo di sapere il nome dei due sceneggiatori italiani, ma soprattutto per verificare quanto detto da Cimino sul fatto che non vi fossero stati nella storia grandi film su grandi scrittori. Certo non erano mancate ambizioni in quel senso, come quella di Visconti e del suo film su Proust. Progetto che non vide mai la sua realizzazione. Sappiamo però che quando si era sul punto di farlo il regista aveva immaginato un casting davvero recherché : Silvana Mangano per la duchesse de Guermantes, Marlon Brando nel ruolo di Charlus, Helmut Berger in quello di Morel, Alain Delon Marcel e Simone Signoret come interprete di Françoise. I produttori avrebbero parlato anche di Dustin Hoffmann, Brigitte Bardot, Charlotte Rampling e addirittura di Greta Garbo per una breve comparsa come Regina di Napoli.
Eccoli i giganti, Leopardi, Dostoevskij, Proust, Victor Hugo di cui va ricordato lo straordinario Adele H di François Truffaut e in cui il gigante delle lettere brilla per la sua quasi totale assenza ; grandi scrittori europei, ovvero appartenenti a una tradizione che non si limita alla letteratura nazionale ma che la sovrasta, la travalica come in passato era stato il caso per Dante e Boccaccio o ancor prima con Virgilio. Non so per esempio quanti siano al corrente del fatto che diverse sue opere furono pubblicate in Francia ancora inedite in Italia e che il poeta avesse negli anni ’30 manifestato il proprio desiderio di andarsene nella capitale francese. « Io per molte e fortissime ragioni sono desideroso di venire a terminare i miei giorni a Parigi »( lettre de Leopardi à De Sinner du 20 mars 1834.) Queste due premesse, una sulla complessità della vita degli scrittori come materia cinematografica e la dimensione europea della figura di Leopardi sono necessarie per capire come a mio avviso Mario Martone, il suo cineteatro, sia riuscito con questa sua opera a rendere verosimile il suo, nostro racconto della vita del poeta di Recanati. Cominciamo dalla luce.
 Come tutti sanno il cinema è luce. Un buon direttore della fotografia è colui che riesce ad ammaestrare la luce, a comporre con essa il quadro-inquadratura dell’azione scenica. Per questo suo film Mario Martone ha affidato la camera a Renato Berta ; non vorrei apparire wikipedante ma è uno, per capirci, che ha lavorato con Danièle Huillet e Jean-Marie Straub, Patrice Chéreau (L’homme blessé, 1983), Éric Rohmer (Le notti della luna piena, 1984), Jacques Rivette (Hurlevent, 1985) e André Téchiné (Rendez-vous, 1985). Louis Malle, Arrivederci ragazzi (1987) con il portoghese Manoel de Oliveira e con l’israeliano Amos Gitai. Insomma per capirci ci capisce. Se provaste mentalmente a crearvi un blob di sequenze di tutti questi film citati ritrovereste assai facilmente un uso della luce che nel film di Martone si deterritorializza e si detemporalizza costantemente. Sia che si tratti delle rimembranze del poeta o dello sguardo sulle cose, ora la montagna incantata del Vesuvio ora i rituali gesti dei giocatori nel pallone, il flusso di immagini e di coscienza del protagonista ne determina il pensiero, la forza delle idee quasi in sinergia con i momenti di massima fragilità come quando la luce irrompe nella camera buia del poeta quasi accecato dalla fatica. Una luce che quasi si modula sui diversi registri linguistici, sia che si tratti delle lingue regionali che dei passaggi dallo scritto al parlato.
Come tutti sanno il cinema è luce. Un buon direttore della fotografia è colui che riesce ad ammaestrare la luce, a comporre con essa il quadro-inquadratura dell’azione scenica. Per questo suo film Mario Martone ha affidato la camera a Renato Berta ; non vorrei apparire wikipedante ma è uno, per capirci, che ha lavorato con Danièle Huillet e Jean-Marie Straub, Patrice Chéreau (L’homme blessé, 1983), Éric Rohmer (Le notti della luna piena, 1984), Jacques Rivette (Hurlevent, 1985) e André Téchiné (Rendez-vous, 1985). Louis Malle, Arrivederci ragazzi (1987) con il portoghese Manoel de Oliveira e con l’israeliano Amos Gitai. Insomma per capirci ci capisce. Se provaste mentalmente a crearvi un blob di sequenze di tutti questi film citati ritrovereste assai facilmente un uso della luce che nel film di Martone si deterritorializza e si detemporalizza costantemente. Sia che si tratti delle rimembranze del poeta o dello sguardo sulle cose, ora la montagna incantata del Vesuvio ora i rituali gesti dei giocatori nel pallone, il flusso di immagini e di coscienza del protagonista ne determina il pensiero, la forza delle idee quasi in sinergia con i momenti di massima fragilità come quando la luce irrompe nella camera buia del poeta quasi accecato dalla fatica. Una luce che quasi si modula sui diversi registri linguistici, sia che si tratti delle lingue regionali che dei passaggi dallo scritto al parlato.
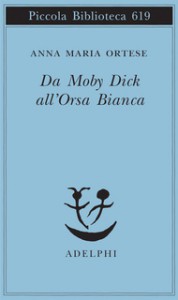 Questo tema della luce e della cecità ci riporta ad Anna Maria Ortese, il cui racconto, Pellegrinaggio alla tomba di Leopardi (nel libro edito da Adelphi, da Moby Dick all’Orsa Bianca) non si limita a suggerire il titolo del film, come è stato ricordato dal regista ma ne orienta quasi tutta la visione, del poeta e dello spettatore, al punto che mi è sembrato perfino magica, nel senso di magicamente evocativa, la scena del canto, a Napoli, di uno dei suoi attendenti della settecentesca ‘O Cardillo. Non si tratta più della malattia, allora ma del dolore da capire in tutta la sua capacità fondativa della verità. La verità dice male all’uomo non perché in un particolare destino, una malattia individuale ne determini la tragicità ma proprio perché grazie a quel preciso e concreto male è come se il corpo si affrancasse dall’illusione dell’anima e ne cogliesse tutta l’universalità. Per capire questa esperienza quasi orientale della verità del giovane favoloso basterebbe rileggere uno dei più potenti ed insieme chiarificatori passaggi di un altro gigante europeo, Friedrich Nietzsche, che fu tra l’altro tra i primi a cogliere la grandezza di Leopardi.
Questo tema della luce e della cecità ci riporta ad Anna Maria Ortese, il cui racconto, Pellegrinaggio alla tomba di Leopardi (nel libro edito da Adelphi, da Moby Dick all’Orsa Bianca) non si limita a suggerire il titolo del film, come è stato ricordato dal regista ma ne orienta quasi tutta la visione, del poeta e dello spettatore, al punto che mi è sembrato perfino magica, nel senso di magicamente evocativa, la scena del canto, a Napoli, di uno dei suoi attendenti della settecentesca ‘O Cardillo. Non si tratta più della malattia, allora ma del dolore da capire in tutta la sua capacità fondativa della verità. La verità dice male all’uomo non perché in un particolare destino, una malattia individuale ne determini la tragicità ma proprio perché grazie a quel preciso e concreto male è come se il corpo si affrancasse dall’illusione dell’anima e ne cogliesse tutta l’universalità. Per capire questa esperienza quasi orientale della verità del giovane favoloso basterebbe rileggere uno dei più potenti ed insieme chiarificatori passaggi di un altro gigante europeo, Friedrich Nietzsche, che fu tra l’altro tra i primi a cogliere la grandezza di Leopardi.
Scrive il filosofo: “La salute dello spirito si misura da quanto esso è in grado di sopportare e superare e cioè risanare. La malattia è un sintomo della grande salute”. In tal guisa va a parer mio interpretato il processo di annientamento fisico così finemente raccontato da Martone con la progressiva conquista di una verità laica, rivoluzionaria per i suoi tempi nel non volere assecondare le due cecità della religione e del progresso. Leopardi, le grand malade, compie attraverso sé stesso una trasfigurazione del tempo, rimembra e si smembra in virtù di una profonda conoscenza delle cose.
Nel suo racconto Anna Maria Ortese scrive : “Il sentimento della vita sì bella e fugace lo dominava come un prodigio. […] Da quella coscienza, l’uomo saliva. […] Il suo dolore, come un fuoco, distrusse, come una luce ricreò tutto”.
Così mi ritorna in mente il finale della canzone ‘o cardillo:
T’accarezza te vasa ah… viato
chiu’ de me tu si certo cardi’
Si cu’ tico cagnarme m’è dato
doppo voglio davvero muri’.
e la necessaria metamorfosi, che la vita procura a sé stessa attraverso la vita, sia che si tratti della natura in cui il poeta si perde, si rotola, si arrampica, cade che dell’aristocratico amore via via crescente verso il popolo umile come nella sequenza in cui il giovane e deforme conte è accolto da giovani e vecchi al tavolaccio lungo di una bettola di quartiere. L’interpretazione di Elio Germano è talmente connaturata al personaggio che la vita dell’uno si troverà a coincidere nel finale con quella dell’altro: Elio Germano ha 34 anni, Leopardi muore a trentanove. Altra interpretazione degna di nota quella di Raffaella Giordano, nota coreografa e danzatrice che nel ruolo della madre è totalmente ripiegata su se stessa, matrigna ancor più che madre, tumultuosa nella sua immobilità.
La lenta ginestra che sul finale rappresenta meglio di qualsiasi altra natura la conversione di Leopardi all’eterno ritorno delle cose, al vivere e morire incessantemente, si compie ancora una volta attraverso la caduta del cielo in mille frammenti. La voce di Elio Germano porta naturalmente ognuno di quei versi alla ragionevole mutezza, a quella che Walter Binni, il primo ad avere tentato di liberare Leopardi dalla sfiga del personaggio e dall’erronea attribuzione alla sua poetica di una autofondazione idillica, definiva una “musica senza canto”. Aggiungendo: “Ed ogni lettore che abbia storicamente e correttamente compresa la direzione delle posizioni leopardiane (anche se personalmente non le condivida interamente) non può comunque uscire dalla lettura di questo capolavoro filosofico ed etico, inscindibilmente poetico, senza esserne coinvolto in tutto il proprio essere, senza (per usare parole leopardiane) “un impeto, una tempesta, un quasi gorgogliamento di passioni” (e non con l’animo “in calma e in riposo”) che è appunto per Leopardi il vero effetto della grande poesia.”
Mos Maiorum: connotazioni ideologiche di un’operazione di polizia
di Filippo Furri
Mentre il panico da contagio invade per l’ennesima volta un occidente vittima dei suoi anticorpi e della speculazione farmaceutica, e il virus Ebola non ha ancora raggiunto le 5000 vittime, un centesimo di quelle prodotte ogni anno dall’influenza ; mentre la corte d’appello di Palermo assolve i due comandanti dei pescherecci tunisini che nel 2007 sono finiti sotto processo per aver tratto in salvo 44 naufraghi nel canale di Sicilia, perché salvare vite umane non può (e non deve) essere considerato un reato ; mentre Renzi annuncia, sempre con un piglio propagandistico, uno « ius soli temperato » che permetta ai figli di stranieri in Italia di acquisire la cittadinanza a patto che portino a termine almeno un ciclo scolastico ; mentre Lega Nord e Casa Pound si ritrovano in piazza Duomo per sbandierare i soliti propositi xenofobi ed invocare la sospensione di Schengen, a braccetto con le altre destre europee ; mentre tutto questo, sul territorio dei 26 paesi membri dell’Unione Europea è in atto, dal 13 al 26 ottobre, un’operazione di polizia in grande stile, battezzata Mos Maiorum e destinata a « raccogliere informazioni sui flussi migratori nei Paesi dell’U.E., con particolare riguardo alla pressione nei singoli Stati Membri, alle principali rotte utilizzate dai trafficanti di esseri umani, le principali mete di questi ultimi, i paesi di origine e transito, i luoghi di rintraccio e i mezzi di trasporto utilizzati.
Les infréquentables: Dominique de Roux
da Immédiatement
di
Dominique de Roux
traduzione di Francesco Forlani
A force de me faire traiter de fasciste j’ai envie de me présenter ainsi : moi, Dominique de Roux, déjà pendu à Nuremberg.
A furia di farmi trattare da fascista mi è venuta la voglia di presentarmi così: io, Dominique de Roux, già impiccato a Norimberga.
Il successo dei paranoici presso le donne; in ogni paranoico, la donna trova un territorio in cui finisce con il confessarsi inferiore.
Dell’impossibilità di lavorare per un poeta. Rimbaud ha pensato di risolvere il problema sopprimendo la poesia Éluard sopprimendo il lavoro.
Lo snobismo si è esteso alle masse.
Quel che scriveva nel 1927 lo scrittore italiano Piovene a proposito di Italo Svevo: “Svevo, commerciante triestino, scrittore di tre mediocri romanzi è improvvisamente annunciato come un grande scrittore da uno scadente poeta irlandese abitante a Trieste, Joyce, uno scadente poeta di Parigi,Valery Larbaud”
C’è il fegato di Lumumba conservato in un boccale di scotch, la zucca di Lenin, ora le mani di Che Guevara in un mausoleo, a quando i coglioni di Casanova sotto vuoto?
Il Maggio 68 è esistito solo grazie al generale de Gaulle. Due fenomeni somiglianti: il gaullisme imitazione della monarchia quanto l’altro della rivoluzione, la mitomania interiore, si è opposta la mitomania collettiva.
La sfortuna di essere nato in francese.
L’innocenza è inespugnabile quando è totale.
L’odio, dimensione borghese della rabbia.
Dopo Kant, Gombrowicz ha previsto l’esplosione della gioventù, dovuta al fossato sempre più largo tra l’età adulta secondo natura e l’età adulta secondo cultura.
Tutti i paesi dell’est sono diventati il paradiso dei paranoici. La paura di essere sorvegliati dalla polizia e la sorveglianza di questa fanno che ognuno al ristorante, al caffé o in strada prenda il proprio vicino per uno della sicurezza. Mentre in occidente ci si abbrutisce all’ascolto della radio o della televisione, in Polonia ci si abbrutisce allo stesso modo ma per altre ragioni. Una radio o una televisione che funzioni confonde l’ascolto eventuale. Cappa di piombo all’Est, cappa di detriti mentali e cappa di merda all’Ovest.
L’uomo metafisico è per sua natura reazionario.
La crisi dell’intelligenza proviene dal fatto di volersi definire con delle parole quando invece non ci si definisce che con le azioni.
Un tecnocrate: figlio di buona famiglia pietrificato sul lato destro e impotente su quello sinistro. Nel mezzo un’intelligenza che si giustifica incessantemente, tipo un cadavere che bofonchia.
I voli di uccelli sono anch’essi presi nel fiume dei radar, che li portano di aerodromo in aerodromo.
É surrealista o marxista? si domandava ad André Breton; e se è marxista, che bisogno c’è di essere surrealista? Questa fatale domanda di Antonin Artaud dovrebbe figurare, anche, su tutti i giornali di sinistra e giornaletti marxisteggianti.

Lei dice: Mi ha fatto l’amore, è brutto in un libro, è bello ora.
Il tradimento è complementare al segreto.
Essere moderni è cedere alle circostanze.
Siamo bloccati tra il gauchisme denunciato da Lenin e il gusto per l’Hotel Hilton.
Tra i manoscritti che ricevo, molti si appellano alla tecnica del monologo interiore nlla peggiore tradizione del meccanismo psicologico, dell’oscurantismo di certi dettati automatici, il tutto incantato da simboli trafficati (La maggior parte di questi autori sono beninteso degli universitari).
Una donna può volere il proprio suicidio a sedici o diciott’anni, in pieno possesso della propria gioventù, bellezza, dei suoi lussi, dunque d’una scelta. Però in vecchiaia diventa economa. Vuole durare. Sa che tenere più a lungo costa caro.
Un giorno Glucksmann va a trovare Lacan e gli chiede dei soldi per la sua rivista. Risposta di Lacan: “Non ho soldi con me, non ho visto malati”. Del resto alcuni malati si lamentano del rumore di carta spiegazzata alle loro spalle quando parlano distesi sul divano. É Lacan che palpeggia gli onorari.
Discorso che ogni generale che si rispetti dovrebbe fare ai propri uomini prima di andare al fronte: Chiunque si faccia uccidere, prima lo resuscito e poi lo faccio fucilare per tradimento.
Lavoro solo di notte. Se ci fossero su terra solo persone che vivono di notte, la lotta di classe non esisterebbe. La notte cancella le classi sociali.

*
L’artista “collabora” attualmente, si conforma alle regole del gioco, alle convenzioni. Non è la repressione a nuocere al pensiero, ma le agevolazioni offerte dal potere stabilito.
Questa fatalità del vicinato della morte che è l’ombra di tutti quei campi del mondo che hanno ricevuto l’inscrizione seguente all’ingresso di Auschwitz: « Dein Block ist dein Heim » (il tuo blocco è la tua patria)
Nota
Di Dominique de Roux esistono poche opere pubblicate in Italia. Mademoiselle Anicet, La morte di Céline (in pubblicazione) e Testamento, Conversazioni di Witold Gombrowicz con Dominique de Roux.
Infréquentable, Dominique de Roux è stato scrittore, editore, polemista. Coofondatore delle éditions Christian Bourgois, direttore letterario presso Julliard e Plon, e direttore con Christian Bourgois della collezione 10/18, Fondamentale la sua opera critica su Céline, editoriale con Gombrowicz, Pound, Borges, Burroughs; Gracq, Michaux, Beckett, Soljenitsyne. Inoltre fondatore delle celebri Éditions et des Cahiers de l’Herne fa parte di una tradizione di pensiero, controcorrente, polemista, di cui Philippe Muray, recentemente scomparso, e Michel Houellebecq ne sono i più autentici interpreti ai nostri giorni.
Baby Blues
7:28
Gli occhi sono appiccicosi al risveglio.
Braccia e gambe sembrano tubi di gomma allacciati all’addome gonfio e sporgente.
Le mie dita portano sempre la sua nuca moscia: lei non può reggere da sola la sua testa.
L’altro braccio solleva il resto del corpo: accosto la bambina al petto, i cuori si magnetizzano, i nostri battiti si orientano e si attraggono.
Il suo cranio è allungato, untuoso.
Ha croste bianche sull’attaccatura dei capelli e sulle sopracciglia, e bolle rossastre sulla sua pelle come tanti punti di ruggine, specialmente su fronte e palpebre.
L’ombelico è otturato da residui di carne.
Sfioro la guancia con il dito, lei gira la testa verso il dito, subito, apre la bocca, schiocca la lingua poi inizia a succhiarsi il polso. Posiziono il suo capo nell’incavo del mio gomito, lei resta ancorata al mio tronco, le sue unghie mi rovistano come quelle di un uccello in cerca di insetti.
Giuliano Mesa: Nunc stans
di Biagio Cepollaro
Pubblico qui la parte iniziale di Nunc stans. poemetto di Giuliano Mesa che lessi nell’ ambito della rassegna Tu se sai dire dillo 2014. Una prima documentazione di quella rassegna, a proposito di Paola Febbraro, si può leggere qui. L’intero poemetto, composto tra il 2004 e il 2007, è tratto da Nun (2002-2008) che costituisce l’ultimo testo edito, compreso in Giuliano Mesa, Poesie 1973- 2008, pubblicato nel 2010 da La Camera Verde di Roma. Altrove mi sono occupato di Giuliano Mesa, dedicandogli alcune conversazioni e una pagina del blog Poesia da fare
Nunc stans
5,5
1
[parola voce,
sta tacendo-
non ci sarà più tempo,
prima, poi]
2
[prendi parola preme, ancora,
parola ancora è andata, via,
come se fosse stata
[allora, lì]
[e mentre, ancora mentre
che accade l’accadere e se ne va,
battendo ancora i piedi,
tà, tatà-
[questa è la nenia, notte,
sotto la neve nera]
3
di così tanto,
stato, detto
[poco,
ciò che rimane,
poco-
ma così tanto
per una vita sola-
tanto che si riduce,
si raduna-
[eraso,
diradato,
in poche tracce-
nel nonnulla
di ogni sola vita]
cosa faremo insieme,
che cosa rimarrà?]
4
cosa ci sia laggiù, oltre tutto,
finito, mai finito-
prende il suo tempo dentro, e poi scompare,
e resta prima, prima per sempre andato,
stato
[e sia così
5
[è tutto nella mente che poi muore]
1
dì per che cosa,
turbine, vortice,
per chi,
se non affranto
[e il frangersi, le onde,
su scogliere,
vento su dirupi,
e il farsi forma]
[infranta,
tra vuoto e vuoto,
sparsa, mutilata]
[“tu forse tornerai”]
2
sono soltanto poche righe,
a fare stuolo
è solo l’ansia del già stato,
che corrode,
mettendo insieme il prima, il dopo,
il separato
3
clama, proteso-
l’ora che s’abbuia,
notte del tempo,
e cava, concava-
voce spalanca luce,
lo spolverìo che luccica,
d’acqua, che cade,
che asseta, intridendo,
che prosciuga,
lasciando, cosa,
creta per il nonnulla-
[-andando via, giù,
nell’acqua buia-
“dove ti sto cercando”]
4
parola crosta, creta,
parola forma che s’incrina,
s’ingrava, coltre,
ricava crini e lane,
feltri, da grumi e grani, gravidi,
ossa cariate, cervici sgravate,
lame a segare, separare
[farsi svanire via, da sé-
prendersi cura, ancora,
della notte]
5
e poi non più, quel sempre-
[passerà tempo e sarà stato]
(…)
La mia lettura integrale di questo testo di Giuliano Mesa si può ascoltare in questa registrazione. Introdussi il tema con alcune considerazioni e con alcuni ricordi che qui provo a condividere.
Si potrebbe intendere globalmente il testo come una sorta di meditazione intorno al qui e ora, al presente, alla consistenza o non consistenza del presente e della vita individuale nel tempo e nello spazio. Nun , viene detto in nota, nella cosmologia egizia è il caos delle acque primordiali. Durante la scrittura di quest’opera ci tenevamo costantemente in contatto. La nostra amicizia era iniziata nel 1984 collaborando entrambi ad una piccola rivista romana, Symbola. Negli anni di Nun gli parlavo attraverso lettere e telefonate della meditazione sull’impermanenza di ogni cosa e ci si trovava in sintonia: lui attraverso i tragici greci soprattutto, io attraverso testi orientali. Da queste meditazioni scaturiva per lui e per me un senso di maggiore intensità vitale: la necessità di essere presenti e morbidi. Non pensare davvero alla nostra finitezza ci rende duri di cuore e insensibili verso gli altri, ci si diceva. La mente morbida. Ma in realtà non dicevamo la stessa cosa perché lui stava preparando la sua sparizione, qui resa esplicita e realizzata di lì a poco, nel 2011, e in un certo senso, cominciava a farlo con questa indagine sull’esser presente , sul non esserlo più e soprattutto su ciò che sarebbe restato, dopo la sparizione. Il poco che resta, dirà nella poesia ma anche nelle lettere che mi spediva, è anche tanto per una sola vita: questa l’unica sua consolazione, la possibilità di esser grato a quanti con la loro stima lo avevano sostenuto. Anche per questo la rassegna prende il titolo da un verso del suo Tiresia, di cui si può vedere una parte in video.
Lo stile di Nunc stans porta quasi al parossismo ciò che Giuliano ha imparato nel corso degli anni intorno al fare poetico: comincia con il presentare un tessuto omogeneo sul piano fono-simbolico, costituito da pochissimi elementi e timbri e poi comincia a far muovere dall’interno questo tessuto mescolandone sapientemente le parti per piccoli spostamenti, per leggere inversioni, ripetizioni, sostituzioni. Il tessuto resiste perché tenuto insieme da connessioni paranomasiche, da assonanze, da allitterazioni. E’ però col tempo un tessuto sempre più rarefatto perché sempre più eroso ed abraso. Ed è questa l’esperienza che racconta di più: di qualcosa che si consuma per erosione lasciando intatta e ancora visibile la trama del tessuto. Non c’è cancellazione nella sua esperienza, non c’è nichilismo: c’è invece l’attenuarsi della presenza, così come il ridursi di spessore della sintassi e del lessico che restano come segni di una città antica dissepolta. Il suono anche sulla pagina muta è molto presente organizzando palesemente il senso: le parentesi quadre che qui vengono inserite a me risultano dei tagli che in verticale aggiungono un’altra voce al testo, un inciso che proviene da una distanza maggiore. La parola ‘tagli’ poi nel componimento è anche la parola che chiude.