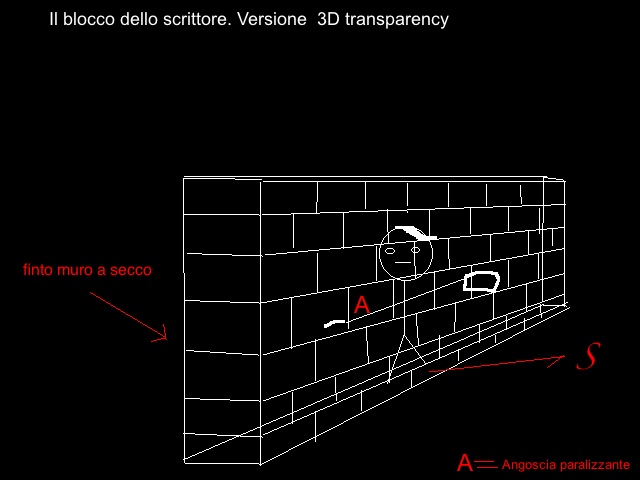di Giovanni Dozzini

Il ristorante dovrebbe essere da qualche parte dietro Plaça Sant Jaume, verso la cattedrale, io percorro l’ultimo tratto di Carrer Ferran cercando disperatamente di connettermi a questo meraviglioso servizio di wi-fi pubblico e gratuito che dovrebbe coprire tutta la città e che invece per qualche motivo pare funzioni solo nei pressi di Paral-lel, dall’altra parte del cuore vecchio di Barcellona, ai piedi del quartiere in cui vivono gli amici che mi ospiteranno in questi giorni appiccicosi di metà ottobre e appena oltre quello in cui è nato e cresciuto l’uomo che è il motivo stesso del mio piccolo viaggio. Sotto i palazzi del potere, tra la Generalitat e l’Ajuntament, riecheggiano le voci di un gruppo di persone in là cogli anni che protestano e sbraitano con più rabbia che convinzione, “No es crisis, es capitalismo”, in castigliano, e sono poche e quasi confuse con il buio e la gente che passa nemmeno troppo incuriosita, i mossos d’esquadra, con la loro fama di cattivi che la scorsa settimana hanno pensato bene di assecondare pestando a morte per strada un imprenditore omosessuale un po’ su di giri, li tengono d’occhio sbadigliando dall’angolo della piazza che secondo i miei calcoli, o per come me li ricordo, dovrebbe portarmi dalle parti del mio obiettivo di stasera. La cena del congresso, la prima delle due in programma, l’unica alla portata delle mie tasche: pago diciassette euro e mangio assaggi di paella e riso, e bevo vino, tutto buono, in potenza, tutta roba Slow Food. La gente che grida è un pezzo della Spagna che ci raccontano tutti da mesi, la Spagna che annega nella disoccupazione e cerca di venirne fuori smantellando lo stato sociale o dando corda alle peristalsi separatiste delle terre più ricche, la Catalogna ribollente su cui ora sto poggiando i piedi su tutte. Una povertà che mi riguarda ma che per ora mi costringo a tenere a bada, i miei problemi di budget al confronto sono nulla, e prima o poi dovrò fare i conti anche con questo.
Nel ristorante mi imbatto quasi improvvisamente, lo pensavo più in là e invece è già qua, e in vetrina un grande adesivo rosso conferma ciò che fino a un secondo prima era solo virtuale, come molte delle cose su cui ormai siamo abituati a fare affidamento nella vita: nel pdf inviatomi dagli organizzatori c’era scritto che la cena si sarebbe fatta al ristorante Allium di Carrer del Call, e ora ho la certezza provata che le cose andranno davvero così. Ma è ancora presto, le nove arriveranno tra mezz’ora, butto un occhio dentro e giro i tacchi, l’aria di Barcellona oggi è mezza avariata e la gola brucia di quella condizionata, e che non finirò mai di maledire, di Ryanair. Ho bisogno di sedermi, ho bisogno di bere qualcosa. In cima a Carrer Ferran c’è un vecchio bar che somiglia poco allo stuolo di locali in franchising o in fotocopia che si incatenano lungo il resto della via. Vado lì, e mi faccio una cerveza clara.
Mezz’ora dopo sono di nuovo davanti al ristorante, entro e chiedo del congresso, la cameriera dice che è ancora presto e mi fa bere un bicchiere di rosso che non me la sento di rifiutare. Nel tragitto da casa di Bea e David a qui ho già attraversato il cuore della Barcellona di Manuel Vázquez Montalbán, il mio uomo, o perlomeno di quella che siamo abituati ad associare a lui e a Pepe Carvalho: il Raval, il Barrio Chino, il quartiere del popolo e dei pochi di buono, delle puttane e degli immigrati, coi suoi musei d’arte moderna e le sue piazze disinfettate da tre o quattro lustri di riqualificazione prepotente. Undici anni fa, quando studiavo qui, era l’altra faccia della Luna, dalla mia parte della Rambla c’era il Barrio Gotico e c’erano le viuzze medievali e i bar da giovani stranieri viziati, dall’altra sorgeva quel peccaminoso mondo fatto di rottami di palazzi e gente torva e scura frutto di secoli di mescolanze di sangue e di paure.
Nei mesi del mio Erasmus Vázquez Montalbán era ancora vivo, ma io pensavo di avere di meglio da fare che non andare a cercarlo o a cercare le tracce della sua letteratura così aderente alla materia, già amavo Carvalho e già sapevo che doveva aggirarsi in quelle strade, ma non potevo far altro che camminare e rubare occhiate fugaci, perché ero convinto, giovane presuntuoso dall’animo eccitato, che quella materia, la realtà, mi sarebbe venuta tutta addosso da sola.
E quindi oggi, più o meno un’ora fa, sono passato per la prima volta in vita mia – o per la prima volta coscientemente – nella strada in cui Manolo è cresciuto. Carrer d’En Botella è minuscola, corta, uguale a mille altre, poche decine di metri che si innestano nel corpo storto di Carrer de la Cera proprio laddove si torce, col buffo risultato di comporre una sorta di enorme Y fatta di asfalto e cemento. Una porta, l’altra, e quale finestra, non lo posso sapere e mi muove la fretta di mettere insieme più tracce possibili, quelle che da ragazzo avrei avuto tutto il tempo di cercare e riconoscere, così passo senza calma, guardo e registro, mi pare, ed è come fare una crocetta in un elenco della spesa stupido che almeno ho avuto il buon gusto di non mettere per iscritto. Poi mi perdo un po’, vado un po’ avanti e un po’ indietro finché non mi accorgo che dietro l’angolo comincia il grande vuoto della Rambla del Raval, quella col gatto grasso di Botero e i palazzi occupati e malandati, quella che un tempo non era così pulita e così piena di verde, o forse mi sbaglio, la memoria gioca già brutti scherzi, e i ritorni sono stati tanti, e mai con lo stesso grado di attenzione e lo stesso tipo di intenzione.
Seduto al bancone del ristorante Allium di Carrer de Call, un’ora dopo adesso, ripenserò alla vista dell’alto e scintillante cilindro ellittico che hanno piantato proprio al centro della piazza che dal 2009 porta il nome di Vázquez Montalbán, che è come un rigonfiamento della Rambla più plebea di Barcellona, un hotel di vetri viola che suona come un’astronave atterrata di corsa in mezzo alla vecchia suburra. Altri hanno già scritto dell’orrore che Manolo avrebbe provato a vedere il Barceló Raval Hotel fare ombra al suo nome, l’ho fatto anch’io fidandomi senza averlo mai visto coi miei occhi, e al momento di trovarmelo davanti, e sopra, non riesco a reprimere un sospetto di pulita e assurda bellezza che peraltro, è vero, difficilmente avrebbe potuto percorrere i nervi suoi, quelli di Manolo. Poco oltre c’è il ristorante in cui avevo pensato di pranzare sabato, tra due giorni, il giorno prima del ritorno in Italia, il ristorante che dicono fosse una sua seconda casa, o quasi, lo trovo e prima ancora di guardarlo mi faccio atterrire dalla cifra che campeggia in bella evidenza sul menu affisso alla porta vetrata: 45, come gli euro che mi costerebbe quel pranzo, e così non ho nemmeno il bisogno di decidere di accontentarmi di una perlustrazione da fuori, che quantomeno mi dà la soddisfazione di indovinare una foto di Montalbán su una parete, forse a ridosso del tavolo di Casa Leopoldo dove deve aver mangiato molte volte, lui come Carvalho.
 Quando sarò a cena, e cioè adesso che ho buttato giù l’ultimo sorso di questo vino tinto eccellente che nel mio stomaco già fa a cazzotti con la clarita e di cui purtroppo la mia memoria smarrirà il nome, non avrò più il tempo di riflettere sulla mia goffa traversata del Raval, perché ci sarà da individuare commensali di pregio che diano senso alla mia presenza così velleitaria, così azzardata. E naturalmente è stupido, è scemo, scegliere un compagno di cena tra decine di sconosciuti sarebbe ancora più velleitario e goffo, ma ho la fortuna di incrociare lo sguardo di un biondo capelluto e appena barbuto che sorride e si presenta, e parla italiano anche se si chiama Andrei e vive nel Vermont anche se è russo, e domani terrà una relazione sul rapporto tra Montalbán e la Grecia, il che mi suggerisce di avere a che fare con un uomo con molti tasselli fuori posto, e di farmelo sedere accanto perché mi spieghi come poterli mettere insieme con un’idea di senso anche solo approssimativa.
Quando sarò a cena, e cioè adesso che ho buttato giù l’ultimo sorso di questo vino tinto eccellente che nel mio stomaco già fa a cazzotti con la clarita e di cui purtroppo la mia memoria smarrirà il nome, non avrò più il tempo di riflettere sulla mia goffa traversata del Raval, perché ci sarà da individuare commensali di pregio che diano senso alla mia presenza così velleitaria, così azzardata. E naturalmente è stupido, è scemo, scegliere un compagno di cena tra decine di sconosciuti sarebbe ancora più velleitario e goffo, ma ho la fortuna di incrociare lo sguardo di un biondo capelluto e appena barbuto che sorride e si presenta, e parla italiano anche se si chiama Andrei e vive nel Vermont anche se è russo, e domani terrà una relazione sul rapporto tra Montalbán e la Grecia, il che mi suggerisce di avere a che fare con un uomo con molti tasselli fuori posto, e di farmelo sedere accanto perché mi spieghi come poterli mettere insieme con un’idea di senso anche solo approssimativa.
Domani arriverò in ritardo alla sua conferenza, ma questo non lo posso sapere ancora, tardi per non aver ritrovato in tempo, nella corsa continua di questi tre giorni barcellonesi, una delle tante sedi dell’università che si presta al congresso, la Pompeu Fabra, gloria della Generalitat, tardi ma non così tanto da non poter ascoltare il finire dei suoi ragionamenti, che adesso, tra i risi e il vino, mi anticiperà solo fino a un certo punto. Poi ci sarà un messicano pingue emigrato in Andalusia che parlerà di Carvalho e il Messico, anzi di Carvalho e del detective Filiberto García e di Rafael Bernal, gente che io non conoscevo, mi confesso, poi ci sarà una tavola rotonda sul giornalismo con pezzi da novanta che conoscevo appena, due dei quali, per un caso che non voglio sminuire troppo, addirittura compaiono nel libro che tradurrò da qui a Natale, Spagna magica che gioca con me e mi fa un po’ trasalire.
Mentre il mio riso, o forse la mia paella, tarda ad arrivare, non so che ascoltando quella gente e i loro racconti su Montalbán e il passato e il futuro della professione non sbadiglierò nemmeno una volta, come invece ormai faccio sempre da quindici anni, a volte ininterrottamente, quando mi siedo tra un pubblico chiamato ad ascoltare un qualsiasi oratore. Sentirò i loro dubbi e le loro idee sul giornalismo di domani, esposti in maniera così genuina e in fondo grossolana di fronte a una ventina di persone chiuse tra le quattro mura di una piccola aula della sede di Poble Nou della Pompeu Fabra, e inevitabilmente penserò ai panel e agli incontri super-referenziati del Festival del Giornalismo che ogni primavera viene ospitato dalla città in cui vivo, senza sapere che proprio in quelle ore starà divampando una polemica devastante sul suo, di futuro, non del giornalismo ma del festival. E avrò persino la presunzione di percepirlo migliore, questo sparuto consesso spagnolo, per gli sbadigli che non mi ha indotto e per il gusto del buon senso dell’esperienza, e dopo un bocadillo al maiale lungo una delle vie che portano verso il mare, mi siederò più o meno nello stesso posto di prima ad ascoltare un americano che ha scritto un libro sul calcio spagnolo e sui suoi conti in sospeso con la letteratura e il cinema e un catalano che riassume scientificamente e con qualche forzatura filo-indipendentista l’opera di Vázquez Montalbán dedicata allo sport.
Sarà la fine del congresso, per me, ma non sarà per quello che sarà valsa la pena di essere venuto a Barcellona. Quello capita già adesso, a cena, al ristorante Allium, lontano dal Raval e dal Poble Nou, cogli organizzatori del congresso seduti a un tavolo nella saletta di là e io seduto in mezzo a quindici, forse venti italiani più Andrei, né vecchio né giovane com’è, grossomodo come me. Davanti a noi una giovane donna che lavora per le edizioni di Slow Food e un vecchio cuoco toscano che ci fa lezione e ci ascolta, meraviglia tra commensali che succede di rado: la settimana scorsa ha cucinato per la moglie di Manuel Vázquez Montalbán nel suo locale ricavato in un vecchio borgo diroccato del basso Appennino aretino rimesso a nuovo un quarto di secolo fa bell’e apposta, per una serata organizzata come questa proprio da Slow Food, e adesso si fa la gita a Barcellona in compagnia. Staremo insieme fino a una ventina di minuti prima che cominci il giorno in cui Montalbán sarà morto da dieci anni esatti, ma nessuno ha il bisogno di rimarcarlo, mai, Mauro ci racconta del ristorante e del suo cucinare, dei suoi viaggi a San Pietroburgo e dei russi che parlavano napoletano, del Pci e delle tasse che ormai ammazzano l’impresa, del suo allievo giapponese che ha aperto a Kyoto riproducendo i suoi piatti e adesso, con il fisco che gli piglia solo il 10%, è uno dei più apprezzati del Sol Levante.
Mauro parla e beve e mangia, Andrei parla ridendo, a volte ridendo persino troppo, e quando si tratta di discutere di cibo questi due qua davanti, Mauro e la tipa di Slow Food, recitano un teatro che io afferro appena e che per forza mi affascina, abbiamo tutti fame e abbiamo tutti sete, più di quanto a giudicare dal poco che ci riempirà piatti e bicchieri ci converrebbe avere. Poi le righe si sciolgono, in strada, in pochi attimi una chiacchiera confonde più del dovuto e c’è chi è andato via e chi se ne sta andando, e prima di mezzanotte io sono già sulla Rambla, senza più sentimenti per la Barcellona che avevo così forsennatamente amato undici anni fa e senza troppi sentimenti, devo ammettere, per l’uomo di cui sono venuto a cercare le impronte e le ombre in quest’altra Barcellona che mi ritrovo a percorrere adesso. Forse è il cuore che si indurisce, forse è il tempo che prosciuga, ma sono i sensi e il cervello a godersi la felicità di essere qui, il riso, il vino, i racconti, quelle due ore di giro del mondo tra San Pietroburgo e il Vermont passando per la Grecia e il Giappone, e la Toscana.
Manuel Vázquez Montalbán è morto troppo giovane, come tutti, dieci anni fa, e io in questo momento sento più di ogni altra cosa la stanchezza e il riempimento di mezza giornata trascorsa muovendomi, sempre, così lontano dalle parole lette e da scrivere, così lontano dai giorni di tutti i giorni. Mi aspetta un letto che è un divano, in una casa sconosciuta, penso al sonno e al wi-fi di Bea e David che mi consentirà di riallacciare i contatti col mondo là fuori, con la donna che presto sarà mia moglie e con le immagini già vecchie dei giochi di oggi di mio figlio. Domani il congresso, altri viaggi e altre stanchezze, e poi niente ristoranti, basta Raval, ho deciso, Manolo è morto e ha scritto così tanto, ascoltare i discorsi dei relatori russi e messicani e americani e catalani, ascoltare i ricordi di Forges e di Enric González, andrà tutto benissimo, sarà sufficiente, varrà la pena, certo, è chiaro, lampante, sicuro. Con tutto quel che c’è da vedere, e da mangiare, e da bere, con tutte le parole che impara mio figlio, ogni giorno una nuova, macché una, cinque, dieci, di più, con tutto quel che può capitare mettendosi a cercare tracce di uomini, senza poterselo figurare, senza poterlo anche solo immaginare, più che altro rimpiango che Vázquez Montalbán non mi sia mai venuto a bussare alla porta, undici anni fa, quando ero giovane e passavo il mio tempo a Barcellona, per portarmi a mangiare a Casa Leopoldo e raccontarmi qualcosa, qualcosa che avesse a che fare col calcio o con la politica o con la letteratura, certo, o con l’amore, o con qualcuna delle altre innumerevoli maniere di esorcizzare la morte in cui tutti gli uomini sono chiamati a esercitarsi più o meno ogni giorno e ogni ora e ogni minuto delle loro faticose esistenze necessarie. Avrebbe pagato lui, naturalmente. Io ero solo un ragazzo, e avrei mangiato e ascoltato di gusto dall’inizio alla fine.




 Quando sarò a cena, e cioè adesso che ho buttato giù l’ultimo sorso di questo vino tinto eccellente che nel mio stomaco già fa a cazzotti con la clarita e di cui purtroppo la mia memoria smarrirà il nome, non avrò più il tempo di riflettere sulla mia goffa traversata del Raval, perché ci sarà da individuare commensali di pregio che diano senso alla mia presenza così velleitaria, così azzardata. E naturalmente è stupido, è scemo, scegliere un compagno di cena tra decine di sconosciuti sarebbe ancora più velleitario e goffo, ma ho la fortuna di incrociare lo sguardo di un biondo capelluto e appena barbuto che sorride e si presenta, e parla italiano anche se si chiama Andrei e vive nel Vermont anche se è russo, e domani terrà una relazione sul rapporto tra Montalbán e la Grecia, il che mi suggerisce di avere a che fare con un uomo con molti tasselli fuori posto, e di farmelo sedere accanto perché mi spieghi come poterli mettere insieme con un’idea di senso anche solo approssimativa.
Quando sarò a cena, e cioè adesso che ho buttato giù l’ultimo sorso di questo vino tinto eccellente che nel mio stomaco già fa a cazzotti con la clarita e di cui purtroppo la mia memoria smarrirà il nome, non avrò più il tempo di riflettere sulla mia goffa traversata del Raval, perché ci sarà da individuare commensali di pregio che diano senso alla mia presenza così velleitaria, così azzardata. E naturalmente è stupido, è scemo, scegliere un compagno di cena tra decine di sconosciuti sarebbe ancora più velleitario e goffo, ma ho la fortuna di incrociare lo sguardo di un biondo capelluto e appena barbuto che sorride e si presenta, e parla italiano anche se si chiama Andrei e vive nel Vermont anche se è russo, e domani terrà una relazione sul rapporto tra Montalbán e la Grecia, il che mi suggerisce di avere a che fare con un uomo con molti tasselli fuori posto, e di farmelo sedere accanto perché mi spieghi come poterli mettere insieme con un’idea di senso anche solo approssimativa.



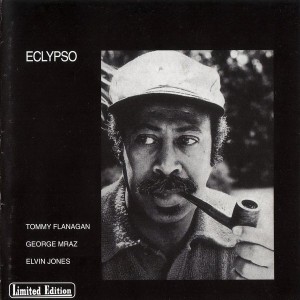
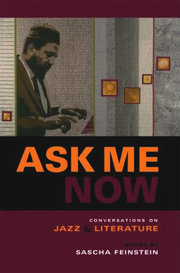
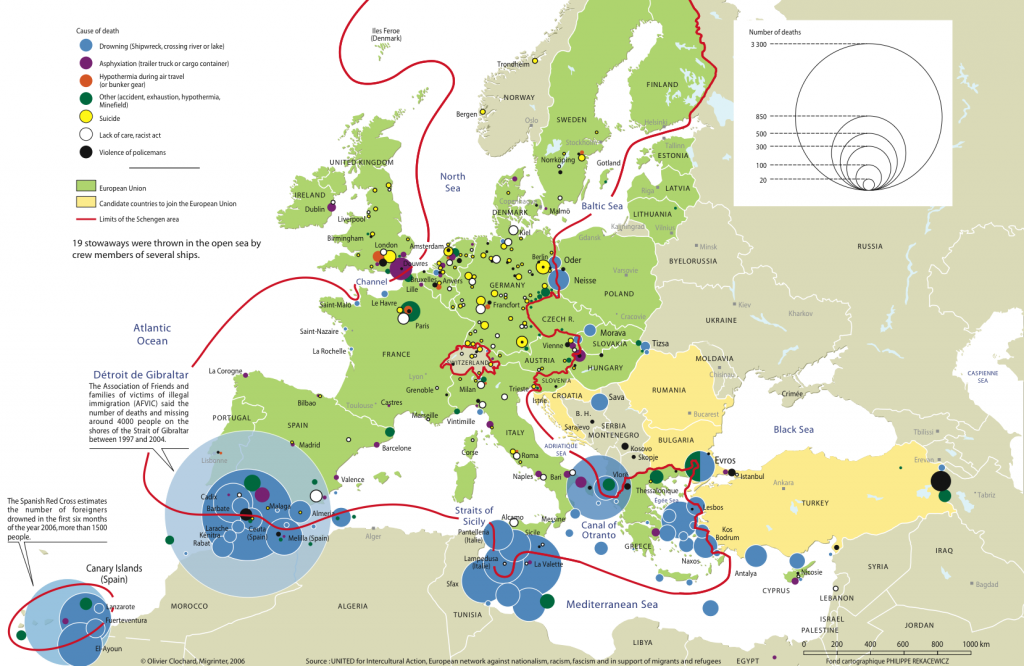





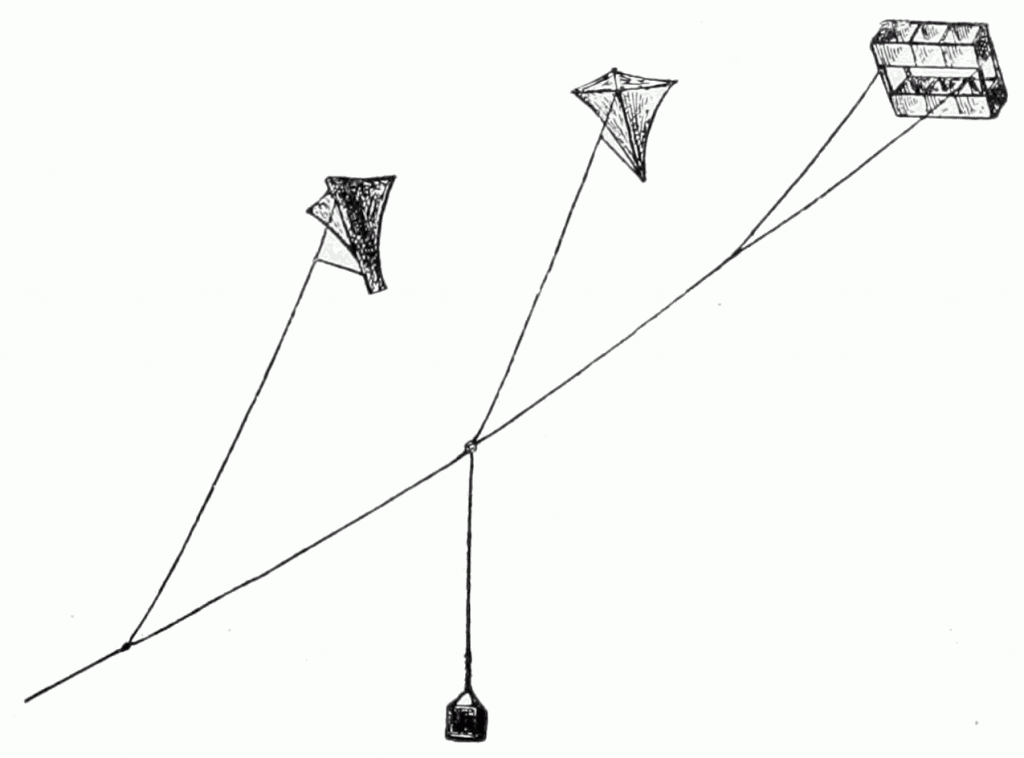
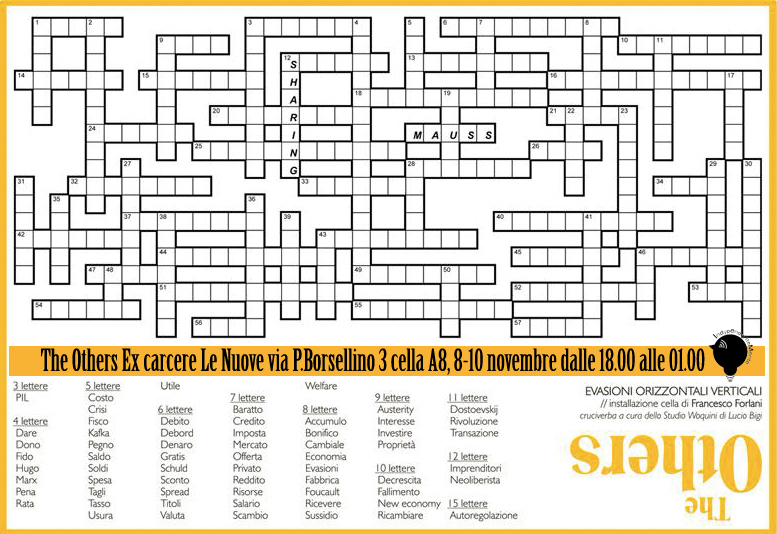
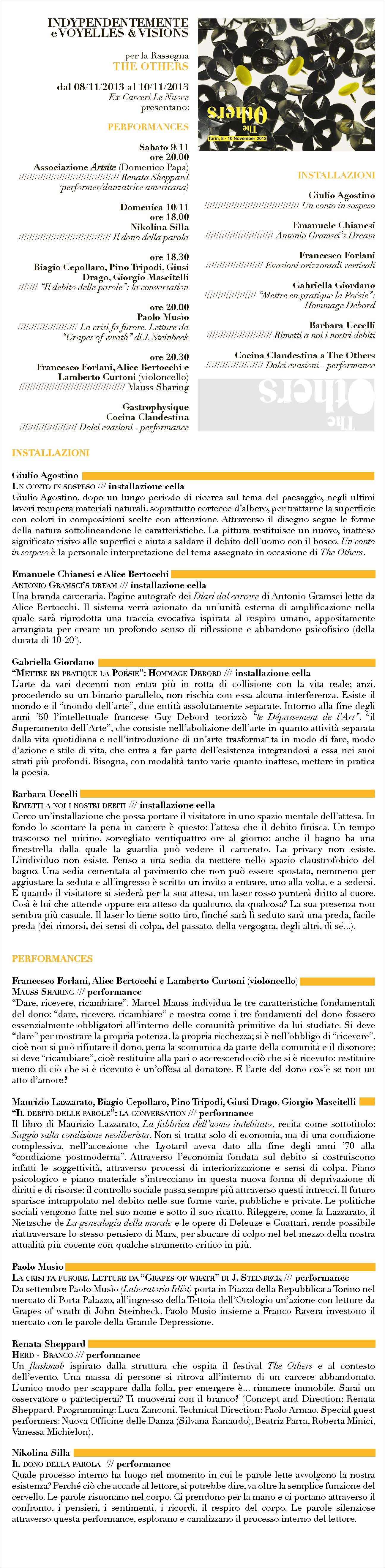


 Il Centro Studi Primo Levi (
Il Centro Studi Primo Levi (