
di Gianni Biondillo
(ero in Piazza Macao il giorno dello sgombero. Ho scritto una cosa, “all’impronta”, che solo ora riesco a pubblicare)
“Sei stato a Macao?” mi chiede via skype Marco Rovelli e io non capisco la domanda. Vengo a conoscenza così dell’occupazione della torre Galfa, gioiello dell’International Style meneghino tanto amato da Gio Ponti. Ma quelli erano gli anni Cinquanta e bastava Melochiorre Bega per farsi ammirare dal mondo, senza bisogno di chiamare archistar irachene o giapponesi per rifare il trucco alla città. Ho passato, per lavoro, buona parte della scorsa settimana fuori Milano. “Ci vado appena posso”, ho risposto, convinto che l’occupazione sarebbe durata più a lungo. Non per romantico spirito ribellista, ma per ingenua convinzione che l’inerzia avrebbe sopraffatto tutto, come al solito. In fondo il grattacielo è rimasto vuoto per quindici anni, a pochi passi da un ganglio urbano in piena trasformazione. Un vuoto sordo, incomprensibile. Che artisti, musicisti, designer, scrittori, avessero deciso di trasformarlo in un luogo vero, pieno di contenuti condivisi con la cittadinanza mi sembrava una cosa importante, oggi, in un tempo del quale persino il Ministro della Cultura sembra un desaparecido (qualcuno di voi sa cosa sta facendo? Ha notizie dal Ministero? Com’è che inizio a provare una nostalgia indicibile per Bondi?).
Come al solito la sinistra meneghina non ha capito niente. Il capogruppo PD al Comune, Carmela Rozza, innervosita, ha trattato gli occupanti come dei perdigiorno radical chic. I “cosiddetti creativi”, così li ha apostrofati, vadano a Quarto Oggiaro, ché lì c’è bisogno di cultura. Eppure Rozza, per la sua storia personale, dovrebbe sapere che in quel quartiere già molta gente lavora sul territorio, organizza eventi, invita scrittori. C’è Vill@perta, Quarto Posto, Il Baluardo… Associazioni che fanno tutto – e tanto – nell’indifferenza dei media e, sospetto, della politica. Occupare la Torre Galfa – il “torracchione” che, nella Vita Agra di Lizzani, Ugo Tognazzi vuol far saltare in aria -, trasformarla in un “Temporary Cultural Center”, dopo tanti inutili “Temporary Shop”, è un gesto oculato, intelligente, fortemente mediatico. Significa, in breve, che la democrazia partecipata, quella che ha portato a Palazzo Marino questa giunta, vuole fare di un simbolo del capitale finanziario un luogo di cultura popolare.
Perché questi che sono stati sgomberati stamattina non sono ragazzi capricciosi, finiamola con la retorica paternalistica dello Stato forte ma giusto. Li vedo, ora che li ho raggiunti in bicicletta, mentre occupano la strada, trasformata in una forzosa piazza pedonale. Ci sono studenti universitari, designer, artisti, musicisti, scrittori. Non c’è la cupa e passatista atmosfera da centro sociale – “poche birre, niente cani”, m’è stato detto, per gioco -, sembra più un vernissage, un Fuori Salone. Questi con cui parlo sono persone che vorrebbero e dovrebbero vivere di cultura ma non ce la fanno, perché mai come in questi anni l’unico talento che potrebbe farci uscire dalla crisi, il loro, viene continuamente represso. Sono la classe creativa, gli intellettuali, gli artisti, che nel resto d’Europa avrebbero già spazi dove esprimere le loro idee innovative, senza doverli rubare ad un capitalismo indifferente alle novità. Sapevano benissimo di aver forzato la mano, sapevano benissimo che li avrebbero sgomberati. Sono usciti senza opporre resistenza.
Guardo i pochi poliziotti e finanzieri in assetto da battaglia, che presidiano l’ingresso, sbadigliando sotto il sole. Nessuno li considera, tutti presi come sono a inventarsi altre forme di lotta creativa. Mi dispiace davvero di non aver visto i concerti gratuiti, le letture, i dibattiti dentro la torre, assieme a loro. Di non aver goduto del panorama agli ultimi piani. Ho perso un’occasione, penso. Ma, quel che è peggio, è che forse anche la politica ha perso la sua, di occasione. Speriamo sappia recuperare al più presto questo inespresso desiderio di dignità e di gioia collettiva. Conviene.

 di Luca Ricci
di Luca Ricci





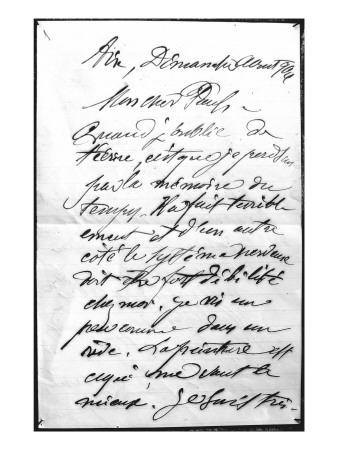
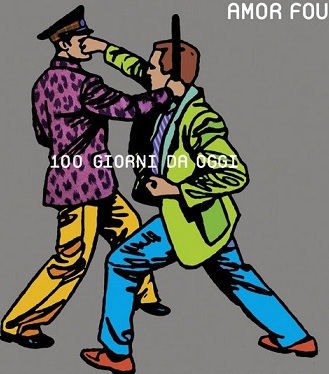 di Gianluca Veltri
di Gianluca Veltri
