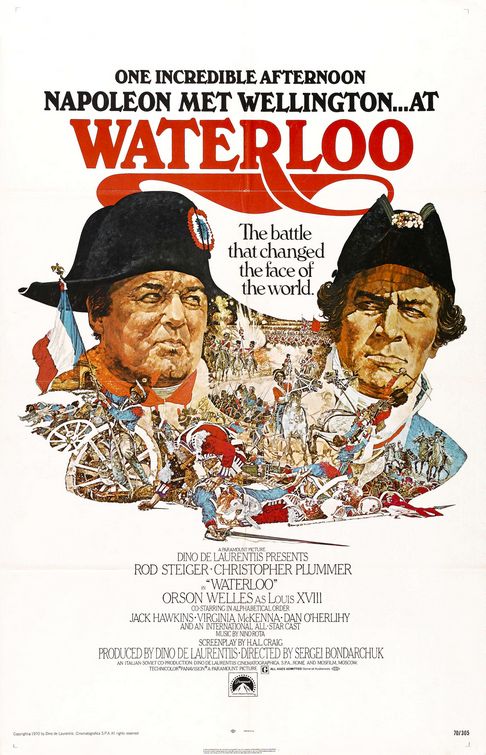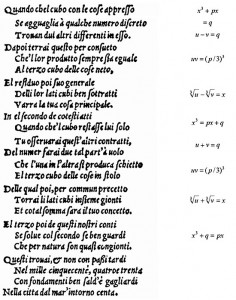di Franco Buffoni
G. M. Hopkins (1844-1889) oggi si staglia ai vertici poetici della letteratura inglese del secondo Ottocento, ma occorsero decenni perché il suo genio venisse riconosciuto. Basti pensare che la prima edizione parziale della sua opera – apparsa in 750 copie solo nel 1918 – impiegò dieci anni ad andare esaurita. (E va dato atto a Benedetto Croce di essere stato tra i primi in Europa a riconoscere il valore di Hopkins sulla rivista “Critica” nel 1937). Incrollabile nella fede cristiana, tolemaico nella visione cosmogonica, Hopkins entra a ventiquattro anni nella Compagnia di Gesù, distruggendo quasi tutte le poesie fino ad allora composte e giurando a se stesso – come Gerard – di non più scriverne. Il secondo nome – Manley – era il nome del padre, e Hopkins spesso fece mostra di esserselo scordato, forse per una questione di omofonia con l’aggettivo manly (virile) che non prediligeva per sé. Studente al Balliol di Oxford, teneva un diario in cui elencava anche i peccati commessi, con abbreviazioni (O.H. – Old Habits, vecchie abitudini: “Ho guardato un corista al Magdalen”).