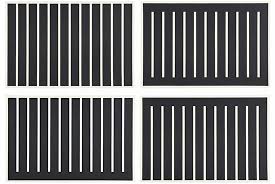 di Ron Silliman
di Ron Silliman
traduzione di Massimiliano Manganelli
(Presentiamo un estratto del volume bilingue inglese-italiano, The Chinese Notebook / Il quaderno cinese, uscito per Benway Series, [1986] 2019.)
.
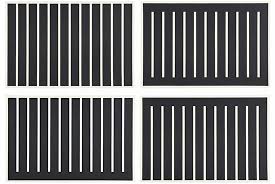 di Ron Silliman
di Ron Silliman
traduzione di Massimiliano Manganelli
(Presentiamo un estratto del volume bilingue inglese-italiano, The Chinese Notebook / Il quaderno cinese, uscito per Benway Series, [1986] 2019.)
.
Note da I Neoplatonici di Luigi Settembrini (Mimesis, 2019)
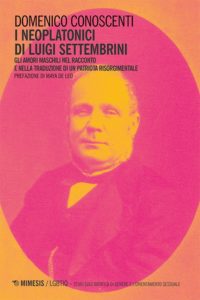
III. b. Una singolare fiaba di formazione
I Neoplatonici non è soltanto una liberatoria favola erotica intessuta di malizie e di ammicchi: la trama è visibilmente organizzata in tre blocchi narrativi che scandiscono per i protagonisti un originale percorso di educazione sentimentale. Il primo blocco (capitoli 1-2) mostra la nascita della relazione fra Doro e Callicle e prosegue con la riflessione sull’amore platonico che essi compiono e mettono in pratica insieme al filosofo Codro; nel secondo (capitoli 3-5) vengono raccontati gli incontri dei protagonisti con Innide e le considerazioni sulla scoperta del rapporto con la donna; infine nel terzo blocco (capitoli 6-8), Callicle si innamora di Psiche, dopo un episodio guerresco, che vede coinvolti entrambi i protagonisti, Doro si innamora di Ioessa, e con queste fanciulle i due convolano a felici e feconde nozze, senza peraltro smettere di amarsi.
Attraverso questa articolazione il «racconto osceno sino a la metà» può integrare la metà restante, lasciata nell’Avvertenza priva di qualunque connotazione, riceverne e darle senso, svelarne la coerenza e la finalità interne. Le modalità, la forma propria di questo percorso di formazione vengono determinate dalla cultura di quella “antica Atene”, all’interno della quale esso è collocato e di cui Settembrini ha una conoscenza non superficiale, che gestisce però da artista, in modo da trarne – anziché un verosimile racconto “storico” – una fiaba o, ancora meglio, una parabola di formazione.
Capitoli 1-2. Aperto favolisticamente ab ovo con le origini dei genitori dei protagonisti, il primo capitolo mostra Doro e Callicle legati fin da bambini di un affetto che li porta a condividere qualunque esperienza fino a quando capiscono che il sentimento e la confidenza fisica che li uniscono da sempre si sono trasformati in amore:
Erano già efebi, e già sentivano quell’interno rimescolamento quell’angoscia che è il primo segno la prima voce di amore. E Doro disse: Io sento, o Callicle, che t’amo con un nuovo ardore, e maggiore di quello che ho sentito sinora. E credo sia quell’amore che secondo il divino Platone, gli Dei mettono nel petto soltanto dei savi, quell’amore che nutrisce la sapienza e la purifica, che unisce e rende prodi i giovani guerrieri. Sì, o Doro, disse Callicle: io non amo che te, e più forte di prima, e credo che sia nato in noi questo amore platonico. Godiamone ora che ne è tempo. [APP, p. 187]
La consapevolezza non si tinge, modernamente, di inquietudine, di tormento, di vergogna per il sesso dell’oggetto d’amore: nel sentimento appena scoperto i protagonisti ravvisano i tratti di quell’amore di cui ha parlato Platone (che coinvolge i savi, cioè i filosofi, e i giovani guerrieri) e che è positivamente riconosciuto dalla cultura della polis. Se il collegamento pederastia-filosofia si affaccia in alcuni luoghi di Luciano di Samosata, in modo particolare negli Amori (per quanto condotto sul filo ambiguo della castità),[1] non si riscontra nella sua opera alcun accostamento tra omosessualità e virtù guerriere, se non implicitamente per qualche generico cenno alla coppia Achille-Patroclo.
L’esortazione di Callicle a vivere insieme e consapevolmente l’amore appena scoperto non ha l’urgenza che risuona nel rapporto pederastico, ammissibile per l’amato solo nell’arco adolescenziale, prima che giunga a compimento lo sviluppo fisico e sessuale. La prima voce del loro amore si fa sentire infatti a diciotto anni, con l’ingresso nell’efebia,[2] che ad Atene sanciva, col compimento dei vent’anni, il passaggio al mondo degli adulti. Trovata la maniera in cui esplicitarlo anche sessualmente, «l’amore dei due giovani non ebbe più smanie né angosce», chiudendo il momento in cui avevano sentito per la prima volta «quell’angoscia che è il primo segno, la prima voce di amore». Da allora, la relazione fra Doro e Callicle, più che semplicemente inserirsi nella quotidianità della vita a scuola, a casa, con i vicini… rafforza e rende più serena, positiva, sennata la loro partecipazione agli impegni quotidiani, alle mansioni e ai doveri richiesti dal loro ruolo sociale. Appare qui la prima eco platonica indipendente dalla mediazione di Luciano, un ricordo del mito raccontato da Aristofane nel Simposio: dopo aver tagliato in due gli esseri sferici, Giove trasferisce i loro genitali sul davanti affinché, se si fossero incontrate le metà maschio-femmina, esse perpetuassero la discendenza umana, «se invece si fossero trovati insieme un maschio con un maschio, ne venisse almeno sazietà dallo stare insieme e smettessero e si volgessero al lavoro e si curassero del resto della vita».[3]
La reciprocità del diletto viene a ragione ribadita dopo che ha iniziato a includere la penetrazione, sempre replicata a ruoli inversi già dalla prima volta: «E così vivevano pigliandosi diletto con temperanza, e tanto ne pigliava l’uno quanto l’altro, una volta per uno in ogni cosa e sempre, come vuole giustizia ed amore» [APP, p. 189]. Che giustizia ed amore, dittologia ripetuta in chiusura di capitolo, sia da intendere nel senso dell’assoluta eguaglianza[4] e reciprocità affettivo-sessuale è evidente; temperanza, l’altra parola chiave, verrà ripresa dal filosofo Codro, in contrapposizione alle caratteristiche del rapporto con la donna.
È possibile cogliere in questo primo capitolo uno scarto fondamentale nell’amore platonico di Doro e Callicle rispetto al modello che emerge nei testi di Luciano, perché il rapporto fra i due comincia quando di solito, per l’amato, terminava il rapporto pederastico, cioè con la fine dell’adolescenza (attorno ai diciassette-diciotto anni).[5] Si ricordi infatti negli Amori l’osservazione di Caricle, paladino degli amori “eterosessuali” e detrattore di quelli “omosessuali”:
Ma se uno tenta un giovanotto di vent’anni, parmi che ei cerchi piuttosto di esser picchiato [= sodomizzato] egli. Chè a quell’età le membra sono già dure e fatte, le gote non più morbide ma aspre e folte di barba, le cosce vigorose sono ispide e brutte di peli, le altre parti nascose le lascio a voi che le conoscete. [LUC, II, p. 237]
Siamo al di fuori della concezione pederastica anche perché l’uguaglianza anagrafica tra amante e amato è strettamente correlata, come si è visto, alla più sconvolgente uguaglianza dei ruoli all’interno del rapporto sessuale.[6]
Il narratore, già intervenuto nel ruolo del testimone nella parte inziale, si inserisce in prima persona anche nel finale:
Ed io credo che se gli Dei immortali riguardano a le cose che fanno gli uomini, hanno dovuto compiacersi a mirare questa bellissima, e forse sentire invidia di due fiorenti giovanetti che tanto si amano fra loro, e godono secondo giustizia e amore. [APP, p. 189]
Il compiacimento degli Dei riprende il cenno contenuto nella “confessione” di Doro, in base al quale l’amore platonico è ispirato dalle divinità. L’intervento della voce narrante ribadisce la legittimità di quell’amore, visto con favore dagli Dei, forse pure invidiosi di tale sentimento goduto secondo giustizia e amore (la reciprocanza). Doro e Callicle stanno sperimentando qualcosa di sconosciuto perfino all’esperienza divina: gli esempi di Giove e Ganimede e di Apollo e Jacinto, ricordati da Settembrini nel Discorso premesso alla traduzione di Luciano, rinviano infatti al modello pederastico, asimmetrico e perciò privo di giustizia.
[1] Cfr. LUC, II, pp. 236-37, 241 e 249.
[2] L’efebia era una sorta di addestramento militare istituzionalizzato (che includeva anche un’educazione letteraria e musicale) della durata di due anni, al termine dei quali i giovani acquisivano la piena cittadinanza.
[3] Cfr. Platone, Simposio. Testo a fronte. Traduzione e commento di M. Nucci. Introduzione di B. Centrone, Einaudi, Torino 2009, p. 85.
[4] Cfr. anche Di non credere facilmente alla dinunzia: «Nessuno può negare che la giustizia consiste nell’eguaglianza in ogni cosa, e nel niente di soverchio, e la ingiustizia nella disuguaglianza e soverchianza», LUC, III, p. 109.
[5] E. Cantarella, op. cit., pp. 58-65 sostiene che l’età per essere eromenos andava solitamente dai dodici ai diciassette-diciotto anni, appunto; sull’estensione di tali limiti cfr. anche G. Dall’Orto, Tutta un’altra storia, cit., pp. 60-63.
[6] Cfr. K. J. Dover, op. cit., p. 91: «si poteva essere erastés ed erómenos nello stesso momento, ma non era possibile essere l’uno e l’altro nei confronti della stessa persona». E. Cantarella, op. cit., p. 70, ritiene che il discredito nel caso di rapporti omosessuali fra adulti, non fosse globale: «Ricalcando il modello della coppia pederastica, quella composta da due adulti prevedeva che uno solo dei due assumesse il ruolo dell’amato: e in questo stava, appunto, il problema sociale e morale che determinava tensioni, contraddizioni, ambiguità, e non poca ipocrisia. Uno solo dei due violava formalmente le regole. E la società greca rispondeva a questa constatazione applicando i tipici criteri di una “doppia morale”. Uno solo dei due era il vizioso, l’indegno, quello da ridicolizzare: quello che, per lo più, veniva definito katapygōn».

di Gianni Biondillo
Fernando Aramburu, Patria, Guanda editore, 2017, 632 pagine, traduzione di Bruno Arpaia
Straordinario successo editoriale in Spagna, Patria sembra oggi un libro imprescindibile e necessario per ragionare attorno a temi quanto mai contemporanei quali le piccole patrie, i nazionalismi, l’identità di un popolo, la lotta armata, la ricerca della verità e il perdono. La forza di Fernando Aramburu sta nel farlo evitando gli storicismi didascalici e affidandosi a un romanzo fiume, poderoso, colmo di una pletora di personaggi, tutti descritti minuziosamente, con pregi e difetti, manie, ossessioni, debolezze, umanità.
Tutto è raccontato dal punto di vista parziale di un piccolo paese basco, inseguendo la vita di due famiglie, dapprima intimamente legate da una amicizia naturale e poi sempre più divise da una scelta di campo. Con o contro. Gli anni sono quelli fra i Settanta e gli Ottanta, ma il calendario del romanzo mischia la cronologie, ci presenta i protagonisti oggi, li ripropone ieri, confonde le acque chiedendo al lettore un impegno ulteriore di ricomposizione delle ragioni degli uni o degli altri.
Svettano le figure due donne: Bittori, alla quale il terrorismo basco ha ucciso il marito, e Miren, madre del presunto omicida dapprima in clandestinità, ora in carcere. Amiche e, nel tempo, nemiche per difesa familiare prima ancora che ideologica. Più deboli, non come personaggi ma come persone, i mariti, Joxian e Txaco. Paesani amanti della bicicletta, della compagnia, lavoratori, uguali in tutto. Ma fragili e incapaci di capire davvero l’avvicinarsi della tragedia. Txaco verrà incomprensibilmente giustiziato, Joxian lo piangerà di nascosto dalla moglie, ormai completamente dalla parte del figlio. Altre bellissime figure familiari di contorno definiscono il quadro di questa epica contemporanea, scritta con una voce inimitabile, capace di definire uno stile narrativo nuovo e riconoscibile.
(precedentemente pubblicato su Cooperazione numero 41 del 10 ottobre 2017)

Delitto perfetto
di Sophie Royère
Nick Cave & The Bad Seeds, Henry Lee -> play
___

___
Da “Il signor Castità”, intervista ad Alfred Hitchcock, in Oriana Fallaci, Gli antipatici, Milano, BUR, 2010
Fallaci : […] malgrado la sua aria di buon uomo innocuo, a far questi film si diverte anche lei.
Hitchcock : Non lo nego. Lo ammetto. Niente mi esalta come immaginare un delitto. Quando scrivo un soggetto e arrivo al delitto, penso felice: non sarebbe bello farlo morire così? E poi penso, ancor più felice: a questo punto, la gente urlerà. Dev’essere perché ho studiato tre anni coi gesuiti. Mi spaventavano a morte, con tutto, ed ora mi vendico spaventando gli altri. E poi dev’essere perché sono inglese. Gli inglesi hanno molta fantasia per i crimini, molto rispetto. Gli inglesi hanno i delitti più divertenti della terra. Mi ricordo quell’adorabile processo contro quell’adorabile Christie, un necrofilo che aveva ucciso otto donne. Sull’ottava vittima si svolse tra giudice e imputato il seguente dialogo : “Dunque lei scaraventò la donna in cucina, signor Christie.” “Sì, Vostro Onore.” “Ci sono tre scalini per scendere in cucina.” “Sì, Vostro Onore.” “La poveretta cadde.” “Sì, Vostro Onore.”. “E lei la uccise.” “Sì, Vostro Onore.” “E abusò anche di lei ?” ” Credo di sì”, Vostro Onore.” “Prima, dopo, o durante la morte ?” “Durante, Vostro Onore.” Oh, l’Inghilterra è fantastica per queste cose. Peccato che non riescano mai ad occultare il cadavere. In America questo è molto più facile. Io suggerisco sempre lo scarico della spazzatura: che brucia tutto. Oppure mangiarlo: ma dev’essere tenero.”
___
[Mots-clés è una rubrica mensile a cura di Ornella Tajani. Ogni prima domenica del mese, Nazione Indiana pubblicherà un collage di un brano musicale + una fotografia o video (estratto di film, ecc.) + un breve testo in versi o in prosa, accomunati da una parola o da un’espressione chiave.
La rubrica è aperta ai contributi dei lettori di NI; coloro che volessero inviare proposte possono farlo scrivendo a: tajani@nazioneindiana.com. Tutti i materiali devono essere editi; non si accettano materiali inediti né opera dell’autore o dell’autrice proponenti.]

di
Lucio Saviani
Mercoledì 21agosto, a Roma, al Campidoglio, tanti amici si sono raccolti a salutare il grande Cosimo Cinieri nella Camera Ardente allestita nella Sala del Carroccio. Questo che segue è il mio discorso che ho letto per Cosimo.
——————————————————————————————————-
Oggi stiamo salutando un grande attore, un grande protagonista e testimone non solo della scena teatrale ma della cultura italiana degli ultimi cinquanta anni.
Ma noi stiamo anche ricordando la meraviglia, l’entusiasmo, la curiosità, l’ironia, il lampo, la dolcezza, l’empatia, l’intuizione, la filìa che Cosimo Cinieri dovunque andasse, in qualunque stanza entrasse, sempre portava con sé.
Con la sua signorilità d’animo, la sua raffinata e rispettosa sensibilità, oggi così tanto rara ovunque, che ogni volta tutti ci sentivamo addosso, e veniva dai suoi occhi e dalla sua voce.
Un grande attore lo si riconosce dal suo modo di uscire di scena. E insegna proprio questo, a tutti quelli che calcano le tavole e la scena del mondo.
Caro Cosimo, ti sarebbe piaciuto molto, ne sono sicuro. E’ un aneddoto che racconta di due uscite di scena. C’è il grande Socrate, che muore in catene ma libero, rinunciando al piano di fuga dei suoi discepoli: sopravvivere sarebbe stato un naufragare, e morire un continuare a essere stesso. E poi c’è Protagora, meno grande, che accusato di empietà sfugge al processo, scappa da Atene e muore in un naufragio.
Caro Cosimo, ti piacevano i naufragi, ma di un altro tipo. Dicevi che avresti voluto morire con un primo vagito.
Di naufragi tu hai parlato, cantato, raccontato, come nella tua grandiosa Ode marittima, o come nel nostro spettacolo su Nietzsche, con quella tua grande finale uscita di scena cantando la stessa canzone napoletana che il filosofo cantò uscendo di scena, nel suo naufragio torinese.
Cosimo, io ti sono così tanto grato, per la tua presenza così preziosa, così puntuale ai nostri seminari, alle lezioni, ai nostri dialoghi.
Per sempre ti sarò grato per il tuo affetto e la grande amicizia per me e per Ruzenka.
Ma, più di tutto, ti sarò grato per quell’ultima parola che, pochi giorni fa, ti sentii pronunciare mentre andavo via. Senza voltarmi, ti ho sentito dire: “Grazie”. Era a me? A Domenico Zampaglione, che era con me? A Irma, al pubblico, al mondo?…
Nel tuo navigare dolce, per le carezze di Irma, era ancora una volta la tua grande uscita di scena.
E io ora, caro Cosimo, sono qui, a nome di tutti noi, a dire a te, e per sempre: “Grazie”.
(Questo racconto ha una “peculiarità” tecnica, vediamo chi la indovina per primo.)
di Maddalena Fingerle
Io sono la ragazza con i piedi per terra
Racconto a Flavio del mio problema, ma lui non capisce e pensa che sia metaforico. Coglione, dai, sul serio, gli dico al telefono. Non ho capito, mi dice lui, hai i piedi per terra e la testa in cielo? Lo ripeto, ancora una volta: la testa va su, i piedi devono stare giù.
Giura che non mi stai prendendo in giro, Francesca.
Cazzo, fidati!
Ti ho sentito dire tante di quelle balle.
Le ho mai dette su una cosa così?
Sì, certo.
Tormentami, Flavio, tranquillo.
Lo mando a fanculo e gli butto giù il telefono. Non è mica uno scherzo, questo. Torno a casa, ma non riesco a entrarci. Ci vorrebbe un coltello per tagliare il collo che si allunga, si allunga e arriva in alto. Torno indietro e cammino lungo la strada. Da qualche parte potrò pur vivere, anche se la testa è finita quassù. Sudo e mi agito perché non ci avevo mica pensato che domani dovrò andare al lavoro. Romperò il soffitto, il capo mi licenzierà, i colleghi mi prenderanno in giro, se riuscirò anche solo a entrarci. Ci devo provare, almeno. Non riuscirò a dormire. Resto a fissare le nuvole mentre i piedi, per terra, rimangono ben saldi. Dico agli uccelli che a me non piace volare. Resta giù, allora. Ragazzi, che noia vivere così. Si sta male, potessi almeno scindere, staccare la testa e lasciarla qui, perché no? Non lo sopporto più, questo dolore al collo. Lo sento allungarsi e allungarsi e fa tanto tanto male. Lecco un po’ di cielo e non sa di niente. Te pareva! Vado in giro e sbatto contro un aereo, mi faccio un male allucinante. Temo seriamente di avere un trauma cranico e poi boh, ora sembrerò un mostro. Robe da matti. Ti puoi spostare? chiedo all’airone che non ha nessuna intenzione di spostarsi.
Siamo nella merda, mi dice.
Ce l’hai una sigaretta? gli chiedo.
Domani avrai poco da fare la spiritosa.
Sai qualcosa su domani?
Nietzschiana?
Naturalmente!
Te lo dico lo stesso.
So che dovrei avere paura.
Ragazza, ascoltami, domani avrai problemi al lavoro.
Rotture di coglioni?
Nietzschiana?
Naturalmente, ma ora basta chiedermelo!
Lo so, scusami.
Mi dici?
Ci devi fare attenzione, a questa cosa del cielo.
Lo so, lo so.
Soprattutto perché rischi di farti male.
Lentamente inizio a pensare che non sarebbe poi male.
Lentamente inizio a stufarmi di questa conversazione.
Nemmeno un saluto e l’airone se n’è già andato. Tocca a me capire come fare. Resto qui come una scema, appesa. Sai che non si fa così? Sì, mi risponde un corvo. Vorrei essere più gentile, ma mi scoccia da morire essere bloccata. Taglierò il collo. Lo farò, deciso.
Sono indiscreto se ti chiedo che fine ha fatto il resto?
Toccami e ti uccido.
Dovrei scomodarmi dalla nuvola.
La nuvola?
La nuvola.
Lasciami in pace.
Certo che sei antipatica.
Cazzo, che palle.
Le ragazze con i piedi per terra sono tutte uguali.
Litighiamo, ti assicuro che così litighiamo.
Morirei contro di te.
Terrorizzato!
Toccami e ti uccido.
Dovrei scomodarmi dalla terra.
Ragiona, dai: perché hai la testa quassù?
Suppongo sia perché i piedi sono laggiù.
Giuro che pensavo foste più intelligenti, voi ragazze con i piedi per terra.
Razionalmente non fa una piega, ma tu non sei disposto a capirmi.
Mi vado a fare una carbonara.
Ragiono da sola e penso che anche io vorrei mangiare. Resisto alla tentazione di infilare la testa dentro a una nuvola. La infilo, invece, ma non è emozionante come speravo. Vorrei tanto tornare con la testa giù, vivere come prima. Ma so che ormai non sarà più niente come prima. Magari riesco a capire il meccanismo. Morirei se non riuscissi a trovare la soluzione, se non riuscissi a decifrare un enigma. Mangio un po’ di aria e mi metto al lavoro. Ronfo dopo due secondi. Diamine, non ci posso credere, ho dormito in piedi come i cavalli! Li ho sempre odiati, i cavalli, animali stupidi. Dicono che siano intelligenti, ma io proprio non ci credo. Dopo un risveglio faticoso mi ricordo della mia situazione. Ne devo prendere atto. Tossisco e per un attimo penso di aver capito il meccanismo perché la testa scende un po’, ma poi si ferma. Magari ci riprovo. Voglio scendere con la testa e tornare bassa. Sai che noia, vivere così per sempre, sai che agitazione? Nemmeno voglio pensarci. Ci riprovo, ma rimango uguale. Le otto, sono in ritardo. Dopo quello che mi è successo posso permettermi anche qualche minuto di ritardo. Dovrò spiegare a tutti perché la testa è quassù e il corpo laggiù. Giurerò che farò di tutto pur di continuare a lavorare. Resto immobile davanti all’edificio. Io non ci entro, non c’è verso. So che potrei tagliare il collo. Lo voglio? Io non voglio, no, io non voglio. Io non sono così, non posso non lavorare, ma nemmeno vivere senza testa. Tagliare o non tagliare? Resto immobile, senza decidermi. Mi sforzo per urlare al mio collega che è appena sceso. So che non mi sente perché la mia testa è troppo in alto, ma continuo a strillare. Resta un po’, ascoltami. Mi senti? Ti volevo dire che ho un problema, cioè, capirai anche da solo. Lo urlo, ma quello non mi sente, finisce di fumare, spegne la sigaretta, entra. Raggiungo il bar di fronte e tossisco. Come mai non funziona? Naturalmente pensavo che almeno un pochino riuscissi ad abbassarmi. Mi sto innervosendo. Dovrei trovare un metodo per farmi sentire. Resto delusa e mi sto seriamente scocciando. Dolorosamente vedo che c’è il figlio del capo che mi guarda il collo e ride. Derisioni a quest’età, che merda. Dalla sua prospettiva devo essere una specie di gigante strano con il collo da giraffa.
Facciamo così, io ti permetto di prendermi in giro, tu però in cambio mi senti!
Ti sento, mi dice quel marmocchio.
Io non credevo…Vorresti aiutarmi?
Mi dispiace, non posso parlare con gli sconosciuti.
Ti pare che sia una sconosciuta?
Tanto, sì, non ti ho mai vista e sei strana.
Naturalmente lo sono, ho un problema.
Ma la testa ce l’hai, vero?
Rompicoglioni, sto marmocchio, penso. So che non posso dirlo. Lo dico.
Come, scusa?
Sai, è stancante stare con la testa quassù. Suppongo che ora non vorrai più aiutarmi.
Mica puoi insultarmi!
Mi dispiace.
Certo, come no.
Non sto scherzando, ascolta: puoi dire al tuo papà che sono qui fuori e lo aspetto per spiegargli la situazione?
Nemmeno per sogno!
Non faccio scene, cammino e mi immagino di parlare con Flavio, intravedo una fessura e ci infilo dentro la testa. Talvolta pensavo di averlo intuito, questo luogo qui, ma esiste davvero, è assurdo. Dovrà dipendere dal fatto che sono inclinata, mi metto dritta e no: è proprio tutto, tutto al contrario. Io non ci posso davvero credere! Resto così, un po’ rimbecillita. Tanto non lo sai, dico a Flavio.
Sonia Ciuffetelli
Sic et simpliciter
Sic et simpliciter. Dicunt. Il nesso stroppio
sguidato franto. Obnubilato. Recessit.
Polveri infisse su sampietrini spaccati.
Di lavori in corso.
Sbotta il rumore in centro storico infranto.
I silenzi in notturna ballano.
Ciuffi di rabbia diventano protesi inalienabili.
Indistruttibili.
Passi e ripassi. Osservi.
Percorsi dei venti in vicoli ciechi. Sbarre.
Affacciarsi sull’ultimo mondo
aspirare ultime inalazioni di cantiere.
Puzzo di ferro, cemento in pelle umana.
Alcol e sangue. Calici.
Oltre la barricata. Topi e vuoti.
Forfetarie speranze, incalzano.
Provvedono.
Baratti di parole per un allarme in meno.
O in più.
Fughe in fabula. Radice.
Leggendario
Fintanto canto un tanto che serve.
Pensate inutili. Expedit.
Formulari.
Baubauli ricchi di carogne in bau maggiore.
Cangrandi senza scala.
Osti senza vini. Formule forate.
Al mondo in cu. (B)rioso sguardo.
Foglie umane in forme di zerbini.
Vieni a vedere vieni questa follia silente.
Specchi. D’Italia italiota pluriporca.
Panni al vento. Lingua approssimata.
Cultura zero in con-dotta. Adotta,
addotta, adducente sciatte parole
e spira il vento dal Gran Sasso.
Sesso in marcia sessista. Cultura in cu minuscolo.
Scolo d’ideologie in vapore.
Amminìstrati tu, se ce la fai.
Ah no? Re sia! Ma sono contro la monarchia.
E con chi stai? Con la noia degli analfabeti.
Tardi e ritardi
Impianto senza espianto.
Dunque? Pensaci.
Illo tempore potevo imboccarti.
Vorrei ancora. Tanto.
Ma il passo è lungo, il respiro allenato.
Frutti facili in marcescenza, caduti.
Così dentro alle cose. Esco.
Scatto e ritorno. Dentro.
Insieme abbiamo costruito il
paese dei balocchi.
Un balocco mondiale.
Tardi per capire, carpire ora il segreto.
Sul greto del fiume troppo a lungo
ho pianto. Non si aspettava sull’argine il morto?
Sbagliare prospettiva. Essere fuori luogo.
Appanna uno scorcio definisce i tratti dell’immaginazione.
Dillo perché
Non soccombere. Bombe che non bombano.
Minati territori; da sorvolare. Volat.
Neppure la mafia ci viene più in questa landa.
Chi resta chi scappa. Chi si incarta.
Retorici passaggi, litanìe logore.
Solo perché. Dillo perché.
Perché il monte è duro e il paesaggio brullo.
Perché l’acqua è lontana e i pesci estinti,
l’aria tersa e il cielo perfetto
la gente sana e il ghiaccio impietoso.
A cosa serve la terra se è dura e fredda
se il gelo brucia il verde.
La neve, uno sfondo. In fondo.
Ai progetti. Che non decollano.
Ognuno la sua Itaca, ognuno la sua guerra.
E un silenzio che ogni tanto si spacca.
Fende. Muove, ma non troppo.
Si arrende. Si riallinea alle attese.
*
I quattro testi fanno parte della sezione “Lavori in corso” inclusa nella raccolta di Sonia Ciuffetelli La farfalla sul pube (Arcipelago Itaca 2018). Il riferimento è al terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009, anche se mentre leggevo, sbagliando, pensavo alla sequenza Amatrice-Norcia-Visso, di cui la fine dell’estate mi porta sempre gli echi; ma cosa non li porta, dopotutto, viste le macerie che ancora lì giacciono, il nastro segnaletico, le zone rosse, i divieti di ingresso, e il resto dei feticci degli eterni lavori. (rm)
di Alberto Cristofori
[Accolgo e pubblico volentieri il testo di Alberto Cristofori dedicato alle sue iniziative dantesche. In particolare il 14 e il 15 settembre avrà luogo la lettura integrale dell’Inferno in un centro culturale e sportivo di via Padova, alla periferia nord di Milano.B.C]
Il testo che segue è la rielaborazione di alcune osservazioni da me annotate alla bell’e meglio in vista della lettura-commento del I canto, nell’ambito della lettura-commento integrale della Commedia che ho iniziato in questo anno 2019 e che mi impegnerà fino al 2021 nella libreria milanese del Tempo ritrovato. Il progetto si intitola “Il lettore di Dante” perché muove dall’ipotesi che sia possibile leggere, e non solo studiare, il poema trecentesco, seguendo le strategie attraverso cui Dante definisce, nel testo, il proprio pubblico di riferimento, precisandone a poco a poco le caratteristiche fondamentali.
In un precedente articolo su questa rivista (qui il link) spiegavo le ragioni per cui mi sembra importante leggere e rileggere Dante, e riproporre la Commedia ogni volta che sia possibile: come simbolo di resistenza all’incultura mediatica e politica che si vorrebbe trionfante, e come occasione per riscoprire un metodo di lettura e di analisi del mondo che, a dispetto dei settecento anni che ci separano dall’esperienza di Dante, continua a rivelarsi utile e fecondo.
Il 14 e il 15 settembre, per gli stessi motivi, leggerò integralmente l’Inferno, senza commento, in un centro culturale e sportivo di via Padova, alla periferia nord di Milano. E in autunno conto di portare almeno qualche canto in un carcere della Lombardia. Spero che queste poche pagine diano un’idea delle riflessioni alla base di queste e di altre iniziative simili.
Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.
Che ai primi tre versi della Commedia si accompagnino, nella maggior parte delle edizioni in commercio, quasi due pagine di note, gonfie di citazioni dotte, dalla Bibbia al Convivio e all’Ottimo e al Boccaccio e giù giù fino al Sapegno, a me pare uno spauracchio, più che un aiuto, per il lettore, e forse anche un parziale tradimento del progetto dell’autore.
Il significato letterale della terzina, così come quello figurato, non necessita infatti di molte spiegazioni: il lettore comprende benissimo che Dante, autore e protagonista del poema, avendo smarrito “la diritta via”, si ri-trova (cioè trova di nuovo se stesso, riprende coscienza di sé, come risvegliandosi da un sogno: lo dirà subito dopo) nel mezzo di una selva oscura (anche le ragioni dell’oscurità, e quindi i suoi significati secondi, verranno spiegate nei prossimi versi).
Che la vita umana si possa paragonare a un arco, col punto culminante che coincide con il trentacinquesimo anno, non è un’idea originale di Dante, e lui stesso lo dichiara nel Convivio. Del resto, sapere che Dante compie il suo viaggio esattamente a 35 anni, ovvero nell’anno 1300, per il momento non è affatto essenziale: Dante stesso tornerà su queste informazioni quando ce ne sarà bisogno – per ora dobbiamo cogliere piuttosto che la vita di cui Dante parla non è la sua, ma la “nostra”, quella di tutti; e che il “mezzo del cammin” è il luogo in cui sempre ci troviamo, stretti come siamo fra passato e futuro.
La scommessa, se vogliamo leggere e non studiare il I canto dell’Inferno, è che la selva, la via, e poi il colle, il sole, le fiere, Virgilio, tutti gli elementi del racconto insomma, possano trovare spazio a poco a poco nella nostra immaginazione. Dico scommessa perché questi versi li abbiamo talmente nell’orecchio che non siamo più in grado di “leggerli”. Come non riusciamo più a “vedere” la Gioconda, o La creazione di Adamo nella Cappella Sistina, se non attraverso un percorso di riscoperta. L’eccesso di ripetizione ha svuotato di senso il testo, l’ha ridotto a cantilena, a rumore di fondo – le Quattro stagioni al supermercato. Come potevano suonare allora questi versi ai loro primi lettori, o meglio al lettore ideale a cui Dante intendeva rivolgersi?
Io credo che il lettore a cui Dante pensava dovesse rimanere colpito innanzitutto dal carattere narrativo di questo incipit: quando, dove, chi, cosa, perché – la prima strofa del poema contiene tutti gli elementi base della narrazione. (Possiamo ipotizzare che per questo motivo, fra gli altri, il progetto del Convivio sia fallito e sia stato abbandonato: perché, al contrario della Vita nuova e della Commedia, non era sorretto da un Grande Racconto.)
E nello stesso tempo quel lettore ideale vedeva deluse alcune delle sue attese, giacché Dante salta a piè pari ciò che di solito si trovava in limine ai poemi classici come ai romanzi contemporanei, cioè il prologo-argomento-invocazione, e lo getta, senza preamboli, nel mezzo di una storia. Argomento e invocazione arriveranno a breve, ma il lettore non lo sa, e la loro collocazione imprevista equivale, per ora, a un’assenza.
Proviamo dunque a seguire Dante in questa sua scelta: lasciamoci catturare dalla fabula, rimandando a più tardi l’approfondimento di dettagli, dubbi e questioni critiche. Il ritmo narrativo, fino all’incontro con Virgilio, è quello di un incubo adrenalinico. Dante si ritrova tutt’a un tratto in mezzo alla selva, è in preda al terrore perché la selva è oscura e selvaggia e lui non ricorda nemmeno come ci è entrato (dormiva…) e quindi non sa come uscirne – ma tutt’a un tratto vede il colle illuminato dal sole che sta per sorgere (ecco dunque la spiegazione dell’oscurità della selva, interna alla logica del racconto: è ancora notte…) e, rincuorato, come farebbe qualunque naufrago approdato fortunosamente a una terra sconosciuta, incomincia l’ascesa; la quale ascesa è però ostacolata tutt’a un tratto dalla lonza, poi dal leone, infine dalla lupa – e mentre il poeta, ormai disperato, sprofonda di nuovo nel buio della selva, ecco apparire tutt’a un tratto lo spettro di colui che si rivelerà il salvatore, ma che all’inizio aggiunge spavento allo spavento.
A partire dalla risposta di Virgilio, la sequenza di colpi di scena lascia il posto a un dialogare via via più pacato: se il primo discorso diretto di Dante è ancora un grido di terrore (“Miserere mei”), il secondo è un’accorata e già fiduciosa richiesta di aiuto (“Or se’ tu quel Virgilio…? Aiutami da lei…”), il terzo è la condivisione di un programma (“Poeta, io ti richeggio… che tu mi meni là dov’or dicesti…”). L’apparizione di Virgilio comporta il passaggio dall’accumulazione di elementi simbolici, tipica del sogno, a una logica discorsiva e razionale, fatta di spiegazioni, argomenti, distinguo. Il ritmo narrativo si placa e il lettore viene finalmente rassicurato dalla presenza dell’argomento, inserito però all’interno del racconto ormai in fieri, con una funzione psicologica precisa, di rassicurazione appunto, nei confronti del protagonista, e non più sulla soglia, in qualche modo “fuori” del testo, com’era nella tradizione.
Accanto al ritmo, senza dubbio l’elemento musicale più evidente di questo I canto, le ripetizioni. Innanzitutto “io”: “Mi ritrovai… i’ trovai… i’ v’ho scorte… i’ v’intrai… i’ fui… i’ passai…” e così via. Non per ingenuo autobiografismo, ma perché l’esperienza concreta dell’uomo Dante (protagonista e narratore della storia) è il filtro attraverso cui il messaggio universale arriva a noi, lettori plurali.
Seconda parola-tema, ripetuta cinque volte nella prima metà del canto: “paura”. È la reazione naturale del protagonista alla situazione, certo, ma Dante ci parla della paura che si rinnova adesso che racconta, che ripensa a quell’esperienza terribile; e quindi è una paura che può essere subito contraddetta, o mitigata, perché da quella esperienza Dante non solo è sopravvissuto per raccontarcela, ma ha ricavato anche del bene, e di questo, soprattutto, intende parlare – per questo, per parlare di questo bene, scrive.
Dante non sta scrivendo un horror, non si compiace della sua e nostra paura, non si crogiola nel male che descrive, e dal quale pure a volte rimane affascinato; il suo scopo è “trattar del ben” che si può ricavare anche dall’esperienza della selva e dell’Inferno più profondo. La contrapposizione tra vita e morte (parole-rima 1 e 7: a questi numeri senza dubbio il lettore ideale di Dante prestava attenzione) si articola in quella fra paura e bene – e il poeta ci promette subito il trionfo di quest’ultimo, ma un trionfo non facile, appunto perché la paura si rinnova, ripensando all’esperienza vissuta.
Il ritmo narrativo della prima metà del canto è scandito anche dalle due ampie similitudini, che concludono le due sequenze principali e fermano momentaneamente l’azione. La similitudine del naufrago (fermiamoci per ora su questa) illustra lo stato d’animo del poeta nel momento in cui spera di poter raggiungere la cima del monte illuminata dai raggi del sole nascente; ma al lettore attento chiarisce anche che tale speranza è prematura, la paura “un poco queta” non è vinta davvero (il naufrago, ahilui, “si volge a retro” anziché guardare avanti).
Azzardo l’ipotesi che l’immagine del naufrago anticipi anche l’apparizione di Virgilio: l’Eneide si apre infatti con una drammatica scena di naufragio – è come se Dante, con questa similitudine, orientasse la fantasia del suo lettore, la preparasse, subliminalmente, alla possibilità che Virgilio in qualche modo sia coinvolto. Dante si rivolgeva dunque a un lettore in grado di cogliere un riferimento intertestuale del genere? Non solo, ma anche. La possibilità di una lettura “stratificata”, tendiamo a dimenticarcene, non è una scoperta dell’età contemporanea.
Il poeta, rinfrancato dalla vista del colle illuminato, riprende fiato e comincia l’ascesa. “Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta…”, la lonza. Dante si rivolgeva a un lettore nelle cui orecchie suonava l’evangelico “Et ecce” e a cui quindi non appariva strana la brusca transizione al nuovo episodio, qui e innumerevoli altre volte. Ciò non ci impedisce, a noi che i Vangeli li frequentiamo molto meno, di apprezzare l’arditezza dell’ellissi, dopo il “rallentando” che la precede. A me pare in effetti che spesso le transizioni dantesche, “Allor”, “Ed ecco”, “Mentre che” ecc., fingano di istituire nessi logici, temporali o causali, ma in realtà abbiano carattere onirico – scandiscono apparizioni ex nihilo: prima la selva, ora le fiere, fra poco Virgilio. Anche in questo caso, si tratta di una scelta ben meditata, che ci tiene vivo nella memoria lo strano “sonno” che ha portato Dante nella selva e mette il lettore sull’avviso rispetto a uno dei temi segreti e ricorrenti del poema: come vedremo nel II canto, il lettore a cui pensa Dante conosce la Vita nuova, e il primo evento narrativo fondamentale del romanzo giovanile, quello che dà avvio alla scrittura poetica del protagonista, è per l’appunto un sogno – e un sogno così inquietante da potersi definire anch’esso un incubo, quello in cui Amore personificato dà in pasto a Beatrice il cuore di Dante stesso.
Con questo “Ed ecco” vengono dunque introdotte le tre fiere che ostacolano il poeta e lo rispingono nella selva. Anche sulle fiere le note interpretative si moltiplicano. Ma Dante propone al lettore un racconto, non una serie di rebus. È quindi dalle articolazioni del racconto che dobbiamo ricavare lumi.
(Breve parentesi metodologica: il fatto che Dante avesse letto e apprezzato altri testi in cui si parla di lonza, o di lussuria, o di entrambe le cose, non garantisce affatto che in essi vi sia la chiave per “spiegare” Dante. Il quale, come stiamo verificando e come si confermerà procedendo nella lettura, esibisce e rivendica in continuazione la propria originalità e la propria libertà – rispetto ai classici, rispetto ai padri della Chiesa, rispetto ai teologi suoi contemporanei… Le spiegazioni, quando è necessario, vanno cercate all’interno del testo, non nelle fonti presunte, e neanche nelle certe.)
Dunque: la lonza ostacola l’ascesa di Dante, ma non la interrompe. La prima fiera è sensuale, vellutata (“pel macolato… gaetta pelle”), minacciosa in quanto fiera, ma senza apparente violenza (“leggera e presta”). La lonza simboleggia la lussuria, dicono. Ma la descrizione di Dante dice più in generale la dolcezza dei sensi, l’abbandono languido a ciò che piace, a ciò che è facile, a discapito di ciò che è giusto. Dante esita, si volge all’indietro (è lo stesso gesto del naufrago, lo stesso verbo…), ma non perde la speranza. È mattina, ci informa l’io narrante, è primavera, la stagione in cui Dio ha creato l’universo – il viaggio individuale si colloca subito in una dimensione cosmica – e il poeta si illude di poter sfuggire alla lonza e alla sua ingannevolezza tentatrice.
Violento senz’altro è invece il leone, che non si limita a “impedire” il poeta, ma gli si avventa contro, “con la test’alta e con rabbiosa fame”. Il leone incarna dunque non semplicemente l’orgoglio, ma tutte le forme di aggressività, di prepotenza, di brutalità fisica. La sua vista rinfocola in Dante la paura (illusoriamente quetata poco prima, come si è detto). E io credo sia legittimo immaginare Dante, che di fronte alla lonza cercava cammini alternativi per proseguire, paralizzato dal terrore di fronte al leone, immobile e tremante – lui, e per simpatia l’aria intorno.
La “gravezza” che emana dalla lupa e dalla sua fame insaziabile si contrappone alla leggerezza della lonza come i peccati più leggeri, legati alla sensualità, si contrappongono a quelli legati all’avidità, i più gravi di tutti. Dante, che prima ha esitato, poi si è fermato, ora arretra, fugge, e risprofonda nell’oscurità della selva.
La lupa introduce il tema polemico fondamentale della Commedia, la contrapposizione fra i valori etico-religiosi che Dante aspira a restaurare e la mentalità mercantile ormai egemonica. E infatti: delle prime due fiere Dante “si dimentica” subito dopo averle descritte: solo contro la lupa chiede l’aiuto di Virgilio, solo la lupa è oggetto della profezia di quest’ultimo (in verità la lonza verrà rievocata nel prosieguo del viaggio, e forse anche il leone, più indirettamente – ma per ora solo la lupa sembra davvero importante).
La lupa-avidità, come spiega Virgilio poco più avanti, è stata liberata dall’Inferno nel mondo a causa dell’invidia. Per il lettore di Dante, questa affermazione aveva un peso particolare. Fin dalle origini del Cristianesimo l’avarizia/cupidigia contende all’orgoglio/superbia il ruolo di radix omnium malorum, e nel corso del Duecento acquista sempre più peso, man mano che la classe dominante degli orgogliosi, leonini cavalieri feudali, cede il posto all’avida, cupida, lupesca borghesia mercantile. Dante aveva già descritto nel IV libro del Convivio il meccanismo psicologico alla base della nuova mentalità, sottolineando l’insoddisfazione a cui il proto-consumista (possiamo ben chiamarlo così) era per forza di cose condannato: “Onde vedemo li parvuli desiderare massimamente un pomo; e poi, più procedendo, desiderare uno augellino; e poi, più oltre, desiderare bel vestimento; e poi lo cavallo; e poi una donna; e poi ricchezza non grande, e poi grande, e poi più. E questo incontra perché in nulla di queste cose truova quella che va cercando, e credela trovare più oltre”.
Indicando l’invidia come la forza che ha liberato la lupa nel mondo, cioè come la causa prima dell’avidità, vera radice di tutti i mali, Dante non può ignorare l’effetto sorpresa che provoca nel suo lettore. Anche nella ribellione di Lucifero, anche nella disubbidienza di Eva, è all’opera l’invidia, cioè il desiderio di primeggiare ad ogni costo. Perché io creatura dovrei accettare la subordinazione al mio creatore? Perché io essere umano dovrei rinunciare a diventare come Dio (la promessa del serpente a Eva)?
Siamo a uno snodo etico e politico decisivo. L’invidia come negazione di ogni limite. La mentalità mercantile, fomentando l’illusione di una crescita infinita (“dopo ’l pasto ha più fame che pria”), cambia di segno all’invidia, facendo di un vizio capitale il motore dello sviluppo: come dice il moderno lupo di Wall Street, l’avidità è buona. Dante dichiara invece che l’avidità ci lascia necessariamente insoddisfatti perché si rivolge a beni materiali, illudendosi che essi possano soddisfare un bisogno che è in realtà di tipo spirituale. Il motore di questa avidità, l’invidia, è una forma di materialismo, di tradimento dello spirito, il più grave e imperdonabile dei peccati.
L’analisi dantesca dei fenomeni storici, economici e sociali del suo tempo, dati gli strumenti che il poeta aveva a disposizione, a me pare lucidissima. Così la veemente opposizione a tali sviluppi, il rifiuto in base a motivazioni etico-religiose di quella che a noi pare un’inevitabile evoluzione verso la modernità, da parte di un autore modernissimo e innovatore. Ciò che a noi, a distanza di secoli, appare come una trasformazione osservabile sine ira et studio, per lui che ne è travolto in prima persona è una catastrofe apocalittica… La fine della democrazia, l’annichilimento delle tradizioni culturali, l’adesione di massa a un modello economico schiavistico sono tragedie per noi che ci rendiamo conto di viverle in questo inizio di III millennio, non per chi ne parlerà fra settecento anni…
Alla presenza della lupa è legata la seconda similitudine del I canto, quella appunto del mercante che, dopo aver a lungo accumulato, perde tutto all’improvviso e si dispera. In questa caduta delle speranze va trovato il nesso con la similitudine del naufrago: entrambi i personaggi nutrono illusioni prive di fondamento.
E alla presenza della lupa è legata l’apparizione di Virgilio, il cui aiuto Dante invoca appunto contro la “bestia” che gli fa “tremar le vene e i polsi”. L’apparizione di Virgilio introduce nel poema un elemento nuovo: finora Dante ha fatto ricorso a quella che lui stesso chiama nel Convivio “allegoria dei poeti”, cioè a una serie di invenzioni frutto della libera immaginazione dell’autore (la selva, il colle, le tre fiere…); ora Dante ricorre invece alla “allegoria dei teologi”, cioè a una figura storica reale, non frutto di invenzione.
Diciamo subito che c’è in Virgilio una complessità umana, psicologica, irriducibile a ogni allegorismo (“Virgilio o la ragione”). Nota, per esempio, la sottile ironia con cui, subito dopo essersi presentato, chiede a Dante perché non salga il “dilettoso monte” – lo sa benissimo, ce lo confermerà lui stesso nel II canto. Di contro, dalle sue prime parole (“omo già fui”) e più chiaramente alla fine del canto (“felice colui cu’ ivi elegge!”), traspare una malinconia da esclusione che si approfondirà nel IV dell’Inferno e soprattutto nel Purgatorio, di fronte alle anime destinate al cielo. Ma queste sono sfumature che il lettore del poema al momento non può cogliere.
Ciò che invece doveva sorprenderlo e suscitare la sua curiosità è il fatto che Virgilio si presenta (e sarà sempre considerato, in tutta la Commedia) come autore della sola Eneide, senza riferimento alle altre opere. È una scelta che doveva sorprendere perché al lettore trecentesco il nome Virgilio evocava immediatamente la cosiddetta “rota Vergili”, lo schema elaborato da Donato già nel IV secolo e diventato la base del classicismo medievale, per cui a Bucoliche, Georgiche ed Eneide erano collegati tre livelli stilistici (umile, mediocre e sublime) e tre serie di contenuti, di personaggi, di ambientazioni, di simboli…
Ancora una volta, Dante delude le attese del suo lettore: il Virgilio personaggio della Commedia coincide in parte con il Virgilio storico, ma non del tutto: come l’io di Proust o il Federigo di Manzoni o il Napoleone di Tolstoj, si tratta di una funzione interna al testo, ritagliata (come saranno tutti i personaggi del poema), ridotta, deformata in base alle esigenze rappresentative dell’autore.
A Virgilio, “poeta” e “famoso saggio”, viene comunque affidata, prima dell’argomento tanto atteso (“trarrotti di qui per loco etterno” ecc.), la profezia della Divina Commedia, quella del veltro. Mentre sintetizza la storia del mondo chiarendo cosa vuol dire, su un piano non più individuale, l’iniziale “nel mezzo” (tra peccato originale d’invidia e palingenesi ventura), Virgilio chiarisce la natura profetica del testo che stiamo leggendo.
La profezia, giocoforza, procede per accenni, allusioni, metafore ed enigmi… L’oscurità del suo linguaggio è voluta e necessaria. Noi oggi pensiamo che la storia umana sia imprevedibile (forse non casuale, ma certo non anticipabile) – c’è un elemento imponderabile, che nessun raffinamento di scienza potrà eliminare. Dante, viceversa, crede che la storia segua un piano preciso, a noi sconosciuto, certo, ma rivelabile, sia pure per brevi, confuse intuizioni. Videmus ut per speculum et in aenigmate.
L’oscurità del linguaggio profetico non è dunque un “difetto”: non è per ingannare o beffare i destinatari della profezia che l’illuminazione è parziale, bensì perché la nostra conoscenza non può che essere parziale, un lampo che svela e acceca nel medesimo istante. La profezia non risolve un enigma, ma affronta un mistero: il suo senso profondo sta proprio nella sua oscurità, come dice bene Pascoli: “il poeta, sempre coerente, non spiega il mistero” perché “con la spiegazione, non sarebbe mistero”. Se Dante ricorre all’oscurità del linguaggio profetico, è perché vuole che il lettore riceva per l’appunto un’impressione di oscurità.
Di contro all’allegoria della lupa, fin troppo didascalica (perché il senso figurato fa aggio sul senso letterale: per esempio in “e molte genti fé già viver grame”), i versi sul veltro hanno il fascino del mistero reale. L’eccesso di annotazione, in questo caso, è più che un sintomo di sfiducia nel testo – è un tentativo di ridurre il perturbante, il segreto insondabile del disegno provvidenziale di Dio, a un indovinello più o meno ingegnoso, pacificando il lettore con l’illusione della sua spiegabilità.
Virgilio parla di un “oltre” che ci trascende e, verrebbe da dire di conseguenza, allude anche a un oltre-sé-stesso: il viaggio di Dante proseguirà dopo che lui avrà esaurito la sua missione, quando un’anima “più degna”, che per il momento non viene nominata, accompagnerà il pellegrino in Paradiso. (Allo stesso modo, il viaggio del lettore non potrà concludersi, almeno idealmente, con l’ultimo verso del poema: l’opera va oltre-il-testo, oltre la materialità linguistica, chiama in causa tutta la nostra vita spirituale.)
Nessun mistero, invece, quando Virgilio confonde troiani (Eurialo e Niso) e latini (Camilla e Turno), un tempo (nel mito) nemici e oggi (nel 1300) morti tutti per la stessa “umile Italia”. Virgilio sta parlando dal punto di vista dell’eterno, sta anticipando ciò che Dante, e il lettore con lui, scoprirà a poco a poco nel corso del viaggio – vale a dire: che rispetto al disegno provvidenziale di Dio, le più feroci lotte politiche sono risibili bisticci. Il tempo della cronaca, della storia o del mito, cioè i tempi umani, e la dimensione dell’eterno che è propria di Dio non coincidono.
di Giacomo Sartori
Pur aborrendo le scarificazioni urbanistiche, vorrei che l’intero cimitero monumentale a nord della città (“Trento Nord”) fosse decostruito, e che si riedificasse in armonia e tra viluppi di piante (includendo colture urbane).
Vorrei che nelle vie di Trento si respirasse l’alito del naturalista e socialista e anticlericale Cesare Battisti.
Vorrei che nelle panetterie di Trento si rinvenisse del pane buono (come avviene in moltissime regioni italiane), o insomma mangiabile.
Vorrei che il quartiere delle Albere fosse ribattezzato “Quartiere Fallimento” o anche “Fallimento PIANificatO”, e che vi ci si organizzassero visite per assaporare l’istruttiva assurdità di una pianificazione piovuta da alti limbi.
Pur non amando i maxischermi, vorrei che in Piazza Duomo si erigesse un maxischermo sciorinante in diretta le cifre dei mezzi che transitano sull’Autobrennero (conta cumulata per anno solare, divisa per auto e mezzi pesanti, in direzione nord e sud).
Vorrei che lo stesso maxischermo in Piazza Duomo distillasse on live anche le cifre degli inquinanti generati dai mezzi che transitano sull’Autobrennero (stime per i vari tossici, divisi per auto e carriaggi pesanti).
E che lo stesso maxischermo disseppellisse ora dopo ora le cifre dell’utile netto di Autostrada del Brennero SPA (cifre cumulate per anno solare).
Vorrei che grazie a interventi illuminati e coraggiosi l’Adige ritrovasse vita, apertura alla città, utilità e bellezza.
Vorrei che i ristoranti di Trento quando si ordina polenta servissero genuina polenta (possibilmente con mais locali di qualità), invece che poltiglie e mattoncini di dubbia origine e gusto.
Vorrei che nei ristoranti di Trento quando si ordinano funghi servissero genuini funghi (parlo naturalmente della stagione dei funghi), invece che pseudocarpi di lattina metallica.
Vorrei che i ristoranti (di ogni ordine e grado) di Trento imparassero a fare da mangiare, non dico bene, ma almeno passabile (mettendo in atto gemellaggi con altre regioni italiane?).
Vorrei che i ristoranti di Trento, e per primi quelli senza pretese, rivedessero al ribasso i prezzi, allineandosi su quelli delle altre città di provincia italiane, e tenendo conto della oggettiva inferiore qualità.
Vorrei che si ripartorisse Piazza Dante, trasformandola in limbo pedonale intenso e accogliente, con un suo senso e legame con la città – un accesso dantesco privilegiato – invece di considerarla un problema d’ordine pubblico.
Pur considerando i maxischermi inquinanti, vorrei che in Piazza Duomo si ergesse un maxischermo (un altro) che propagasse le cifre del reddito provinciale che si deve agli italiani (o non italiani) che vengono da altri paesi, e delle tasse e contributi che sborsano.
Vorrei che il personale al gran completo di negozi, esercizi e biglietterie della città seguisse dei corsi di cordialità e loquace buon umore (anche qui mediante gemellaggi con altre regioni e etnie).
Vorrei chiedere al Vescovo di traslocare in periferia, come ha fatto il Questore, cedendo il suo non leggiadrissimo palazzo, e le vegetazioni attinenti, a una destinazione che ridia vita – e senso – a Piazza Fiera: “Museo della Controriforma, dell’Inquisizione e degli effetti psicopatologici a lungo termine dei gioghi religiosi”.
Vorrei che il pernicioso “Mercatino di Natale” fosse proibito per i prossimi centomila anni, o meglio ancora cinquecentomila.
Vorrei che la disconosciuta plaga viticola che abbraccia la città fosse convertita per intero alle attenzioni biologiche, e fosse cucita intimamente alla città da una rete di rotte pedonali e ciclabili.
Vorrei che il Presidente della Provincia fosse un uomo, o meglio una donna, di colore, o almeno di origine vistosamente straniera.
Vorrei che il potere politico della città si inchinasse alla ricchezza della cultura delle associazioni ambientaliste e civiche e della montagna, e coagisse con esse per il governo del territorio cittadino e extra-cittadino.
Vorrei che si estirpasse il traffico privato davanti al Castello del Buonconsiglio.
Pur amando gli alberi, e considerando un delitto ogni taglio raso o capitozzamento, vorrei che si prendesse in considerazione di espiantare i ginko che nascondono le splendide scuole Sanzio (trasferendoli da qualche altra parte?).
Pur trovando simpatico l’accento trentino, vorrei che fosse bandito dalle trasmissioni radiofoniche locali della RAI.
Vorrei che si abbattesse la muraglia invalicabile tra università e città, e che il sapere accademico irrigasse i destini culturali, civili, civici, tecnici e paesaggistico-architettonici della città (ricevendo in cambio la linfa del mondo reale).
Vorrei che le ex prigioni di Via Pilati diventassero “Museo delle catastrofi ecologiche e delle malefatte finanziarie degli impianti sciistici trentini”.
Pur essendo contrario all’ingegneria genetica sull’uomo e al transumanesimo, vorrei che nel patrimonio genetico-culturale degli abitanti di Trento si ritrapiantassero franchezza e coraggio intellettuale, rarefatti dai secoli di servitudine ai poteri ecclesiastici e temporali.
Ambirei che si inventariassero i pletorici mostri architettonici e parcheggistici edificati negli ultimi trent’anni a Trento e nei suoi sobborghi, e che i responsabili pubblici e privati fossero rieducati (prevedendo dei corsi di aggiornamento all’estero).
Vorrei che le sommità del Monte Bondone (a cominciare da Vaneze) fossero trasformate in ecoparco alpino chiuso al traffico e privo di impianti di risalita (ad eccezione di quello di accesso dalla città), ridisegnando la composizione e la disposizione delle vegetazioni con delicata sensibilità ecologica e estetica (e integrando utilizzi silvo-pastorali e caseari, altro che demenzialità golfistiche).
Desidererei che la cultura trentina fosse in mano a funzionari colti, aperti, audaci, sensibili, lungimiranti, anticonformisti, spassionati, spiritosi (nei limiti del possibile), e quindi diventasse una cultura – e anche una politica – invidiata, e imitata, a livello nazionale (invece di scimmiottare lei).
Vorrei che gli abitanti di Trento avessero meno aprioristico orgoglio trentino.
Vorrei che il Museo delle Scienze (MUSE) svolgesse massiccia ricerca scientifica a alto e umanitario livello, oltre che intrattenimento ludico, diventando un faro per la cultura alpina.
Vorrei che gli abitanti di Trento accettassero senza complessi di inferiorità la loro identità fitta di ombre e frustrazioni (senza bisogno di inventarsi identità fittizie).
Amerei che gli abitanti di Trento fossero più buoni, e potessero strapparsi di dosso le invidie, retaggio certo del loro sottomesso passato.
Vorrei che gli abitanti di Trento si unissero a quelli di Besenello (o a quelli di Rovereto, si veda il progetto prescelto) per infuriare contro il fioccaccio autostradale ivi previsto, costringendo le autorità a desistere dal loro folle piano (sono pronto a partecipare in prima persona).
Vorrei che la città di Trento trovasse un rapporto di ascolto e collaborazione, e forse anche di coordinamento illuminato, con le valli che la circondano e le loro culture (e non solo con i relativi potentati economici).
Vorrei che la città di Trento, che per tanti anni ha avuto una minoranza tedesca, sapesse instaurare un dialogo costruttivo e vivido con Bolzano.
Vorrei che si ripristinasse la magnifica e nobile pavimentazione sconnessa dei marciapiede del centro storico, vittima del gusto spartitraffistico e autogrillesco.
Vorrei che si interrasse l’onerosissimo progetto di interramento della ferrovia, non esiziale (e men che meno risolutivo) per i destini della città.
Vorrei che a Trento arrivasse il mare (il Tirreno), con un relativobel lungomare, o in mancanza di meglio almeno un braccio del Lago di Garda.
Vorrei che i governanti di Trento fossero coscienti che la viabilità culturale è più importante, e ben più redditizia, della viabilità automobilistica.
Vorrei che il quotidiano ‛L’Adige’ non ignorasse i miei libri quando escono (anche per criticarli, naturalmente), e questo non per ammaliare il mio ego ma in quanto contributi (certo modesti) della cultura trentina innestata nel mondo.
Vorrei che il bar della stazione fosse promosso monumento nazionale (mantenendo l’attuale arredo e personale).
NdA: questo pezzo è compreso nella raccolta di contributi “La Trento che vorrei”, pubblicato da Edizioni Helvetia (2019)
di Giuseppe Martella
5. Simulazioni e rivendicazioni
In effetti tale è Ulisse, ultimo degli eroi mitici, primo degli eroi letterari, frutto egli stesso di una selezione culturale e della sopravvivenza del più adatto. Nell’Iliade, primo modello letterario, gli eroi greci e troiani sono ancora impregnati di sostanza mitica, escono dalle nebbie della tradizione orale, impastati di divinità, in continuo commercio con gli dei, figure della loro stessa statura, semidei.

di Chiara De Caprio
Alla fine di ogni giorno fortunato
ricorda che il fuoco e il ghiaccio
sono a un passo soltanto
dalla città temperata […].
Ma se tu fallissi […],
ringrazia l’aspro trattamento della marea
per la dissoluzione del tuo orgoglio
poiché la tromba d’aria può assoggettare il tuo volere
e il diluvio rilasciarlo per trovare
la primavera nel deserto, l’isola
fruttifera nel mare, dove il corpo e la mente
vengono liberati dalla sfiducia.
(W.H. Auden)

0.
In fisica quantistica il valore di una grandezza osservabile di una specifica particella in un certo stato quantico non è definito prima di effettuare una misura. Tuttavia, quando si effettua una misura su una delle particelle di uno stato entagled, questo determina istantaneamente anche i valori delle grandezze osservabili di tutte le altre particelle, per quanto lontane: la cosiddetta non-località quantistica. Questa “interazione a distanza” è nota col termine inglese entaglement e viene descritta anche come azione fantasma a distanza (spooky action at distance).

Movimento d’ingresso
I
[Sonoro: Anthony and the Johnson, My Lady Story]

(a). 1. [si rifiuta di distinguere]
va incontro all’invito di sua cugina, il fisico quantistico; va a Nizza. Mentre le insegne dell’aeroporto si fanno via via meno sfocate, prova a comprendere le proprietà corpuscolari della luce di cui le parlava: un movimento i cui effetti perdurano nello spazio
la sospinge, il caldo, sotto la volta della sala d’attesa. Con trattenuta apprensione supera l’indolenza di una fila; forse, si rifiuta di distinguere fra battuta d’arresto e catastrofe. Nell’eseguire i gesti del controllo-valigie, se ne sente, di nuovo, assediata: un’infinità di dettagli, in cui si fa liquida la sua protratta osservazione di ogni incidenza, in cui si riaccostano i lembi di ciò che si strappa
sfila stivali lunghi fino al ginocchio; a lei tocca, come addetto, una donna in corpo di uomo, alta e decisa nella sua metamorfosi; mascara e matita nera, orecchini su lobi un po’ cascanti, un liscio mogano ad incorniciare il volto: asciutto, graffiato e benevolo. Le riconsegna gli anelli; accompagna il gesto con una frase che è il bisbiglio con il quale viene pronunciata, quasi una canzone, nel falsetto della sua voce: Oh, miss, beautiful rings
la punge il freddo della montatura d’argento, quella carne di entrambi i sessi che per un attimo la sfiora. Il tocco imprevisto la sbalza verso ciò che le è interdetto, e la fa poi ridiscendere lungo la materia che lei lambisce e afferra meccanicamente; una routine di contatti ordinari e ammissibili, che disegnano i confini della giurisdizione sotto cui ricade il corpo: ciò che lo accetta, sopporta, e accoglie
sosterebbe ancora davanti alla sua (S)he: Oh lady, your story. Are you a bride on fire or twisted into a starve of wire? Ma già altre voci, meno dotate di grazia e articolazioni interne, chiedono di avanzare nella fila: Madame, please, please. Si chiude lo spazio per lo sguardo, tra decine di altri: che tornano a infilare cinture nei passanti allentati, impugnare saldamente guinzagli, tastare cinghie di museruole; una rete di disciplinamento e comunicazione controllata le cui linee le si conficcano fra gola e inguine, lievi e taglienti
intravede il gate; come promettono le insegne, il volo per Nizza

(b). 1. [come promettono le insegne]
Accanto, sull’autobus una coppia con bambina. Non saprei dire quando ho pensato che no, non erano qui in vacanza. Certo prima di mettere a fuoco lei, la bimba, forse nemmeno sette anni, che sedeva sul sedile opposto al mio, dall’altro lato. Lei, la sua eccezionalità: che, nel linguaggio ordinario, avrebbe il nome di ciò che è deforme. Ma, prima, prima di lei, era forse quell’aria compita e spaesata di chi la guidava: i volti, nel fondo, privi di gioia, ma anche fissi in una loro misura assorta. Così, quando chiedono della fermata dell’ospedale, è solo una conferma. E la gentilezza con cui rispondo loro, ai miei stessi occhi, nel rimbombo interno della mia voce, non è che una forma inefficace del senso della mia differenza, e della mia consapevolezza.
(Perché qui, e non lì, ora, sembra perfino una domanda mal posta: è il tuo turno, affrettati, fai il tuo gioco. Il banco, lo sai, vince sempre).
Si ferma l’autobus e nel vetro si riflette una bimba riccia e scattante: i bracciali in legno, la treccina colorata, la pelle scura del sole di luglio. Resisto, ora, a sentire oltraggiosa la forma che tiene, la bellezza che resiste, ancora.
Scendo, dietro di lei. Dietro di me, si chiudono le porte: mi consegnano alla mia strada, all’indirizzo che cerco.
I rumori e la luce di Nizza sono già qui, il sole che mi spezza il fiato, il mare che non vedo; ma sarà azzurro come promettono le insegne.

(b) 2. [di lì non c’è altro spazio]
Ci sorprende la pioggia, mentre provo ad avere ragione della Promenade: la folla di bici e pedoni, oggi sereni; la serie azzurra delle sedie verso cui le bambine corrono, la linea di grigio che ora è il mare, i bagnanti che si attardano ai bordi, sui ciottoli e sul bagnasciuga.
Arriva sempre più distinto il suono dei megafoni e la musica degli altoparlanti. Leggo le scritte sulle bandiere arcobaleno, gli slogan pieni di movimento e autodeterminazione: PMA pour toutes; Pas de fierté pour nos frontières. Le frontiere come i corpi, i corpi come le frontiere: come se lo spazio primo e nostro di cui siamo fatti non sia che un sottoinsieme di quello più vasto che pure ci delimita. Li osservo meglio, mentre procedono sotto un ampio tendone multicolore, ornato di palloncini rossi, arancioni, gialli, verdi, blu, e viola. Distinguo slip azzurri, chiome rosa ed altre argentate, splendide ali avorio ad ornamento di un body e di un paio di stivali bianchi; “e lei chi è?” mi chiede M., sorridendomi: vuole entrare nella parata, seguirne la scia, ballare. Ci investe l’ebbrezza gioiosa e un po’ dimentica della musica. Seguiamo il ritmo, ridiamo.
(Mi dico che, quasi prima del pensiero, è il sensorio, questo qui-ed-ora, a farmi stare fra loro e con loro, in una Nizza che sembra ora sovrapporre categorie e far saltare distinzioni).
Una scritta luminosa, in alto a sinistra, avvisa gli automobilisti che la Promenade è chiusa al traffico, le transenne a delimitare gli spazi. Alcuni scrutano dai balconi e dalle finestre semiaperte. Torno a guardarmi intorno; quasi per caso mi volto indietro: due uomini in tuta gialla si incaricano di far sparire i coriandoli e di pulire il manto stradale, man mano che la Pink Parade avanza. Davanti, altre transenne e direzioni di scorrimento predeterminate: di lì non c’è altro spazio.
Esito. Mi domando quali siano le possibilità di conoscenza e gioia di un movimento che abbia una così rigida modalità di esecuzione e un percorso vincolato dall’esterno: se sia ancora, questa, una protesta, una richiesta, o almeno una ricerca.
Una voce mi chiama; mi giro di scatto, sottratta all’indagine. Avanzo fra due manifestanti e, infine, rientro nella parade: quasi come un tuffo.

(a). 2. [a fatica individua margini]
troppo rapidi i suoi movimenti sotto la cupola del centro commerciale. Pure riesce a schivare un trolley e il suo proprietario, e il cagnolino invadente che già le lecca le caviglie. Tocca, col suo piegarsi istintivo, la fibbia che non ha ceduto sotto le unghie dell’animale, poi il punto del sandalo che teme umido
procede; registra la sommergente marea di ineffabili gaudi e incomunicabili paradisi privati: vetrine di corpi in plastica, cabine per prove d’abiti, volute di borse a basso costo, trionfi di profumi e creme, cascate di lingerie per notti fatali, cimiteri di peluche per la solitudine del giorno dopo
avanza. Avanza in un’irrelata successione di forme e funzioni fra le quali, ora, il sensorio istituisce collegamenti, forse legami e genealogie: il cuscino reggi-spalla per sonni ristoratori, le cuffie da musica nell’ultima illusione on-the-air, gli slip in offerta per essere caldi e puliti; che, se il corpo non è proprio una poltiglia, bene gli slip à la page, dopo uno schianto o un ammarraggio in un oceano total black
torna indietro, dinanzi a una fila di specchi; di lì non c’è altro spazio, solo la serie della sua immagine che si ripete di fronte a lei. Distoglie lo sguardo: come se fra la detentrice di quella forma e quei frammenti moltiplicati non esistesse alcun rapporto
eppure, quasi di sghembo, le appare una figura al confine col mondo vegetale e animale: una medusa, o una di quelle creature luminescenti che solcano gli abissi. Si sforza; ma è impossibile comprendere la carne quando resta nuda: la natura del proprio sguardo senza gli altri uomini intorno. A fatica individua margini nel grigio-pietra dei suoi occhi moltiplicati
una voce la chiama; si volta: quasi sottratta all’indagine

di Adriano Ercolani
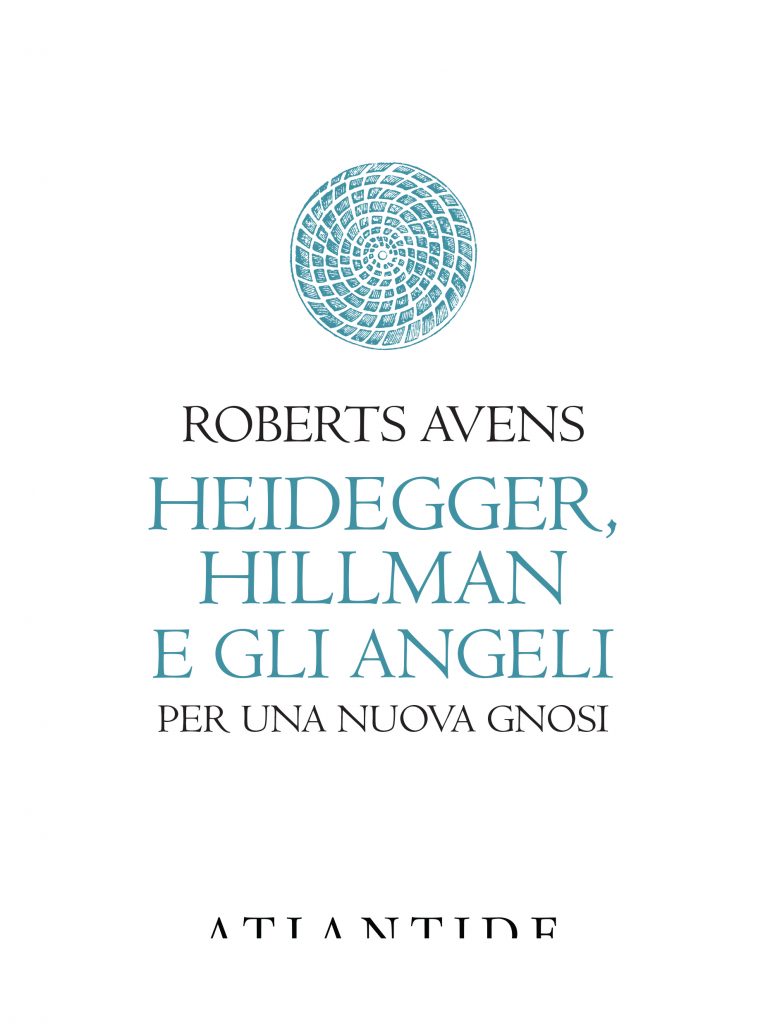
Pochi tra i libri pubblicati negli ultimi anni sono interessanti, fecondi di riflessioni e forieri di spunti come Heidegger, Hillman e gli angeli. Per una nuova Gnosi di Robert Avens.
Per chi, come il sottoscritto, da venti anni si divide (o forse si riunisce) tra studio della filosofia occidentale e pratica della meditazione orientale, il libro è una dimora confortevole, dall’atmosfera familiare e dalla progressione architettonica spontaneamente comprensibile.
Immagino però che possa far storcere il naso fino alla nuca agli accademici, soprattutto in questo momento storico di violenta e falsa polarizzazione dialettica: l’agguato del pensiero magico è dietro l’angolo, soprattutto ora che scie chimiche e terre piatte sono temi presenti nell’agenda dei governanti, quindi è anche comprensibile nutrire un sospetto sistematico degno della Stasi nei confronti di tutto ciò che possa essere ricondotto a una giustificazione filosofica di tali deliri.
Chiariamo ogni dubbio: l’autore, Robert Avens, è stato uno studioso serissimo, importante filosofo e storico delle religioni.
L’edizione italiana (Atlantide) è a cura di Marco Filoni e tradotta da Matteo Trevisani: già questo, per i lettori nostrani, dovrebbe essere garanzia di prestigio intellettuale.
Siamo davanti a un’opera densissima dal punto di vista filosofico, un susseguirsi di vertigini abissali, sospese sull’ineffabile.
L’intuizione alla base del libro è chiara: “Le gnosi di Heidegger e Hillman sono radicate nel desiderio di superare il dualismo (l’interno contro l’esterno, lo spirituale contro il materiale, la realtà contro l’apparenza) recuperando un livello di consapevolezza che sia più originario della sensazione e della percezione da un lato, e del ragionamento dall’altro”.
Terzo grande protagonista della riflessione è Henry Corbin, importantissimo studioso di mistica islamica (e non solo), di cui Avens è stato notevole esegeta, a cui si deve la cruciale nozione di mundus imaginalis: “un mondo ontologicamente reale, come il mondo dei sensi e dell’intelletto, un mondo che richiede una specifica facoltà percettiva, facoltà che è una funzione cognitiva, un valore noetico, pienamente reale come le facoltà della percezione sensoria o dell’intuizione intellettiva. Tale facoltà è il potere immaginativo, quello che dobbiamo evitare di confondere con l’immaginazione che i moderni identificano con la “fantasia” e che, secondo questo parere, produce semplice “immaginario” (tratto dal saggio “Mundus Imaginalis, o l’immaginario e l’immaginale”, traduzione di Beatrice Polidori).
Come scrivono Maura Gancitano e Andrea Colamedici in Tu non sei Dio (Edizioni Tlon): ”La potenza delle parole di Corbin è quasi senza paragoni, eppure ha rappresentaro un canto pressoché inascoltato. Il termine immaginale è stato da allora utilizzato nell’ambito della nuova spiritualità – a volte non cogliendo la differenza con “immaginario”, ma solo l’eleganza del termine – ma è stato messo da parte l’apparato sapienziale su cui Corbin intendeva riportare l’attenzione degli occidentali. Si trattava del tentativo di spostare lo sguardo dalla spiritualità d’importazione a una tradizione più vicina all’uomo occidentale, ma purtroppo dimenticata. Il modo in cui le idee di Corbin sono state e continuano a essere usate ha a che vedere con la difficoltà dell’uomo occidentale di distinguere, come vedremo, tra fantasia e immaginazione”.
Leggendo Heidegger attraverso Hillman (e Corbin), Avens individua le basi di una nuova possibile gnosi: “La fenomenologia heideggeriana apre la strada alla gnosi producendo quel tipo di conoscere che non è separato dall’essere. In questo senso la fenomonologia è la gnosi – una conoscenza che viene prodotta nell’anima e dall’anima”.
Per comprendere lo sguardo di Avens bisogna tenere presente una meravigliosa intuizione poetica di Rabidranath Tagore: “Una mente tutta logica è come un coltello tutto lama. Fa sanguinare la mano che lo usa”.
Il miglior invito al corretto approccio ce lo offre lo stesso Avens: “Comprendere è sempre (probabilmente anche in ambito scientifico, come indicano il principio di Heisenberg e la teoria quantistica dei campi) un’operazione circolare o referenziale. Dato che la logica non può essere pienamente responsabile del funzionamento di questo circolo, diventa necessario una specie di salto nel circolo ermeneutico, per arrivare a comprendere allo stesso tempo il tutto e le parti che lo compongono”.
Chiaramente, il libro (dottissimo, traboccante di note, spunti, richiami, chiose e riferimenti) sconta il paradosso enunciato dalla teologia apofatica: “La verità (…) appena la nomini, non c’è più”, come fa dire Pasolini (con ironico gioco di significati) a Totò, maschera vivente che interpreta Iago il mentitore in Che cosa sono le nuvole?.
Non a caso ritornano spesso nel libro come mentori adorati i giganti della teologia negativa, da Meister Eckhart a Silesius, lasciando emergere la poesia come dimora prediletta della parola sacra: da William Blake e Holderlin fino a Rilke e T.S.Eliot, passando per George e Trakl, per Avens (e Heidegger) “la missione del poeta è quella di essere un messaggero, quindi di dire all’uomo cosa ha appreso sugli dèi e di dare un nome a cosa ha scoperto essere “sacro””.
Siamo sull’orlo dell’abisso filosofico, dell’indicibile: eppure, l’ineffabile appare il solo tema di cui valga la pena parlare.
Nel V capitolo, Gioco e Terra, si affronta il tema del “gioco imperscrutabile”, il mistero del gioco di cui parla Eraclito: “Il tempo della vita umana è un bimbo che gioca muovendo i suoi pezzi: a un bimbo appartiene il potere sovrano”. Ma, attenzione, il tempo di Eraclito è Aion (“durata”, “eternità”), non Chronos (scorrere del tempo).
Avens ha facile gioco nel trarre la sua conclusione, collegando Eraclito, tramite Heidegger, alla gnosi e Hillman: “Il tempo-del-gioco è il tempo della gnosi, che è anche il tempo del fare anima”.
Non solo l’uroboro (il serpente che si morde la coda, simbolo dell’Eterno Ritorno), non solo Dioniso contro Apollo, ma in primo luogo Ermes è il grande riferimento di questa riflessione di Avens: “L’elusività e la doppiezza di Ermes sono espresse da Heidegger nella sua caratterizzazione dell’Esserci come essere simultaneamente nella verità e nella non-verità”, ricordando altrove il passo di In Cammino verso il linguaggio in cui Heidegger sottolinea come nel dialogo platonico Jone Socrate definisca i poeti “messaggeri degli dèi”, facendo derivare l’etimologia di “messaggeri” proprio da Ermes.
Ecco, molto si è discusso sull’uso disinvolto delle etimologie di Heidegger; il caso più celebre è proprio il caso di aletheia (“svelamento”, “verità”), concetto da cui scaturisce l’intera riflessione di Avens: non sarebbe corretto, secondo Paul Friedlaender far derivare il termine greco dall’alfa privativo prima del verbo lanthano (“celarsi”), quindi l’intera interpretazione heideggeriana sulla verità quale “svelamento” sarebbe discutibile.
Concordiamo però con John Caputo quando scrisse: “anche se l’etimologia di aletheia è un’altra rispetto a quella che riporta Heidegger, è nondimeno vera in termini di luce e oscurità, di abbagli e apparizione – in un parola di svelamento”.
Questo vale, forse, per l’intero approccio di Avens: pensiamo alle bellissime pagine sul Gelassenheit (“l’abbandono” predicato da Heidegger), erede forse per noi della noluntas schopenhaueriana, accostato al precetto taoista del wei wu wei (“azione tramite non azione”).
Si potrebbe discuterne, certo.
Ma la sfida di Avens è proprio nell’abbattere muri immaginari della razionalità, che ci impediscono all’accesso al mondo immaginale.
Una nuova via per la ricerca filosofica, aliena da dogmi quanto dall’arroganza eurocentrica di dominare il reale col pensiero; si parla di nuova gnosi perché ”L’irrazionalismo mistico non può essere un’alternativa al razionalismo filosofico, perché essi sono gemelli, l’uno l’inverso dell’altro”.
Verso la fine, l’autore svela le proprie carte: “La conclusione più importante che può essere tratta dal nostro esame della gnosi in Heidegger e Hillman è che essa lascia la porta aperta all’inaugurazione di una nuova metafisica, centrata sulla nozione di un cosmo personificato”.
Al termine della lettura emerge il percorso, per l’appunto uroborico, della storia della filosofia: sembra che le ultime, ardite frontiere della speculazione razionale occidentale ci abbiano riportato, come tremanti neofiti, a bussare ai cancelli della sapienza orientale.

di Andrea Dei Castaldi
Ancora rivedo tutto come fosse oggi. Ho tredici anni e guardiamo il profilo duro delle montagne a nord, i versanti scorticati e radi su cui la primavera tarda a mostrarsi. Non sembrano che un malfermo fondale di cartone alle spalle del paese. È da lì che arriverà, dice Roberto senza smettere di tamburellare sul volante a tempo di musica. Dovrebbe essere qui domattina, o forse già stanotte, aggiunge socchiudendo di qualche centimetro il finestrino, dicono che a quest’ora sia già sopra la Francia, però vai te a sapere. Il suo viso da adulto si contrae in qualcosa che somiglia a un sorriso, ma questo non basta a rassicurarmi. Alla tivù hanno detto che sarà meglio non mangiare l’insalata per un po’, o la frutta dagli alberi, dico io tornando a guardare la linea spezzata che taglia il cielo di traverso sopra le montagne, e che ci si deve chiudere in casa fino a che non sarà passata. Roberto sputa uno sbuffo d’aria a labbra strette, e torna ad abbozzare quella cosa simile a un sorriso sulla sua faccia ossuta di ventenne. Bastasse questo, dice allora scrollando le spalle, bastasse chiudere le porte e le finestre come dicono, ma quella non è roba che la puoi tenere fuori così. Però vai te a sapere, ripete poi sigillando il finestrino alla sua sinistra. Io faccio lo stesso, dando mezzo giro alla manovella dal mio lato. Bastasse questo, mi dico. Guardo la casa dei nonni in fondo al pendio, è così piccola e sbilenca vista da qui che basterebbe un soffio di vento per buttarla all’aria. Mi metto più comodo sul sedile e mi concentro sulla musica che se ne esce dall’autoradio, una melodia insieme sognante e tragica che stende un velo stinto di tempo passato sulle cose intorno, su tutto ciò che vedo al di là del parabrezza, e mi sembra perfetta per questo momento che pare già un ricordo. E lo è, anche se non posso saperlo. Questa mi piace, dico allora. È Alan Parsons, dice Roberto passandomi la custodia vuota di un’audiocassetta, questo pezzo è ispirato alla Genesi. Scorro con un dito la lista dei titoli fino a che non trovo quello di cui parla e lo memorizzo, quasi dovesse servirmi in futuro, o avesse a che fare con quello che ci aspetta. La chitarra ha qualcosa dei Pink Floyd, dico poi rendendogli la custodia. Qualcosa, annuisce soddisfatto lui. Ora andiamo, dice poi mettendo in moto, che qui fa buio presto e ci aspettano per cena.
In cortile Roberto scende dall’auto e si stiracchia gettando un’ultima occhiata alle cime dei monti che già virano al violetto. Prendo un po’ di legna per stasera, dice poi trascinando i piedi fino a sparire dietro l’angolo che dà sul retro. Io corro dentro con qualcosa che mi accorcia il fiato e che cerco di scacciare o tenere a bada. Dov’è tuo cugino, mi chiede mia madre quando la incrocio sulle scale. Ora arriva, dico soltanto, e continuo a salire i gradini a due a due per poi infilarmi nella camera dei nonni. La luce debole della sera che viene disegna una lama di pulviscolo attraverso la stanza in penombra. Accendo la lampada sul comodino e levo dal cassetto la vecchia edizione della Bibbia rilegata in tela verde. Mi ripeto più volte il titolo di Alan Parsons che ho memorizzato, mentre giro impaziente le pagine ingiallite alla ricerca del passo giusto, di ciò che ancora mi sfugge e che di certo ha a che fare con quello che ci aspetta. Ma poi mi accorgo che quel passo non c’è. Sfoglio perplesso qualche pagina oltre per poi tornare a quell’ultimo versetto. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. Tutto qui.
Quando torno di sotto trovo gli altri di fronte al televisore acceso. Se ne stanno tutti in piedi, rigidi e muti, a formare un semicerchio alle spalle di mio padre, l’unico seduto davanti alla luce traballante dello schermo. Lo vedo scuotere la testa. Questi russi non ce la raccontano giusta, dice poi, con una voce che non pare la sua. Roberto entra dalla porta d’ingresso con un pesante cesto di legna ad allungargli le braccia. Che c’è, mi chiede subito leggendomi qualcosa in faccia. Non c’è nessun versetto trentadue nel primo capitolo della Genesi, dico io, non è mai stato scritto. Forse non ancora, dice lui abbozzando un nuovo sorriso che però gli va a male quasi subito. Io torno a guardare mia madre e gli zii che se ne restano in piedi davanti al televisore, grigi e immobili come statue di creta, o cumuli di polvere.
di Giovanni Dozzini

Chiese un trancio di pizza al salame piccante e si mise a sedere accavallando le gambe e scoprendo caviglie sottili e glabre fin quasi a metà stinco. Vestiva con una certa eleganza, i pantaloni di cotone color pesca, la camicia celeste avvitata, le scarpe sportive crema, il tocco naif di uno Swatch blu e nero con un cinturino che saliva appena sul bordo del polsino. Era un sessantenne molto preparato sul passato e, con ogni evidenza, meno sul futuro, perché tutto in lui tirava all’indietro, o meglio verso gli innumerevoli, per lui pressoché infiniti, punti del tempo in cui era stato più giovane e pieno di aspettative di adesso: non solo il look ma i modi, la camminata svelta, gli occhi in tralice con cui affrontava gli estranei o si preparava a sferrare una battuta, non per forza di spirito, con i conoscenti. Tipo il pizzaiolo, un ometto più vecchio di almeno una quindicina d’anni, zoppicante e un po’ in sovrappeso nella sua tenuta bianca rafforzata dal bianco dei ciuffi di capelli che gli crescevano ai lati della testa. Il posto era piccolo, ma quando l’uomo era entrato aveva già trovato altri due clienti, uno abituale, l’altro mai visto prima. Una volta scelta la pizza si era seduto teatralmente, poggiando un gomito sul tavolino e perlustrando le sagome delle tre persone che occupavano insieme a lui quei pochi metri quadrati. Si era naturalmente concentrato sullo sconosciuto, un ragazzo sui trentacinque anni, la barba castana a ricoprire una faccia allungata in cui due grandi e verdi occhi sporgenti sormontavano un grosso naso sefardita che gli pareva di avere già visto da qualche parte. Guardò poi il pizzaiolo, che però era impegnato a contare le monete finite nel cassetto scorrevole del registratore di cassa nel corso della mattinata, e non gli fece caso. Si sentì quindi squillare un telefono nel retrobottega in cui il vecchio doveva impastare la pizza e le focacce e farcirle prima di portarle di qua per infilarle nel forno, e una voce gracchiante da adolescente rispose masticando un nome incomprensibile per poi allontanarsi subito e trasformarsi in un riverbero lontano. Per l’uomo con lo Swatch fu una sorta di via libera.
-Mannaggia al clero- disse senza particolare enfasi, facendo dondolare una gamba sull’altra e scuotendo la testa, gli occhi che guizzavano qua e là per cogliere le reazioni della platea. Il ragazzo reagì non reagendo, rimanendo cioè apparentemente impassibile, le braccia incrociate, la barba ferma, i piedi piantati sul pavimento a scacchi bianchi e neri. L’altro cliente finì di svuotare la Peroni da 66 in un bicchiere di plastica trasparente e fece per accennare un sorriso dal quale poi desistette, il pizzaiolo afferrò un bicchiere dalla cima della pila che si ergeva sulla mensola di vetro dietro di sé e lo porse all’uomo. Lui però gli fece cenno di no.
-Questa è sua- disse, e si riferiva alla lattina di Coca Cola appoggiata sul tavolino. Intendeva dire che era del ragazzo, ora assorto nella contemplazione delle cartoline ammucchiate sulla parete. Il pizzaiolo allora annuì, allungò il bicchiere al ragazzo, che lì per lì non se ne accorse.
-Tu aspetti la focaccia?- gli chiese, sorprendendolo, e quello rispose di sì. La sorpresa era dovuta al fatto di essere entrato nel locale non più di due minuti prima, e di aver chiesto la focaccia non più, grossomodo, di un minuto e mezzo prima.
-Certo- disse il pizzaiolo, piegando la testa in avanti e affacciandosi nel vano scaldavivande. Si rigirava a malapena nell’intercapedine tra la parete e il bancone, ma dava ugualmente l’impressione di sentirsene il sovrano potente e indiscusso, e di sentirsi gratificato da quella consapevolezza. L’uomo con lo Swatch, ottenuto meno di quanto non avesse pensato con l’imprecazione di prima, si alzò in piedi e andò a prendersi una lattina di Coca Cola nel frigorifero all’angolo accanto alla porta. Aveva un bel volto, scavato sulle guance, gli occhi erano chiari di un chiaro che alla luce artificiale del locale appariva indefinibile, il naso piccolo e deciso, le labbra carnose anche se sbiadite. I capelli erano corti, brizzolati, nemmeno troppo radi.
-Devi farti operare, Carmelo- sentenziò –Così non ti si può più vedere-
Se ne tornò a sedere, ma il pizzaiolo non gli fece caso, perché la focaccia del ragazzo era pronta e gli toccava armeggiare con la paletta di metallo e i tovaglioli in cui avvolgerla. Afferrandola spostò anche la pizza al salame piccante, e decise che pure quella era pronta.
-Tieni- disse.
L’uomo dello Swatch si rialzò, prese la pizza, lo fissò.
-Hai capito quel che ti ho detto?-
-Ho capito. Ma è una cazzata- rispose Carmelo.
Il tizio della Peroni guardò il tizio dello Swatch, e stavolta sorrise. Se ne accorse anche il ragazzo, che s’era seduto pure lui e già affondava i denti nella focaccia ripiena di salsiccia e spinaci. Aveva appena aperto la lattina di Coca Cola, senza però versarne una sola goccia nel bicchiere.
-In una settimana sei a posto- disse l’uomo dello Swatch, ma Carmelo sbuffò.
-Neanche dopo cinque mesi sono a posto. Su dieci che si operano al ginocchio nove zoppicano come prima. Io manco morto- disse –Col cazzo che mi opero, io-
L’uomo con lo Swatch era di nuovo seduto, tutti e tre i clienti del locale adesso erano seduti, allineati, le schiene alla parete, le pizze o nel caso del ragazzo la focaccia in mano e i bicchieri e il da bere sui tavolini. Carmelo, oltre il bancone, sembrava un attore, o l’oratore di un minuscolo congresso sull’ortopedia. Ma quello che ne sapeva di ortopedia, là dentro, era un altro.
-Il problema è Perugia- disse l’uomo con lo Swatch –È l’ortopedia di Perugia. Se mi dici che si tratta di questo, Carmelo, ti capisco. Ti do ragione. Lascia stare Perugia, vattene a Milano. Al Galeazzi, devi andare. Se vai lì risolvi tutto-
Il pizzaiolo non rispose, e in quel momento la porta si aprì e fece il suo ingresso un uomo distinto dai tratti mediorientali. Aveva folte sopracciglia nere, la schiena curva, un’espressione dimessa e le mani in tasca. I capelli erano grigi, non troppo corti, folti solo sui lati e sulla nuca.
-Ah- disse Carmelo –Attenzione. Che adesso arriva Salvini e sono cazzi tuoi-
-Per la Madonna- disse l’uomo dello Swatch –È proprio vero-
Lo straniero borbottò qualcosa senza cambiare espressione, tolse una mano dalla tasca e si passò il palmo sul naso bagnato dalla pioggia.
-Piove?- gli chiese il pizzaiolo, e lui si limitò a indicare fuori dalla porta.
-Piove- ripeté Carmelo, e questa era un’affermazione –Ma non cambia niente. Se non ti fai mandare qualche documento dagli amici tuoi Salvini ti rispedisce a casa. Arabo del cazzo-
L’uomo con lo Swatch, a bocca piena, provò a obiettare, ma l’attenzione del pizzaiolo era già stata catturata dall’irruzione di un tizio stralunato che spuntò dal laboratorio brandendo il telefono in mano. Gli somigliava, lo stesso naso affilato e gli stessi occhi rapinosi, ma era troppo giovane per essere suo figlio.
-Nonno, ho preso un pastore maremmano- disse.
Era la voce gracchiante di prima, una voce da diciassettenne che in realtà apparteneva a un uomo che viaggiava perlomeno sul doppio di quegli anni.
-Porca Puttana!- urlò Carmelo –Tu sei matto. Non ci pensare neanche. Se ci provi io ammazzo te e il cane-
-Ma perché?- disse il ragazzo strascicando la “é” finale. In testa aveva un cappellino da baseball nero, senza loghi o scritte né niente. Per tutta risposta il pizzaiolo avanzò verso di lui minaccioso, costringendolo a indietreggiare e a rintanarsi nel laboratorio. Bestemmiava tra i denti, zoppicava, e passandole accanto afferrò la pala con cui infilava le pizze nello scaldavivande.
-Oh!- disse il nipote, senza urlare.
-Guarda che non scherzo- fece Carmelo sollevando la pala sopra la testa.
L’uomo dello Swatch intanto aveva finito di mangiare la pizza e di bere la Coca Cola.
-Carmelo- disse –Lascialo perdere. Dammi un altro pezzo di pizza. Però scaldamelo davvero, questo-
Lo straniero adesso era sulla porta, il naso quasi schiacciato contro il vetro. Guardava la pioggia scrosciare, la gente che passava riparandosi sotto gli ombrelli, quella che correva senza niente con cui proteggersi dall’acqua. Il ragazzo seduto al tavolo si chiese se stesse pensando alla casa lontana, il tizio della Peroni fissava il passaggio verso il laboratorio, da cui uscì il pizzaiolo claudicante, la faccia congestionata dalla rabbia. Dietro di lui si sentì una flebile bestemmia, infilò il trancio di pizza al salame piccante nello scaldavivande, cercò di ricordarsi a che punto era rimasto.
-Oh, arabo. Testa di cazzo. Hai capito o no?-
L’uomo si voltò, annuì, disse qualcosa di incomprensibile, e quello dello Swatch si pulì la bocca con un tovagliolo e schiarì la voce per riprendere a parlare.
-Guarda che lui non è arabo. Il Paese suo una volta andava alla grande-
Il pizzaiolo non gli diede troppa considerazione, digrignò i denti e puntò un coltello in direzione dello straniero.
-Attenzione a Salvini- gli disse.
-Erano ricchi- riprese l’uomo con lo Swatch- Erano civili. Erano messi meglio di noi-
Lo straniero sollevò appena una mano, in segno di approvazione, mantenendo però l’espressione imperscrutabile di sempre.
-Poi è arrivato Khomeini e ha fatto un disastro-
Quindi si alzò e raggiunse l’iraniano, gli diede una pacca sulle spalle.
-Bei tempi quando c’era lo Scià, vero?-
-Eh- rispose quello.
Carmelo intanto era tornato nel retrobottega, sciabattando, e aveva ripreso ad apostrofare il nipote senza curarsi dei clienti. Il forno emanava un calore che andava a folate, la scacchiera del pavimento rifletteva lo sfrigolio del neon e in certi punti registrava l’impressione delle scarpe dell’iraniano. L’uomo dello Swatch adesso si fermò per qualche istante davanti alla porta, come per riflettere su qualcosa d’importante, o cercare di ripescare qualche ricordo.
-Sì- disse poi –Gli ortopedici. Vattene al Galeazzi- disse rivolto al pizzaiolo –Al Galeazzi ti rifanno come nuovo-
Quindi si mise a raccontare la storia della figlia scoliotica.
-Adesso ha vent’anni, e quando ne aveva diciassette l’abbiamo fatta operare alla schiena. Scoliosi al 65%. A Perugia non hanno voluto metterci le mani. “Ve lo scordate”, c’hanno detto, “questa è inoperabile”. E allora siamo andati a Milano. Un amico ha parlato con un dottore del Galeazzi, e nel giro di un mese siamo andati su. È stata sette ore sotto i ferri, angelo mio. Ma dopo la scoliosi era al 20%, quasi non si vede più. Ed è anche diventata più alta. Dicono che con la rieducazione può scendere fino al 10%, in pratica scomparirà. Il problema è Perugia. L’ortopedia di Perugia non vale un cazzo-
Carmelo lo aveva ascoltato, ma senza smettere di maneggiare le pizze che il nipote aveva impastato e infornato. Lui le tirava fuori dal forno, le tagliava, spostava i tranci sul vassoio di metallo e li travasava sul ripiano di legno del bancone. L’iraniano lo osservava compiere quelle operazioni semplici, uguali a se stesse da almeno mezzo secolo, e sembrava piuttosto affascinato. Il pizzaiolo se ne accorse, e subito lo insultò.
-Maiale. Tanto prima o poi Israele vi rompe il culo-
Quello per la prima volta sorrise, e disse di no. Disse qualcosa a proposito degli americani e dei francesi, ma nessuno capì esattamente cosa. Parlava a voce bassissima, parlava in direzione del pavimento, e non stava mai fermo. Camminava curvo, con le mani incrociate dietro la schiena all’altezza dell’osso sacro, forse pensava alla Persia natia, forse no.
-E le donne- fece l’uomo dello Swatch –Com’erano belle le donne, prima di Khomeini. Facevano la bella vita, da voi. Che gli è successo alle vostre donne, dì un po’? Si sono imbruttite o è solo per via del fatto che adesso sono tutte coperte?-
-Sono coperte- disse l’iraniano, e stavolta si capì distintamente.
-Già- fece l’uomo dello Swatch, dandogli un’altra pacca sulla schiena.
A quel punto, inaspettatamente, intervenne l’uomo della Peroni. Era grasso, fulvo, sui quarantacinque anni, e aveva occhi tondi e giallognoli. La bottiglia era vuota, il bicchiere quasi. Aveva mangiato tre tranci di pizza, tutti margherita.
-Mia figlia- disse –è nata coi piedi torti. A Perugia non le han voluto fare niente. L’abbiam portata a Bologna, e lì le hanno risolto il problema-
-Operata?- chiese il tipo dello Swatch.
-Operata. A Perugia volevano farle mettere il gesso al Pronto Soccorso. Quando aveva cinque giorni. A Perugia in ortopedia non capiscono un cazzo-
-Esatto!- esclamò l’altro –Proprio così. A Milano, bisogna andare. O a Bologna. Ma meglio a Milano: il Galeazzi è il massimo. Capito, Carmelo? Devi andare a Milano-
-Per l’amor della Madonna!- quasi urlò il pizzaiolo –Tu sei matto. Col cazzo. Io a Milano non ci vado-
Ma l’uomo dello Swatch non si dava per vinto. -Mannaggia al clero, Carmelo – disse quindi – Quando fai così io non ti seguo proprio. Di che cazzo hai paura a ottant’anni suonati?-
-Ottant’anni ce l’avrà tua moglie- rispose il pizzaiolo –Non mi fare incazzare pure tu-
Riapparve quindi il nipote, sembrava somigliargli sempre di più. Aveva il cellulare in mano, e si avvicinò al nonno per fargli vedere la foto del cane.
-Dimmi se non è bello-
-Ancora?- urlò Carmelo –Allora non hai capito un cazzo-
-Lo tengo a casa del babbo. Perché no?-
-Perché i cani puzzano e cacano dappertutto. E costano un sacco di soldi-
-Ma questo me lo regalano-
-Come no- disse il pizzaiolo –Col cazzo che te lo regalano-
Il ragazzo cercò complicità in qualcuno degli avventori, ma nessuno lo stava guardando. Non l’iraniano, intensamente assorto in pensieri presumibilmente cupi, e non il tizio della Peroni, che ragionava sulla pioggia e sulla strategia per uscire e andare dove doveva andare senza infradiciarsi. Non il ragazzo con gli occhi sporgenti, che aveva roso metà focaccia e stava silenziosamente armeggiando col cellulare, e non il tizio dello Swatch, intenzionato a proseguire il suo discorso sull’ortopedia.
-Tanto lo prendo- disse infine, e dicendolo indietreggiò e si armò di un ghigno che fece infuriare il nonno ancor più di quelle tre misere parole.
-Porcaccia della puttana- disse, e lo inseguì cercando di accelerare il passo. Solo che il ginocchio gli doleva parecchio, e stavolta fu costretto a fermarsi prima ancora di arrivare alla fine della pedana di legno.
-Prima o poi ti ammazzo- disse piegandosi e portando una mano al ginocchio. L’uomo dello Swatch si fece avanti, con fare sardonico.
-Mi devi dare retta. Lo vedi che non riesci neanche a correre dietro a tuo nipote?-
-Dove non arrivo io c’arriva un colpo secco. Il Padreterno lo fulmina presto. Quel drogato del cazzo-
L’iraniano sorrise di nuovo, ma Carmelo non se ne avvide.
-Però almeno a Bologna- disse il tipo della Peroni –Milano no, ma Bologna? È vicina-
Forse tra di loro non c’era questa gran confidenza, forse il cliente in carne se n’era presa più del dovuto grazie ai due terzi di litro di birra che aveva ingurgitato tra un boccone di pizza e l’altro. Fatto sta che Carmelo non gli rispose male come avrebbe fatto con qualcun altro, tipo l’uomo dello Swatch, per esempio, per non parlare dell’iraniano o del nipote.
-Ho detto di no- si limitò a dire –Bologna o Milano per me è uguale. Io da Perugia non mi schiodo-
-E allora rimani storpio finché campi- fece quello con lo Swatch.
-Saranno pure cazzi miei- disse Carmelo.
-Certo- fece l’altro –Sai cosa me ne importa a me-
Fu allora che l’iraniano si spinse più in là di quanto lui stesso non avrebbe mai pensato. Si accostò al bancone, davanti al pizzaiolo, e lo fissò negli occhi. Improvvisamente sembrava aver perso la sua natura dimessa, la postura era ritta, vigorosa, le braccia poggiate sul vetro e quasi minacciose.
-Il cane sì- disse.
-Il cane cosa?- fece Carmelo, stupefatto.
-Il cane, tuo nipote. Digli sì-
-Ah- esclamò il pizzaiolo –Guarda tu questo. Viene a dirmi se prendere o non prendere un cane del cazzo in casa mia. Ma che cazzo ti salta in testa, testa di cazzo?-
L’iraniano strinse il pugno della mano destra lasciando fuori solo l’indice dritto. Lo puntava verso il vecchio, verso il petto abbondante che gli riempiva la maglietta bianca. Gli altri tre osservavano la scena con una punta di meraviglia, ma nessuno pensava che potesse realmente degenerare. Infatti non degenerò.
-Digli di sì- ripeté l’iraniano.
-Vaffanculo-
Squillò di nuovo un telefono, la stessa suoneria di prima, la stessa provenienza, e la stessa voce gracchiante da adolescente rispose remotamente.
-Portamelo alle cinque- si sentì dire –Ma almeno dieci euro per la benzina te li do-
-Hai un nipote obbediente- disse l’uomo dello Swatch –Un ginocchio fuori uso, ma un nipote obbediente. Forse fai bene a non volerti operare-
Carmelo nemmeno lo guardò, si guardò intorno, si piegò in avanti e spostò qualcosa che nessuno, al di qua del bancone, poteva vedere. Era un banchetto di legno, e quando ci si metteva a sedere, come era in procinto di fare adesso, lo faceva scomparire quasi per intero.
-Sapete che vi dico?- disse una volta poggiate le terga sul banchetto –Andatevene affanculo pure voi. Tutti e tre. Mio nipote, l’arabo, e voi tre. Vi conosco poco o niente, ma già mi state sul cazzo a sufficienza-
Si mise le mani sulle cosce larghe, del suo grosso corpo spuntava solo la testa, tagliata tra la bocca e il mento.
-Io mi sono rotto i coglioni- aggiunse, e si passò una mano sulla testa, sulla pelle lisa e macchiata dalla vecchiaia. Poi si mise a fissare il forno, il nero del forno, dove tutto era più o meno successo, dove aveva trascorso una vita intera a infilare impasti e tirar fuori pizze, il forno che aveva adoperato più di ogni altra cosa al mondo, che aveva comprato, aggiustato, buttato via, ricomprato, riaggiustato, ricomprato di nuovo, il forno grazie al quale aveva sfamato migliaia di persone e potuto sfamare anche se stesso e la sua famiglia, a partire da quella testa di cazzo drogata del figlio di suo figlio, che adesso impastava la pizza al posto suo e la faceva di merda, schifosa, terribile, tanto che non sapeva come facesse la gente a mangiarla ancora, la pizza di Carmelo, una volta era forse la pizza più buona della città e ormai era diventata la più schifosa. Gommosa, senza equilibrio tra i sapori, sbagliata in tutto e per tutto. Fissava il forno, e c’avrebbe ficcato dentro la testa, stavolta, in modo da farla finita una volta per tutte con quelle cazzate e quella gente che non sopportava più.
-Mi sono proprio rotto i coglioni- ripeté. Quando suo nipote fece ritorno, con passo molleggiato e trionfale, non ebbe nemmeno la forza di insultarlo.
-Vedrai che ti ci affezioni, nonno. Tu va a finire che ti ci affezioni sempre, ai cani-
Carmelo si tirò faticosamente su facendo leva con le mani sulle cosce, scostò il banchetto, guardò l’uomo con lo Swatch, che lo stava guardando, e gli fece l’occhiolino. Quindi prese il cellulare dalle mani del nipote, cercava la foto ma non si vedeva più. Così glielo ridiede. Fece i due passi che lo separavano dal registratore di cassa sbuffando per il dolore al ginocchio, aprì il cassetto e si mise di nuovo a contare i soldi.
Questo racconto è tratto da Giovanni Dozzini (a cura di), A casa nostra, lontano da casa, Aguaplano 2019 (con racconti di Pierpaolo Peroni, Giovanni Pannacci, Riccardo Meozzi, Caterina Venturini, Chiara Santilli, Stefano Baffetti, Gianni Agostinelli, Paola Rondini, Eugenio Raspi, Pasquale Guerra, Giovanni Dozzini, Antonio Senatore, Marija Strujic).
di Giuseppe Martella
4. Prove e messe in scena
Nel libro VIII dell’Odissea il re Alcinoo appresta il banchetto e i giochi in onore di Ulisse, chiamando Demodoco, rapsodo cieco, a cantare le gesta del ritorno degli eroi greci. In un rituale meticoloso, in cui si alternano danze, canti, libagioni e gare di destrezza, Odisseo viene pian piano irretito e sedotto, circuito egli stesso dalla potenza del culto, convinto a rivelare la propria identità narrando le proprie gesta. In questo seguito dettagliato di ripetizioni, sospensioni e riprese di gesti consueti, in questa esibizione cerimoniale, si vede bene come tecnica, rito e poesia siano intimamente connessi in quanto motori culturali.
di Francesca Matteoni
Land’s End – Cornovaglia

Così la terra finisce nel granito a picco sull’oceano. Là sotto le onde coprono e scoprono scogli aguzzi, la rovina di imbarcazioni e vite nei secoli. Le leggende dicono che fossero le streghe, sedute sulle sporgenze e le rocce di Land’s End, a far naufragare le navi e poi inviare i loro famigli canini a divorare le anime dei marinai annegati. Le possiamo immaginare accovacciate a parlare nel vento. In realtà nessuna strega di quelle finite nei documenti processuali è stata condannata per naufragi o altri cataclismi. Semmai per la morte di un cavallo da tiro, la malattia di un vicino, lo spegnersi di un neonato, una vacca che smette di dare latte – e ancora meglio se per vari di questi accadimenti, accumulati negli anni in cui la strega si costruisce la reputazione. Ma sulla scogliera le paure quotidiane incontrano il mito: la strega umanissima presta il corpo alla sua controparte soprannaturale dagli occhi spiritati color della tempesta. Questo è un punto mediano. Fra la terra e l’oceano. Fra l’acqua e la roccia. Nonostante i turisti, i camminatori, i surfisti che si dirigono alle piccole baie sabbiose come Sennen Cove, questo luogo non può essere addomesticato. Le rocce prendono nomi suggestivi, come la Irish Lady, un grande scoglio che sembra una creatura ammantata, rivolta all’Atlantico. Una dama irlandese nel senso fatato: una Banshee che geme e ammonisce, il cui sembiante è appena riconoscibile e sembra un drappo, una creatura di stracci svolazzanti e solenni. O i sedili dei giganti, i volti del tale o del tal altro, quasi scolpiti con un’intenzione dalle correnti. Ma nelle correnti non vi è nessuna intenzione che non sia loro stesse. La scogliera è una soglia. Sono già stata qui, vent’anni fa esatti, per l’eclissi di sole: con pochissimi soldi, lo zaino dell’inter-rail, trascorsi la notte nel sacco a pelo poco distante dai picchi, al riparo nella brughiera. Allora volevo solo andare altrove, con la bussola interiore puntata a nord, a queste lande che poi negli anni ho visitato spesso e abitato. Oggi imparo a stare sulla soglia come chi torna.

Viaggiare verso la regione sconosciuta è spesso viaggiare verso casa,
dice Tallis la ragazzina protagonista del libro che ho con me, Lavondyss dell’inglese Robert Heldstock. Cerco le parole e le storie del libro nella propaggine di occidente dove mi trovo. Il nome Lavondyss è il risultato di un incontro fra due isole leggendarie: Lyonesse e Avalon. Terre dove eroi e profeti toccati dalle fate dormono in attesa di un sogno che li riporti all’origine. Lavondyss è la foresta primigenia nata dalla congiunzione di sogno e paesaggio, dove la protagonista si spinge alla ricerca del fratello maggiore, smarrito anni prima in questi luoghi senza tempo o meglio – luoghi dove il tempo non scorre come siamo abituati a pensarlo, ma alterna rinascite, trasmutazioni cicliche del medesimo spazio e dei suoi ospiti che possono svanire o viaggiarci dentro. La forza del libro sta nei nomi che la ragazzina dà ai boschi e campi e terre lavorate che circondano il suo luogo natio: viaggerà sempre dentro di loro, attraverso ere diverse, indietro o avanti, attraverso corpi diversi – di donna, di vecchia, di legno e linfa. E i nomi sono incantesimi infantili e potenti: Vecchio Posto Proibito (Old Forbidden Place); Campo del Trovami Ancora (Find Me Again Field); e poi Landa dello Spirito Uccello (Bird Spirit Land), ovvero la landa sospesa fra la vita e la morte, fra la caduta del corpo e quel volo che fantastichiamo proprio dell’anima, non senza qualche sgomento. I nomi sono la nostra immaginazione che ci iscrive nei luoghi ed è difficile pensare a cosa siano prima di essi. Anche un campo senza nome per noi, quasi inconsapevolmente, può divenire il Campo Innominato o Innominabile, manifestando tutta la sua potenza.

Raccolgo una grossa piuma di gabbiano: la scogliera è una Bird Spirit Land. Gli uccelli marini sono i residenti elettivi, capaci di farsi portare su dal vento, gracchianti, predatori di altri piccoli uccelli, uova e pesci, raccolti a decine là sotto, su uno scoglio. Mi risuona dal libro la definizione che Tallis dà degli sciamani, prima di divenire lei stessa qualcosa di molto simile a una sciamana che ha attraversato paura, dolore e sconfitta:
Sono custodi e maestri di conoscenza. Conoscenza dell’animale nella terra. Nella visione, nella storia, nella scoperta dei sentieri.
Conoscenza dell’animale nella terra: con questa intuizione viene tradotta l’esperienza estatica, ovvero l’andar fuori di sé, all’oltremondo, che sorge metamorfico sulle tracce familiari di questo dove siamo. Non si tratta di andare via, ma di trovare vie, di immergersi, di ripercorrere, di stabilire punti di contatto con il noto, mentre siamo alla ricerca dell’ignoto. Conoscenza dell’animale nella terra – ovvero osservarlo fino a non sapere più nulla di lui, a non avere più pregiudizi, liberarlo dagli apparati simbolici. Sono già stata qui, dicevo, eppure non è qui che torno: sono diversa e il luogo è diverso. Ci cammino portando in lui la terra che anche io sono diventata, cerco di liberarmi da tutte le mie aspettative e perfino dai ricordi. Mi attrae ed entusiasma la prossimità dell’oceano poiché provengo dai monti e dalle colline, dall’interno che nel mio caso è anche un altro paese, a sud.
Esultanza è il recarsi
Dell’anima di terra al mare,
Oltre le case – oltre i promontori,
Nella profonda Eternità –
scriveva Emily Dickinson. E io so che ha ragione. Immagino sempre l’odore del mare, a un certo punto, mentre cammino in alto verso il mio bosco appenninico preferito. Immagino il suo cielo non interrotto. In “Poetry and the Mind of Indirection” un saggio all’interno di un altro libro che ho con me, Jane Hirshfield dice che:
per vedere il mondo davvero, abbiamo bisogno di una consapevolezza che si sia immersa in molto altro rispetto all’umano – che abbia viaggiato lontano dal domestico, dal familiare, dai limiti angusti dell’io. Nell’avviarsi su un simile sentiero, le difficoltà e durezze sono tutto quanto ci è promesso, tuttavia la conoscenza acquisita in un simile viaggio non è necessariamente tragica.
E ancora il poeta californiano Robinson Jeffers scrive:
Dobbiamo dislocare le nostre menti da noi stessi;
in-umanizzare un po’ le nostre prospettive, e divenire certi
come la roccia e l’oceano da cui sorgemmo.
Conia il termine unhumanize, in-umanizzare, ovvero guardare al mondo stupiti, recuperando quella che chiamiamo intimità, là, nelle sostanze elementali che formano e sostengono. In questo modo procede la lingua poetica e la possibilità di stare dove in effetti stiamo, invecchiamo e torniamo bambini, quasi senza saperlo.

Che cos’è la fine della terra? Una punta, uno scoglio, uno sprofondamento, una mancanza, una presenza altra che modula le voci nell’aria, un nome per domare l’indomabile. Una regione sconosciuta se decidiamo di non prendere il sopravvento. Una forma di esilio: non sono con gli altri che qui camminano come me, come me scattano foto, come me cercano forse il punto d’incontro fra il loro mondo e il mondo. Provenienza e approdo. Un silenzio che parla continuamente e assomiglia all’oblio. E nell’oblio un’interezza incomunicabile.
Torri – Appennino pistoiese

Ho preso casa in montagna nel mio paese paterno per tutta l’estate. Mi trasferisco qui quando non lavoro o non ho impegni di comunità nell’altro paese, a valle, dove abito. Nei mesi di giugno e luglio, durante la settimana, siamo pochissimi: i residenti che non arrivano a dieci e altri dalla città, per lo più pensionati. Da casa, in alto, raccolgo tutti i suoni. Sto finendo di scrivere alcune poesie su una montagna dove si sono rifugiati gli animali, fuori dal tempo, che significa sia in un tempo remoto che in uno a venire. Nella montagna gli animali parlano. Al di là sorge l’oceano o l’oltremondo. Come raccoglierò le loro voci?
Nel pomeriggio mi incammino verso il bosco sulla cima, al Prataccio. È un luogo che conosco bene: un rifugio per vagare, scrivere, leggere, suonare qualche strumento, stare così a far niente, scrutando l’abetaia o attraversando la faggeta che conduce a Forravernio e alle rocce interne, dove ci si affaccia su altri paesi occhieggianti nella macchia verde – Campaldaio, ad esempio. Ancora i nomi – come fai a sapere che la fine di un corridoio di faggi con le rocce esposte al sole è Forravernio? Che significa? Quanti Forravernio ci saranno nell’Appennino? O Casetta Bruciata o Collina o Lagacci. Ai margini della strada, prima di raggiungere l’entrata del bosco, crescono erbe e fiori, fra cui mi soffermo sull’iperico; i fusti alti del verbasco che sono le sentinelle dei boschi come mi ha insegnato la mia amica erborista Cecilia; la digitale bianca che spunta all’ombra, quasi alla fine del percorso, in un punto dove mi fermo per ascoltare il vento. Si forma un vortice d’aria fra gli abeti, che porta l’odore degli aghi e delle cortecce. E naturalmente dei merli, dei cuculi, delle cince che si mescolano qui alle foglie, sfuggono ai rapaci: il gheppio o la poiana. Anche se lo raccontassi molte volte questo specifico tratto di strada resterebbe un segreto: cosa sentirebbe qualcun altro? Come potrei convincerlo del potere che c’è qui? Non potrei e non dovrei. Non sono la traduttrice del vento. Sono un’ospite di lunga data, però – forse per questo a volte riesco a cavarne dei versi, delle parole. Questo tratto ultimo di strada stretta è la mia attesa, prima di riemergere sul burrone e sotto la calura, arrivare ai sassi dove ci si arrampica, si battono le mani per scoraggiare le vipere, ci si addentra, nasce il sentiero.
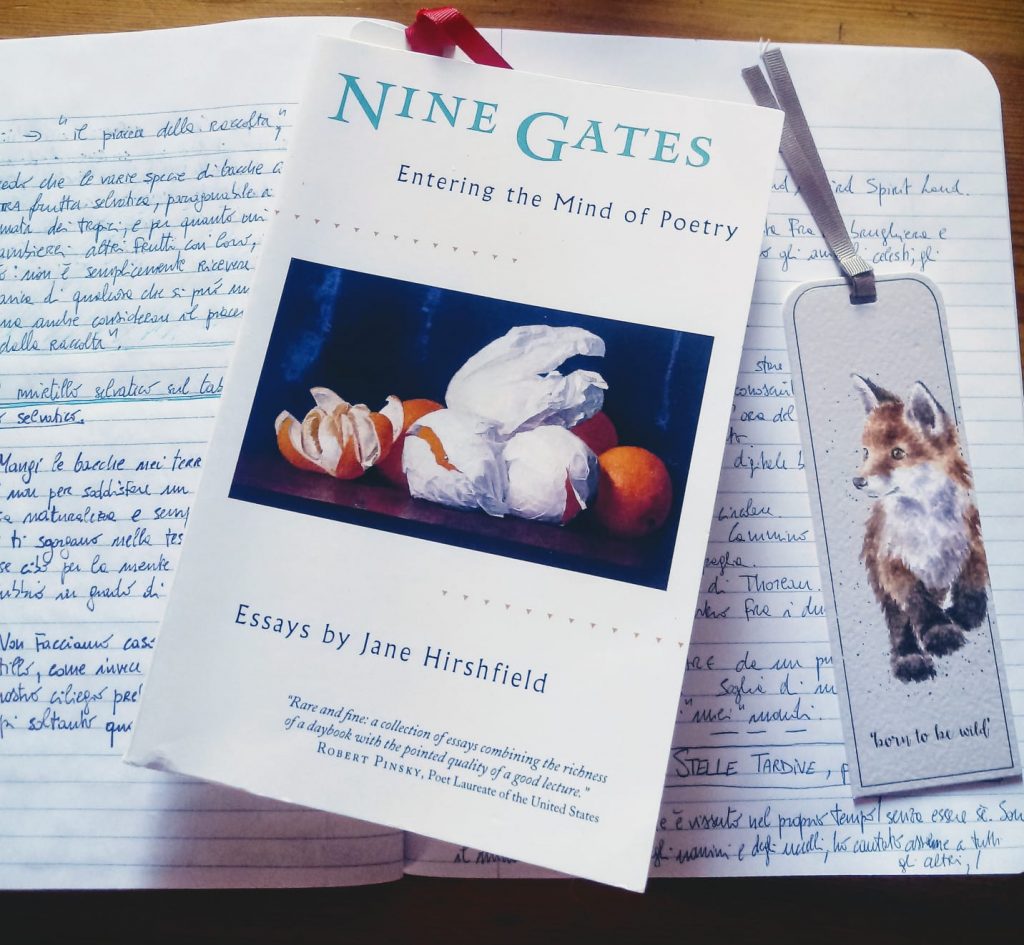
Qual è la natura di questo momento? Chiede la poesia e non abbiamo tregua finché la domanda non trova soluzione. Poi viene posta, di nuovo,
ancora Jane Hirshfield in un saggio sull’originalità. La natura dell’Appennino, della saggezza che cerco. Della solitudine densa di rumori e ogni rumore una domanda che ha in sé la risposta. Mi scopro a pensare che l’udito conta più della vista, che nel paesaggio siamo in attesa di decifrare una lingua: quanto vediamo è secondario, serve a calare la sostanza nella forma, ma la sostanza è il suono. Suono composto di tutte le vite che poi gli occhi si impegnano a riconoscere. Prima ascolta, poi guarda. Anzi vedi. Dicono le piante e canta quell’uccellino di cui non riconosco il verso. Ascolta per non essere più soltanto te.
Sono colui che è vissuto nel proprio tempo
senza essere sé. Sono il minore della famiglia
degli uomini e degli uccelli, ho cantato assieme a tutti gli altri
Leggo questi versi di una poesia di Arsenij Tarkovskij un giorno in cui è calato il freddo – piove e io resto a casa, con la finestra aperta perché la nebbiolina dai monti si sparga anche sul tavolo. Come si può vivere nel proprio tempo senza essere sé? È un bene o un male? È una perdita o una grazia? O entrambe? Anche io voglio essere la minore di questa famiglia da cui sono circondata. La più piccola, quella che non sa e per questo può ancora ricordare tutto. Mi viene in soccorso Libera, la bambina protagonista di una fiaba di Matteo Meschiari, L’ora del mondo, uscita a inizio estate. Figlia di tutto e di nessuno, è nata senza una mano, un difetto che può farne un’anomalia nella società, ma che ne fa una sciamana nel mondo dello spirito. Tutti gli sciamani erano toccati dalla diversità o dalla deformità, segno elettivo della loro prossimità allo straordinario nel quotidiano. Libera vive nell’Appennino modenese. Ne condivide l’antichità, pur restando una ragazzina, ha in sé i segni del luogo e di tutte le storie non scritte o dimenticate. Pastori di anime, semidei dai tratti teriomorfi come l’Uomo-Somaro, suo maestro che solo nella morte si ricompone completamente nell’animale; dei alteri e sprezzanti come una lince furtiva; creature-albero che mutano per sopravvivere e tramandare. Nell’Appennino, come in Lavondyss, si apre una regione ignota che conosceremmo bene, se solo volessimo svegliarci. Perché esso ci compone tanto quanto la carne o il respiro o l’osso, esso è tutto quello che amiamo. Ci sono Sedi e luoghi piccoli dove nascondersi dalle potenze, ci sono segreti e doni e pericoli che sono anche amici da tenere a distanza. Ho pensato che sapevo quello che stava accadendo a Libera, non perché io sia selvaggia come lei, ma ancora per quell’insieme di sillabe, quel vocabolo così importante – Appennino. Dove sono. Di cui ho nostalgia. Dove, per assurdo, sogno la costa estrema, l’odore del salmastro, la riva a nord, l’oceano. Dove posso rivivere tutte le mie mitologie – inventate, presunte, reali. Dove essere dimenticata e divenire montagna.
Loro sono i Pastori. Quando un’anima viene presa o lascia il suo corpo arrivano i Servitori Notturni. E la portano via.
E dove lo portano?
All’Albero Nero.
Non mi piace.
Non ti piace? Chissà quante volte l’hai visto ma non te lo ricordi. Io invece mi ricordo bene di te. La Neanderthal che non è scampata all’incendio della foresta. L’arvicola uccisa dal falco. La cerbiatta presa dal cacciatore villanoviano. La figlia del cacciatore e la nipote della nipote di sua figlia. La matriarca dei cinghiali con i suoi cento discendenti ai Taburri. La neonata morta di peste a Sant’Anna nel 1633. La cagna del dottor Bertocchi a Frassinoro. La gatta di Beata Monterastelli a Ospitale. E Libera la Selvaggia di genitori ignoti.

Questo dice il Mezzo Patriarca arboreo alla bambina, lei stessa luogo di incontro per le vite oltre i legami temporali. È vero che in noi risuonano più esistenze, che possiamo sentirci profondamente vicini a creature altre, sensibili a epoche remote, richiamati da paesi molto oltre l’orizzonte visibile, e non sappiamo spiegare perché. Lo si avverte in modo nitido lasciando in disparte l’umano, muovendoci verso il posto primigenio, ai primordi della nostra stirpe, qualsiasi essa sia. Con il sangue e le memorie familiari e i volti, si alzeranno in nostra difesa il greto del torrente, il rovo, la saltabecca, le case diroccate, gli occhi di una bestia boschiva, quel certo prato, quel preciso masso che ricopre appena una buca. Da cosa ci difenderanno? Non dal terrore, dai malanni, dalla morte. Dalla nostra impazienza.

Regione interna del Penwyth, Cornovaglia
Prendiamo l’autobus verso l’interno a poche miglia dalla costa. Siamo io e mia madre, la sua seconda volta in Cornovaglia, la mia quinta. Scendiamo nel piccolo villaggio di Madron, il cui nome rimanda a un presunto santo cristiano che ha incorporato qualche divinità celtica femminile. C’è una sorgente sacra qui, sgorga direttamente dalla terra in un boschetto: l’ho letto qualche mese fa in un libro di Sharon Blackie, che potrebbe rientrare nella categoria eco-femminismo, If Women Rose Rooted. L’autrice racconta che oggi il luogo è dismesso, pur se segnalato. Ci incamminiamo, è abbastanza facile trovarlo. Prima della fonte i soliti alberi a cui sono stati legati nastrini colorati, braccialetti, foglietti con preghiere e desideri. Se ne incontrano tanti nei luoghi sacri o magici dell’isola britannica. Ripenso a St. Nectan’s Glen, più a nord-ovest in questa stessa contea, o alla collina fatata ad Aberfoyle, nell’interno della Scozia.
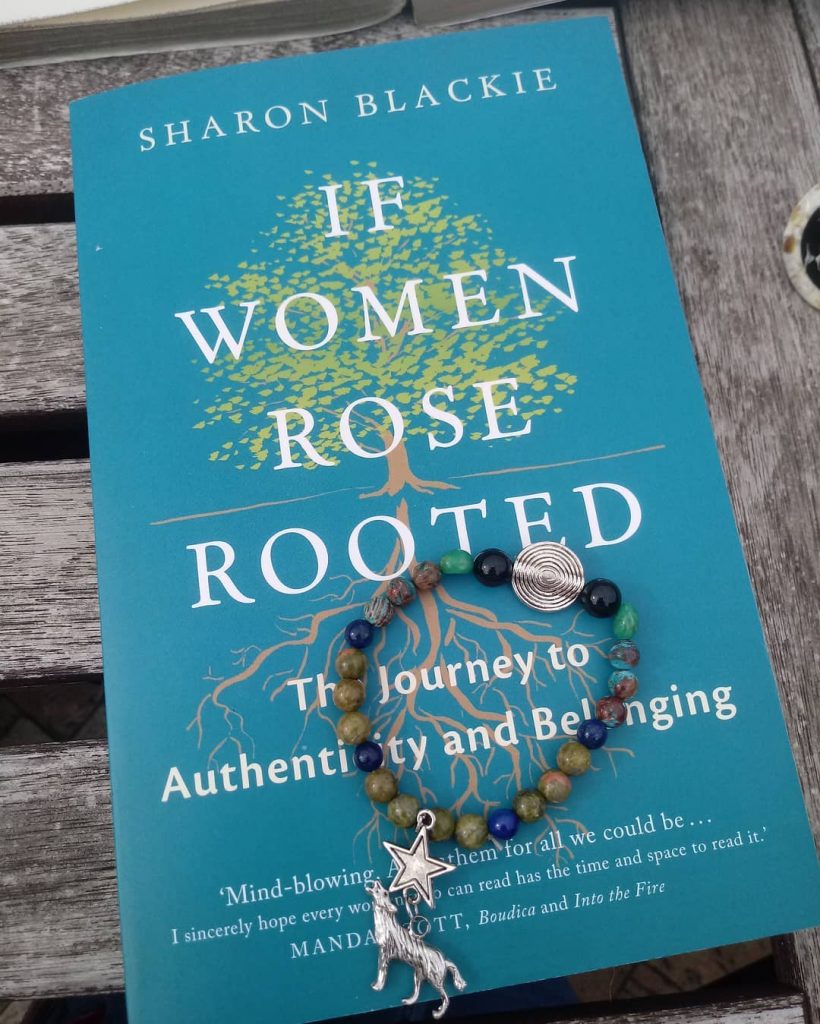
La fonte è prosciugata. Siamo già state avvertite da un gruppo di inglesi, arrivati qui con l’auto: “Spero non siate assetate. Non c’è più nulla”, ci ha detto l’uomo con tono sarcastico, di chi in fondo non ha molto interesse in ciò che ha visitato. Lo registro con fastidio. La fonte è protetta da una piccola cappella aperta, formata da quattro mura di pietra al cui interno ci si può sedere. Secondo la leggenda era custodita da nove vergini, nove donne dedite alla terra e ai suoi segreti. Ma ora l’acqua non sgorga – la calura eccessiva, il cambiamento climatico, l’incuria dell’umano odierno, per lo più curioso, incapace di capire perché nascono miti sulle fonti nel bosco, sugli alberi che le vegliano. Mi viene la tristezza, non scatto nemmeno una foto col cellulare. Riprendiamo il cammino verso Lanyon Quoit, uno dei dolmen della regione. Questa parte di Cornovaglia è ricca di monumenti megalitici e del loro mistero: a cosa servivano? Conosciamo le storie, la sorte che hanno avuto con l’arrivo del cristianesimo, ma sull’origine antica ci sono solo ipotesi non verificabili – essi sono lì da prima della scrittura, cancelli che si aprono per la nostra immaginazione. Tombe, templi, osservatori per le stelle. Penso alle Merry Maidens verso Land’s End, diciannove pietre disposte in cerchio. Le fanciulle allegre, dice il nome non senza un’ironia perfida. Questa è la leggenda cristiana. Diciannove fanciulle trasformate in pietra per aver osato danzare la domenica. Che assurdità.

La brughiera intorno è rialzata rispetto alla strada dove camminiamo, tenendoci vicine ai margini per evitare le rare auto. Ovunque, sui cigli, rovi, e nei rovi le more che cominciano a maturare. Le cogliamo: molte hanno un retrogusto aspro, dovuto alle vicinanza della costa. Mi ricordo quando da bambina ci inoltravamo fra i boschi con barattoli e pentolini di latta, alla ricerca di more, mirtilli, lamponi, fragole. Mangiarle così, dai rovi o dalle piante, era una grande soddisfazione: lo è ancora, anche se mi capita poco sulla mia montagna, perché… le lamponaie, i roveti e i mirtilli sono quasi del tutto spariti. Più facile che colga more camminando fra i paesi a valle, dove alcuni rovi sono stati piantati e hanno proliferato, e naturalmente ogni volta che viaggio in questi paesi d’estate: non manco mai di mangiarne mentre camminiamo, è quasi un rito. Accetto il cibo della terra come un dono.
(…) io credo che le vere specie di bacche costituiscano la nostra frutta selvatica, paragonabile a quella più rinomata dei tropici, e per quanto mi riguarda non scambierei altri frutti coi loro, perché il punto non è semplicemente ricevere una nave carica di qualcosa che si può mangiare e vendere, ma anche considerare il piacere che si ricava dalla raccolta.
Scrive Henry David Thoreau in un prezioso saggio, Mirtilli, che ho letto recentemente. Parla del mirtillo americano, certo, ma io lo paragono alle mie more e ai miei lamponi, al rovo che ho avuto nell’orto della casa materna per molte estati. Quando seccò mio nonno impiegò un giorno intero a sradicarlo – pianta tenace, difensiva, generosa. Penso spesso alla poesia che ricerco come a un rovo, carico di spine, di frutti asprigni e dolci. Continua Thoreau:
Mangi le bacche nei terreni aridi su cui crescono non per soddisfare un appetito, ma con la stessa naturalezza e semplicità con cui i pensieri ti sgorgano nella testa, come se fossero esse stesse cibo per la mente, essiccato di per sé, e senza dubbio in grado di nutrire il cervello.
Il suo elogio delle bacche è un inno al gratuito, allo scambio, al godere della natura, all’apprendere nei suoi campi come nella più entusiasmante delle scuole, portando rispetto per coloro che ci camminavano prima di noi, per le altre vite senza prezzo. Imparare a riconoscere chi abita un luogo. Cercare i nomi originari, come, nel caso americano, quelli dati dai nativi alle piante e non quelli importati dai vocabolari greci e latini d’Europa. Addentrarsi. L’opera è anche una condanna al sistema moderno, dove vale solo ciò che è monetizzabile: i bambini nei campi e nei boschi a tingersi le mani di succo violaceo sono roba da sciocchi, da passeri, da animali invisibili. Ma la natura ha vie che riescono ad aggirare i nostri interessi… quasi sempre.
Non facciamo caso al pettirosso che becca un mirtillo come invece facciamo quando il volatile visita il nostro ciliegio preferito, e la volpe si aggira nei campi soltanto quando siamo lontani.

Quante cose accadono mentre non siamo lì, non siamo presenti! Eppure sono proprio queste le cose che dovremmo sforzarci di raccontare. Come? Tornando a immergerci, a scrutare l’orizzonte, a percepire i rumori, a scomparire nel giallo o nel verdastro dei campi. Bacche – cibi delle fate. Se ne mangi nulla sarà più come prima, sarai perduta, perduta! Per sempre incantata dagli esseri del crepuscolo, che intrecciano nodi nei crini del cavalli e cavalcano lepri. Quegli stessi esseri che si aggirano tra i megaliti di cui nessuno sa più cosa fare, se non scattare una fotografia. Quegli esseri che aspettano nei miei boschi, sull’Appennino, anche se nessuno ci crede. Raccolgo i frutti, li assaggio, mi perdo con consapevolezza.

Lanyon Quoit non è lontano, ma sotto il sole del mezzogiorno è una conquista: io e mia madre pranziamo lì. Siamo sole per un po’. I turisti sono nei villaggi pittoreschi dei pescatori, sulle spiagge, nei locali della costa – le dico che è normale: anche quando ho viaggiato nelle regioni più a nord e interne della Cornovaglia ho incontrato poca gente. Certo le persone arrivano a piccoli gruppi durante la giornata, spesso in auto e per pochi minuti. Non si paga un biglietto. A volte penso sia questo, in una società distorta dove il valore è dato dal costo, non dall’esperienza, a rendere un posto poco invitante. Arrivano due coppie di stranieri, poi una famiglia locale con il cestino del pic-nic. Noi vorremmo raggiungere Mên an Tol, la pietra forata, il monumento megalitico più singolare della zona, che sappiamo non molto distante. Potremmo riprendere la strada asfaltata, ma cerchiamo la scorciatoia nella brughiera, che vediamo indicata sulla nostra cartina topografica.
Una coppia francese ci soccorre: vengono proprio da lì. Ci indicano la direzione, ci dicono che sì, c’è una specie di sentiero, sommerso dalla sterpaglia. Ci avviamo ed è una piccola avventura. Il paesaggio sembra sempre uguale a se stesso e racconto a mia madre che i folletti che abbondano nei negozi di souvenir, quali portachiavi o calamite, i pixie, piskie, pesky, pigsy, e via dicendo, non sono affatto innocui omini, buoni come ricordo delle vacanze: è qui che vivono, dispettosi e irascibili, mimetizzati, pronti a condurre fuori strada il viaggiatore che incautamente metta il piede sulla loro zolla. Io ho i miei amuleti, le dico, scuotendo i braccialetti, e quindi a noi non succederà niente. Mia madre scuote la testa, rassegnata. Arriviamo al rudere della vecchia miniera di Ding Dong: sotto la torre, in una buca nella pietra hanno gettato di tutto fra lattine e confezioni di plastica. Qualche cornacchia svolazza, chissà se prova rabbia verso di noi. Molto distante scorgiamo la sagoma di un cairn, un’antica tomba, ma è tardi e non pensiamo di raggiungerlo.

Ci sono tre sentieri striminziti dietro la miniera – mia madre conduce decisa, seguendo la sua cartina. Attraversiamo altri sterpi, un piccolo fosso segnalato sulla mappa. E in pochi minuti –la pietra forata. Una giovane coppia di francesi si aggira per lì. Li guardo: lei è incinta e a me viene un sorriso. Mên an Tol, che significa proprio “pietra forata”, è formato dai resti di un monumento dell’Età del Bronzo, forse era una vera a propria struttura, un tempio o una tomba, di cui la pietra poteva essere l’ingresso. Ma la verità è che non lo sapremo mai. Quello che sappiamo è quello che ho letto tanti anni fa nei testi di Mircea Eliade sulla storia delle religioni e in altri libri di tradizioni celtiche. Passare attraverso la pietra per nove volte, con un giro antiorario, garantiva alle donne di restare incinta o di portare a termine felicemente la loro gravidanza, ed era un atto curativo per varie malattie, soprattutto deformità e rachitismo. Vado a memoria, ma non credo di sbagliare. La pietra rinsalda, fortifica, fissa e aggiusta quanto è fragile. Salutiamo la coppia. Quando restiamo sole passo anch’io per il foro e così fa mia madre. La giornata è splendida, l’orizzonte ampio, siamo nel passato ancestrale dell’umanità ed esco dai miei libri, dalle suggestioni che mi hanno guidato fin qui, esco, metaforicamente, come rinascendo dal foro in una pietra circolare. Dimentico quello che so. Cerco quello che sono e dove le due realtà si incrociano. Da una parte della pietra questa brughiera sollevata che si estende in una coda fino agli scogli e all’oceano e rovi di more ai margini; dall’altra una lamponaia sepolta, dei faggi magici, un bosco che a volte risuona come le onde, lassù, nel centro dell’Appennino.

[Ospito qui una partitura poetica tratta da Datità di Giovanna Frene, dal titolo Per l’operazione subita, insieme ad una nota critica sul libro scritta da Elisa Vignali ]
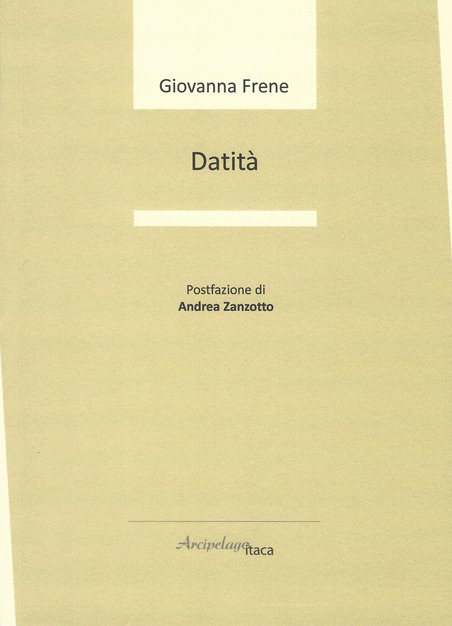
Per l’operazione subita
siamo per noi stessi
la stessa immagine per gli altri
sia da vivi che da morti
di Giorgio Mascitelli

Che il personaggio di Sordello, il poeta già presente nel Purgatorio dantesco, si trovi anche nel Baldus potrebbe essere tranquillamente letto come un localismo: il mantovano Folengo che in un’opera ambientata in parte anche a Mantova evoca un genius loci per nobilitare la materia macheronica. Forse però le cose non stanno del tutto così.
Sordello da Goito appare alla fine del terzo libro del Baldus. Baldus ancora ragazzino sta per essere arrestato dal bargello e dai suoi sbirri per aver ucciso a Mantova nel corso della festa delle calende di maggio un assalitore. Lo stesso Baldus chiede a Sordello di essere giudice nella contesa con la sbirraglia e ovviamente l’antico trovatore darà ragione a Baldus e anzi lo prenderà sotto la sua protezione. Folengo lo descrive come ormai vecchio, ma sostanzialmente secondo i canoni di rappresentazione della tradizione letteraria: insomma il Sordello del Baldus non è a prima vista troppo diverso da quello dantesco e agisce e parla con aristocratico senso dell’onore e della giustizia. Intima al bargello di lasciare il ragazzo, ma questi vuole procedere con l’arresto e portarlo in città da Cipada. Allora Sordello riprende la parola e, approfittando del fatto che si è radunata una piccola folla di contadini per assistere alla contesa, denuncia con vigore la malvagità e la corruzione degli sbirri, costringendo il bargello a rinunciare al suo proposito.
Sebbene egli riconosca in Baldus un suo pari travestito da contadino, per salvarlo richiama la natura di oppressi dei contadini di fronte al potere poliziesco e cittadino, inaugurando così un’inedita alleanza tra valori aristocratici e mondo contadino oppresso. Ovviamente parlare di valori aristocratici qui significa parlare di ideologia cavalleresca, ossia l’aristocrazia degli squattrinati e dei secondogeniti, e probabilmente significa parlare con più precisione di valori umanistici. La scena dello pseudocomizio è descritta da Folengo secondo i dettami dell’arte macheronica e dunque il poeta ci informa che Sordello è sì vecchio, ma si tiene bene tant’è vero che non sputa o scoreggia involontariamente come fanno gli altri vecchi. La vecchiaia e la saggezza rette da giusti valori dovrebbero consigliare e guidare il giovane Baldus, che non a caso si è messo nei guai durante la festa di primavera. Ma si sa che le cose nella vita non vanno mai così lisce e la vecchiaia è anche debolezza. Sordello nel quarto libro, chiamato a Mantova a difendere Baldus da nuove accuse, dovrà confessare i limiti della sua protezione, che è anche una paternità spirituale, perché gli manca la forza ormai di lottare contro il pretore della città. Difatti tre giorni dopo morirà o per il dispiacere o per l’avvelenamento procurato dallo stesso pretore Gaioffo.
Le sue ultime parole nel poema sono emblematiche: “At plures video de vobis torcere testam,/nasutosque mihi oranti deducere nasos./Sat bene nunc vestri pensiria nosco magonis,/ quare nolo meas ventis gittare parolas./ Quam doleo quod longa bovi paleria vecchio/ iam mihi nunc pendent, quam quod mihi bolsa cavalla est./ Non animus, fateor, mancat, sed forza volavit.” ( IV,vv. 542-548: ma vedo che molti di voi girano la testa e allontanano da me che chiedo i loro nasi arricciati. Ora conosco abbastanza bene i pensieri del vostro magone perciò non voglio gettare al vento le mie parole. Ciò di cui mi lamento è il fatto che una lunga giogaia pende a me vecchio come ai buoi, e che la mia cavalla è bolsa. Non mi manca il coraggio, lo confesso, ma la forza se ne è andata). E’ una drammatica confessione d’impotenza che prelude alla morte ed è sorprendente che Folengo con un lingua dalle connotazioni comiche come il macheronico regga anche questa confessione così drammatica. La morte di Sordello potrebbe essere una sorta di passaggio di consegne allo stesso Baldus di quei valori, ma in realtà non è così perché al vecchio trovatore è mancato anche il tempo per istruire il suo pupillo. Allora quella morte rappresenta la morte dei valori umanistici, che non sono più patrimonio della cavalleria e non trovano nel mondo contadino chi li possa riprendere. La specificità di Folengo non sta però nella dichiarazione della fine del mondo cavalleresco, o meglio della fine dell’ideale di quel mondo, della qual cosa non mancano certo esempi illustri anteriori, contemporanei e posteriori, ma nel fatto che venga cercata come estrema salvezza di quei valori l’accordo con quella parte della società, i contadini, che è senz’altro la più lontana nella gerarchia sociale. Infatti la dichiarazione della fine della cavalleria, e più in generale della fine di un’idea aristocratica della vita, non è certo una caratteristica del solo Baldus, come si è detto, ma piuttosto una contraddizione interna dell’umanesimo che riprende, in realtà trasformandolo, un ideale aristocratico di vita proprio nel momento storico in cui la borghesia europea comincia la sua lunga ascesa che terminerà con il 1789 o il quarantotto. E’ invece peculiare di questo poema l’idea che tale concezione della vita possa essere ripresa solo dagli ultimi ed è comprensibile che sia isolato in ciò: chiedere alla plebe contadina, alla schiuma della società di comportarsi aristocraticamente significa essere per la rivoluzione. Il problema storico è che non c’è nessuna rivoluzione ( al massimo il sogno di questa per chi non sa che Lutero si è subito messo d’accordo con i principi), il problema letterario è che Sordello ormai vecchio muore senza poter correggere Baldus. E muore con pathos il combattente irriducibile, il poeta satirico che prende in giro i potenti ( gli storici hanno restituito un’immagine del Sordello reale, come era lecito aspettarsi, piuttosto diversa, ma qui è in questione il Sordello personaggio letterario introdotto da Dante), che anche nel Purgatorio non si piega a domandare favori per la propria anima, muore con il pathos, e la disperazione, di chi si deve arrendere (forza volavit, fateor ) perché non ha più energie.
Sordello richiama ai termini della loro oppressione i contadini, benché essi siano avidi e creduloni, come li descrive Boccaccio, il cittadino e borghese Boccaccio, e vorrebbe prestare loro un po’ della sua coscienza di sè, conferire loro la sua dignità come strumento di lotta, ma non è possibile, non ci crede nessuno, nemmeno Folengo temo. E Sordello paga questo errore con la sua incomprensibilità per i posteri. Infatti un curioso destino lo attende: Sordello viene rievocato anche in un grande romanzo del XX secolo, il Molloy di Beckett, quando ormai la civiltà cittadina del lavoro ha trionfato da tempo. In un passo di questo romanzo Sordello viene confuso, ovviamente dal protagonista non dall’autore, addirittura con Belacqua, il personaggio dantesco che incarna la pigrizia; la confusione è giustificabile per un moderno, entrambi i personaggi nella Divina Commedia evidenziano una certa indolenza non affannandosi a venire incontro al poeta e alla sua guida, anche se una simile confusione avrebbe sorpreso non poco Folengo e Dante. Molloy, uno dei barboni beckettiani, si paragona a Belacqua o Sordello, non si ricorda neanche lui bene, perché pigrizia e nobile ritegno si confondono inevitabilmente nell’epoca dell’etica del lavoro (e a maggior ragione ancor di più nell’epoca dell’autoimprenditorialità).
Questa incomprensibilità di Sordello rispetto ai criteri ideologici del moderno e del postmoderno illumina anche l’incomprensibilità del macheronico. Non alludo qui alla difficoltà linguistica di questa mescolanza lessicale e sintattica di italiano, dialetto lombardo e latino, ma a un’incomprensibilità radicale di un linguaggio che nella sua alterità comica mantiene una tensione utopica, certo nel senso bachtiniano del carnevalesco. E una prova di tale tensione è offerta da quei pochi versi riportati sopra in cui un linguaggio comico, pastoso e scurrile riesce a tenere anche in un contesto di drammatica serietà. L’incomprensibilità del macheronico dunque è più radicale di quella linguistica ed è relativa al senso stesso della sua scelta come lingua e al significato della sua comicità. L’incomprensione è del resto il destino che tocca a coloro che hanno provato a percorrere vie che si contrapponevano a quelle dominanti e non sono riusciti a farcela, ai perdenti che non hanno potuto realizzare neanche un brandello della propria utopia. E’ un prezzo da pagare pesante, ma è il rischio che bisogna correre talvolta per giungere a testimoniare la propria porzione di verità.
 Nota a cura
Nota a cura
di
Alida Airaghi
Di Nichita Stanescu, in Italia sappiamo pochissimo.
Nato a Ploiești, in Romania, nel 1933, compì i primi studi nella città natale, quindi si trasferì a Bucarest, dove si laureò in letteratura, sposandosi tre volte e collaborando per tutta la vita a varie testate giornalistiche. Come poeta debuttò nel 1960 con la raccolta di versi Sensul iubirii (Il senso dell’amore); il suo ultimo libro uscì nel 1982, un anno prima della morte, provocata dalla grave epatite di cui soffriva a causa dell’abuso di alcol. Vinse diversi premi letterari (Premio Herder nel 1976, Premio Struga nel 1982…): nonostante la diffidenza riservatagli dalla politica repressiva di Ceausescu e lo stigma sociale da cui veniva segnato per il suo inquieto anticonformismo, anche in patria si riconosceva e celebrava la forza innovativa e sperimentale dei suoi versi, lontani da ogni retorica e propaganda civile.
Stanescu è riuscito infatti a creare nella scrittura un universo immaginario in cui ideale e fantastico convivono con realismo e concretezza, utilizzando un linguaggio inedito e straniante, che sa prendersi gioco delle regole grammaticali, servendosi di neologismi e connessioni discordanti, di non semplice decifrazione, per raggiungere effetti di giocosa visionarietà.
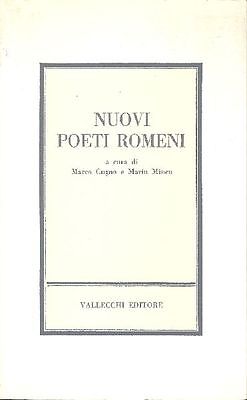 Se nelle sue liriche hanno una netta prevalenza i temi amorosi (ma sempre dirottati verso un simbolismo surreale e talvolta grottesco, nemico di ogni facile tono idilliaco), sono pure frequenti le rielaborazioni di concetti filosofici e teologici, il recupero di miti classici, l’interesse scientifico per la fisica e la matematica, l’invenzione costante di un’esistenza parallela (distopica, diremmo oggi), che si fa beffe della logica razionale, smontando la realtà in un insieme di fenomeni non ricomponibili, come in un puzzle impazzito, e accomunando i suoi testi all’arte astratta più labirintica e alienata.
Se nelle sue liriche hanno una netta prevalenza i temi amorosi (ma sempre dirottati verso un simbolismo surreale e talvolta grottesco, nemico di ogni facile tono idilliaco), sono pure frequenti le rielaborazioni di concetti filosofici e teologici, il recupero di miti classici, l’interesse scientifico per la fisica e la matematica, l’invenzione costante di un’esistenza parallela (distopica, diremmo oggi), che si fa beffe della logica razionale, smontando la realtà in un insieme di fenomeni non ricomponibili, come in un puzzle impazzito, e accomunando i suoi testi all’arte astratta più labirintica e alienata.
Nei versi qui riprodotti, ad esempio, è evidente l’interesse per la mutazione delle forme, in un interscambio continuo tra mondo vegetale e animale, che confonde il piano mentale con l’ossessione di sentimenti perturbanti, in una metamorfosi costante di ciò che è materia in spirito, e viceversa.
L’unico volume di Nichita Stanescu pubblicato in Italia è La guerra delle parole (con testo a fronte), uscito nel 1999 da Le Lettere, curato da Fulvio Del Fabbro, e tradotto da Fulvio Del Fabbro e Alessio Tondini, e oggi introvabile. Possiamo tuttavia recuperare alcune poesie in antologie o in rete, proposte e commentate da studiosi di letteratura romena.
Quinta elegia
La tentazione del reale
Non sono mai stato adirato con le mele
perché sono mele, con le foglie perché sono foglie,
con l’ombra perché è ombra, con gli uccelli perché sono uccelli.
Ma le mele, le foglie, le ombre, gli uccelli
si sono improvvisamente adirati con me.
Eccomi portato al tribunale delle foglie,
al tribunale delle ombre, delle mele, degli uccelli,
tribunali sferici, tribunali aerei,
tribunali tenui, freschi.
Eccomi condannato per ignoranza,
per tedio, per irrequietezza,
per inerzia,
Sentenze scritte nell’idioma dei noccioli.
Atti di accusa timbrati
con viscere di uccello,
fresche contrizioni grigie, apposta per me.
Sto in piedi, la testa scoperta,
tento di decifrare ciò che mi spetta
per ignoranza,
e non posso, non posso decifrare
nulla,
e questo stato d’animo, esso stesso,
si adira con me,
e mi condanna, indecifrabile,
ad una perpetua attesa,
ad una tensione dei significati in se stessi,
fino a buscarsi la forma delle mele, delle foglie,
delle ombre,
degli uccelli.
**
Chiaro di cuore
Le ore fluttuano accanto alla tua spalla,
sfere azzurre, e fra di esse c’è Saturno.
E mentre trascorrono, diminuiscono
più serali e più notturne.
Non mi dispiace, non mi dispiace per loro.
Dritta come stai, il loro passare
quasi infantile e soave
brilla nel tuo occhio immobile.
E mi dimentico di loro, te ne dimentichi anche tu,
e nell’oscurità della stanza si accendono,
si spengono, si accendono, si spengono
i tuoi occhi allungati, morendo,
risorgendo.
**
Segno 12
Lei era divenuta pian piano parola,
fili di anima nel vento,
delfino negli artigli delle mie ciglia,
pietra che disegna anelli nell’acqua,
stella dentro il mio ginocchio,
cielo dentro la mia spalla,
io dentro il mio io.
**
L’abbraccio
Quando ci siamo intravisti, l’aria fra noi
ha gettato d’un tratto
la sua immagine degli alberi, indifferenti e vuoti,
da cui si lasciava attraversare.
Oh, ci siamo lanciati, chiamandoci per nome,
l’uno verso l’altro, e così velocemente,
che il tempo si è schiacciato fra i nostri petti,
e l’ora, colpita, si è frantumata in minuti.
Avrei voluto conservarti tra le mie braccia
così come tengo il corpo dell’infanzia, nel passato,
con le sue morti irripetibili.
E avrei voluto abbracciarti con le costole.
**
Storia sentimentale
Poi ci vedevamo sempre più spesso.
Io stavo su un margine dell’ora,
tu – sull’altro,
come due manici d’anfora.
Solo le parole volavano tra noi,
avanti e indietro.
Il loro volteggio si vedeva appena,
e di colpo
piegavo un ginocchio
e conficcavo il gomito nella terra,
solo per vedere l’erba inclinata
dalla caduta d’una parola,
come sotto la zampa d’un leone in corsa.
Le parole ruotavano, ruotavano tra noi,
avanti e indietro,
e più t’amavo più
ripetevano, in un volteggio appena visibile,
la struttura della materia, da capo.
**
Altra matematica
Sappiamo che uno per uno fa uno
ma un unicorno per una pera
non sappiamo quanto fa.
Sappiamo che cinque meno quattro fa uno
ma una nube meno un vascello
non sappiamo quanto fa.
Sappiamo, noi sappiamo, che otto
diviso otto fa uno
ma un monte diviso una capra
non sappiamo quanto fa.
Sappiamo che uno più uno fanno due
ma io e te non sappiamo,
ahimè, non sappiamo quanto facciamo.
Ah, ma una coltre
per una lepre
fa una rossa, certo,
una verza divisa una bandiera
fa un maiale,
un cavallo meno un tranvai
fa un angelo,
un cavolo più un uovo
fa un astragalo…
Solo tu ed io
moltiplicati, divisi
sommati e sottratti
restiamo uguali…
Muori nella mia mente!
Tornami nel cuore!
**
Al nord del nord
Anche ciò che non esiste può morire,
come la vita di un animale boreale
del cui stato crepuscolare
non ho mai saputo niente.
Appariva talvolta
nel tuo modo di camminare,
ma ero troppo sonnolento per vederlo.
Cantava talvolta nelle tue occhiate
quando guardavi attraverso di me
alla mia adolescenza.
Ti allungava talvolta la mano.
Aggiungeva al tuo odore
il soave odore di decomposizione
d’uno scheletro di fiocco di neve.
Mai ne ho sentito la presenza
nemmeno in questo secondo
che infreddolito sono di colpo solidale
con tutto ciò che non esiste.
Ahi, anche ciò che non esiste può morire.
**
Poema
Dimmi, se un giorno ti prendessi
e ti baciassi la pianta del piede,
non è vero che dopo zoppicheresti un po’,
per paura di schiacciare il mio bacio?
∗∗∗
Le non-parole
Lui ha teso verso di me una foglia come una mano con le dita.
Io ho teso verso di lui una mano come una foglia con i denti.
Lui ha teso verso di me un ramo come un braccio.
Io ho teso verso di lui il braccio come un ramo.
Lui ha piegato verso di me il suo tronco
come un melo.
Io ho piegato verso di lui la spalla
come un tronco nodoso.
Sentivo la sua linfa accelerare pulsando
come il sangue.
Sentiva il mio sangue rallentare salendo come la linfa.
Io sono passato attraverso di lui.
Lui è passato attraverso di me.
Io sono rimasto un albero solo.
Lui
un uomo solo.
 di Gianni Biondillo
di Gianni Biondillo
Alberto Rollo, Un’educazione milanese, 320 pagine, Manni editori, 2017
Come si forma una persona? Grazie a chi o cosa? I genitori, gli amici, gli incontri fortuiti, gli ambienti frequentati, le strade percorse… non è tutto questo, in una parola, la città stessa dove si è vissuti?
Il protagonista di questo libro – né romanzo, né saggio, letteratura ibrida, che usa i ricordi personali per renderli condivisi – aspetta l’arrivo della metropolitana che lo deve riportare a casa. Questo frangente ctonio diventa la metafora di una condizione della memoria profonda, che scava nelle viscere del passato.
Alberto Rollo, l’autore e protagonista di Un’educazione milanese, ritorna ai momenti necessari, formativi della sua infanzia e giovinezza. Trova nella città operaia delle fabbriche, dei cavalcavia, dei cantieri, delle periferie, nella Milano del dopoguerra e del boom il suo paesaggio interiore, la definitiva lezione esistenziale.
Essere milanesi, in quegli anni, significava appartenere a una classe sociale, sentirsi parte di un progetto di emancipazione collettiva, guardare al futuro con ottimismo. Un’educazione milanese ha in molte pagine il passo del romanzo familiare – quello che rammenta i nonni emigrati dal sud, o i lavori umili dei genitori – in altre quello del romanzo di formazione – le nuove amicizie adolescenziali, l’impegno politico negli anni dell’università, la perdita tragica di amicizie fraterne.
Ma su tutto, è la condizione di milanesità che Rollo cerca di dimostrare. Giganteggia, in questo senso, la figura del padre, il metalmeccanico comunista dalla morale integerrima, dal quale per ribellione giovanile il protagonista cerca di emanciparsi. Rendendosi conto, ora, seduto su quella panchina della metropolitana, con gli anni di suo padre allora, quanto gli sia riconoscente. A lui e alla città che pullula sulla sua testa.
(precedentemente pubblicato su Cooperazione numero 37 del 12 settembre 2017)
di Vincenzo Celano
Smarrito, confuso nella città di Firenze, come colui che ha perso le coordinate del tempo e dello spazio, Anice comprava ogni giorno il giornale con immutata puntualità, ma non riusciva più a leggerlo. Lui, che pure scriveva per alcuni importanti periodici, intratteneva ora con la carta stampata un rapporto particolare, parecchio somigliante a quello di un dongiovanni rimbambito che, ritrovandosi quotidianamente disponibile un’invitante ragazza, ogni volta s’affretta più che può a spogliarla per abbandonarsi subito dopo all’ebete contemplazione dei nei scoperti sulla fresca pelle di lei, senza fare neanche un tentativo di andare più oltre.