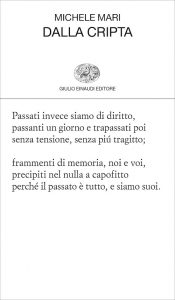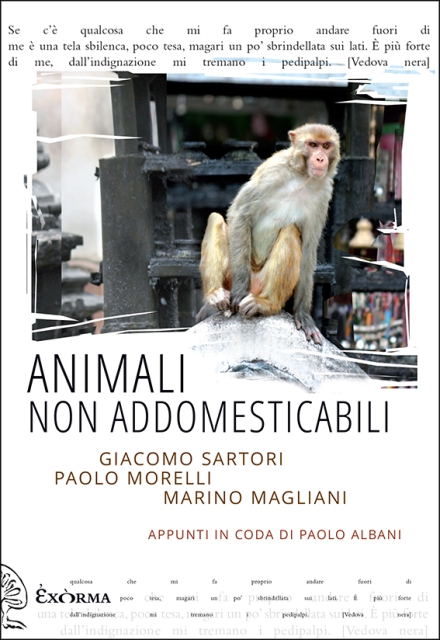di Hernán Ruiz
Già da alcuni anni diversi esponenti del circuito intellettuale argentino praticano un nuovo sport: criticare Julio Cortázar. Queste critiche si accentuarono nel 2004 quando, in occasione del novantesimo anniversario della nascita e ventesimo della morte, fu organizzata una serie di omaggi con ripercussioni internazionali (mostre itineranti, riedizioni integrali, premi letterari, cicli di conferenze, proiezioni di documentari e film basati sulla sua vita e sulla sua opera) che rivitalizzarono la centralità dei suoi testi. Gli attacchi cominciarono a popolare lentamente le riviste letterarie, i blog di scrittori emergenti, le interviste radiofoniche e televisive.
Alle vecchie questioni motivate dalla presunta artificialità con la quale irrompe il politico-testimoniale nella sua scrittura, si aggiungevano le più recenti. Lo si svalutava identificandolo come scrittore d’iniziazione, che asseconda il senso di ribellione adolescente e il cui successo tra le giovani generazioni si deve principalmente alla sua affascinante capacità inventiva. Però questa fascinazione, instabile e deteriorabile, si sarebbe dimostrata incapace di influire in modo decisivo su produzioni letterarie specifiche. Quasi all’unanimità sostengono che “Il gioco del mondo (Rayuela)” è un testo invecchiato e dicono, con ironia, di aver letto Cortázar ormai molto tempo fa, riprendendolo solo per avere la conferma che la sua opera soffre ormai del passare del tempo. Riconoscono che i suoi racconti sono di buona fattura ma lo accusano di cercare sempre il grande effetto.
Se a queste aggiungiamo le critiche di alcuni operatori culturali reazionari, che asseriscono che la sinistra è ormai talmente anchilosata da non essere in grado di fare altro che riesumare e rileggere fino allo sfinimento sempre le stesse figure, scopriamo che il contesto per recuperare un libro perduto di Cortázar non potrebbe essere migliore. Un tentativo che per il suo innegabile anacronismo è già irrimediabilmente condannato dall’inizio.
Cronaca della scomparsa
Nel 1983, alcuni mesi prima di morire, Cortázar pubblica due libri: Los autonautas de la cosmopista e Nicaragua tan violentamente dulce. I diritti d’autore di entrambe le edizioni furono ceduti alla rivoluzione sandinista nicaraguense.
Los autonautas oggi forma parte di quel corpo cortazariano continuamente rieditato; Nicaragua, al contrario, è scomparso. E la cosa è piuttosto curiosa perché non è stato cancellato completamente, persiste come ricordo in qualunque biografia, in ogni riassunto bibliografico e sono pochi i lettori di Cortázar che non ne conoscono l’esistenza, così come sono pochi quelli che hanno potuto leggerlo; semplicemente perché il libro non c’è. Non c’è nelle librerie e neppure nelle biblioteche, non c’è nelle università né nei caffè letterari. Non c’è.
Il primo di questi due libri fu scritto in collaborazione con la sua ultima moglie, Carol Dunlop, dopo un viaggio di 33 giorni che tra maggio e giugno del 1982 fecero insieme percorrendo la transitata autostrada Parigi-Marsiglia. L’esperienza, condizionata da rigide regole che si autoimposero, riprendeva lo scenario de La autopista del sur, racconto iniziale di Todos los fuegos el fuego, del 1966. La prima edizione di questo diario di viaggio romanzato si pubblica grazie alla casa editrice spagnola Muchnik e alla francese Gallimard.
Il secondo, invece, viene pubblicato da Editorial Nueva Nicaragua, fondata nel 1981 dalle autorità del Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale (FSLN), che nel 1979 aveva rovesciato il regime dittatoriale della dinastia Somoza. Una seconda edizione nicaraguense arriva nel 1985, dopo che la casa editrice Muchnik pubblicò un anno prima l’edizione spagnolo-argentina; Cortázar riuscirà a vedere il volume stampato dal suo amico Mario Muchnik qualche giorno prima della sua morte, avvenuta a mezzogiorno di domenica 12 febbraio dello stesso anno. Muchnik lancerà un’ultima edizione nell’87. Verranno effettuate anche due traduzioni in tedesco (1984/85) e una in inglese (1989). Alcuni frammenti furono inseriti, da altre case editrici, all’interno di un numero limitato di antologie di testi politici dell’autore. Poi basta.
Mentre lo cercavo disperatamente, ho creduto plausibile che il libro non esistesse. Ho anche sospettato che le varie citazioni incontrate fossero un deliberato errore incoraggiato dall’autore, un messaggio inintelligibile o un desiderio che non era riuscito a realizzarsi.
Mi sono ricordato allora della favolosa storia di una poetessa argentina, che comincia nei primi anni ‘60, durante un viaggio a Jujuy. Un passeggero aveva dimenticato sul sedile che le era stato assegnato un romanzo di Italo Svevo che lei non conosceva. Le era stato impossibile non dedicare tutto il resto del viaggio a quella lettura nella quale si era immersa profondamente, sentiva di essersi incontrata per la prima volta con il bello, di aver aspettato di leggere o di scrivere quel libro da sempre. Nella sua unica intervista che ancora si conserva racconta che forse pensando ad un possibile ritorno del proprietario forse solo per incapacità di reazione di fronte ad un incontro dirompente, lasciò il libro sul sedile e scese dall’autobus. Non riuscì a ritrovarlo mai più. Cercò quel titolo in ogni possibile nascondiglio, lesse tutta l’opera di Svevo, studiò rigorosamente l’italiano, i suoi dialetti e un po’ di tedesco, partì per la Penisola e si stabilì a Trieste per più di tre anni, ebbe accesso a manoscritti inediti, lesse il diario di Elio, fratello minore di Svevo, insegnò letteratura nelle Università di Padova, Milano e Bologna, ebbe figli ingegneri indifferenti alla letteratura; e quell’incontro con Svevo non si ripeté mai più. Come Bartleby, preferì non continuare a scrivere. Prima di quella rivelazione aveva composto una dozzina di buone poesie che le valsero un certo prestigio. Quel viaggio a Jujuy era di sicuro il primo invito a partecipare ad un festivalnazionale di poesia; dedicò tutto il suo intervento a parlare di quel libro del quale nessuno dei presenti aveva notizia.
Una minuscola tipografia, sospesa sulla montagna nel lillipuziano borgo ligure di Apricale, stampò alla fine degli anni ‘80 una cinquantina di copie di un suo romanzo con il quale interruppe per l’unica volta il silenzio. Il libro perduto di Italo Svevo, questo è il titolo dell’esperimento mediante il quale l’autrice tentò di recuperare, riscrivendolo, il testo scomparso dell’autore di Senilitá. Molti hanno visto in questa esperienza la reincarnazione di Pierre Menard, autore del Quijote, il racconto di Borges nel quale si narra la storia di uno scrittore francese che all’inizio del XX secolo affronta il monumentale compito di scrivere, con precisione assoluta e senza avere la possibilità di confrontarsi con l’originale, l’opera massima di Miguel de Cervantes. Di sicuro le differenze sono molte. La poetessa argentina, forse per lo svantaggio di essere reale, non solo era meno ambiziosa, ma sentiva in modo senz’altro più urgente la necessità di quel recupero. Il suo libro era scritto in un castigliano rioplatense che risentiva di alcune differenze rispetto alla traduzione madrilegna trovata e perduta venti anni prima. Ma la differenza più importante è che alla poetessa anonima non interessava scrivere il libro di Svevo, voleva ripercorrere quello che aveva sentito nel leggerlo. Menard, pensava che il Quijote fosse trascurabile; lei, aveva la certezza che in quel libro si celasse il mondo.
Mi perdevo in questi confronti e spiegazioni inverosimili quando finalmente incontrai un collezionista che mi allontanò da tutte queste teorie di cospirazione e progetti esagerati; possedeva una prima edizione di Nueva Nicaragua, comprata a Cuba all’inizio degli anni ‘90. Seppi da lui che anche a L’Avana era difficilissimo trovare il libro. La rete informatica delle biblioteche argentine mi fece sapere che solo tre biblioteche erano riuscite a rispondere alla mia richiesta: la biblioteca del Congreso de la Nación, un’Università privata di Buenos Aires, e l’Università di Tandil. L’Istituto spagnolo Cervantes e la sua smisurata rete mondiale di biblioteche, che dalle sue 900 e più postazioni di lettura permette la consultazione di circa 700.000 volumi, dispone soltanto di sette esemplari, uno di questi in inglese, disseminati a Lisbona, Praga, Tangeri, Rabat, Dublino e New York. Il libro esiste, l’accessibilità alla sua lettura no.
Come si spiega che non abbia resistito questo ultimo libro che Cortázar vide pubblicare in vita, dove confluiscono i suoi sforzi per integrare la creazione letteraria con il progetto di una rivoluzione che credeva fosse necessaria e difese anche a discapito della sua produzione precedente? Di sicuro, non è il meglio della sua opera, ma è importante in relazione ad un’analisi completa che permetta di ricostruire l’itinerario di uno scrittore che comincia abbandonando l’Argentina all’inizio degli anni Cinquanta perché gli altoparlanti di una manifestazione popolare peronista disturbavano l’ultimo concerto di Alban Berg e termina nella Cuba castrista, nel Cile di Allende e nel Nicaragua sandinista.
In Nicaragua sopravvisse una notevole quantità di esemplari del libro, ciò che non sopravvisse fu la rivoluzione. Nel 1990, a seguito di elezioni svoltesi in un clima difficile originato principalmente da un embargo economico letale e dagli attacchi dei contras finanziati dagli Stati Uniti, le forze sandiniste persero il potere, e la casa editrice Nueva Nicaragua la possibilità di ripubblicare un libro i cui diritti le appartenevano. Il movimento che Cortázar aveva visto risorgere e trionfare, gli uomini che erano stati protagonisti delle sue cronache, non furono in grado di sostenere un processo che soffrì dei colpi delle innumerevoli crisi, e che alla fine terminò perdendo l’appoggio popolare.
NdR: il frammento che precede è tratto “da Frequentazioni mancate – Walsh, Cortázar, Lezama Lima. Letteratura e rivoluzione in America Latina”, Unicopli, 2008.
NOTA BIOGRAFICA
Hernán Ruiz è nato a Rosario, Argentina, nel 1977. Studioso di letteratura contemporanea ha affrontato di recente il tema del legame tra scrittura e politica nella narrativa latinoamericana. Attualmente insegna lingua spagnola e traduzione a Milano presso le Università Iulm e Cattolica e presso la Scuola per Mediatori Linguistici “Carlo Bo”.

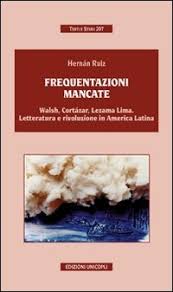
 di Massimo Raffaeli
di Massimo Raffaeli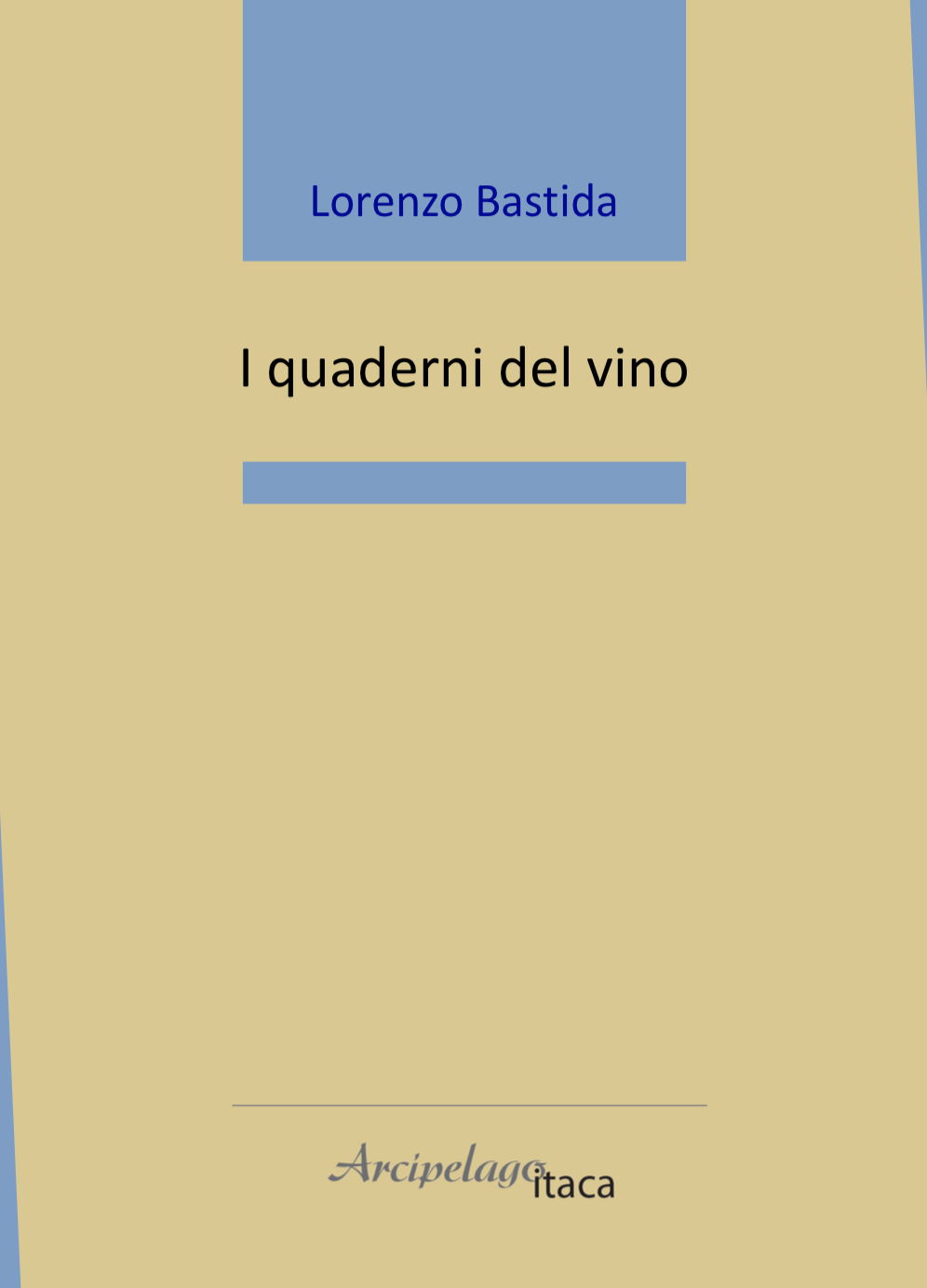




 di Francis Ponge
di Francis Ponge




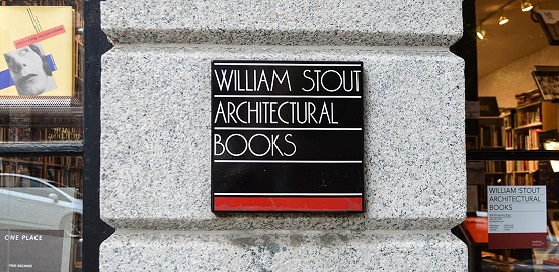 di Gianni Biondillo
di Gianni Biondillo
 Non è un problema di stile. Non è perché le case del Movimento Moderno, pensate come macchine da abitare (a detta di Le Corbusier), non sappiano essere emozionanti. Lo si capisce quando il progettista e il committente si incontrano nella stessa persona. Come nel caso più unico che raro di Casa Cattaneo a Cernobbio. L’edificio fu progettato nelle migliori delle condizioni di libertà creativa per il giovane progettista. Cesare Cattaneo, appena laureato, aveva ricevuto in regalo il terreno dove poter edificare senza alcun vincolo quello che più desiderava. La casa fu pensata fin nei suoi più intimi particolari, con una meticolosità fanatica. Una sorta di modello in scala 1:1, un enorme prototipo che doveva dimostrare la forza poetica del linguaggio moderno, la sua realizzabilità (siamo negli anni trenta del secolo scorso), la sua intrinseca qualità. Nulla fu lasciato al caso, ogni tema sviscerato: il negozio a doppia altezza al piano terra, quello che si apre sulla città, gli appartamenti ai piani superiori, la terrazza all’ultimo piano affacciata sul panorama lacustre. Progetto libero da condizionamenti perché non tenuto, come ebbe a dire Cattaneo stesso, a “soggiacere alla volontà tirannica dei clienti”. Un capolavoro che purtroppo non ha avuto seguito essendo Cattaneo morto giovanissimo. (Mi sono accorto che gli architetti o muoiono molto giovani, vedi Sant’Elia o Terragni, oppure vecchissimi, come il quasi centenario Giovanni Michelucci o l’ultracentenario Oscar Niemeyer. Avendo io superato da bel po’ la giovinezza mi auguro sempre più convintamente di appartenere alla seconda categoria).
Non è un problema di stile. Non è perché le case del Movimento Moderno, pensate come macchine da abitare (a detta di Le Corbusier), non sappiano essere emozionanti. Lo si capisce quando il progettista e il committente si incontrano nella stessa persona. Come nel caso più unico che raro di Casa Cattaneo a Cernobbio. L’edificio fu progettato nelle migliori delle condizioni di libertà creativa per il giovane progettista. Cesare Cattaneo, appena laureato, aveva ricevuto in regalo il terreno dove poter edificare senza alcun vincolo quello che più desiderava. La casa fu pensata fin nei suoi più intimi particolari, con una meticolosità fanatica. Una sorta di modello in scala 1:1, un enorme prototipo che doveva dimostrare la forza poetica del linguaggio moderno, la sua realizzabilità (siamo negli anni trenta del secolo scorso), la sua intrinseca qualità. Nulla fu lasciato al caso, ogni tema sviscerato: il negozio a doppia altezza al piano terra, quello che si apre sulla città, gli appartamenti ai piani superiori, la terrazza all’ultimo piano affacciata sul panorama lacustre. Progetto libero da condizionamenti perché non tenuto, come ebbe a dire Cattaneo stesso, a “soggiacere alla volontà tirannica dei clienti”. Un capolavoro che purtroppo non ha avuto seguito essendo Cattaneo morto giovanissimo. (Mi sono accorto che gli architetti o muoiono molto giovani, vedi Sant’Elia o Terragni, oppure vecchissimi, come il quasi centenario Giovanni Michelucci o l’ultracentenario Oscar Niemeyer. Avendo io superato da bel po’ la giovinezza mi auguro sempre più convintamente di appartenere alla seconda categoria). Ogni casa, insomma, porta con sé una storia, un mondo. Spesso mi accorgo quanto un appartamento mi dica molte cose di chi lo vive. Gli oggetti quotidiani, gli arredi, i quadri o le fotografie ai muri, ci vestono, ci rappresentano, esattamente come quando indossiamo un abito. Perché ogni casa, dal ricco maniero al monolocale in affitto, assomiglia alla persona che la abita. Anche qui il gioco delle etimologie può tornare utile. “Persona” deriva da Per Sonar, la maschera in legno che serviva a rafforzare il suono della voce nel teatro antico. La casa è innanzitutto la creazione di un ambiente ideale. Ma “ambiente” viene da Ambire, cioè andare attorno come l’aria, o come le persone attorno alle quali si vive. Quindi quando si abita una casa si indossa una maschera che dà un’idea di sé a se stessi e al mondo circostante. Oggi, in un mondo di risorse scarse, abitare significa stare in una casa sostenibile, ecologica. Inevitabilmente, mi viene da chiosare, dato che “Ecologia” deriva dal greco Oikos logos, “discorso sulla casa”: lo studio delle relazioni fra l’umano e il mondo vivente.
Ogni casa, insomma, porta con sé una storia, un mondo. Spesso mi accorgo quanto un appartamento mi dica molte cose di chi lo vive. Gli oggetti quotidiani, gli arredi, i quadri o le fotografie ai muri, ci vestono, ci rappresentano, esattamente come quando indossiamo un abito. Perché ogni casa, dal ricco maniero al monolocale in affitto, assomiglia alla persona che la abita. Anche qui il gioco delle etimologie può tornare utile. “Persona” deriva da Per Sonar, la maschera in legno che serviva a rafforzare il suono della voce nel teatro antico. La casa è innanzitutto la creazione di un ambiente ideale. Ma “ambiente” viene da Ambire, cioè andare attorno come l’aria, o come le persone attorno alle quali si vive. Quindi quando si abita una casa si indossa una maschera che dà un’idea di sé a se stessi e al mondo circostante. Oggi, in un mondo di risorse scarse, abitare significa stare in una casa sostenibile, ecologica. Inevitabilmente, mi viene da chiosare, dato che “Ecologia” deriva dal greco Oikos logos, “discorso sulla casa”: lo studio delle relazioni fra l’umano e il mondo vivente. Stiamo domesticizzando lo spazio pubblico. Alcuni oggetti di culto della casa moderna, novecentesca e borghese, sono perfettamente inutili per le nuove generazioni. Fate un test (io l’ho fatto con le mie figlie): fra televisore e computer vince il computer. Fra computer e smartphone vince lo smartphone. Tutto si miniaturizza, diventa etereo. Oggi l’infrastruttura necessaria, indispensabile, in ogni casa, in ogni città anzi, è il Wi-Fi.
Stiamo domesticizzando lo spazio pubblico. Alcuni oggetti di culto della casa moderna, novecentesca e borghese, sono perfettamente inutili per le nuove generazioni. Fate un test (io l’ho fatto con le mie figlie): fra televisore e computer vince il computer. Fra computer e smartphone vince lo smartphone. Tutto si miniaturizza, diventa etereo. Oggi l’infrastruttura necessaria, indispensabile, in ogni casa, in ogni città anzi, è il Wi-Fi.