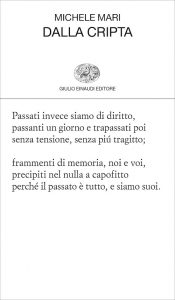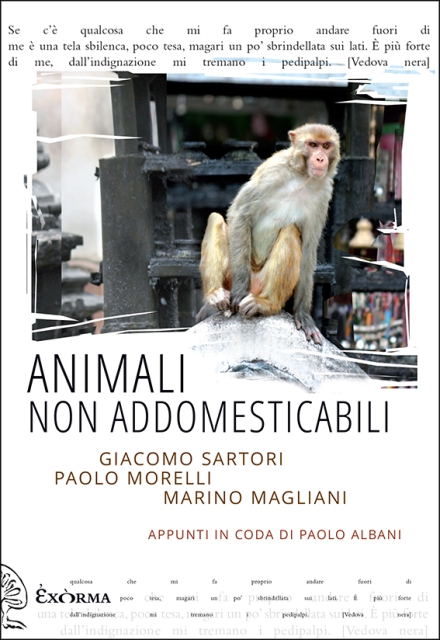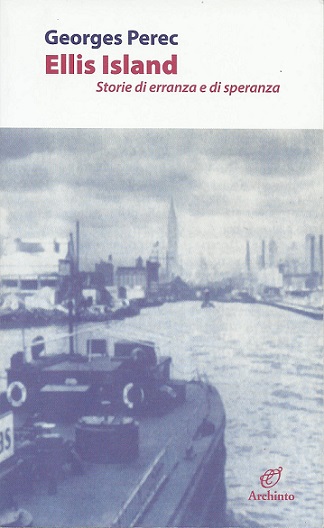 di Romano A. Fiocchi
di Romano A. Fiocchi
Georges Perec, Ellis Island. Storie di erranza e di speranza, Archinto, 2017.
Pochi sanno cosa sia Ellis Island. A scuola non te lo insegnano. A scuola ti parlano soltanto di quella migrazione in massa di milioni di europei verso un mondo dove c’era libertà, democrazia, lavoro. E allora l’immagine più comune scolpita nella memoria collettiva è il grido che Baricco mette in bocca ai passeggeri del Virginian che per primi avvistano la Statua della libertà: l’Americaaaa!
Ma l’America era altro. In primo luogo era Ellis Island. Tra il 1978 e il 1980 Georges Perec e il regista Robert Bober cercarono di capire cosa fosse e soprattutto lo documentarono in un lungometraggio che fu trasmesso nel novembre 1980 dalla rete francese con il titolo: Récits d’Ellis Island. Histoires d’errance et d’espoir (alcuni spezzoni sono reperibili su YouTube, mentre il video completo è acquistabile in versione DVD sul sito dell’Ina, l’ente nazionale francese incaricato di archiviare le documentazioni audiovisive). Quello che fecero, Bober con le immagini e Perec con il testo della voce fuori campo, fu raccontare come tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del secolo successivo, in alcuni edifici appositamente costruiti su un isolotto alla foce dell’Hudson, a un passo da Manhattan, oltre sedici milioni di emigranti vennero trasformati in oltre sedici milioni di Americani. Il testo di Perec, pubblicato in Francia, uscì nell’edizione italiana solo nel 1996 grazie alla traduzione di Maria Sebregondi, in un volumetto verde della collana Gli Aquiloni di Rosellina Archinto. Poi, come tante pubblicazioni di Perec, sparì dal mercato. (La sparizione è un motivo caro a Perec, ricordiamoci che fece sparire la lettera “e” da un intero romanzo…)
Nel 2005 Ellis Island riapparve parzialmente in rete: una decina di pagine tradotte dal nostro Andrea Inglese, uscite appunto su Nazione Indiana, qui. Mentre il 10 maggio 2017 Laura Barile rievocava il fascino di questo testo su Alfabeta 2, l’Archinto S.a.s. lo ripubblicava e ricolmava il vuoto editoriale. È stato così che l’ho trovato, rovistando sulle scaffalature della Libreria del Mondo Offeso.
Ellis Island è un prezioso libretto di settantadue pagine composto di due parti: L’isola delle lacrime, una sorta di introduzione storica, e Descrizione di un cammino, la parte più corposa e poetica. Perché Perec, fedele alla sua scrittura, riesce a fare della poesia attraverso la semplice elencazione di oggetti, luoghi, persone: “All’inizio, si può solo provare a nominare le cose, una per una, semplicemente, enumerarle, censirle, nel modo più banale possibile, nel modo più preciso possibile, cercando di non dimenticare niente”. Tanto meno i numeri, quelli più impressionanti: cinque milioni di emigranti provenienti dall’Italia, quattro milioni dall’Irlanda, un milione dalla Svezia, sei milioni dalla Germania, tre milioni dall’Austria e dall’Ungheria, tre milioni e cinquecentomila dalla Russia e dall’Ucrania, cinque milioni dalla Gran Bretagna, e così via. Tutta gente disperata che per i più svariati motivi scappava dal vecchio continente. Poi elenca le compagnie di navigazione (compresa la nostra Italian Line), i porti di partenza (i nostri: Palermo, Napoli, Genova, Trieste), i nomi dei piroscafi (i nostri: Umbria, Lusitania, San Giovanni, Giuseppe Verdi, Duca degli Abruzzi), la raffica incalzante delle ventinove domande che bersagliavano l’emigrante: Come si chiama? Da dove viene? Perché viene negli Stati Uniti? Quanti anni ha? Quanti soldi ha? Dove li tiene? Me li faccia vedere. Chi ha pagato la sua traversata? eccetera. Sì, perché i soldi erano una garanzia: chi viaggiava in prima o in seconda classe veniva ispezionato a bordo da un medico e da un ufficiale di stato civile, e sbarcava senza problemi. Gli altri sostavano a Ellis Island sino a passare il controllo degli ufficiali sanitari che segnalavano i casi sospetti tracciando una lettera con il gesso sulla schiena: C la tubercolosi, E gli occhi, F il viso, H il cuore, K l’ernia, L la claudicazione, SC il cuoio capelluto, TC il tracoma, X il ritardo mentale. Il sospettato avrebbe prolungato la sua permanenza a Ellis Island per accertamenti più minuziosi, talvolta sino ad essere respinto.
Tutti insomma passarono da Ellis Island. Che funzionava, dal punto di vista organizzativo, con la proverbiale efficienza degli States: “Una fabbrica all’americana, rapida ed efficace come un salumificio di Chicago: a capo di una catena, si mette un irlandese, un ebreo ucraino, un pugliese, all’altro capo – previa ispezione degli occhi, ispezione delle tasche, vaccinazione, disinfezione – ne esce un americano”. Col tempo le regole di questa fabbrica diventarono sempre più severe. Alla fine i respingimenti furono duecentocinquantamila, tremila i suicidi. I fortunati sentirono invece pronunciare l’agognata e fatidica frase: Welcome to America.
Perec non commenta, lascia che commenti e paragoni siano elaborati nella mente e nel cuore del lettore, quello di allora e quello di oggi. Perché il testo, inutile dirlo, è di una valenza universale e attuale: “L’emigrazione verso gli Stati Uniti era cominciata molto prima che incominciasse Ellis Island e non è terminata con la sua chiusura. I messicani, i portoricani, i coreani, i vietnamiti, i cambogiani hanno dato il cambio”. Ci sono poi le vicende dei nomi storpiati, suoni tipici di mezza Europa trascritti all’americana trasformando Skyzertski in Sanders, Goldenburg in Goldberg, Kowalski in Smith (entrambi significano fabbro). Compresa la storiella del vecchio ebreo russo che disse shon vergessen (in yiddish: l’ho scordato), e lasciò Ellis Island come John Ferguson.
Tutto questo per poi scoprire che l’America non era poi l’America che era stata loro raccontata. Certo, la terra apparteneva a tutti, peccato che i primi arrivati si erano ampiamente serviti e ai nuovi emigranti non restava se non ammassarsi in tuguri senza finestre e lavorare quindici ore al giorno. “I tacchini – scrive Perec – non cadevano già arrostiti direttamente nei piatti e le strade di New York non erano lastricate d’oro. Anzi, il più delle volte, non erano lastricate affatto. E allora capivano che era proprio per fargliele lastricare che li avevano fatti venire. E per scavare gallerie e canali, costruire strade, ponti, grandi dighe, ferrovie, dissodare foreste, sfruttare miniere e cave, fabbricare automobili e sigari, carabine e vestiti, scarpe, chewing-gum, corned-beef e saponette, e costruire grattacieli ancora più alti di quelli che avevano scoperto all’arrivo”.

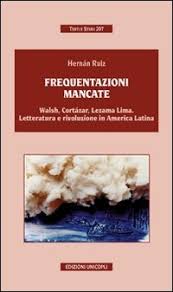
 di Massimo Raffaeli
di Massimo Raffaeli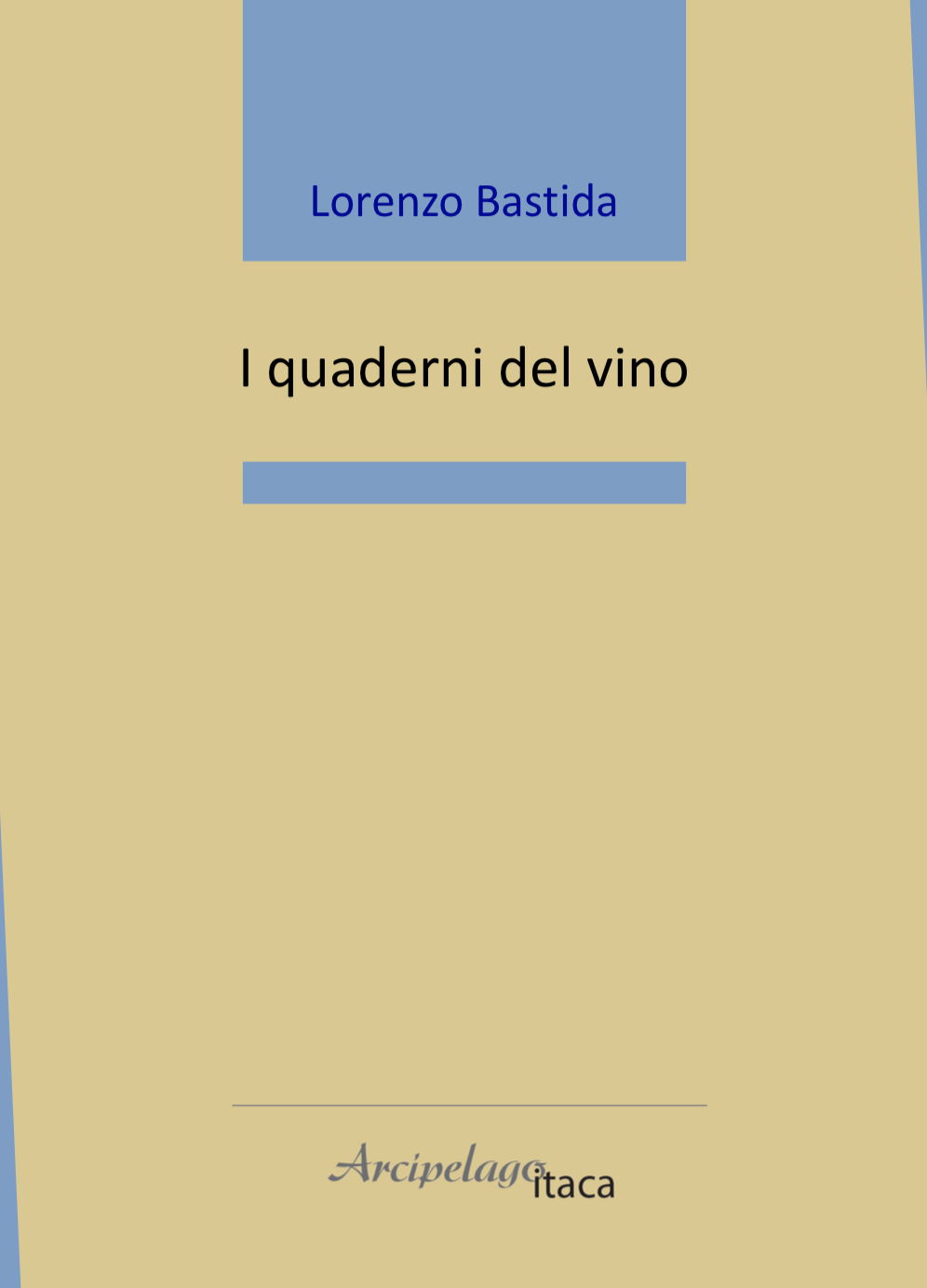




 di Francis Ponge
di Francis Ponge




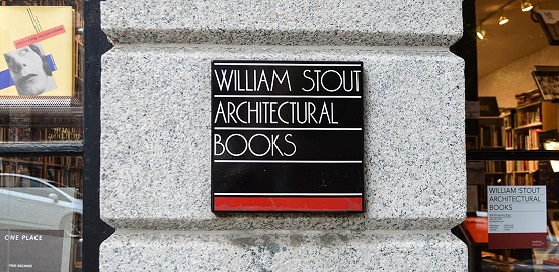 di Gianni Biondillo
di Gianni Biondillo
 Non è un problema di stile. Non è perché le case del Movimento Moderno, pensate come macchine da abitare (a detta di Le Corbusier), non sappiano essere emozionanti. Lo si capisce quando il progettista e il committente si incontrano nella stessa persona. Come nel caso più unico che raro di Casa Cattaneo a Cernobbio. L’edificio fu progettato nelle migliori delle condizioni di libertà creativa per il giovane progettista. Cesare Cattaneo, appena laureato, aveva ricevuto in regalo il terreno dove poter edificare senza alcun vincolo quello che più desiderava. La casa fu pensata fin nei suoi più intimi particolari, con una meticolosità fanatica. Una sorta di modello in scala 1:1, un enorme prototipo che doveva dimostrare la forza poetica del linguaggio moderno, la sua realizzabilità (siamo negli anni trenta del secolo scorso), la sua intrinseca qualità. Nulla fu lasciato al caso, ogni tema sviscerato: il negozio a doppia altezza al piano terra, quello che si apre sulla città, gli appartamenti ai piani superiori, la terrazza all’ultimo piano affacciata sul panorama lacustre. Progetto libero da condizionamenti perché non tenuto, come ebbe a dire Cattaneo stesso, a “soggiacere alla volontà tirannica dei clienti”. Un capolavoro che purtroppo non ha avuto seguito essendo Cattaneo morto giovanissimo. (Mi sono accorto che gli architetti o muoiono molto giovani, vedi Sant’Elia o Terragni, oppure vecchissimi, come il quasi centenario Giovanni Michelucci o l’ultracentenario Oscar Niemeyer. Avendo io superato da bel po’ la giovinezza mi auguro sempre più convintamente di appartenere alla seconda categoria).
Non è un problema di stile. Non è perché le case del Movimento Moderno, pensate come macchine da abitare (a detta di Le Corbusier), non sappiano essere emozionanti. Lo si capisce quando il progettista e il committente si incontrano nella stessa persona. Come nel caso più unico che raro di Casa Cattaneo a Cernobbio. L’edificio fu progettato nelle migliori delle condizioni di libertà creativa per il giovane progettista. Cesare Cattaneo, appena laureato, aveva ricevuto in regalo il terreno dove poter edificare senza alcun vincolo quello che più desiderava. La casa fu pensata fin nei suoi più intimi particolari, con una meticolosità fanatica. Una sorta di modello in scala 1:1, un enorme prototipo che doveva dimostrare la forza poetica del linguaggio moderno, la sua realizzabilità (siamo negli anni trenta del secolo scorso), la sua intrinseca qualità. Nulla fu lasciato al caso, ogni tema sviscerato: il negozio a doppia altezza al piano terra, quello che si apre sulla città, gli appartamenti ai piani superiori, la terrazza all’ultimo piano affacciata sul panorama lacustre. Progetto libero da condizionamenti perché non tenuto, come ebbe a dire Cattaneo stesso, a “soggiacere alla volontà tirannica dei clienti”. Un capolavoro che purtroppo non ha avuto seguito essendo Cattaneo morto giovanissimo. (Mi sono accorto che gli architetti o muoiono molto giovani, vedi Sant’Elia o Terragni, oppure vecchissimi, come il quasi centenario Giovanni Michelucci o l’ultracentenario Oscar Niemeyer. Avendo io superato da bel po’ la giovinezza mi auguro sempre più convintamente di appartenere alla seconda categoria). Ogni casa, insomma, porta con sé una storia, un mondo. Spesso mi accorgo quanto un appartamento mi dica molte cose di chi lo vive. Gli oggetti quotidiani, gli arredi, i quadri o le fotografie ai muri, ci vestono, ci rappresentano, esattamente come quando indossiamo un abito. Perché ogni casa, dal ricco maniero al monolocale in affitto, assomiglia alla persona che la abita. Anche qui il gioco delle etimologie può tornare utile. “Persona” deriva da Per Sonar, la maschera in legno che serviva a rafforzare il suono della voce nel teatro antico. La casa è innanzitutto la creazione di un ambiente ideale. Ma “ambiente” viene da Ambire, cioè andare attorno come l’aria, o come le persone attorno alle quali si vive. Quindi quando si abita una casa si indossa una maschera che dà un’idea di sé a se stessi e al mondo circostante. Oggi, in un mondo di risorse scarse, abitare significa stare in una casa sostenibile, ecologica. Inevitabilmente, mi viene da chiosare, dato che “Ecologia” deriva dal greco Oikos logos, “discorso sulla casa”: lo studio delle relazioni fra l’umano e il mondo vivente.
Ogni casa, insomma, porta con sé una storia, un mondo. Spesso mi accorgo quanto un appartamento mi dica molte cose di chi lo vive. Gli oggetti quotidiani, gli arredi, i quadri o le fotografie ai muri, ci vestono, ci rappresentano, esattamente come quando indossiamo un abito. Perché ogni casa, dal ricco maniero al monolocale in affitto, assomiglia alla persona che la abita. Anche qui il gioco delle etimologie può tornare utile. “Persona” deriva da Per Sonar, la maschera in legno che serviva a rafforzare il suono della voce nel teatro antico. La casa è innanzitutto la creazione di un ambiente ideale. Ma “ambiente” viene da Ambire, cioè andare attorno come l’aria, o come le persone attorno alle quali si vive. Quindi quando si abita una casa si indossa una maschera che dà un’idea di sé a se stessi e al mondo circostante. Oggi, in un mondo di risorse scarse, abitare significa stare in una casa sostenibile, ecologica. Inevitabilmente, mi viene da chiosare, dato che “Ecologia” deriva dal greco Oikos logos, “discorso sulla casa”: lo studio delle relazioni fra l’umano e il mondo vivente. Stiamo domesticizzando lo spazio pubblico. Alcuni oggetti di culto della casa moderna, novecentesca e borghese, sono perfettamente inutili per le nuove generazioni. Fate un test (io l’ho fatto con le mie figlie): fra televisore e computer vince il computer. Fra computer e smartphone vince lo smartphone. Tutto si miniaturizza, diventa etereo. Oggi l’infrastruttura necessaria, indispensabile, in ogni casa, in ogni città anzi, è il Wi-Fi.
Stiamo domesticizzando lo spazio pubblico. Alcuni oggetti di culto della casa moderna, novecentesca e borghese, sono perfettamente inutili per le nuove generazioni. Fate un test (io l’ho fatto con le mie figlie): fra televisore e computer vince il computer. Fra computer e smartphone vince lo smartphone. Tutto si miniaturizza, diventa etereo. Oggi l’infrastruttura necessaria, indispensabile, in ogni casa, in ogni città anzi, è il Wi-Fi.