
di Davide Orecchio
… ed entra marzo quando Giulio Andreotti promette a Leone la lista del nuovo governo, e la fa, sposta ad esempio Tina Anselmi alla sanità, e con Aldo Moro fa il conclave del partito di Dio per i sottosegretari, per il sottogoverno, lo fa alla Camilluccia e dice al diario Ho tenuto duro; e dice che Aldo Moro promette che l’aiuterà; e non resta che giurare e chiedere il voto alle camere,
ed ecco il sedici marzo quando le maestre si apprestano a scuola,
i bambini si apprestano a scuola,
vestono i grembiali e i fiocchi azzurri,
prendono le cuccume dalle madri e le nonne,
i macellai tritano carne, i fruttivendoli legano asparagi,
Giulio Andreotti porta il governo alle camere,
i pizzaioli sfornano la rossa con le olive e l’origano,
i bidelli aprono scuola,
i tranvieri aprono le porte dell’autobus,
le brigate rosse prendono Moro,
i giornalai alzano le saracinesche,
le tintorie avviano le lavatrici,
le brigate rosse uccidono due carabinieri,
i postini imbucano lettere,
i bancari incassano assegni,
gli architetti progettano,
le scrittrici fantasticano,
le brigate rosse uccidono tre poliziotti,
alcuni bambini hanno il morbillo e non vanno a scuola,
alcuni bambini hanno la varicella e non vanno a scuola,
i bambini di Monte Mario sentono spari e frenate,
una notizia corre da Monte Mario a Montecitorio (di parola in parola, di filo in filo),
un’automobile si divarica stuprata nel sangue,
Andreotti si piega e vomita, sviene a Palazzo Chigi, si sdraia sul divano e in fretta gli portano un abito da cerimonia pulito,
un’altra camicia, un’altra cravatta,
Andreotti si piega come la madre si piegò sul padre che muore,
il dolore è un atto geometrico nel tempo dell’indimenticabile morte,
giurano i sottosegretari del nuovo governo,
Aldo Moro scompare coi brigatisti
e vengono a Palazzo Chigi gli uomini del partito di Dio, i socialisti, i sindacalisti,
il partito della storia invia i suoi rappresentanti più degni;
e Andreotti dice al diario Emozione profonda;
e dice Tutti concordano nel non dare (spazio bianco); e dice Ma (spazio bianco) immediatamente la fiducia per il governo (spazio bianco);
e in poche ore le due camere votano;
e Giulio Andreotti raccoglie le forze, sigilla lo zaino.
Ora Giulio Andreotti vede Aldo Moro: i capelli leonati, sulla fronte una ciocca di bianco germoglia sul cespo d’argento, gli occhi del lemure timido, dentro la gabbia il volto è lungo, appeso alle tempie e alle sopracciglia come un ometto aggrappato alla balaustra prima del precipizio, il labbro superiore sottile, il labbro inferiore carnoso, la camicia aperta sconfitta, il giugulo è l’ultima trave che regge Aldo Moro, sul capo Aldo Moro ha un drappo di cielo e una sola stella, gli artefici annunciano il processo al “Responsabile primo della controrivoluzione”, ora Aldo Moro è in un telo.
E i bambini sono in ostaggio,
e gli agrimensori, e i macellai, e i netturbini coi giornalisti,
e le casalinghe, i lavascale sono in ostaggio,
e gli stagnini con gli sterratori,
e gli elettricisti e le rammagliatrici: sono tutti in ostaggio con Aldo Moro;
sbiancano le pagine dei libri di favole,
tacciono tutte le storie;
dalle ville, dai palazzi a cortina, dalle borgate, dai condomini, dai tuguri spruzza nero di seppia;
nel tempo di morte e vita sospesa;
loro controllano se hanno ancora uno zaino, e se sia colmo o deserto;
loro chiedono se hanno ancora un governo;
loro chiedono Chi governa l’Italia?, le Br o Andreotti?;
e non accade nulla, questa malattia paralizza i dischi invertebrali e i corpi vertebrali e i nervi spinali.
E si spengono le lavatrici nelle tintorie,
i bidelli chiudono scuola,
le maestre diventano mute,
le scrittrici non fantasticano più,
gli architetti non progettano più,
i bibliotecari non catalogano libri,
i sarti non rammendano gli abiti,
gli stenografi non consegnano i verbali,
i capibarca affondano,
i barbieri rompono le forbici,
gli infermieri gettano i camici,
i tassisti parcheggiano e dormono,
i cuochi consegnano pietanze crude ai camerieri,
i camerieri portano in tavola pietanze crude,
gli idraulici non spurgano più,
i geometri non tracciano segni,
gli elettricisti spruzzano nero di seppia,
i preti stringono al petto gli zaini.
E i bambini sono sempre in ostaggio,
e i capibarca galleggiano sul fondale del mare, tra le grotte e il nero di seppia,
e i camerieri supplicano i clienti Mangiate noi, perché non abbiamo più cibo;
e le macchine da scrivere chiedono asilo agli svizzeri, perché i giornalisti non hanno più nulla da dire,
e le edicole non alzano più le serrande,
e le maestre convocano i sarti e le rammagliatrici e supplicano Cucite le nostre bocche, perché non abbiamo più nulla da dire;
dalle fogne emergono idraulici imbrattati di nero di seppia,
gli stenografi verbalizzano il tempo della morte e dell’omicidio,
i bancari incassano assegni in nero di seppia,
gli scrittori friggono libri in padella e poi ridono,
i falegnami restituiscono i mobili ai boschi,
i tranvieri ripartono sigillando i convogli,
e che nessuno vi salga.


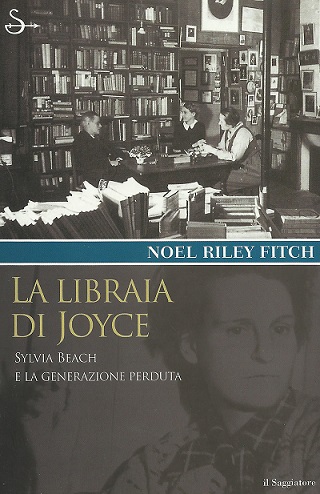 di Romano A. Fiocchi
di Romano A. Fiocchi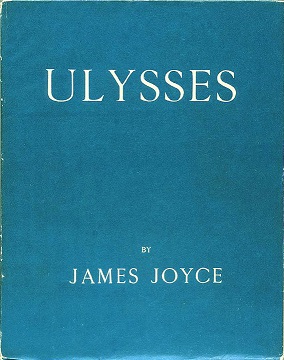 Dalla storia della pubblicazione dell’Ulisse emergono due immagini contrastanti dei protagonisti: la tenacia e la generosità di Sylvia Bech e la fragilità di un Joyce pieno di ossessioni e spesso dedito all’alcol, squattrinato ma sempre pronto a vivere oltre le sue possibilità a scapito di amici e conoscenti, arrivando al punto di sfruttare le risorse economiche della stessa Sylvia e di “tradirla”, dopo undici edizioni, cedendo i diritti ad un importante editore americano.
Dalla storia della pubblicazione dell’Ulisse emergono due immagini contrastanti dei protagonisti: la tenacia e la generosità di Sylvia Bech e la fragilità di un Joyce pieno di ossessioni e spesso dedito all’alcol, squattrinato ma sempre pronto a vivere oltre le sue possibilità a scapito di amici e conoscenti, arrivando al punto di sfruttare le risorse economiche della stessa Sylvia e di “tradirla”, dopo undici edizioni, cedendo i diritti ad un importante editore americano.

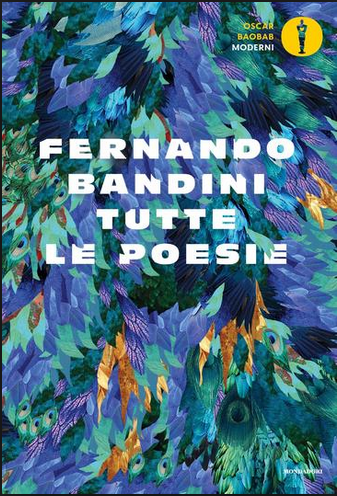 Nota
Nota
 di Matteo Pelliti
di Matteo Pelliti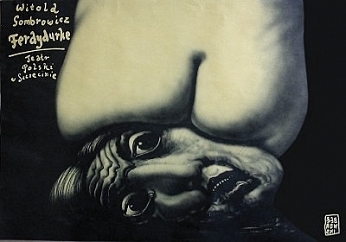

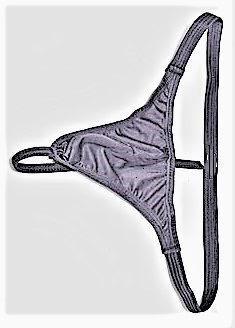 di Mirfet Piccolo
di Mirfet Piccolo








 Domani 1 marzo esce il romanzo di Paolo Pecere, filosofo e ricercatore, “La vita lontana”, edito da LiberAria, nella collana Meduse curata da Alessandra Minervini.
Domani 1 marzo esce il romanzo di Paolo Pecere, filosofo e ricercatore, “La vita lontana”, edito da LiberAria, nella collana Meduse curata da Alessandra Minervini.