di Andrea Corona
1. «Fondamentalmente non fanno altro che starsene lì in piedi». La generazione b(a)loccata di Mark, Tom e Drew-Lynn
Parlare di David Foster Wallace non può fare a meno di suscitare un entusiasmo prossimo a quello di chi si appresta a sfondare una porta aperta. Tale entusiasmo, tuttavia, è destinato a fare i conti con un’agrodolce presa di coscienza nel momento in cui si decide di passare dalle parole alla scrittura: scrivere di un autore complesso come Wallace è, infatti, un’operazione molto faticosa. Non c’è quasi pagina, nei suoi scritti – saggi e romanzi, come pure racconti brevi, articoli e interviste – che non sia in grado di far scattare dei meccanismi nella testa del lettore, per una gamma di stimolazioni intellettuali (in cui si accavallano riflessioni, associazioni con altri testi, collegamenti e ponti con altri autori) che si traducono in uno stato di sovreccitazione, prima di risolversi in affaticamento mentale. Le porte di cui si diceva, dunque, continuano a restare aperte; ma con la consapevolezza, adesso, di quanto fossero vere le parole di Robert Musil allorquando ne L’uomo senza qualità scriveva che «Se si vogliono varcare senza danno delle porte aperte, bisogna tener presente il fatto che gli stipiti sono duri» (Musil 1992: 16).
Varcare una porta aperta ma dagli stipiti duri significa, nel nostro caso, ritrovarsi a fare i conti con un autore i cui testi sono, da un lato, dei “libri-mondo” capaci di fornire su un piatto d’argento una quantità non numerabile di informazioni, spunti e rimandi, ma che, dall’altro, de-sistematizza continuamente il proprio sistema. Essendo il pensiero wallaciano totalmente libero (e, per l’appunto, non sistematico), esso è libero anche, per così dire, dall’obbligo di fornire delle risposte esaurienti e/o definitive. Pur seguendo un percorso di riflessione logico e progressivo, l’autore appare spesso (e proprio in virtù di tale libertà) non lineare e tortuoso. Per esprimere al meglio questo concetto teorico, sarà forse utile prendere in prestito un passo de I testamenti traditi in cui Milan Kundera chiarisce che:
Pur sostenendo la necessità di una forte presenza del pensiero in un romanzo, rifuggo da quello che viene definito «romanzo filosofico», asservimento del romanzo ad una filosofia, «messa in racconto» di idee morali o politiche. Il pensiero autenticamente romanzesco (quello che il romanzo conosce da Rabelais in poi) è sempre asistematico, indisciplinato; è simile a quello di Nietzsche; è sperimentale; apre brecce in tutti i sistemi di idee da cui siamo attorniati; prende in esame (specialmente attraverso i personaggi) tutte le strade della riflessione tentando di arrivare in fondo a ciascuna di esse (Kundera 2000: 168).
Ecco, dunque: Wallace è uno scrittore che apre brecce di continuo, che lo fa per mano dei suoi personaggi (ivi inclusi quelli di nome David Wallace ) anziché attraverso la mera edificazione di un apparato di teorie morali o convinzioni politiche, e che spinge le proprie riflessioni alle estreme conseguenze, ma in modo tale che “estreme” non significhi mai “ultime”.
E, ciò premesso, domandiamoci ora: quali tematiche veicolano, seppur in modo non sistematico e non lineare, le opere di David Foster Wallace? Ebbene, solo per citare alcune tra le più presenti, sono certamente da tenere in conto l’incomunicabilità, il solipsismo e la solitudine, il rapporto spesso ossessivo con il proprio corpo (e dunque con la dismorfofobia), la relazione tra il mercato e le paure collettive, il legame tra il divertimento e la pubblicità, l’analisi dei grandi spettacoli d’intrattenimento di massa (e dell’influenza di questi sui loro fruitori, ossia gli spettatori), l’interdipendenza di realtà e fiction.
È evidente che ci troviamo dinanzi a un autore che affronta temi di grande attualità. Ma il punto è un altro: chi legge Wallace ne ricava, più propriamente, una sensazione di familiarità. Come se lo scrittore riuscisse a farci sentire tutti chiamati in causa, e lo facesse dicendo cose che ci riguardano. Molto interessante, in tal senso, è una dichiarazione di Luca Bargagna, attore e regista teatrale, nonché autore degli spettacoli Verso Occidente l’Impero dirige il suo corso (tratto dal romanzo omonimo) e Il dono (tratto stavolta dalla raccolta di racconti Brevi interviste con uomini schifosi). Nella sua dichiarazione, Bargagna ha spiegato le ragioni che l’hanno spinto a portare Verso Occidente a teatro, affermando che si tratta di
“un romanzo assolutamente attuale perché scritto alla fine degli anni Ottanta ma che riesce a declinare quelle che sono ancora oggi le paure della generazione fra i trenta e i quarant’anni. In qualche modo, dietro l’impalcatura del romanzo, c’è un’impostazione fotografica, ossia il tentativo di fotografare una generazione come la nostra, che si ritrova in mezzo, che non ha più dei riferimenti, non ha più dei padri, ma non ha neanche la possibilità di strutturare o ipotizzare un futuro, per cui una generazione bloccata” (Bargagna 2014) .
In effetti, in questo romanzo (lungo circa duecento pagine nelle varie edizioni, e dunque piuttosto breve rispetto agli abituali standard dello scrittore di Ithaca) sono presenti praticamente tutti gli spunti di cui sopra e che, nell’ottica di un volume sul mondo di oggi visto attraverso il filtro wallaciano, si rivelano assolutamente funzionali allo scopo. Seguendo uno schema di allontanamento e riavvicinamento al testo, andremo dunque a toccare questioni di forte pregnanza contenutistica, e lo faremo a partire proprio dalla stasi di una generazione bloccata (e, come si vedrà, baloccata).
Un’immagine che immortala in modo molto efficace la situazione di stallo in cui si trovano i protagonisti del romanzo – Mark Nechtr, Drew-Lynn Eberhardt e Tom Sternberg – è infatti quella che li vede letteralmente impantanati e incerti sulla destinazione che li attende. Una destinazione, sia chiaro, meramente geografica; ma che reca nondimeno l’emblema di un destino simbolico, condiviso e collettivo:
Perciò fondamentalmente non fanno altro che starsene lì in piedi, come farebbe chiunque, in mezzo a una montagna di bagagli; si sentono un po’ impantanati, stanchi, con la tipica tensione da “ci siamo quasi ma non ancora”, con la sensazione che ci sia un posto preciso dove devono trovarsi a un’ora precisa, ma senza aver raggiunto alcun consenso sul modo di arrivarci […] sono emblematicamente incerti su dove andare da questo punto in poi (Wallace 2001: 57-58).
E l’adagio si ripeterà quando, più avanti, ritroviamo una irritabilissima e infantilmente imbronciata Drew-Lynn (moglie – incinta – di Mark e antico oggetto di un timido amore adolescenziale da parte di Tom) alle prese con mille borbottii e lamentele: «E non siamo nemmeno sicuri di dove si trovi Collision rispetto a questo aeroporto. A ovest di qui, ma quanto? Ci si arriva a piedi? C’è una strada? Non abbiamo visto altro che granturco. Disorientante […]. Tutta questa regione mette paura» (ivi: 82-83).
Si tratta di personaggi spaesati e vulnerabili che risultano, per molti aspetti, simili a dei bambini che chiedono incessantemente quando si arriva a casa.
2. «Per chi è una casa la Casa Stregata? E perché costruire una Casa Stregata in ogni grande città, secondo le leggi del marcato?». J.D. Steelritter e il potere “oikonomico”
Verso Occidente l’Impero dirige il suo corso è il secondo romanzo di David Foster Wallace. Curiosamente, in quanto comparve per la prima volta nella raccolta di racconti del 1989 La ragazza dai capelli strani, è da molti considerato a sua volta un racconto. Ad ogni modo, indipendentemente dalla definizione che se ne vuol dare , si tratta di una narrazione che si rapporta, dialogandovi a distanza ma soprattutto prendendone in chiave ironico-polemica le distanze, con un testo sperimentale del 1968 di John Barth dal titolo La casa dell’allegria. Storie da stampare, incidere su nastro, recitare.
Quel che ci preme è fare innanzitutto presente che, se nell’orbita di un discorso più marcatamente critico-letterario (ma anche storico-letterario), Verso Occidente nasconde, al di là dell’evidente rivisitazione in chiave parodica, delle importanti riflessioni sulla teoria letteraria, sulla metanarrativa e sul racconto postmoderno, dal mero punto di vista dei contenuti si distacca dall’opera di Barth per fotografare, come appunto si diceva, i disagi di una generazione bloccata.
Non che l’incomunicabilità o la difficoltà a relazionarsi fossero aspetti assenti ne La casa dell’allegria, ma la generazione degli anni Ottanta, descritta da Wallace in maniera così esageratamente “imbambolata” e quindi facilmente malleabile e governabile, risulta agli occhi del lettore odierno talmente vicina alla nostra da meritare un approfondimento in primo luogo sociologico. Vediamo ora perché.
Si inizi col dire che l’episodio che dà il via agli eventi narrati in Verso Occidente è la realizzazione di uno spot televisivo della catena di fast-food McDonald’s. E si aggiunga, poi, che non si tratta di una réclame come tante.
Siamo a Collision, una sonnolenta cittadina dell’Illinois, dove l’intraprendente pubblicitario J.D. Steelritter ha organizzato una riunione con tutti gli attori, comparse incluse (tra cui i nostri Mark, Tom e Drew-Lynn), che abbiano mai recitato in uno dei 6659 spot McDonald’s girati fino a quel momento. «E sentite questa: la Riunione è stata ideata e promossa così bene che tutti quelli che sono ancora vivi hanno promesso di partecipare. Il cento per cento di risposte positive, come J.D. sa bene, non è un caso». Veniamo così a sapere che «l’ideazione e l’organizzazione di questo gala sono da anni la passione principale di J.D. Steelritter», il quale «Fin dall’inizio aveva previsto un risultato del genere» (ivi: 70).
In altre parole, era tutto calcolato. E questo, come mostreremo a breve, costituisce un primo elemento di interesse. Ma andiamo avanti. Tra i principali punti di forza dell’operazione, che includono vari privilegi per gli accorrenti attori, ce n’è uno in particolare che sembra far gola agli invitati. Se è vero che non tutti possono usufruire ad esempio del «trasferimento a bordo di macchina da clown sul luogo della Riunione», in quanto servizio riservato esclusivamente agli ospiti più puntuali, è però vero che per tutti i quasi 44.000 ex attori in arrivo sul luogo è incluso nel pacchetto «[l’]accesso alla discoteca numero uno di una catena che promette di espandersi alla velocità di un carcinoma, di essere nel prossimo millennio il posto dove farsi vedere» (ivi: 70-71).
E che questa discoteca giochi un ruolo importante nei piani del pubblicitario lo si intuisce da un particolare: nelle sale d’aspetto dell’aeroporto dell’Illinois centrale, dove giungono gli attori prima che un’apposita navetta li conduca a Collision, campeggia un poster gigantesco, su cui appare un enorme J.D. Steelritter accanto a un enorme Ronald McDonald, un Ronald che assomiglia a J.D., sotto il cerone, nello stesso strano modo in cui, per dire, il rugby assomiglia al football; l’enorme Ronald tiene in mano un manifesto promozionale, solo leggermente meno enorme, del prototipo di una discoteca Casa Stregata […] sembra grosso modo una casa normale, come quelle che ti aspetteresti di vedere a decine in qualsiasi quartiere dormitorio, fatta eccezione per l’enorme ghigno da cadavere che sarebbe la porta della Casa Stregata. L’espressione di J.D. è congegnata in maniera tale da farvi già sentire privati di qualcosa per non essere lì con loro (ivi: 55).
Se il primo era relativo al calcolo, gli altri elementi che ci interessano riguardano rispettivamente il mercato, la paternità e il governo della casa. Andando con ordine: la grande Riunione dei 44.000 attori segnerà l’apice ma anche il superamento e la fine degli spot McDonald’s perché darà luogo, certo, al più importante spot di sempre, ma questo sarà tale in quanto la pubblicità numero 6660 è l’ultima in programma, l’ultima prevista, l’ultima che verrà mai girata. Parallelamente a ciò, avrà luogo l’inaugurazione della catena di discoteche “Casa Stregata”, con una «in ogni grande città, secondo le leggi del mercato» (ivi: 32).
J.D., apprendiamo poi, ha un figlio. E «Lo stesso figlio di J.D. Steelritter, DeHaven Steelritter, è un marchio di fabbrica umano. Un clown. Il clown. È il Ronald McDonald di questa campagna ormai da un anno» (ivi: 41-42). Ecco perché il pagliaccio del poster gigante assomiglia a J.D. come il rugby assomiglia al football: perché è suo figlio. Ma di «quel pagliaccio del figlio» (ivi: 43) parleremo più a fondo nel prossimo paragrafo.
Ora concentriamoci sull’elemento “casa”. Ricorrono, nel romanzo, passaggi che sottolineano come gli spot McDonald’s riescano a far sentire a casa chi li guarda, oltre che chi li interpreta – basti pensare che la politica aziendale prevede, per chiunque sia mai comparso in uno spot, «un coupon senza scadenza che gli dà diritto a un numero illimitato di hamburger gratis in ogni ristorante della catena, dovunque, in qualunque momento» (ivi: 51); ma ancora più illuminante ci sembra un passo in cui il narratore, ripercorrendo i pensieri di J.D., si domanda: «Una Casa Stregata deve essere qualcosa di più che un divertimento? Qualcosa di più che una forma di divertimento nuova e perfezionata? L’idea stessa di “casa” sta giocando un ruolo in questa campagna, invisibilmente?» (ivi: 36). Ebbene, la risposta è sì.
Stacchiamoci adesso dal testo wallaciano per tracciare una sintesi di questi primi spunti: il calcolo, il mercato, la paternità e il governo della casa.
In riferimento al potere del mercato, come ha rilevato il gruppo di filosofi napoletani Collettivo 33, i nostri tempi registrano un’immanenza della sovranità all’economia e viceversa, in quanto «Nell’economico agisce un’istanza di sovranità e nella sovranità un’istanza di calcolo. L’economico ha bisogno della sovranità – il politico – per funzionare e la sovranità si esercita per “calcolare” la società» (Collettivo 33 1997: 12).
Ma qual è l’esito di questo gioco? Un gioco assai simile a quello che, nel romanzo di Wallace, è praticato così abilmente dal personaggio di Steelritter? Come ci indica ancora il Collettivo, il diffondersi degli enunciati economici ha portato a una lingua depoliticizzante che sembra far ritorno a qualcosa di antico quanto la figura del pater familias, del responsabile del governo della casa (oikos) e, quindi, a quel responsabile dell’oikonomia che esercitava un potere e un controllo dispotico sui figli e in generale su tutti membri dell’oikos.
Ha dunque ragione Hannah Arendt quando in Vita activa afferma che l’attuale dominio dell’economia non è che l’estensione mondiale del governo della casa: «con il sorgere della società, cioè con l’estendersi della “comunità domestica” (oikia) o delle attività economiche al dominio pubblico, la gestione della casa e tutte le faccende che rientravano precedentemente nella sfera familiare sono diventate una questione “collettiva”» (Arendt 1989: 142).
La cosiddetta globalizzazione assume perciò, anche in Wallace, col cui testo ora ritorniamo a dialogare, un significato ontologico e linguistico: «Per chi è una casa la Casa Stregata? Forse per i bugiardi, i tipi creativi, i promotori di campagne pubblicitarie, i potatori alle prese con il grande albero della lingua» (Wallace 2001: 61).
Ecco allora che, se «il dominio dell’economico è tale che nessun luogo gli sfugge, anzi ogni luogo è continuamente preso e dislocato dal processo tecno-economico» (Collettivo 33 1997: 14), a maggior ragione, «con una Casa Stregata in ogni grande città, secondo le leggi del mercato» (Wallace 2001: 32), la comunità domestica proseguirà nel suo progetto di estensione su tutta la terra. Ma con una differenza: l’espansione avverrà non già più con «l’insegna del ristornate sotto casa per il mondo intero» (ivi: 52) o col sorriso di un clown che augura «una buona giornata» (ivi: 99), bensì con un «enorme ghigno da cadavere» (ivi: 55) stampato sulla porta d’ingresso.
3. «E quel pagliaccio del figlio». DeHaven Steelritter, i “consumati” e la produzione di adulti-bambini
Il capovolgimento da sorriso a ghigno non si manifesterà all’improvviso, perché sarà preannunciato dall’espressione intermedia, vacua e apatica, del novello (ma al contempo ultimo, si ricordi, dal momento che dopo di lui non ve ne saranno altri) Ronald McDonald. E la grottesca smorfia, sorta di equivalente orale di una palpebra a mezz’asta, pare sia sempre appartenuta a questo figlio neghittoso e indolente che si presenta come «Un bambino che è uscito dal grembo della madre infastidito» (ivi: 43).
In riferimento al «terzo Ronald McDonald nella storia del franchising americano» (ivi: 44), alias DeHaven Steelritter, leggiamo infatti che
“è chiaro che non apprezza l’occasione che gli è capitata, che non gli piace il lavoro che fa; e, ancora peggio, la sua antipatia per quel lavoro la dimostra come farebbe una persona addormentata, con un piagnucolio intorpidito e un broncio assoluto da bambino: espressione che ha in faccia ora, e da quel broncio J.D. è infastidito e innervosito, dal corrugarsi della pelle del figlio sotto quel folle sorriso dipinto… ha un’aria grottesca, le labbra e il rossetto formano una specie di cerchio grossolano, e l’impressione che danno (e che non dovrebbe mai dare una bocca che rappresenta un ristorante) è semplicemente quella di un buco, di una monetina senza nessuna incisione, di un’entrata vuota da cui vorresti solamente uscire” (ibidem).
Di indole diametralmente opposta a quella del genitore e contraddistinto da una cronica insofferenza al lavoro, come pure da una sistematica sottrazione preventiva a tutto ciò che «non è al cento per cento facile e piacevole» (ivi: 42), DeHaven, nel momento in cui «alza le spalle con quell’apatia alla “che ci vuoi fare?” con cui affronta ogni ostacolo» (ivi: 43), assume un atteggiamento di attesa e passività che non è poi così diverso, a ben vedere, da quello degli altri personaggi.
Così come per il disorientamento palesato dinanzi a un destino perennemente evanescente e aleatorio, anche per la fissità si può parlare di una componente letterale e non solo metaforica delle vite di Mark, Tom e Drew-Lynn. Si pensi allora, ad esempio, al momento in cui «tutti e tre questi bambini ormai sessualmente maturi» (ivi: 77) fissano lo schermo della tv. Che si tratti di quello posto nella sala d’aspetto e che trasmette le repliche del tanto amato telefilm Hawaii Five-O, o che sia quello del piccolo televisore a gettoni che distrae finalmente Drew-Lynn dai suoi rovelli mentali, i nostri protagonisti si rendono, a uno sguardo esterno, sottosviluppati e inamabili (cfr. ivi: 90-91).
E proviamo a comprendiamoli meglio, dunque, questi bambini sessualmente maturi (ricordiamo che Mark e Drew-Lynn stanno per diventare genitori) grazie all’identikit che il narratore traccia del loro coetaneo – e certamente non meno sottosviluppato e inamabile – DeHaven Steelritter:
Ma allora, DeHaven K. Steelritter? adulto? figlio putativo? possibile erede? usurpatore? Chi mai potrebbe amare questo DeHaven Steelritter? Età: dovrebbe proprio farsi la barba; altezza: sta sempre ingobbito, deliberatamente; peso: chi potrebbe dirlo, sotto i vestiti di pelle o questo costume a pois coi fianchi larghi e le scarpe a punta?; istruzione: dato che la scuola non è al cento per cento facile e piacevole “non vale un cazzo”; aspirazioni professionali: comporre musica atonale (a quanto dice), ricevere ottimi stipendi facendo il minimo indispensabile e passare il resto del tempo a cazzeggiare (a quanto pare). Lui rappresenta il Prodotto. È Ronald McDonald. Di professione. Questo figlio, questo orzaiolo sulla palpebra del cosmo, questo incomprensibile SHRDLU nello slogan pubblicitario del cosmo rappresenta “il ristorante sotto casa per il mondo intero” (ivi: 42).
Il quadro che emerge non è certamente dei più edificanti, eppure sarebbe crudele non tener conto del fatto che DeHaven sia fondamentalmente, come si diceva, l’incarnazione stessa del prodotto. Illuminante il flashback sull’episodio d’infanzia – risalente al tempo in cui frequentava la prima media – di colui che diventerà il futuro Ronald McDonald: «rimasto a casa da scuola […] per uno di quei misteriosi raffreddori senza febbre che chiedono a gran voce di essere stroncati sul nascere, augura a J.D., con la più completa innocenza, l’innocenza di un bambino davanti a una televisione, una buona giornata» (ivi: 99).
Eccoci giunti, dunque, alla radice del male, all’eziologia della malattia: l’innocenza di un bambino che, plagiato da un televisore acceso, al momento di salutare il padre ripete meccanicamente “Have a nice day”, la formula standard rivolta al cliente dall’impiegato delle grandi aziende. Non è difficile, a questo punto, immaginare cosa stesse guardando in quel momento (magari, e non è un azzardo pensarlo, stava guardando proprio lo spot McDonald’s del 1970 in cui il Tom bambino di nove anni s’infatuò della Drew-Lynn bambina di dodici anni).
E parimenti importante è il passo relativo al disturbo dell’umore di Mark. Caratterizzato da un temperamento immancabilmente serafico, Mark, nei rari momenti di sovreccitazione, diventa tuttavia simile a uno spettatore seduto in prima fila (cfr. ivi: 26). Che la genealogia della sua apatia coincida con quella di DeHaven non è dato saperlo con sicurezza; ma certo è che, allo stato attuale:
Non è che le emozioni di Mark siano distorte o disturbate, è che lui ha problemi a relazionarcisi. Ecco perché appare in genere sereno e distaccato, neutralmente cordiale. Quando le prova, è come se alle emozioni gli venisse negato l’accesso. Non sente mai di possedere le sue emozioni. Quando ne ha, se ne sente lontano; si sente fuori dal proprio corpo, estraneo (ivi: 121).
Non un broncio né una smorfia, ma nemmeno l’ombra di un sorriso in questo ritratto in carne e ossa dell’alienazione agli altri e a se stessi. Ma sul solipsismo si avrà modo di parlare più avanti, perché prima di passare in esame un’ulteriore tematica sarà bene allontanarci nuovamente dal testo wallaciano per vedere come le problematiche appena emerse siano state affrontate in anni più recenti.
A venire in mente, qui, è innanzitutto il bel libro del 2010 di Benjamin Barber Consumati. Da cittadini a clienti in cui si afferma che la quotidiana offerta di giochi a premi, concorsi, gratta e vinci, anche quando estesa alle pratiche più futili o alle interminabili raccolte di bollini e coupon, rappresenta di fatto la creazione di un comportamento infantilistico utile ad alimentare una cultura del consumo a ogni costo:
L’infantilizzazione tende a indurre comportamenti puerili in soggetti adulti e a preservare l’aspetto infantile nei bambini che cercano di crescere, persino quando sono “legittimati” a consumare […]. L’ethos infantilistico è straordinariamente abile nel creare una domanda di mercato incoraggiando la generazione di falsi bisogni nella società opulenta, in modo da garantire la vendita di tutti quei prodotti e servizi che il capitalismo, con zelo, sta producendo in eccesso (Barber 2010: 119-120).
Quella della produzione di adulti-bambini, dunque, è una strada intrapresa dal marketing per ovviare a tutta una serie di “resistenze” e obiezioni che solitamente fermano il consumatore adulto di fronte a un acquisto. Non si tratta solamente di produrre oggetti per bambini, quindi; ma di trasformare gli adulti in bambini una volta che li si è posti dinanzi all’oggetto/prodotto desiderato. Per questo motivo, l’utilizzo della forma ludica, ribaltata anche nel linguaggio della comunicazione commerciale, viene ad essere lo strumento privilegiato per la regressione verso l’infanzia di sempre nuovi bambini sessualmente maturi.
E si consideri, sempre in quest’ottica, la rilevanza assunta dalle discoteche, oramai importate all’interno dei contesti più disparati; così che, manifestazioni tradizionalmente riservate a un pubblico di persone mature, come le olimpiadi, si stanno trasformando sempre più in colossali operazioni d’intrattenimento. Si tratta di manovre dirette ai nuovi consumatori di ragazzi e appunto, ancora una volta, di adulti-bambini. È quanto ha ravvisato anche il giornalista Curzio Maltese quando, seguendo la cerimonia inaugurale delle olimpiadi di Londra 2012, parlò, e a ragione, di
“un allegro ripasso di tutti i miti della letteratura infantile, da Mary Poppins ad Alice, con al culmine della rappresentazione J. K. Rowling, la creatrice di Harry Potter, che legge Peter Pan. Senza dimenticare naturalmente il coro di bambini che intona “God save the queen”, sotto lo sguardo commosso di nonna Elisabetta. Per finire ovviamente con la trasformazione dello stadio olimpico in un’immensa discoteca” (Maltese 2012: 7).
4. «Dividere uno specchio con una massa di attori»: lo spettatore in controcampo e la coazione alla mimesi
Siamo ritornati alle immense discoteche, dunque, e l’abbiamo fatto con un’immagine che rimanda al “solipsismo da folla” (altrimenti detto “alone together”) di Mark Nechtr e della sua generazione. Sono proprio solipsismo e folla gli elementi fondanti di un passo collocato da Wallace al centro del romanzo (ma che rimanda direttamente alla sublimazione della scena finale):
tutti noi, e Mark lo saprebbe bene se si prendesse la briga di chiederlo a J.D. Steelritter, che in passato ha fatto ampie ricerche sulle paure derivanti da illusioni solipsistiche, tutti noi abbiamo le nostre piccole illusioni solipsistiche, spaventose intuizioni di una nostra assoluta singolarità: crediamo di essere gli unici della casa […] a provare, quando il sole tramonta, lo stesso tipo di panico che un bambino dell’asilo prova quando la mamma si allontana. Di essere solo noi ad amare i solo-noi. Di essere solo noi ad aver bisogno dei solo-noi. Il solipsismo ci tiene insieme, e J.D. lo sa. Sa che ci sentiamo soli in mezzo a una folla; senza fermarci a pensare a cosa ha dato vita a quella folla. Sa che siamo, sempre, volti in mezzo a una folla (Wallace 2001: 128).
Si tratta di un passo emblematico in quanto riferito alla medesima folla che compare nell’epilogo, ossia la «folla di coloro per i quali la casa è stata messa lì: quelli riccamente bisognosi, quelli che rifuggono fobicamente da ciò che è chiuso, quelli a cui serve un riparo. Bambini» (ivi: 216).
Prima di esaminare la scena conclusiva del romanzo, lanciamo una nuova occhiata al di fuori del testo narrativo per guardare a quella evaporazione delle sensazioni e delle emozioni paventata da Camille Dumoulié, intellettuale francese che in un saggio del 2004 metteva in guardia dal controllo dei godimenti operato dalla pubblicità. La tesi di Dumoulié è che l’immagine pubblicitaria, onnipresente, ha già realizzato ciò che essa propone al desiderio dello spettatore: una vita ricca di colori, di gioia, di originalità; ma pur sempre una vita virtuale.
Proprio come in quel vecchio spot della Kodak in cui tre piccole pesti – le “Kodakettes” – si aggirano per la città e, a mo’ di banda di criminali, rubano letteralmente i colori: scattando foto ad abiti, coppe di gelato e mazzi di fiori, non solo spogliano cose e persone della loro precedente vitalità cromatica, condannandole a un bianco vuoto e spettrale, ma privano di qualsiasi gusto o profumo tutto ciò che catturano su rullino, mentre sghignazzano divertite e lo slogan recita «Kodak il ladro di colori» .
Una vita virtuale, dicevamo per l’appunto, e non già più una vita activa, per quello che è un mero simulacro del godimento, ma che, nondimeno, ha come diretta conseguenza nel reale «Un’umanità trasformata in fantasmi che attraversano la vita come in un permanente Halloween, ridotta allo stato di corpi stravolti e vampirizzati dalle stesse immagini che devono imitare» (Dumoulié 2004: 97). Tale è l’operazione del virtuale mediatico sul mondo: esso vampirizza la vita anticipando il godimento. E non potrebbe del resto essere altrimenti dal momento che, con la pubblicità, «si gode per voi, si è già goduto. Non avete più nulla da desiderare» (ivi: 98).
Non è un caso, allora, che il finale di Verso Occidente si risolva in una sorta di godimento abortito, dal momento che Wallace ferma la narrazione prima di mostrare un qualsivoglia scorcio di appagamento, divertimento o allegria. Ed eccoli i nostri eroi, così come appaiono nell’ultima pagina, trascinarsi alla stregua di morti viventi alle soglie della Casa Stregata. Consumati dalla fatica del percorso (un percorso iniziato molti anni addietro e che li ha gradualmente, con un lento lavorio del tempo, trasformati da cittadini a comparse), quelli che vediamo sono dei volti ormai anonimi di una folla indistinta di 44.000 clienti
Che, stanchi, ma in tempo, arriveranno a ciò che è stato costruito. Che è di gran lunga troppo tardi per tirarsi indietro. E dunque avanti, verso la Riunione Di Tutti Coloro Che Sono Comparsi, verso la Via d’Uscita, verso la Casa Stregata, […] progettata secondo standard universali per essere – al di là di tutta la campagna propagandistica che la sosterrà – nient’altro che quello. Una casa (Wallace 2001: 216).
A questo punto, occorrerà pur dire qualcosa su come sia fatta questa casa all’interno. Ebbene, a tal proposito Wallace fornisce un unico particolare, ma assolutamente pregnante, nel momento in cui ci informa che «la Casa Stregata, dice il dépliant, è stata accuratamente progettata utilizzando soprattutto un sistema di specchi» e che si tratta perciò, in sostanza, di «Un posto affollato e pieno di specchi» (ivi: 90).
E non è una coincidenza che già nel romanzo d’esordio di Wallace, La scopa del sistema, vi sia spazio per ampie trattazioni relative a immagini riflesse, specchi e narcisismo, dismorfofobia e solipsismo (con un capitolo, il secondo, interamente dedicato al tema). Sono alcuni degli argomenti-chiave di uno scrittore che ha anticipato sin dai primi lavori degli anni Ottanta una serie di questioni che avrebbero caratterizzato i dibattiti sociologici dalla fine degli anni Novanta in poi.
Basti pensare alla “folla solitaria” di consumatori analizzata da David Riesman nel saggio omonimo o all’Homo consumericus di Gilles Lipovetsky, fino a quella “McDonaldizazione” del mondo presa in esame da George Ritzer e che fa il paio con le famose disamine sulla globalizzazione e sulla solitudine del cittadino globale proposte da Zygmunt Bauman, in cui il mondo si riduce a fabbrica di attrazioni passeggere, mentre il cittadino del mondo a “turista” della suddetta fabbrica (cfr. Riesman 2009, Ritzer 1997 e 2003, Lipovetsky 2007, Bauman 1999 e 2000).
Pur senza sviscerare in maniera esaustiva una tale quantità di spunti e rimandi bibliografici, possiamo valerci di un’immagine, stavolta cinematografica, che ci sembra assai pertinente nonché utile a sintetizzare gran parte del discorso wallaciano relativamente a questo secondo gruppo di punti – la fissità e il solipsismo, gli specchi e l’immagine speculare, il rapporto fra attori e spettatori – che sono venuti a delinearsi.
Quando in Verso Occidente si legge che «Sternberg non è affatto sicuro che gli piaccia l’idea di dividere uno specchio con una massa di attori» (Wallace 2001: 90), non può non venire in mente la sequenza d’apertura del film In girum imus nocte et consumimur igni di Guy Debord – frase palindroma che darà anche il titolo a un suo saggio – in cui il filosofo mostra che «L’attuale pubblico di una sala cinematografica, intento a guardare fissamente davanti a sé, sta di fronte, in un perfetto controcampo, agli spettatori, che dunque sullo schermo non vedono altro che se stessi» (Debord 1998: 7).
Ebbene, si sappia che in Verso Occidente questo fenomeno ha luogo letteralmente. Se infatti Tom Sternberg «ha con gli specchi un rapporto di amore-odio» (Wallace 2001: 90) è perché, da un lato, ambisce a diventare attore di professione ma, dall’altro, il suo aspetto è segnato da «un fatale difetto fisico. Ha un occhio completamente rivoltato verso l’interno della testa» (ivi: 49). E sappiamo che non si tratta di un occhio cieco, ma di un occhio che vede, sebbene Tom «di quello che vede l’occhio rivolto all’indietro non parla» (ibidem).
Lo sguardo di Sternberg, possiamo dunque affermare, è a sua volta palindromo, speculare nella misura in cui i suoi occhi non guardano nella stessa direzione, né in direzioni opposte ma entrambe esterne, bensì rispettivamente all’esterno e all’interno, separandosi là dove si toccano e toccandosi là dove si separano. In altre parole, i suoi occhi formano il medesimo gioco di campo/controcampo mostrato da Debord. E sarà lo stesso Wallace a trattare esplicitamente questo concetto nel suo romanzo successivo, Infinite Jest (1996).
Nella famosa nota 24 di Infinite Jest, quella relativa all’estesa filmografia di James Incandenza, oltre a non mancare un riferimento al regista Hollis Frampton (autore, aggiungiamo noi, di un film muto del 1969 intitolato Palindrome e che si chiude significativamente con la didascalia «Et consimumur igni»), compare un «pubblico come cast riflesso», insieme spettatore e attore protagonista di un bizzarro film, The Joke:
The Joke (La beffa). A.S. Latrodectus Mactans Productions. Pubblico come cast riflesso; 35 mm x 2 telecamere; lunghezza variabile, bianco e nero; muto. Parodia degli «eventi specifici del pubblico» di Hollis Frampton, due videocamere Ikegami Ec-35 riprendono nella sala il pubblico del «film» e proiettano sullo schermo le immagini risultanti – il pubblico della sala che guarda se stesso guardare se stesso mentre comprende la «beffa» e si mostra sempre più imbarazzato e a disagio e ostile, comprendendo di far parte dell’involuto flusso «antinarrativo» del film (Wallace 2006: 1187).
Questo sguardo in controcampo – o, se lo si preferisce, questo sguardo/controsguardo – assume, in Infinite Jest come già in Verso Occidente, i tratti di un’efficace metafora: se le passate generazioni di spettatori avevano da fare i conti con lo schermo cinematografico e con quello del televisore per affacciarsi ai mondi mostrati nelle pubblicità e nei film, la generazione attuale non si limita ad affacciarsi a determinati scenari, perché ha in aggiunta la possibilità di interfacciarsi costantemente con uno schermo – che sia quello di un televisore o di un monitor, di un tablet o di uno smartphone – fino, però, a rivoltare subito verso l’interno uno sguardo che non ha fatto in tempo a guardar fuori, condannandosi in ultima istanza a riflettere incessantemente se stessa e la propria immagine in un gioco vertiginoso di rincorsa, o perdita, di identità.
Volendo in conclusione individuare un senso complessivo che colleghi tutti questi spunti, possiamo dire che l’esito del nostro discorso sembra condurre a ciò che potremmo definire come coazione alla mimesi, intendendo con quest’espressione un processo che fa capo alla passività esasperata di quell’“Io minimo” che, mosso da impulsi ambivalenti, coniuga dentro di sé il sentimento di onnipotenza narcisistica con la percezione del proprio vuoto e della propria debolezza (cfr. Lasch 1981 e 1985, Lipovetsky 1995 e 2007).
Avendo inizio in età infantile con la ripetizione meccanica degli slogan pubblicitari, tale coazione alla mimesi ha il suo tratto distintivo nell’emulazione e nella riproduzione, e quindi nella mancata opposizione ai desideri seriali – di cui l’Io subisce la seduzione anche in età adulta – e nella mancata reazione alla forza livellante di un’indifferenziazione che, confinando le soggettività in un monadico isolamento, tutto uniforma senza nulla accomunare.
Per un mondo – e Wallace lo insegnava già trent’anni fa – omogeneizzato nei costumi e nei pensieri tanto quanto lo sono i burgers di McDonald’s.
Fonti citate
Bibliografia:
Arendt 1989: H. Arendt, The Human Condition (1958), trad. it. Vita activa. La condizione umana, Bompiani, Milano.
Barber 2010: B. Barber, Consumed: How Markets Corrupt Children, Infantilize Adults, and Swallow Citizens Whole (2007), trad. it. Consumati. Da cittadini a clienti, Einaudi, Torino.
Barth 1974: J. Barth, Lost in the Funhouse. Fiction for Print, Tape, Live Voice (1968), trad. it. La casa dell’allegria. Storie da stampare, incidere su nastro, recitare, Rizzoli, Milano.
Bauman 1999: Z. Bauman, Globalization. The Human Consequences (1998), trad. it Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Laterza, Roma-Bari.
Bauman 2000: Z. Bauman, In Search of Politics (1999), trad. it La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano.
Collettivo 33 1997: Collettivo 33, Per l’emancipazione. Critica della normalità, Cronopio, Napoli.
Debord 1998: G. Debord, In girum imus nocte et consumimur igni (1978), trad. it Id., Mondadori, Milano.
Dumoulié 2004: C. Dumoulié, Controllo dei godimenti e fascismo soft, in “L’espressione”, anno II, n. 1, Cronopio, Napoli, pp. 83-99.
Karmodi 2012: O. Karmodi, David Foster Wallace. Un’intervista inedita, Terre di Mezzo, Milano.
Kundera 2000: M. Kundera, Les Testaments trahis (1992), trad. it. I testamenti traditi, Adelphi, Milano.
Lanier 2010: J. Lanier, You’re Are Not A Gadget: A Manifesto (2010), trad. it Tu non sei un gadget, Mondadori, Milano.
Lasch 1981: Ch. Lasch, The Culture of Narcissism (1979), trad. it La cultura del narcisismo, Bompiani, Milano.
Lasch 1985: The Minimal Self. Psychic Survival in Troubled Times (1984), trad. it L’io minimo. La mentalità della sopravvivenza in un’epoca di cambiamenti, Feltrinelli, Milano.
Lipovetsky 1995: G. Lipovetsky, L’ère du vide. Essais sur l’individualisme contemporain (1993), trad. it L’era del vuoto. Saggio sull’individualismo contemporaneo, Luni, Milano.
Lipovetsky 2007: G. Lipovetsky, Le Bonheur paradoxal: essai sur la société d’hyperconsommation (2006), trad. it. Una felicità paradossale. Sulla società dell’iperconsumo, Raffaello Cortina, Milano.
Maltese 2012: C. Maltese, Harry Potter e discomix. Sono giochi da bambini i veri clienti di domani, in “La Repubblica”, 28 luglio 2012, p. 7.
Musil 1992: R. Musil, Der Mann ohne Eigenschaften (1933), trad. it. L’uomo senza qualità, Mondadori, Milano.
Riesman 2009: D. Riesman, The Lonely Crowd (1961), trad. it La folla solitaria, Il Mulino, Bologna 2009.
Ritzer 1999: G. Ritzer, The McDonaldization of Society. An Investigation into the Changing Characters of Contemporary Social Life (1993), trad. it. Il mondo alla McDonald’s, Il Mulino, Bologna 1999.
Ritzer 2003: G. Ritzer, Expressing America: A Critique of the Global Credit Card Society (1995), L’era dell’iperconsumo. McDonaldizzazione, carte di credito, luoghi del consumo e altri temi, Franco Angeli, Milano.
Wallace 2000: D. F. Wallace, Brief Interviews with Hideous Men (1999), trad. it. Brevi interviste con uomini schifosi, Einaudi, Torino.
Wallace 2001: D. F. Wallace, Westward the Course of the Empire Takes Its Way (1989), trad. it Verso Occidente l’Impero dirige il suo corso, minimum fax, Roma.
Wallace 2004: D. F. Wallace, Oblivion (2004), trad. it. Oblio, Einaudi, Torino.
Wallace 2006: D. F. Wallace, Infinite Jest (1996), trad. it. Einaudi, Torino.
Wallace 2008: D. F. Wallace, The Broom of the System (1987), trad. it. La scopa del sistema, Einaudi, Torino.
Wallace 2008: D. F. Wallace, Girl with Curious Hair (1989), trad. it. La ragazza dai capelli strani, minimum fax, Roma.
Wallace 2011: D. F. Wallace, The Pale King (2011), trad. it. Il re pallido, Einaudi, Torino.
Sitografia:
LiveJournal (www.livejournal.com)
The New York Review of Books (www.nybooks.com)
YouTube (www.youtube.com).
Filmografia:
G. Debord, In girum imus nocte et consumimur igni, documentario, Francia 1978, 100 min.
H. Frampton, Palindrome, film muto, USA 1969, 22 min.
J.-B. Mondino, The Color Theft, spot pubblicitario, Francia 1987, 1 min.
Teatrografia:
L. Bargagna, Verso Occidente l’Impero dirige il suo corso, Compagnia Blu Teatro, Italia 2014.
L. Bargagna, Il dono , Compagnia Blu Teatro, Italia 2016.

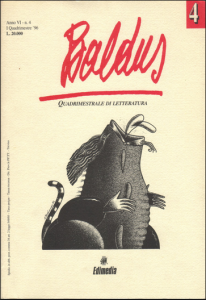 A proposito di Nazione Indiana tra noi redattori si è sempre detto che quella che a molti appariva come una debolezza- la mancanza di una gerarchia redazionale, di una parola d’ordine diktat condivisa da tutti, un’estetica e un pensiero unici e trionfanti – e perché no anche un po’ tronfi- costituiva il punto più saldo e solido, insieme alla stima e all’amicizia che hanno reso il nostro sito longevo e vivace. Eppure uno degli elementi che ci accomuna va a mio avviso identificato in quella parola di cui si diceva all’inizio: le riviste. La maggior parte di noi si è formato sulle riviste e per alcuni addirittura nelle stesse, come è stato prima il caso di Baldus, poi Paso Doble, Sud, Alfabeta e l’Atelier du Roman. L’elenco va chiaramente completato ed è proprio questo che chiederò agli altri collaboratori o lettori di Nazione Indiana: segnalate nei commenti la rivista in cui vi siete formati. Ma formati a cosa? ci si potrebbe chiedere. A stare con gli altri? A crescere insieme? A farsi le ossa? A scoprire da subito che la qualità letteraria non va affatto a braccetto con “l’argent”? Che non si è pagati per fare cultura ma appagati dal desiderio di farne parte? Che il conflitto può essere foriero di scoperte e non solo di spaccature? O più semplicemente si impara con le riviste che le cose possono finire e ricominciare, che nulla è più duraturo dell’effimero.
A proposito di Nazione Indiana tra noi redattori si è sempre detto che quella che a molti appariva come una debolezza- la mancanza di una gerarchia redazionale, di una parola d’ordine diktat condivisa da tutti, un’estetica e un pensiero unici e trionfanti – e perché no anche un po’ tronfi- costituiva il punto più saldo e solido, insieme alla stima e all’amicizia che hanno reso il nostro sito longevo e vivace. Eppure uno degli elementi che ci accomuna va a mio avviso identificato in quella parola di cui si diceva all’inizio: le riviste. La maggior parte di noi si è formato sulle riviste e per alcuni addirittura nelle stesse, come è stato prima il caso di Baldus, poi Paso Doble, Sud, Alfabeta e l’Atelier du Roman. L’elenco va chiaramente completato ed è proprio questo che chiederò agli altri collaboratori o lettori di Nazione Indiana: segnalate nei commenti la rivista in cui vi siete formati. Ma formati a cosa? ci si potrebbe chiedere. A stare con gli altri? A crescere insieme? A farsi le ossa? A scoprire da subito che la qualità letteraria non va affatto a braccetto con “l’argent”? Che non si è pagati per fare cultura ma appagati dal desiderio di farne parte? Che il conflitto può essere foriero di scoperte e non solo di spaccature? O più semplicemente si impara con le riviste che le cose possono finire e ricominciare, che nulla è più duraturo dell’effimero. Ma tornando da dove eravamo partiti, ovvero dalle dodici bellissime gambe, una cosa mi ha sempre incuriosito, come strani misteri che ci si porta dietro dall’adolescenza ed è il fatto che un numero di avanspettacolo e quello di un dossier monografico portassero lo stesso nome: rivista!! La risposta è semplice. Entrambe portano lo stesso nome perché le caratterizza la periodicità, il suo ripetersi almeno nella cornice che ospita contenuti diversi. In realtà anche altro, ancora più essenziale, unisce queste due rappresentazioni, ed è il loro mettere insieme generi diversi, gusti differenti, proponendo una mescla di alto e basso, elitario e popolare. Avanspettacolo e avanguardia hanno calcato per decenni lo stesso palco a cominciare dalla grande lezione di Tzara e Compagni, inventori di quel Cabaret Voltaire a cui è ispirato il titolo delle nostra serata. Ci saranno performance, musica improvvisata, reading, convivialità, conversations, preferendo questo termine, civile, a quello di dibattito generalmente stantio come l’acqua nelle caraffe posate sul tavolo dei relatori. Le feste di Nazione Indiana sono state e saranno questo. A Fano faremo come a Milano, Mesagne, Pistoia, Torino, Parigi, Fos’di Novo, Bolzano, dunque non mancate.
Ma tornando da dove eravamo partiti, ovvero dalle dodici bellissime gambe, una cosa mi ha sempre incuriosito, come strani misteri che ci si porta dietro dall’adolescenza ed è il fatto che un numero di avanspettacolo e quello di un dossier monografico portassero lo stesso nome: rivista!! La risposta è semplice. Entrambe portano lo stesso nome perché le caratterizza la periodicità, il suo ripetersi almeno nella cornice che ospita contenuti diversi. In realtà anche altro, ancora più essenziale, unisce queste due rappresentazioni, ed è il loro mettere insieme generi diversi, gusti differenti, proponendo una mescla di alto e basso, elitario e popolare. Avanspettacolo e avanguardia hanno calcato per decenni lo stesso palco a cominciare dalla grande lezione di Tzara e Compagni, inventori di quel Cabaret Voltaire a cui è ispirato il titolo delle nostra serata. Ci saranno performance, musica improvvisata, reading, convivialità, conversations, preferendo questo termine, civile, a quello di dibattito generalmente stantio come l’acqua nelle caraffe posate sul tavolo dei relatori. Le feste di Nazione Indiana sono state e saranno questo. A Fano faremo come a Milano, Mesagne, Pistoia, Torino, Parigi, Fos’di Novo, Bolzano, dunque non mancate.


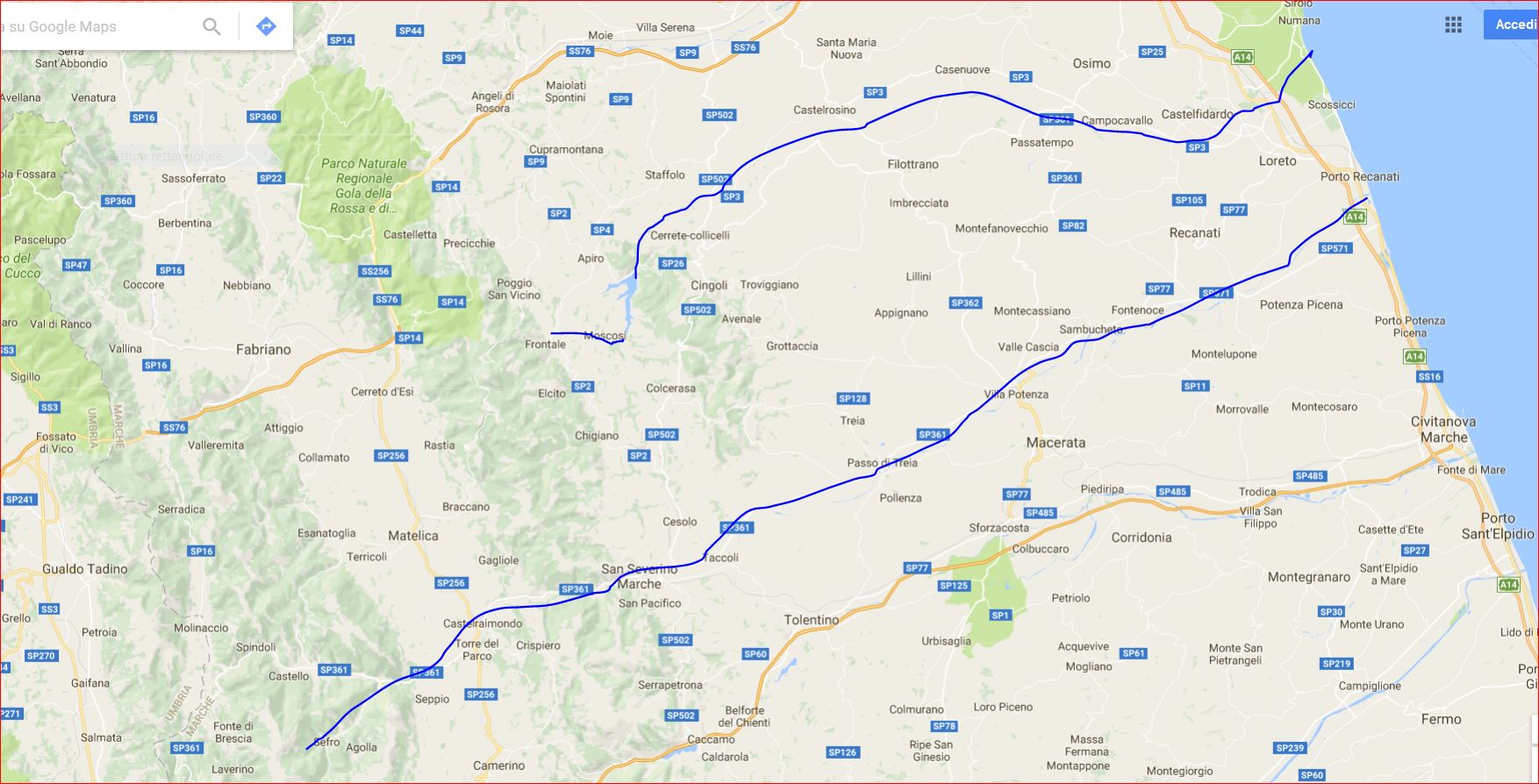
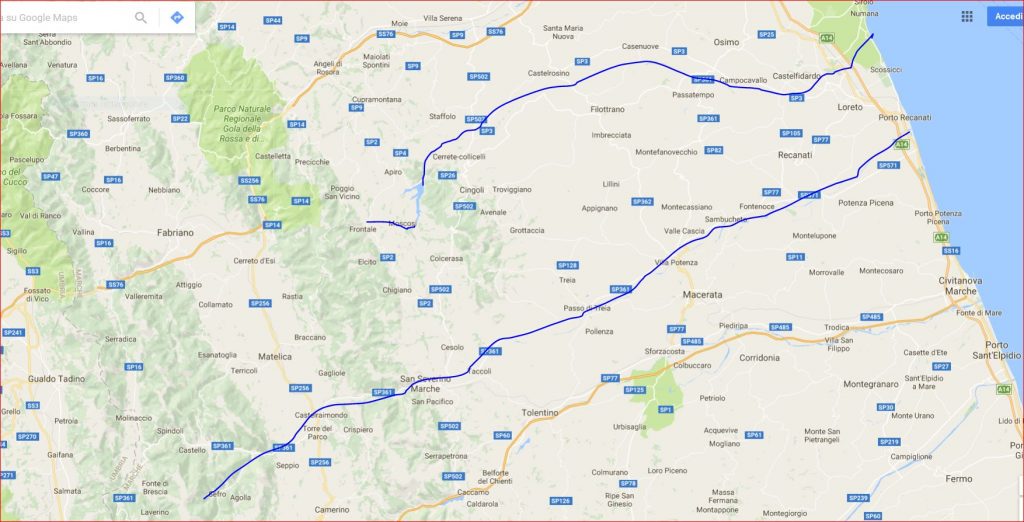




 E’ uscito ormai da qualche mese Santa Mamma il nuovo romanzo di Giulio Cavalli. Pubblico volentieri qui su Nazione Indiana qualche pagina e ringrazio l’autore per la disponibilità. G.B.
E’ uscito ormai da qualche mese Santa Mamma il nuovo romanzo di Giulio Cavalli. Pubblico volentieri qui su Nazione Indiana qualche pagina e ringrazio l’autore per la disponibilità. G.B.
 di Gianluca Garrapa
di Gianluca Garrapa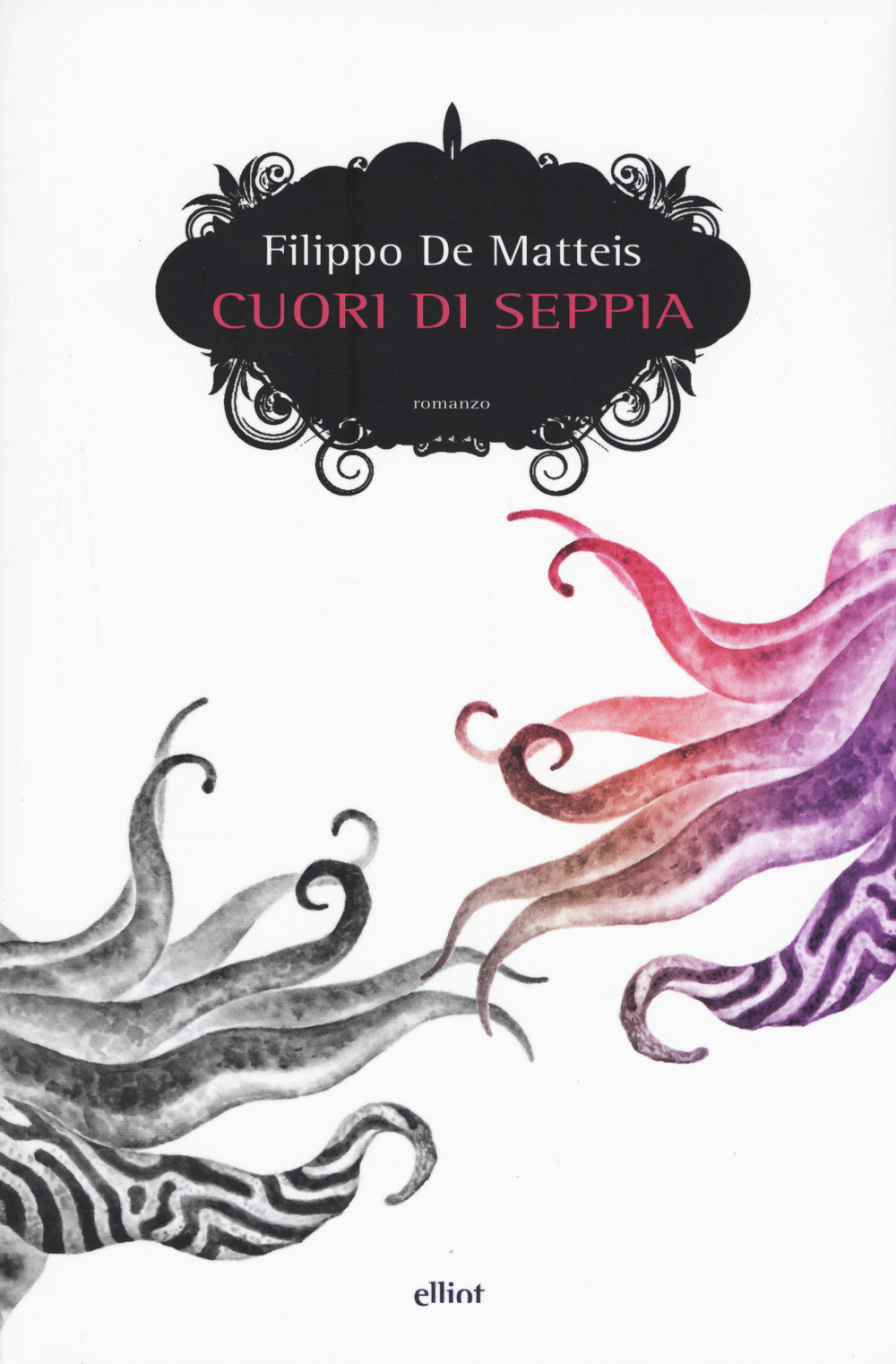
 Filippo De Matteis ha scritto un libro delicatissimo e struggente. Cuori di seppia, il suo esordio narrativo per Elliot Edizioni, è un improvviso viaggio a rebours nei meandri più reconditi di mente, corpo e anima, attraverso un soliloquio ininterrotto popolato da presenze misteriose, personaggi lugubri e inquietanti rivelazioni.
Filippo De Matteis ha scritto un libro delicatissimo e struggente. Cuori di seppia, il suo esordio narrativo per Elliot Edizioni, è un improvviso viaggio a rebours nei meandri più reconditi di mente, corpo e anima, attraverso un soliloquio ininterrotto popolato da presenze misteriose, personaggi lugubri e inquietanti rivelazioni.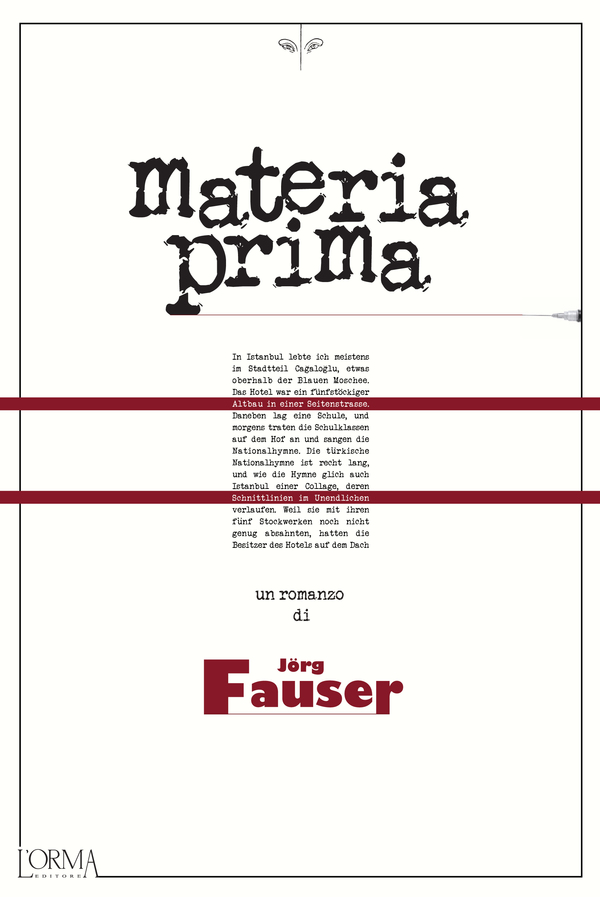
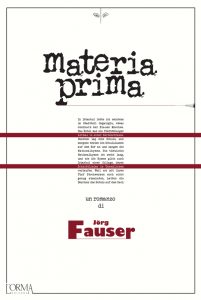 Di Daria Biagi
Di Daria Biagi