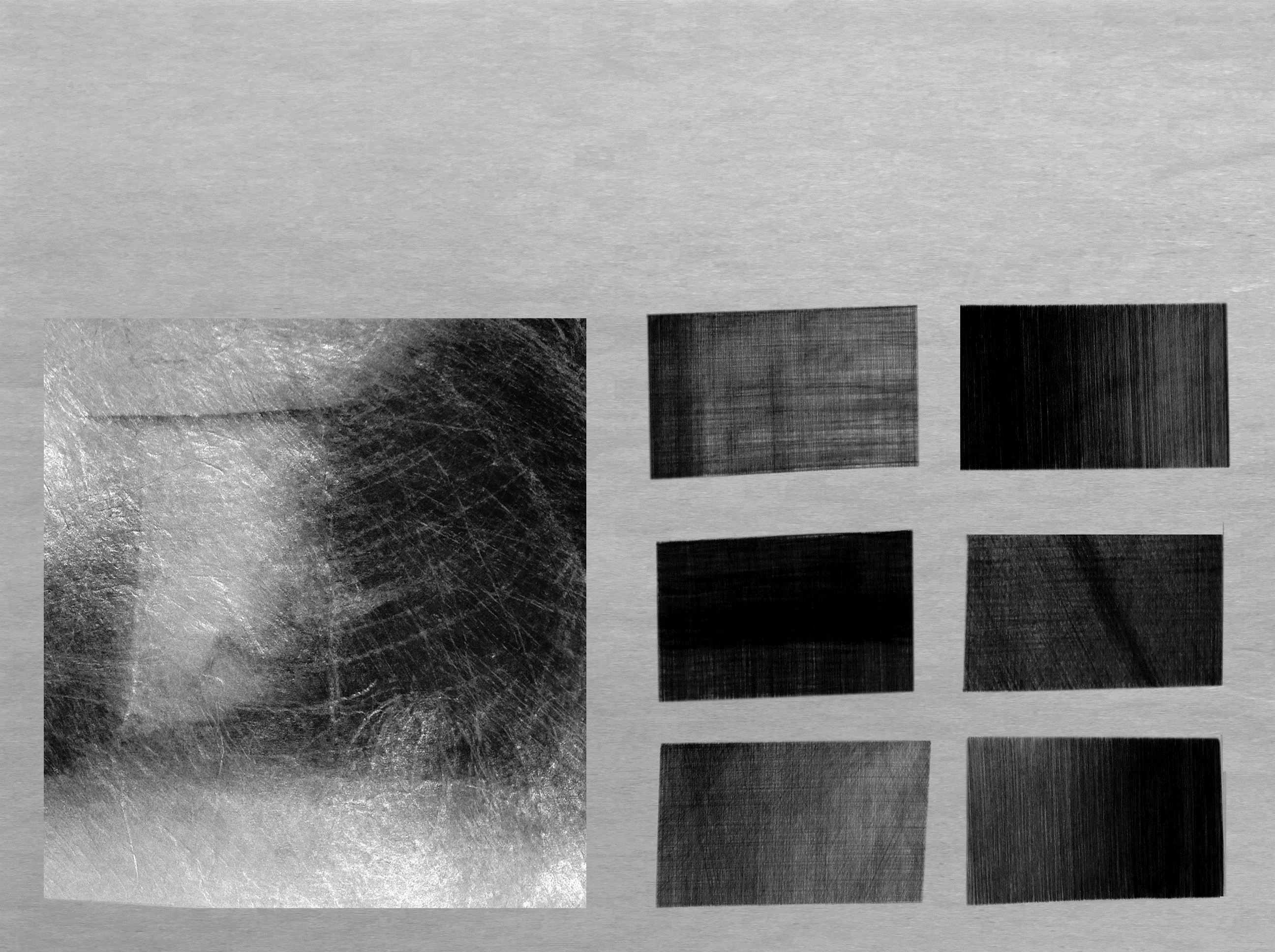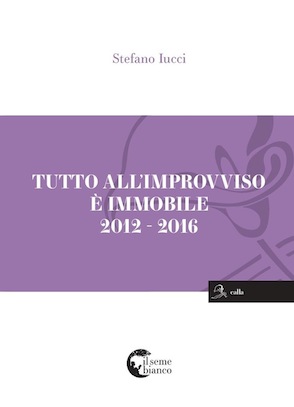di Helena Janeczek

Dopo due anni d’attesa credevo che era fatta. Il decreto prefettizio firmato in data 12 aprile e notificato il 23 maggio dal mio comune di residenza, comunicava che mi è stata “conferita la cittadinanza italiana”. Ero così euforica che mi sono illusa di poter votare subito. “Deve aspettare il giuramento” m’hanno detto all’ufficio elettorale. Sono tornata a casa con la coda tra le gambe.
No taxation without representation
Non credo di esagerare…
di Monia Gaita
Non credo di esagerare se affermo che siamo diventati un popolo di arresi, di stanchi, di vinti e desistenti. La frattura tra volontà e realizzazione è sotto gli occhi di tutti. Ognuno la possiede in dotazione variabile. La gente è riluttante a unirsi per dare uno sbocco congiunto alle proprie istanze. Si cammina da soli, si rinuncia alla lotta, si accetta e si mescola il giusto e l’ingiusto come soluto e solvente, in nome di una neutralità generica che annienta lo slancio e blocca i progetti. Abbiamo espropriato il fare di troppi latifondi, aggravato la povertà del pensiero, sconvolto la struttura sociale della linearità logica a favore di un impianto centralizzato instabile e confuso. Siamo schiavi di consorterie e corporazioni, schieramenti associativi collusi e prepotenti, disarticolati e frammentati disegni di miglioramento, sporadiche e maldestre imprese di rivolta. Per non parlare della politica, a metà tra demagogiche réclame a buon mercato e soluzioni friabili, incongrue e partigiane. Questa incertezza manomette il quadro delle relazioni, dal lavoro alle aspettative individuali, permeando di sé persino i luoghi. Diventiamo sostituibili e prosciugati da una precarietà che sempre di più ci annette alla fragile alleanza ramo-foglia. Il tempo ha rotto il negoziato con la contemplazione amica e consolatrice, ci porge solo piccoli bocconi, virate improvvise o striminzite fasce d’aria. Anche le parole hanno fretta e culminano nei trafori dell’ansia: sembrano profughi in cerca d’accoglienza mentre troviamo difficile accogliere pure noi stessi. Siamo dimissionari ancora in carica di una vita che non ci appartiene più. Ecco perché perdiamo il senso: il senso dei valori, del dovere, dell’amore, della gioia, della solidarietà. Abbiamo paura di difenderlo, di proteggerlo, di custodirne il seme. Con la pienezza stipuliamo un armistizio meramente provvisorio, freddi e motivati patrocinatori della teoria del “mi conviene”. Tradiamo all’occorrenza, stringiamo patti caduchi che sbandieriamo eterni. Abbandoniamo con disinvoltura, vigliaccheria o ragionato calcolo. Quando la pressione delle energie richieste si fa forte, preferiamo lasciar andare, capitolare senza ardimento e senza dignità. Si svuotano anche gli spazi che abitiamo. I paesi del Sud lo dimostrano. Qui i campi sono più vincolati al cielo che agli uomini. Di uomini ne sono rimasti pochi e forse, coi decenni, si estingueranno come i dinosauri. Ci sottraiamo alla natura, ai rapporti autentici, al coraggio, all’area della riflessione e delle responsabilità. Così si impennano gli indici della solitudine e ci affidiamo al leggero, inoffensivo reame dell’effimero. Diventiamo seguaci del superfluo, cospiratori di ovvietà. Una mancanza di peso che oltre a toccare i gesti, imbraccia il fucile anche contro il linguaggio. La civiltà innesta la retromarcia pure con le parole. Il dire congeda il poderoso esercito di varietà e di grazia dei lessemi correndo sul nastro trasportatore della ripetitività espressiva. L’abbassamento del linguaggio sanziona un regresso, un arretramento del comunicare che lacera e sfigura anche gli anelli del sentire. Cosa significa, allora, imboccare la via di un’insurrezione consapevole? Trasformarci da operatori d’inerzia a operatori d’azione, uccidere e saccheggiare non quello che siamo, ma quello che siamo diventati un po’ per paura, un po’ per ignavia imitativa, un po’ per abitudine.
Vasio di mezzanotte
di Francesca Fiorletta
 Recentemente pubblicato da nottetempo edizioni, “Tuono di mezzanotte” è una brillante raccolta di racconti di Carla Vasio, in cui grandeggia tutta la sua affilata prosa onirica.
Recentemente pubblicato da nottetempo edizioni, “Tuono di mezzanotte” è una brillante raccolta di racconti di Carla Vasio, in cui grandeggia tutta la sua affilata prosa onirica.
Di seguito, uno dei quattordici spaccati di vita (e magia) che compongono il libro.
Beatrice detta Bea
Incompresa, esasperata, drammatica, la Bea sbatte la porta, accende il lampadario appeso al soffitto, scaraventa la cartella sul letto e si getta bocconi sul tappeto.
Attraverso la finestra spalancata entra un forte odore di erba tagliata, guizza qualche riflesso mobile senza altra causa che non sia il riverbero del tramonto, interviene il suono impaziente di un clacson o lo stridore di una marcia male ingranata.
La Bea aspetta la primavera: la Bea è sicura che non ha mai tardato tanto a venire, ma questa sera il cielo è già di una trasparenza perfetta.
Lettura insolita a Campo Boario: cinque libri – o quasi – (e interventi sonori)
DOLCI + RAOS, MORRESI, SEVERI, SCAPPETTONE + ARIANO > 20.06.17
da I processi di ingrandimento delle immagini
di Paola Silvia Dolci
Cremona. Lungofiume, c’è il sole.
I due sparano ai papaveri,
ai diphylleia grayi che saltano in aria
come palloncini pieni di fumo.
La gente si sveglia con un cane
che gli salta sul letto.
/
da Le avventure dell’Allegro Leprotto
di Andrea Raos
Penso il pensiero
altrui formarsi e farsi fiato e vedo
che le cose accadono
e non sono mai le stesse:
tutte cambiano,
le buone ingrigendo come il giorno, le cattive
fisse in uno sguardo pronto a spegnersi.
Così sono guardato
mai guarito dalle cose.
*
Tutto sta
in un giro di chiave
e in un doppio giro di chiave
e se voglio continuare
e mi sento cadere
giro ancora la chiave.
Tutto cade
non so dove.
Tutto è neve.
Quanto è breve.
/
da anti-sismiche
di Renata Morresi
Una casa avrà i vecchi e gli allettati
allineati per orizzontale e composti
gli uni sugli altri, alternati da strati
di badanti polacche e moldave,
per il sostentamento disposte ad incastro,
a spina di pesce, coi centenari montanari
a triplo vincolo, le vecchissime vergare
marchigiane usate a mo’ di foratelle,
gli intubati sussunti nel grande disegno,
le fantesche innestate come impianti,
i curati e i curanti, i validi e gli invalidi,
canterti delle nuove anti-sismiche,
anti-abitanti, senza bisogno.
/
da Sinopia
di Luigi Severi
non era rimasto nessuno
così è uscito dalla stanza, ha salutato l’infermiere
dopo aver riposto nella bara con ordine la sua biancheria, aver investito
i suoi ultimi fondi pensione, a perdizione
da qualche parte filtra, in quel nero dove non si trova
(lacca di robbia, asfalto, blu d’oltremare: mescola
in furia, stendi senza tregua: stare),
questo è l’assedio immobile, premeditato / stop:
trattenere, rilasciare, trafiggere, credere sempre meno
fino all’ultima molecola che inspiri / crepa la guaina, poco,
crepa la guaina, in fondo, come si dice, al tubo: Schlauch
[Indica due punti] E qui, e qui – sotto pressione
corpo di vecchio e voce, per difendersi
è legno che brucia e in quell’attimo
forse sai (proprio alla fine) di guardare
(disegno che è una brutta imitazione):
la prima, finalmente, parola che dici
/
“Imagine a Cinder-Wench”
da The Republic of Exit 43
di Jennifer Scappettone
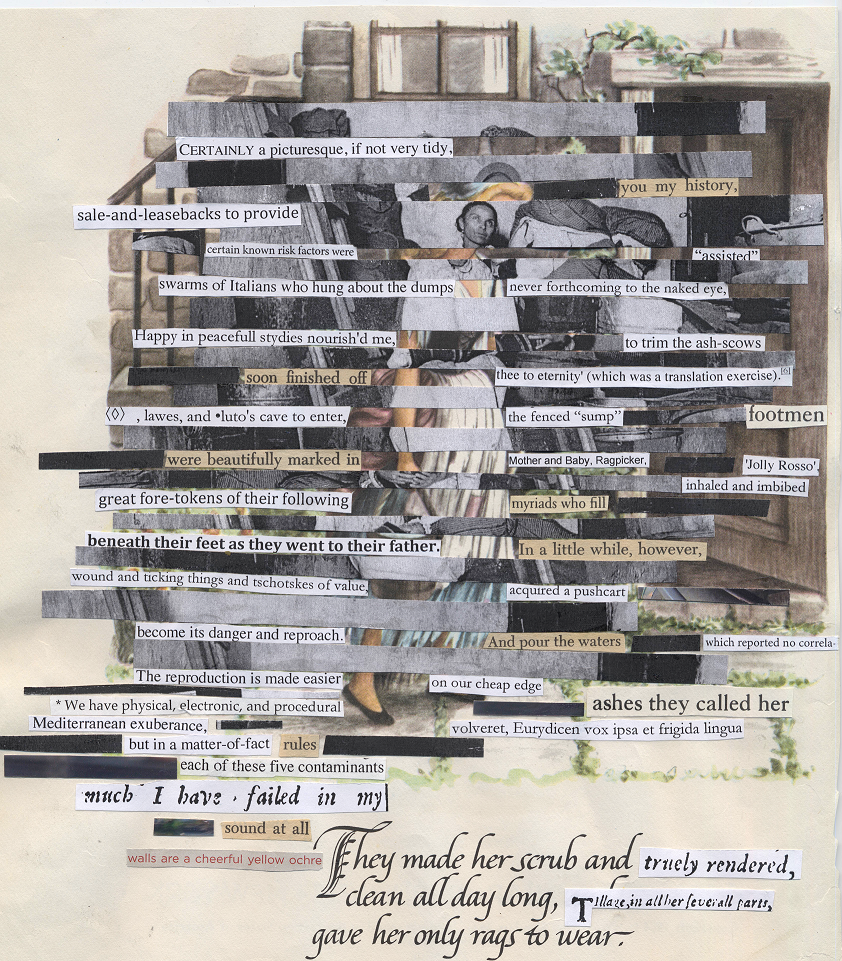
*
letture e performance per 5 testi:
> I processi di ingrandimento delle immagini, di Paola Silvia Dolci
> Le avventure dell’Allegro Leprotto, di Andrea Raos
> Anti-sismiche, di Renata Morresi
> Sinopia, di Luigi Severi
> The Republic of Exit 43, di Jennifer Scappettone
Studio Campo Boario
(Roma, Via Campo Boario 4/A)
ore 18:30
***
Marco Ariano è batterista/percussionista, compositore di musica improvvisata, artista multimediale. Sperimenta scritture poetico-scenico-sonore ed elabora dispositivi/strategie di produzione musicale. Nel 1999 fonda il laboratorio di ricerca artistica CarneCeleste con il quale sviluppa l’idea di un “teatro di eventi sonori” realizzando performance, installazioni e opere multimediali. È fondatore/co-fondatore di gruppi legati a pratiche eterogenee di improvvisazione, come Opera Mutica, Xubuxue, Difforme Ensemble, Ensemble Intondo.
Paola Silvia Dolci, ingegnere civile. Diplomata presso il Centro Nazionale di Drammaturgia. Collaborazioni con riviste letterarie. Direttore responsabile della rivista indipendente di poesia e cultura Niederngasse. Tra gli altri ha tradotto Maxine Kumin e Galway Kinnell. Ha pubblicato Bagarre (Lietocolle, 2007), NuàdeCocò (Manni, 2011), Amiral Bragueton (Italic Pequod, 2013) e I processi di ingrandimento delle immagini (Oèdipus, 2017).
Renata Morresi ha pubblicato Cuore comune (peQuod, 2010), Bagnanti (Perrone, 2013) e La signora W. (Camera verde 2013), quest’ultima apparsa anche in traduzione francese su Nioques 14 (2015). Ha tradotto Rachel Blau DuPlessis (Dieci bozze, Vydia 2012, Premio Marrazza 2014) e nel 2015 ha ricevuto il premio del Ministero dei Beni Culturali per la traduzione di poeti americani moderni e post-moderni. Sta ultimando la traduzione di Zong!, poema della canadese NourbeSe Philip. È redattrice di Nazione Indiana e di punto critico°.
Andrea Raos è scrittore e traduttore. Il suo ultimo libro è Le avventure dell’Allegro Leprotto e altre storie inospitali (Arcipelago Itaca, 2017).
Jennifer Scappettone ha pubblicato From Dame Quickly (Litmus Press, 2009), Thing Ode / Ode oggettuale (La Camera Verde, 2008), tradotto con Marco Giovenale, Err-Residence (Bronze Skull, 2007), Beauty [Is the New Absurdity] (dusi/e kollectiv, 2007) e The Republic of Exit 43: Outtakes & Scores from an Archaeology and Pop-Up Opera of the Corporate Dump (Atelos Press, 2017). La sua monografia Killing the Moonlight: Modernism in Venice è uscito nel 2014 presso Columbia University Press. Ha tradotto e curato Locomotrix: Selected Poetry and Prose of Amelia Rosselli (University of Chicago Press, 2012, Raiziss/De Palchi Book Award dell’Academy of American Poets). Insegna letteratura alla University of Chicago. Il suo sito web è http://oikost.com/
Luigi Severi ha scritto saggi sulla letteratura rinascimentale e novecentesca (tra cui l’e-book Sull’intellettuale dissidente, e-dizioni Biagio Cepollaro, 2007). Libri di poesia: Terza persona (Atelier, 2006), Specchio di imperfezione e Corona (La camera verde, 2013), Sinopia (Anterem, 2016).
Grazie, Sergione
di Helena Janeczek

– Sergio, mi serve il tuo aiuto.
– Whatever, princess.
– Quando questi sparano da giù, a quelli sotto l’abbazia di Montecassino che cosa esattamente gli arriva in testa?
– La gittata?
– Sì, la frammentazione, l’impatto. Del fuoco di sbarramento. L’appoggio dell’artiglieria, in genere. Però hanno beccato i loro uomini, regolarmente.
– Okay. That’s how it goes.
– Okay. Ma me lo spieghi bene?
Sergio Altieri me lo spiegava bene. Mi spiegava come si produce uno shrapnel, come sfonda il cranio o dilania i tessuti, come un’esplosione acceca, assorda ecc. Poi chiedeva come stavano mio figlio e mia madre, quanti anni avessero, se era tutto a posto, a parte ciò che non lo era. Ricambiavo la domanda.
L’ho rivisto poco più di un mese addietro, assieme a Gianni Biondillo, dopo un numero di anni che non so precisare. Scorgere la sua stazza da grizzly, talmente incongrua con quella festa dell’editoria milanese, mi ha allargato il cuore, come sempre.
Ci si sentiva al riparo, vicino a Sergio. Accanto a Sergione non c’era spazio per il cinismo educato, il pettegolezzo, la sfiducia. Sergio Altieri era convinto che il mondo degli uomini stesse andando verso il definitivo game-over e che bastava poco perché, da sempre, la crosta di civiltà si rompesse e ne eruttasse la sopraffazione del homo homini lupus. Era un uomo che ne pativa, credo, nella misura in cui i suoi libri mettono in scena quella violenza e quel nichilismo. Era un uomo molto più sensibile di tanti che credono di esserlo e, a suo modo, ne era consapevole: una cosa assai meno scontata dato l’aspetto, l’eloquio e l’estetica dei suoi romanzi.
Non credeva in niente, Sergione Altieri. Ma credo gli farebbe piacere che il bene che ha disseminato gli stia tornando indietro, come si evince dal cordoglio, così corale e così sincero, che accompagna la sua morte doloramente improvvisa.
Ti terremo nelle nostre librerie e memorie che non prendono la polvere, se abbiamo ancora un po’ di tempo prima della Fine. Grazie, Sergio.
ps. Digitando “Alan D. Altieri”, potete trovare gli articoli dedicati a Sergio.
Letteratura e memoria/2: Michele Mari
di Stefano Gallerani
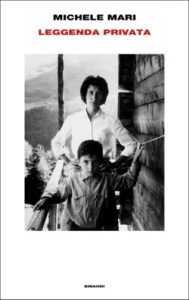
Michele Mari
Leggenda privata
pp. 171, € 18,50
Einaudi, “Supercoralli”
Torino, 2017
La riedizione (rivista e aggiornata) dei saggi contenuti ne I demoni e la pasta sfoglia (Il Saggiatore; già Quiritta e Cavallo di ferro) e quella del romanzo leopardiano Io venía pien d’angoscia a rimirarti (Longanesi prima, Einaudi ora) ha preparato, nei mesi scorsi, l’uscita dell’ultimo libro di Michele Mari: Leggenda privata (Einaudi, “Supercoralli”, pp. 171, € 18,50). Tre anni dopo l’aperçu ottocentesco di Roderick Duddle e sette dopo la psichedelia letteraria di Rosso Floyd, Mari vira su se stesso come già esplicitamente nel suo romanzo più vertiginoso, Rondini sul filo (Mondadori, 1999) o, in maniera più trasversale, nel volumetto fotografico Asterusher (Corraini Edizioni, 2015), non a caso sottotitolato “autobiografia per feticci”.
Irish in Italy

Dopo l’allestimento dello scorso inverno alla Biblioteca Nazionale di Roma, torna oggi, 16 giugno, Bloomsday, la mostra Irish in Italy sui rapporti tra letteratura e politica irlandesi e italiane nella prima metà del Novecento.
In mostra per due settimane le più importanti prime edizioni italiane di Yeats, Joyce, Synge, Wilde, Shaw e di altri autori irlandesi, insieme alle lettere di Pavese, Montale, Joyce, Bragaglia, Yeats.

La poesia come ape operaia. Su Fatti vivo di Chandra Livia Candiani
nota di Giorgio Morale
Silvio Perrella in un articolo su Il Mattino (19, 5, 2017) a proposito di Fatti vivo, il nuovo libro di Chandra Livia Candiani (Einaudi 2017) nota che “Chandra Livia Candiani mentre scrive è come se pregasse; i suoi sono esercizi di armonizzazione tra quel che è passeggero e quel che resta e sta ‘sopra il disordine della realtà’. Scrivere versi pregando è per lei l’infinito inseguimento degli elementi primi, come la pioggia o la sete. È il tentativo di scrutare ‘il fondo/sereno delle cose’”.
Anche Antonio Prete su Il manifesto (21, 5, 2017) parla della poesia di Chandra Livia Candiani come preghiera: “I versi di Chandra Livia Candiani – ho vive in me le impressioni che hanno accompagnato la lettura dei precedenti suoi libri – ospitano gli oggetti, la loro aura onirica, la loro anima, circondandoli di un sentimento del tempo e trasformandoli in presenze intime… A uno sguardo che è di stupore e di preghiera, insieme. Il mostrarsi del mondo – del suo suono, del suo furore – è accolto in una parola che è insieme accoglimento dell’esistente e interrogazione di sé… La poesia è tutta ospitalità che fa rifiorire quel che accoglie, oggetto o ricordo, presenza umana o animale”.
Vorrei porre in evidenza due cose che emergono da queste citazioni. Innanzitutto il rapporto tra io e mondo, per il quale le “presenze intime” diventano “sentimento del tempo” e il “mostrarsi del mondo” diventa “interrogazione di sé”. Questo ritrovare se stessi nel mondo e scoprire nel mondo quel che si ha dentro di sé è un atteggiamento che Candiani ha portato a piena evidenza ne La bambina pugile e che viene approfondito in Fatti vivo: “sono buttata in tutto ferito, / in questo solo questo mondo”. È un atteggiamento che rende il poeta accogliente e allo stesso tempo partecipe delle gioie e dei dolori del mondo e che rende la poesia “cantico” e “preghiera”. Di accoglienza del mondo e di sentimento del tempo oggi c’è molta necessità, ed è questo che rende quella di Chandra Livia Candiani una poesia di cui il nostro tempo ha bisogno. Si tratta di una accoglienza che non arretra di fronte ad alcuni aspetti in ombra della realtà, di fronte al dolore e al male del mondo: “Il dolore degli altri / non mi sta in mano / e nemmeno in gola / più che altro sta nel petto”. Perciò la poesia di Livia Candiani esprime un desiderio di “aspirare / il cielo” ma anche di “farsi terra e polvere”. Senza opporre barriere e difese: “Lasciati bruciare”.
In questo atteggiamento c’è anche un risvolto etico e quindi pragmatico: “L’amore è diverso / da quello che credevo, / più vicino a un’ape operaia / a un tessitore / che a un acrobata ubriaco, / più simile a un mestiere / che a un sentire”. Siamo molto lontani dall’immagine del poeta e dell’uomo come acrobata tipico delle avanguardie novecentesche. Amare è un mestiere, e accogliere implica un’azione che è quella di raccogliere quanto è violentato e disperso.
Come ha detto Erri De Luca nel suo intervento alla riunione nazionale di Emergency, a Genova l’1 luglio 2016, “Il mio verbo moderno è raccogliere: un raccolto di vite che non abbiamo seminato, allegato, educato”. Realizzando il significato originario del verbo dire, in greco legein cioè raccogliere, Chandra Livia Candiani con la parola raccoglie questo che “Mio mondo / chiamano / mio mondo / essere senza mondo”. Il respiro del poeta, metonimia per dire la parola, “porta brandelli di mondo”. Ecco infatti che nei suoi elenchi Chandra Livia Candiani raccoglie “Abu faccia sbriciolata” e i nomi dei bambini morti annegati nel Mediterraneo, “lo sgombero visto da un bambino” rom e l’uomo che chiede “Dammi da mangiare / dammi da bere”, e perfino gli animali privati del loro ambiente naturale: “elefante, leone, tigre, orso bruno, lince, storione…”
L’auspicio è che possa verificarsi per il lettore quello che nella prima sezione del libro dice Il portone: “quelli che entrano / non usciranno uguali”. E che ognuno dei lettori raccolga queste “istruzioni per farsi vivi”, perché “Di guerrieri indifesi / ha bisogno il mondo, / di sacra ira / di occhi spalancati”.
Poesie tratte dalla nuova raccolta di poesie di Chandra Livia Candiani, Fatti vivo (Einaudi 2017).
L’amore è diverso
da quello che credevo,
più vicino a un’ape operaia
a un tessitore
che a un acrobata ubriaco,
più simile a un mestiere
che a un sentire.
Io amavo
un po’ con la memoria astrale
e un po’ con giustizia poetica,
ma l’amore
è più vicino a una scienza
che a una poesia,
ha delle sue regole di risonanza
e altre di respingenza,
ha angoli di incidenza
per profili alari e luce,
ma non ha regole per il buio
e l’assenza di ali.
L’amore è molto simile
all’insonnia,
non devi soffrirla
solo ospitarla,
lasciare che ti squassi
faccia di te un sistema nervoso
senza isolamento,
una corda tesa
di strumento musicale ignoto.
Essere temi musicali
non è una vocazione
ma una disciplina di spoliazione,
è farsi ossi
limati
dalle onde
goccia che si disfa
nel galoppante mare.
*
Il dolore degli altri
non mi sta in mano
e nemmeno in gola
più che altro sta nel petto
nella sua memoria
luogo schivo
che fa stazione
che scartavetra le fughe.
*
Mentre morivo
annegata di promesse
piombate al fondale
col cemento,
mentre deglutivo mare
non pensavo,
elencavo pezzetti di bene
scrostato dalla pelle:
le ombre salvifiche
le ciglia sotto il sole deserto
le labbra bambine
al capezzale del latte.
L’angelo africano
è un baobab
ha radici.
Mentre morivo
mi prendeva una nostalgia
che rapiva via
verso le rapide nuvole
e lui
l’angelo
teneva teneva.
*
E gli uomini della volta celeste
salivano e scendevano
uno spezzava il pugnale
contro la tua roccia
uno scavava con la zappa
fino al tuo serbatoio buio
metteva alla luce i reperti
li nominava
erano blu
uno scardinava il tuo uscio
chiedevi:
“Mi porti in un posto sorvegliato?”
Nessuno è invasore del paesaggio
piuttosto il paesaggio resta per loro
non si muove.
Legge interna dei dormienti
un silenzio scrive che dormi
scrive che ti alzi
scrive che voli.
Fino a qui.
Diritto marittimo
di aspettarti.
Quando una leggenda si sbriciola
gli occhi diventano sassi.
Tu ascolta il prodigioso
canta il nome
non lasciarmi in pace.
*
Dammi da mangiare
dammi da bere
dammi i soldi bui
dammi terra sotto i piedi
dammi le mani
e l’acqua per cancellarle.
Da dove vieni bruci.
L’acqua le mani
gli angoli acuti
per la città dei tuoi passi
ecco
spiccioli di alta e bassa marea.
Fame è misterioso
richiamo
alza e abbassa regge lascia
ti reggo mi lascio.
Dove sono i miei uccelli?
Dove sono i miei cervi?
Chi non canta sui rami?
Chi non salta tra i cespugli?
Dov’è il vento,
il mio pescatore di uccelli?
Dov’è il giardiniere
che sa far ridere i crisantemi
dove sono i passi freddi
delle mucche nella notte?
Guarda, quante mani ha la pioggia
la terra tigre d’erba sotto l’asfalto
gli inciampi nel canto degli uccelli
che scavalcano l’aria.
“Devi” dicono gli alberi
alla leggera forza che smalta il verde
nel nero del ramo in inverno,
guarda il cielo che non è di nessuno
deserto di rondini e rondini.
Mangia parole,
vive.
Dammi l’acqua
dammi la mano
dammi la tua parola
che siamo,
nello stesso mondo.
Prove d’ascolto #6 – Alessandro De Francesco
9 testi da (((
posa la mano su una superficie traslucida che respira
dentro al palmo della mano la curva della superficie si alza e si abbassa a temperatura tiepida talvolta freme si arresta ricomincia a pulsare il tessuto è schiarito da un punto luce senza provenienza
nonostante la semi-trasparenza del tessuto non è dato capire se c’è un corpo dentro o una stanza o se tutto il contenuto è nella superficie stessa che continua a respirare
stanno chiusi tutti dietro alcuni possono uscire per qualche minuto quando si deve fare benzina poi vengono nuovamente spinti dentro le scosse del veicolo e le curve modificano la loro distribuzione nello spazio talvolta gli uni premono gli altri respirando affannosamente altre volte sono disposti in una geometria provvisoria non parlano quasi mai l’odore dei corpi e il tatto prevalgono sulla vista l’abitacolo è privo di finestrini ed è probabilmente notte ormai la notte questo atto di essere trasportati da un luogo all’altro
il rombo ha frequenze molto profonde ed è prolungato nel tempo a un volume elevato satura tutte le stanze ma non se ne capisce la provenienza le finestre sono chiuse ed è troppo presente perché possa infiltrarsi dalle fenditure ogni tanto sembra possibile distinguere pezzi di linguaggio in una massa unica quasi senza variazioni nessuno dei presenti si ricorda quando è iniziato esattamente qualcuno nota in un angolo di una stanza che un corpo si sta muovendo è di dimensioni molto ridotte e pulsa a ritmo irregolare talvolta lentamente altre volte a fremiti non ha occhi né arti forse dei peli stanno sotto questo oggetto liscio che è in vita le minime variazioni del rombo sembrerebbero dipendere secondo alcuni dal ritmo della sua respirazione
nel tardo pomeriggio di ritorno dal lavoro si rende conto che una massa corporea molto alta sta immobile nell’arco della porta tra una stanza e l’altra sembra che lo osservi ma non ha né arti né occhi né forma definita non dice niente non vuole niente è un territorio di tessuti
spesso volumi convessi appesantiscono i rami degli alberi talora sono fatti di foglie che ritmano l’aria altre volte da condensazioni bianche dove scavano gallerie i rami allora tracciano volte passaggi di sotto cunei lunghi
dentro i volumi nelle intercapedini scavate dai vettori o nella tana vuota ricoperta di foglie vengono forse posizionati obiettivi che abbracciano un ampio arco di paesaggio cercando informazione
le tende fatte di tessuto sintetico bianco e ricoperte da un sottile strato di neve sono disposte su uno spazio molto vasto dove predominano polvere marrone pietre e le colline circostanti il perimetro militare regola gli accessi dal promontorio non è possibile avvistare persone al di fuori di qualche
sopra una distesa di luci e nervi le cose corrono veloci dietro il pendio è una volta convessa in discesa riflessa in verticale con l’aiuto di pinze corridoi di gomma e traiettorie vengono posizionate due telecamere alle estremità dell’oggetto che si trova attualmente secondo alcuni dietro il frigorifero al rumore dell’accensione sullo schermo appare improvvisamente il volto di una bambina che fissa l’obiettivo le vengono fatte domande alle quali non risponde
tempo minerale corpo vitreo tegumenti
e piú tardi o allo stesso tempo 27 immigrati rumeni chiusi dentro una camionetta vengono scoperti sul territorio e rinviati oltre il confine
in una teca del british museum un uomo sumero in bronzo sta aspettando davanti a sé da 4000 anni con occhi lisci e senza pupille esplora spazi siderali il rumore della membrana la bacca rossa che cade nel ruscello mentre nessuno passa
l’appartamento è vuoto da sempre le luci sono accese in tutte le stanze e non ci sono interruttori per spegnerle il quadro elettrico è assente in un angolo di una stanza non lontano da una finestra una palla respira la superficie è interamente ricoperta dal derma e innervata da un sistema circolatorio piuttosto visibile sotto lo strato della pelle la sfera misura circa 18cm di diametro non ha orifizi e non emette suoni il suo unico moto è dato dal rigonfiamento ritmico a intervalli di circa 4 secondi dovuto alla respirazione
*
Esercizio ragionativo in forma di descrizione e sintesi visiva su Parentheses di Alessandro De Francesco.
di Mariangela Guatteri
(Maggio 2016)
In una gabbia tipografica voluta minima ci sono spazi ciechi in cui solidi e superfici respirano.
In una gabbia tipografica voluta minima lo spazio è diminuito con accorgimenti che lo rappresentano perimetrato, sovraffollato, saturato da un suono, privo di aperture, ingombrato, stipato, confinato in una stanza.
Qualcosa, seppur minima, respira; e succede che sorge il dubbio circa il contenuto della superficie di un tessuto.
Il contenuto della superficie potrebbe essere lo spazio da esplorare: il tessuto stesso.
Uno spazio tessutale rappresentato in una gabbia tipografica voluta minima è costituito di segni testuali.
Una superficie tessutale ha ulteriori dimensioni rispetto a quelle immediatamente visibili quando la si scorre.
Si scopre che i suoi costituenti sono molteplici e di varia natura ma non è possibile toccarli. Il senso del tatto non è in una condizione produttiva, non genera aria (un gesto sui segni testuali non sposta nulla).
Eppure c’è una continua attività respiratoria.
Respirano corpi che sono un incognito; senza identità, ad alcuni l’aria manca.
Ci sono palle, superfici, immigrati e masse corporee che occupano quasi tutto lo spazio.
Ciò che respira è senza orifizi.
Senza orifizi non si può respirare se non attraverso il proprio tessuto poroso o tramato o che consente l’osmosi.
Qui ancora non si ha certezza di come avvenga la respirazione. Apparentemente non è manifestata alcuna necessità di scambio; ciò risulta coerente con l’ipotesi che quello che respira contiene tanto il suo spazio interno quanto quello esterno.
Chi ha fatto esperienza di spazi diminuiti, tornando a respirare, può comprendere cosa, in definitiva, una delle azioni automatiche vitali per eccellenza consente in termini di dimensioni. Queste non si limitano affatto a quelle volumetriche, o facilmente misurabili, oppure di immediata percepibilità. L’automatismo respiratorio nutre il tessuto e lo fa muovere; la dimensione vitale del respiro è uno spazio che non si vede, che potrebbe risolversi sulla superficie, su una stringa, oppure essere contenuto in essa, ribaltando le consuete cognizioni dello spazio.
In forma di descrizione la superficie tessutale del linguaggio osserva quello a cui dà forma e fa muovere, e informa e istruisce; dà notizia perciò del suo territorio d’azione.
Una tenda innevata su un’area vasta, perimetrata e militarizzata. Un territorio, una superficie traslucida. Pezzi di linguaggio sono riconosciuti in un’unica massa sonora compatta. Paesaggi cadono con un solo salto nelle traiettorie di captatori d’informazione. Archi di paesaggio, tane, corridoi, schermi e distese cablate: luci, nervi. La presenza umana è irrilevante; non dice; respira male; sta in uno spazio esiguo.
Quando è iniziato tutto ciò, non è un tempo congeniale alla memoria dei fatti. Questi succedono correndo lungo nervature tessutali; hanno i loro percorsi nelle loro conseguenze; sono informazioni: le regola una matrice che vive in una gabbia tipografica.
Nella gabbia tipografica non c’è orifizio: né entrata né uscita. C’è superficie, e questa ha trovato il modo di respirare mentre contiene e si contiene nel mondo.
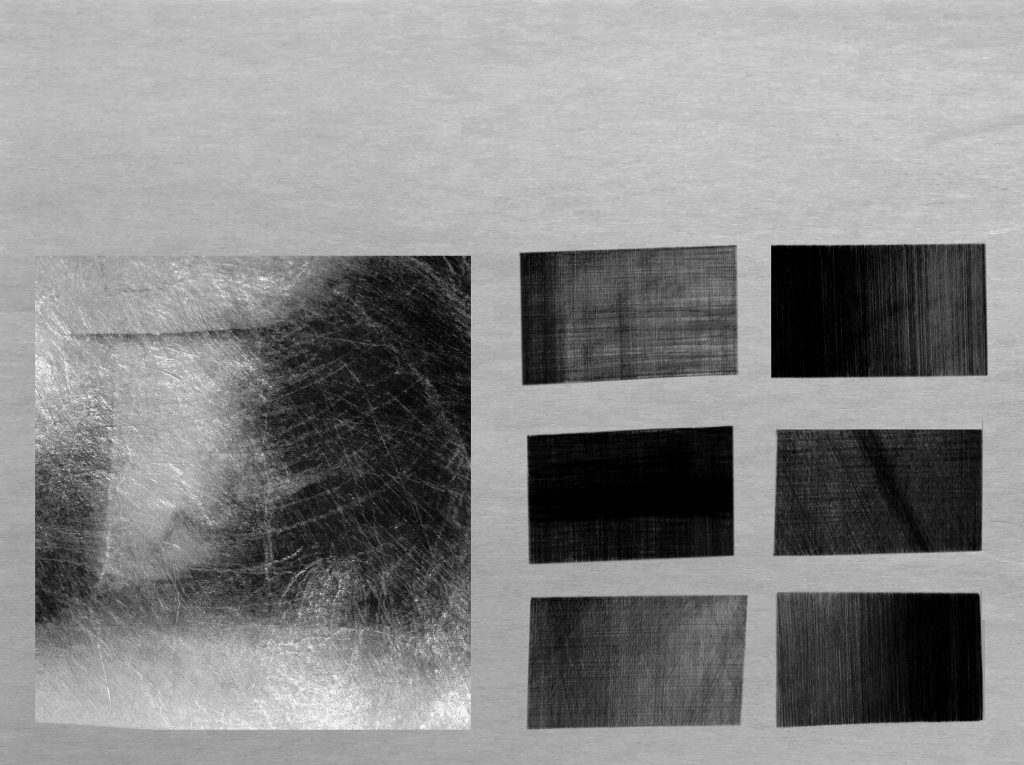
*
Prove d’ascolto è un progetto di Simona Menicocci e Fabio Teti
Com’è trascorsa la notte
 di Edoardo Zambelli
di Edoardo Zambelli
Filippo Tuena, Com’è trascorsa la notte, Il Saggiatore, 2017, 232 pagine
Mia adorata, la prima cosa che vorrei tu facessi per condividere questa specie di sogno nel quale mi trovo immerso è figurarti un palazzo lussuosissimo, ricco di saloni e gallerie, torri e terrazzi, giardini e fontane, scalinate e viali, grotte e cortili; e che questo immenso palazzo appaia tutto intero di fronte a noi; ne vediamo l’insieme e il particolare; ne siamo fuori e ne siamo dentro.
Così inizia Com’è trascorsa la notte, l’ultimo libro di Filippo Tuena. Un misterioso narratore invita la sua amata (e con lei il lettore) a immaginare il teatro dell’azione, la introduce alla fantasticheria notturna che sta per iniziare.
È un invito, ma è anche la prefigurazione di ciò che il lettore si appresta a leggere. Difatti anche lui si troverà allo stesso tempo fuori e dentro la storia, ne vedrà lo svolgersi e allo stesso tempo i meccanismi che la muovono.
La scena è quella della commedia shakespeariana: la preparazione ad Atene del matrimonio tra Teseo e Ippolita, la fuga dei due innamorati Ermia e Lisandro per sfuggire al matrimonio di lei con Demetrio (voluto dal padre di lei, Egeo, ma categoricamente rifiutato dalla ragazza), e di lì tutta la sarabanda di eventi che avverranno nel “bosco nei pressi di Atene”, popolato da magiche presenze, regno di Oberon e Titania, dove il folletto Puck combinerà guai versando il succo di viola del pensiero su occhi sbagliati.
Dicevo, la scena è quella, ma Tuena non si limita a dar voce ai soli personaggi della storia, estende questo diritto di parola anche agli attori che li interpretano. Si viene così a creare un incrocio di voci, di sdoppiamenti, un continuo moltiplicarsi di situazioni.
Dunque, immaginati sì al centro di questo strambo luogo di rappresentazione (gallerie, cortili, scaloni) ma pure immagina che rimani qui, accanto a me e mi ascolti sussurrare con diverse voci le vicende del “bosco nei pressi di Atene” come se quel che accade appartenesse al mio passato, in parte condiviso con te, in parte vissuto per mio conto. Ma lo sai, nella memoria le immagini si confondono. Si confondono gli atti coi desideri e le diverse figure che appaiono si compenetrano le une con le altre.
Filippo Tuena torna quindi in libreria con un’opera bizzarra. In certo modo, si potrebbe pensarla come un’evoluzione del precedente Memoriali sul caso Schumann, perché ne riprende la narrazione a più voci (cosa che comunque Tuena aveva già sperimentato con La grande ombra), e prosegue quella sorta di annullamento degli artifici del romanzo che ne erano caratteristica evidente (assenza quasi totale di descrizioni, ambientali o fisiche, nessun dialogo diretto vero e proprio).
A ben vedere, però, in Com’è trascorsa la notte, Tuena compie un passo ulteriore. Rinuncia ai personaggi, qui ridotti a semplici funzioni, a voci che si inseguono.
Mi viene in mente che Federico Fellini, dopo 8 e mezzo, diceva di non essere più interessato a raccontare una storia; che ciò che gli piaceva fare era lavorare, semplicemente andare sul set e lavorare, e in effetti tutta la seconda parte della sua carriera è fatta di film che hanno un andamento da deriva onirica, con protagonisti che si limitano a percorrere il territorio del sogno, privi (o quasi) di una reale psicologia. Si potrebbe addirittura affermare che i veri protagonisti degli ultimi film di Fellini siano i film stessi.
Questa stessa cosa, a me pare, si può dire anche dell’ultimo libro di Tuena. Perché anche qui, in effetti, il vero grande protagonista è l’atto del raccontare, e quindi, per estensione, il libro stesso.
Continuerò a chiamarlo “libro”, perché chiamarlo romanzo sarebbe allo stesso tempo un togliergli e un aggiungergli qualcosa. Forse sarebbe più facile fare un elenco di cosa non è, poi farne la somma, e così si otterrebbe un risultato che almeno un po’ si avvicini alla verità: riscrittura dell’opera di Shakespeare, insieme di monologhi, saggio sulla pittura dedicata al Sogno d’una notte di mezza estate, meta-romanzo, lunga e frammentaria riflessione sulla natura delle storie, giocoso resoconto di un’avventura onirica, trattato sull’amore in tutte le sue declinazioni e possibilità.
Ecco, tutto questo insieme, senza nello specifico essere nessuna di queste cose.
Pur nella sua brevità, è un’opera tanto complessa che potrebbe essere oggetto di lunghe trattazioni dedicate ad ognuno dei suoi aspetti. La cosa che a me personalmente ha più affascinato (l’ho già citata prima) è la continua riflessione sulla natura di una storia. Cosa rimane di un racconto? Di cosa è fatto? Possono i personaggi in qualche modo decidere il proprio destino? A tutto questo, Tuena dà la sua risposta (che qui è inutile riportare, perché è più bello andare a cercarla tra le pagine del libro).
È però utile una riflessione, che al lettore viene consegnata dalla voce dell’attore “che doveva interpretare Filostrato”. Questi, infatti, si trova ad un certo punto a rimuginare sul perché Shakespeare abbia scelto come motore dell’azione proprio il matrimonio fra Teseo e Ippolita, matrimonio che qui, nel Sogno d’una notte di mezza estate (e quindi anche nel libro di Tuena), alla fin fine si risolve in un momento di gioia, di trionfo d’amore, ma che invece, in altre rappresentazioni, vive un destino tragico. Non il matrimonio in sé, ma ciò che ne viene poi: la nascita di Ippolito, la tragedia di Fedra.
Quello che sembra voler suggerire qui l’autore è che una storia, qualsiasi storia, non si esaurisce nel momento in cui termina la narrazione. Ha bensì una vita molto più lunga, fatta non solo di un dopo, ma anche di un prima. Succede infatti qualcosa prima di una storia, e quando arriva la parola “fine”, in realtà quella storia va da qualche parte. Forse si limiterà semplicemente a trovare posto nell’immaginario di un lettore (che non è poco), oppure forse, con un po’ di fortuna, genererà altre immaginazioni, altre fantasie, altre storie.
Tuena viene da pensarlo come uno scrittore abitato da voci che si sovrappongono, lo incalzano, lo costringono quasi all’urgenza di metterle su pagina. E ad un certo punto, dopo il finale di Com’è trascorsa la notte, compare anche la sua, quella di Filippo Tuena intendo. Mai, infatti, mi era successo di imbattermi in un libro in cui anche la dedica e i ringraziamenti sembrano far parte della storia che è appena terminata.
Io sono la costumista e di tutti prendo le misure. Conosco i fianchi le spalle la pancia il culo ma adesso raccatto maschere e costumi e li rimetto nel baule dei teatranti, perché quel che oggi è finito ricomincia domani, più o meno allo stesso modo.
Prove d’ascolto #5 – Mario Corticelli
da pioggia. rovine
/
la conservazione della pioggia avviene tramite il crollo della pioggia
consecutivo. la ricostruzione della pioggia
consecutiva è tramite il crollo della pioggia
la ricostruzione disinvolta della pioggia
il consolidamento e il ripristino del crollo è tramite la pioggia.
se il paesaggio appare sfumato.
riportare il teatro allo stato precedente.
livellare o erigere colline, creare laghetti e corsi d’acqua
sono creati sono in crescita.
demolire in parte.
/
questo inconveniente
nelle vicinanze
articolato fino alla convenienza
nelle vicinanze
articolata fino all’inconveniente
sembra inarrestabile
rampicante
il luogo spartiacque
le cui parti distrutte o staccate
scrosciano articolate
sembra una prospettiva
rampicante
precedente
/
a ogni tratteggio ricomincia da capo
vi accede una scalinata
una copertura a forma di tetto
inclinata il tramonto
nidi di piccioni, cascatelle, numerosi altri oggetti
come ingresso la ripetizione
della caduta
del prato sul prato
come ingresso, luogo
di stanza
la caduta come ingresso
una bella entrata regolare
la distanza tra prato e stesso prato
tra pioggia e stessa pioggia
la caduta della pioggia
sulla stessa pioggia
l’intervallo
/
trovare un piano che sostiene gocce di pioggia, aggirare, sfiorare passando un piano che sostiene gocce di pioggia, oltrepassare, scavalcare, cadere su un piano che sostiene gocce di pioggia muovere increspare un piano che sostiene gocce di pioggia trovare
erigere
tenere un piano che dà sfondo a gocce di pioggia spingere un piano evitare sbattere contro un piano che dà sfondo a gocce di pioggia superare aggirare un piano fendere un piano o increspare trovare che il piano dà sfondo a gocce di pioggia dare sfondo trovare che le gocce trovare il piano che dà sfondo a gocce di pioggia dare sfondo alla pioggia. trovare
acqua
luogo
trovare
suddividere una porzione di luogo che contiene acqua in gocce d’acqua e luogo privo di acqua, aggirare, evitare, attraversare una porzione di luogo che contiene molta acqua, suddividere, lambire una porzione di luogo ricca d’acqua mantenere una porzione di gocce d’acqua nel luogo ugualmente mantenere il luogo suddiviso in gocce d’acqua suddivise nel luogo, sostenere, trovare che il luogo contiene acqua, trovare che l’acqua contiene gocce d’acqua, trovare il luogo che contenga acqua suddividere il luogo. trovare
che la pioggia
che l’animato differisce dall’inanimato a causa del vivere
che la pioggia
rasentando i rami degli alberi
/
si osservi come da ciò consegue che, quando si vedono formiche risalire i
tratteggi della pioggia verso le nuvole, è possibile inferirne la dolcezza
/
un raggio di luce solare illumina il punto scelto per il foro
verso la natura
inserito nella natura
il fulcro da inserire nel paesaggio lungo percorsi
verso la natura aprendo alla natura
si trasformi
un’isoletta di pioppi filanti
sei colonne superstiti
dalla colonna mancante dieci, venti
fusti si intrecciano ora
salendo
con un moto verso l’alto
scendendo
con un moto verso il basso
salendo
la media versa al basso aprendo alla natura
o le sue punte non possono sbriciolarsi
/
frustuli, rocchi
precipitati e disposti lungo la linea dell’ipotetico crollo naturale
diagonale per via del vento
senza limite nell’estendersi del piano.
si prendano a esempio gli aghi dei pini.
si conviene che risalgano ai rami
esaurito il contatto con la terra
che è una superficie
le cui pieghe sono linee lunghissime
tratteggiate in aghi di pini.
/
cui era collegato da un ponticello
all’esterno presentava un colonnato
coperto da una cupola
sopra tre serie di finestre
un portico semicircolare
cui era collegato da un ponticello
più dietro l’interno
ancora più dietro
l’esterno e dopo il colonnato
una sola scalinata a due bracci
all’interno ripete il retro che impedisce di farne una sede
ancora più interno
dietro
lasciato privo di intonaco
coperto da una cupola in parte
entro un colonnato
cui era collegato da un ponticello
sul retro a portare l’interno
che impedisce di farne una sede
/
si costruiscano torri di pioggia
parzialmente abitabili
non abitabili oppure
abitabili
conseguentemente abitate
conseguentemente
presto
disabitate
sul punto di essere abitate oppure
di essere disabitate
conseguentemente sul punto di essere
nonostante il contatto intermittente con il suolo
/
consentire attorno alla colonna la presa di un rampicante dalla base e il
risalire.
consentire attorno ai fili di pioggia la presa di un rampicante e parimenti il
risalire.
consentire attorno alle caviglie il rampicante e il risalire e parimenti le
variabili posture.
variare le posture consentite.
al cessare della pioggia resta la colonna.
al cessare del corpo resta la colonna.
al rovinare della colonna raccogliere il rampicante seccarlo al cessare della
pioggia farne un falò.
consentire al fuoco la presa sull’aria e il risalire e parimenti le variabili
posture.
al cessare del rampicante liberare l’aria e consentirne le più variabili
posture fino al ritorno del vento.
*
Testi in corso di elaborazione sotto il titolo di “pioggia.rovine” di Mario Corticelli
di Alessandra Cava
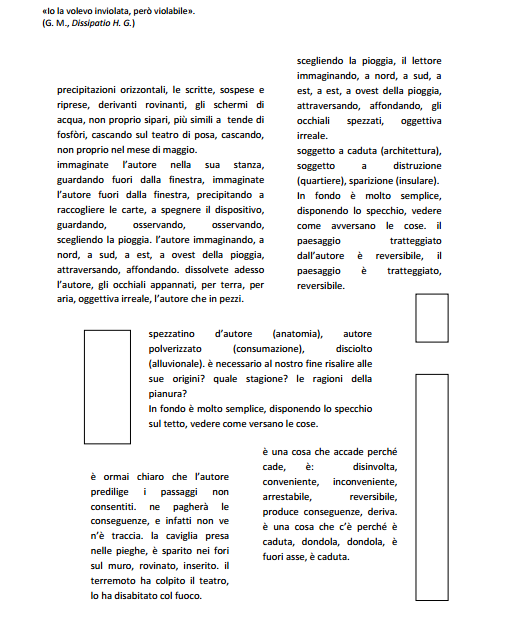
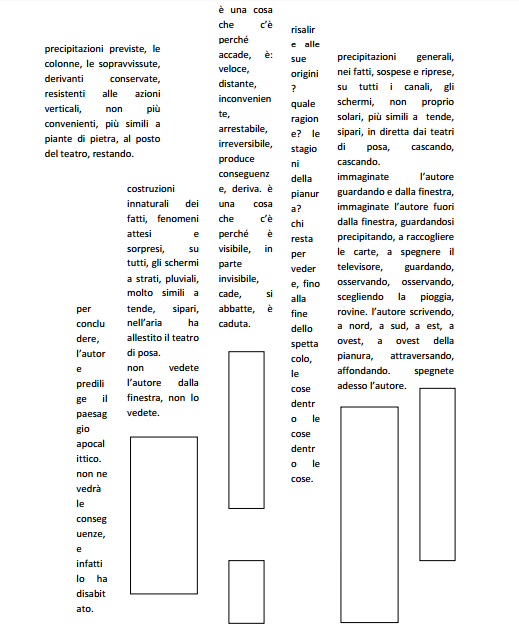
*
Prove d’ascolto è un progetto di Simona Menicocci e Fabio Teti
Over Game: Lucio Saviani

Nota su Ludus Mundi
idea della filosofia di Lucio Saviani
Di
Francesco Forlani
Nella nota con cui Italo Calvino accompagna il volume Le più belle pagine di Landolfi, la parola che più ricorre e ricorrendo ne spiega il motivo, è gioco. La prima regola del gioco, per il lettore di Landolfi, avvisa Calvino, “è che presto o tardi ci si deva aspettare una sorpresa”. Ecco. In ogni libro di Lucio Saviani, parlo da lettore non averti (questa è la parola francese per dire addetto, specialista, avvisato) accade sempre qualcosa che alla fine o dal principio sorprenda; talora un paradigma impensato, talaltra una figura dimenticata o, come nel caso di questa sua ultima opera, un lungo poemetto filosofico di Pasquale Panella a fare da esergo. Del resto cos’è un esergo, se non un fuori\dentro l’Opera? E se non v’è vero confine che non sia ineffabile come faremo a sapere con certezza che chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori?
L’esplorazione del limite – se ogni gioco ha una regola è altresì vero che i giochi possono spostare o reinventare la linea del limite e insieme la sua pericolosità- che Lucio Saviani in tutti questi anni ci ha descritto, analizzato, raccontato, gioca un ruolo importante in Ludus Mundi Idea della filosofia ( Moretti & Vitali) come viene del resto riportato nell’introduzione.
“Questo libro rappresenta il punto in cui confluiscono e trovano un senso unitario gli esiti di un percorso iniziato nei primi anni ottanta. la riflessione intorno al problema filosofico del gioco è spesso presente, in forme diverse, nei punti centrali di alcuni miei lavori che sono del decennio successivo, come Voci di confine (1993), A dadi con gli dei, (1994), Segnalibro (1995) e Ermeneutica del gioco (1998), di cui qui vengono riprese e rielaborate alcune parti.”
Il rigore con cui il filosofo discetta di gioco, la chiarezza degli argomenti che ne indagano la centralità nell’idea stessa di filosofia, è assimilabile a mio avviso a certi libretti con il mode d’emploi, il complesso sistema delle regole, che certi giochi di società comuni ai nostri tempi, che si tratti del Monopoli o dello Scarabeo, Risiko o della più antica e tradizionale tavola degli scacchi, mette ben in vista all’interno della propria confezione. Potremmo allora dire che il saggio di Lucio Saviani sta al poemetto filosofico di Pasquale Panella come la regola al gioco? La filosofia alla poesia? Non saprei ma di una cosa ne siamo più che certi; chi volesse trovarvi per esempio citazioni letterarie “tematiche” – su tutte, quella giocata su tutte le ruote dei lettori amanti dell’azzardo, Il giocatore di Dostoevskij– o annotazioni pop, tipo una fenomenologia del gratta e vinci e simili vivrà la sorpresa di non trovarvi nulla di tutto questo, fortunatamente aggiungiamo noi, proprio perché alla stregua di un libretto con le istruzioni per l’uso, tratta delle regole che fondano il gioco ma non delle pratiche, tutte le pratiche che senza di queste non potrebbero nemmeno aver luogo. Non v’è affatto arbitrarietà, quella del bambino che annuncia il tempo del gioco al proprio compagno con la formula “facciamo che…” o del narratore che crea “i fatti”, ma disposizione genealogica e dunque storicizzata dei concetti chiave. Ripercorriamo così i frammenti dei presocratici, le indicazioni e controindicazioni di rispettivamente Platone ed Aristotele sulla questione della Mimesis, e dell’autenticità di ciò che appare, ma sarà soprattutto in area tedesca, in primis Nietzsche e Heidegger e a seguire, Huizinga, Fink e Gadamer che il pensiero filosofico del gioco si gioca le sue carte. Lato francese, si leggeranno le inattuali di Jacques Derrida e Vladimir Jankélévitch sul game over.
Ecco allora che in un momento in cui i filosofi non “giocano” più il ruolo di penseurs sur scène – così Peter Sloterdijk aveva intitolato una sua opera dedicata a Nietzsche – ma quello di intrattenitori di massa, alla Michel Onfray, per citarne uno, leggere un filosofo che trattenga il fiato, che “sospenda” la scena, non può che salutarsi come si accoglie una bella sorpresa. Prima di lasciare la parola al filosofo Aldo Masullo che ne ha firmato la postfazione mostrando quanto necessario sia oggi partire da questo paradigma, eccomi ritornare lì dove avevamo cominciato.
Grazie a Ludus Mundi finalmente potremo capire meglio insieme ai tic dei nostri giochi moderni, all’anima dei giocattoli che popolano le nostre stanze, i concetti di tempo e destino, o la gravità della frase, per quanto ostentatamente pubblica, “Les jeux sont faits, rien ne va plus”. E rassicurarsi grazie a questa lettura del fatto che la filosofia, il pensiero, possa esercitare ancora la propria libertà fino in fondo, intervenire perfino a giochi fatti sulla realtà. Ma soprattutto risuoneranno più forte che mai perfino le meravigliose pagine del racconto di Tommaso Landolfi, “Lettera di un romantico sul gioco”, come quando scrive:
Pure, miracolo della grazia, v’è per imperscrutabile decreto in questa condizione alcunché d’eroico: qui spira il largo, sebbene vorace, vento degli spazi, che dissipa i meschini ambagi, i vili e uggiosi compromessi, qui, un istante re e imperatore, quello seguente verme della terra, il rampollo dell’uomo, sia travolto o trionfi, è ugualmente travolto, e dunque sempre trionfa, se con puro cuore chini il capo ai voleri del cielo. Qui egli, percosso di religioso stupore, vive le sue ore più gravi; qui, da ultimo, l’Avventura e il Mistero, questi supremi doni della Provvidenza, menano la loro libera vicenda. Sia dunque lode al gioco, la più alta attività dello spirito umano!

Postfazione al libro Ludus Mundi
Filosofia del gioco e gioco della filosofia
di Aldo Masullo
La destrutturazione antimetafisica, operante nell’ermeneutica novecentesca, riduce la filosofia a linguaggio che si autointerpreta, o infine a scrittura, e si serve della ‘ermeneutica del gioco’ per simboleggiare la poetica gratuità dell’interpretazione o il casuale tracciarsi della ri-scrittura. Essa rivela il suo paradossale errore metafisico, oscillando tra due polarità.
O, con Heidegger, s’identifica il potere dell’“altro” con quel “far-esser-la-presenza [An-wesen-lassen]”, a cui l’“esser-presente [An-wesen]” è sospeso. Perfino il linguaggio, il luogo stesso della presenza, fonda la sua presenza in “altro” da sé. L’avvertimento di Heidegger è lapidario: “l’essenza del linguaggio non è un fatto linguistico”.
Oppure, per liquidare l’equivoca significatività dell’“altro”, lo si nega. Così Derrida riduce l’“altro” del linguaggio effettivo al gioco gratuito dei rinvii, all’assenza di qualsiasi ragione, alla pura negatività del caso, insomma a un nulla. Per lui lo stesso discorso filosofico che parla del gioco del linguaggio si risolve nel gioco della “ri-scrittura”, nel semplice e magari “inutile” anche se intellettualmente raffinato spostamento di “margini”, che si compie mentre si ri-percorrono le tracce delle scritture “filosofiche”. Qui non v’è più alcun positivo “altro”, di cui un gioco che gioca possa essere figura.
Certo non si può fare a meno di obiettare che al concetto di “originario” non appartiene affatto, intrinsecamente, il significato di fondamento. L’“originario” in se stesso vuol solo dire l’estrema prossimità di un limite. Il limite è “origine” in un’accezione non metafisica o fisica, ma analoga all’astrazione geometrica, con cui il punto viene definito “origine” di una semiretta, la linea “origine” di un semipiano, il piano “origine” di uno semispazio. Se dalla nozione ideale di limite si passa alla sua applicazione empirica, caso esemplare ne è la linea immaginaria dell’orizzonte come contorno del campo di visibilità definito da un punto di vista. la linea d’orizzonte, come ogni limite, si coglie sensibilmente in un “di qua”, in ciò che le è estremamente prossimo e, visualizzando l’“origine”, è l’“originario”. Essa cioè, nella sua potenza di apparizione sensibile, irresistibilmente suggerisce all’immaginazione un “di là”, un “oltre”.
Ma in un decostruzionismo radicale non può concepirsi un “di là” del limite, neppure immaginario, così come non può concepirsene un “di qua”. La nozione di gioco è stata introdotta proprio per sostituire, e quindi escludere, la nozione di limite. Il limite infatti implica necessariamente il “di qua”, la “presenza”, e insieme il “di là”, l’“assenza”. Derrida, nel ridurre il linguaggio a scrittura, e questa a gioco, intende purificare la filosofia dall’idea metafisica di “presenza” ma, con ciò, anche dalla complementare idea di “assenza”. Espunta la nozione di limite, e dunque la possibilità stessa della verità, la quale o è in sé, perfettamente determinata, o non è, non si dà più “presenza piena”, ma neppure assenza. La filosofia, risolta nel linguaggio interpretante e nel ri-scriversi della scrittura, non s’arroga più d’essere totalizzante, dunque non pretende più di unificare il molteplice nei limiti della determinatezza, e di ridurlo così a presenza di verità. È un esercizio senza “origine” e senza termine, un puro gioco che non dipende da alcuna presenza, o alternativa di presenza e di assenza. Anzi, proprio presenza e assenza non sono che possibilità del gioco.
Non resta alcuna verità, la cui presenza riempia i significati o la cui assenza li trascenda.
C’è ormai solo un gioco di segni, e di relazioni di significanza (significanti-significati), che in questo gioco si fanno e disfanno. si tratta di un gioco che, pur senza regole, senza principio e senza fine, senza vincitori né vinti, senza scopo e senza risultato, tuttavia, per il solo fatto d’esser giocato in un campo (il linguaggio) costituito da un numero finito di elementi, non può assurgere alla leggerezza del play, del gioco giocante. Esso piuttosto inevitabilmente si riduce alla pesantezza dell’agonistica ripetitività del game, del gioco giocato. Infatti, “una modificazione del codice non può provenire da un puro movimento interno al codice stesso”. E, fuori del codice, non c’è “altro”.
A questo punto, appare evidente che, attraverso l’“ermeneutica del gioco”, con l’incauta presunzione di cancellare l’errore metafisico o umanistico di un “oltre” come assolutamente determinato “altro” e, in quanto tale, come “fondamento”, si rende in effetti impensabile la serietà dell’esistere, ovvero l’iniziativa e la responsabilità.
Alla nozione di “altro”, respinta come indebita entificazione dell’Essere, non si risponde se non con la pura e semplice negazio- ne dell’Essere. Così, la difficoltà si radicalizza.
Negl’incunaboli della “filosofia ermeneutica”, ossia nei corsi heideggeriani degli anni 1919-1923, “e-sistere” vuol dire l’incessante trascendere, l’uscire dalla semplice identità di ente, e l’uscire ogni volta dall’essere usciti, l’intenzionale muoversi-verso. perciò un e-sistere che, al “di là” della sua identità, del suo essere il linguaggio interpretante, verso nulla possa trascendere, non è affatto un e-sistere, ma un fortuito gioco di segni. Effetto di una casuale combinatoria, esso non è la soggettività, ma il suo fantasma.
Il gioco può ben essere la metafora di un codice o sistema di segni, il cui funzionare è la significazione linguistica, immenso prodursi di significanti e complicato istituirsi di significati. Ma qual è il senso, la radice vitale, da cui il codice si genera e che lo mette in movimento e lo fa funzionare, e che tuttavia non è, né può essere, contenuta nel codice? Come può la stessa giocosa mancanza di origine e di scopo del linguaggio esercitarsi interminabilmente, se non radicata nella serietà della vita la quale, come dolore o piacere, essendo non indifferente perdersi nel cambiare ma sempre appassionato concentrarsi vissuto, con essa gioca?
Questa è la decisiva questione, con cui è necessario confrontarsi. La sua intera scansione apre, del resto, la strada verso la finale formulazione esplicita della domanda, che fin dall’inizio la sottende.
Nel giro di pensieri del secondo Heidegger, di Gadamer, di Derrida, l’Essere si risolve nel linguaggio. Allora la filosofia, ponendo la domanda sull’Essere, non fa che interrogarsi sul linguaggio.
Qui si pone la difficoltà radicale. il linguaggio è un contesto di significazione, l’Essere è un contesto di senso. Se la filosofia è il linguaggio stesso nel suo autointerpretarsi, essa non sull’Essere in effetti s’interroga, ma soltanto sui significati.
Cos’altro allora resta alla filosofia, se non riconoscersi in un semplice gioco di segni?
Fermarsi a ciò, secondo Lucio Saviani, che per lunghi anni ha esplorato la serrata ricerca novecentesca sul gioco come via al superamento del pensiero metafisico, esprimerebbe una “idea di [questo] superamento ancora tutt’interna al discorso, al progetto del moderno, o di pratica dei margini della modernità, come scrittura- lettura di ‘bordo’ e note a margine del linguaggio (e del testo) della metafisica”.
Paradossalmente chi come Saviani si pone da questo punto di vista pensa di sottrarsi alla prigionia del linguaggio filosofante non uscendone, ma al contrario lavorando al suo interno, facendone aumentare al massimo la tensione, e alla fine lasciando che esso esploda. A lui, nella pratica filosofica del linguaggio, sembra possibile “la novità di una chance in termini di contaminazione, oscillazione e ‘indebolimento’ dell’idea di essere e di tutte le opposizioni metafisiche […]”. Certamente la filosofia, secondo la sua natura, non può non formulare definizioni, perfino di se stessa e dei concetti con cui lavora. Però lo stesso pensiero del gioco, come Saviani scrive in questo libro, “irrompe, scalzando di continuo ogni lavoro di definizione”.
A chi argomenta in questo modo sembra, in conclusione, che dalla costitutiva e perciò insopprimibile metafisicità della filosofia come gioco del linguaggio con se stesso, non si possa salvare la prospettiva antimetafisica se non in quanto “il gioco innesca la sua carica esplosiva innanzitutto su se stesso”.
A questo punto sopravviene irresistibile l’ultima e radicale domanda.
Cosa vuol dire l’esplosione del linguaggio, se non la rovina del riparo che esso costituisce, e il finale restar del pensiero esposto ad “altro”, per quanto sempre dentro il cerchio della soggettività, anzi forse nel cuore di essa, ossia gettato nella tanto familiare quanto oscura terra del senso ?
I “significati” non sono che le pensabili oggettività degli enti, ossia ben definite funzioni dell’operare interpretativo del linguaggio.
Il “senso” invece è la vita che, in sé ri-piegandosi, di continuo da vivente diviene vissuta. impulso irresistibile ne è il tempo, traumatico irrompere della differenza, nativa emozione del cambiamento, patita contingenza del sé: insomma non la compromessa “presenza” teoretica della verità ma l’assoluta “attualità” del patire.
Solo così s’intende come possa il linguistico gioco dei segni fare i conti con la serietà di “altro”, che non sia il metafisico simulacro di un fondamento.
“Oltre” il linguaggio, non come un “di là” bensì un “di qua” da esso, e dunque dentro l’orizzonte della soggettività, vigoreggia l’affettività del vissuto.
La soggettività non si riduce al linguaggio.
In essa vive anche “altro”. Questo, a essa intimo, è l’“originario” noi stessi, che è tale, non originato da alcunché, poiché nulla di vissuto v’è, “prima” del vissuto. È l’ambigua emozione d’irrimediabile perdita eppur di nuova possibilità, del sentirsi morendo nascere e nascendo morire, il tempo appunto, la radice di ogni “senso” che, vissuto, di volta in volta noi siamo.
Con l’esplosione del linguaggio, dileguano le protettive finzioni del suo gioco.
Ora l’arcana nudità della vita vissuta, come dolore e come piacere, fronteggia seriamente il pensiero. Essa, estrema severa occasione, lo consegna all’ineludibile prova dell’etica. La filosofia intanto si fa “pratica del limite ed esercizio di radicale finitezza”.
Transessualità e letteratura
 di Yasmin Incretolli
di Yasmin Incretolli
A differenza degli scritti autobiografici, la narrativa d’autore per opera di persone transessuali è praticamente irreperibile.
Apparentemente sembra che la legittimità editoriale della loro creatività debba sottostare alla richiesta d’intimità ed esibizionismo.
Il lettore prevede dalla narrazione alcuni paradigmi che costituiscono convenzionalmente un iter di cambio di sesso: intenso disagio, vulnerabilità, tormento interiore e indeterminatezza – con aneddoti su più punti culminanti della fenomenologia.
Prove d’ascolto #4 – Elisa Davoglio
Tormenta
Le prime, efficienti e strutturate macchine da guerra si chiamano Tormenta.
Quelle più pesanti funzionano per lanciare oggetti a caduta libera, pesanti, capaci di forare spesse mura e creare fuochi.
In forma più leggera, ma sempre efficace, denominate scorpioni, possono essere trasportate su navi, affondare insieme ai marinai, fare luci con le esplosioni per avvertire dei pericoli in arrivo dal mare, ripetutamente segnalare perdite e l’avanzamento di danni.
Tormenta agiscono per offesa, anche come fuoco di copertura, e protezione.
Tormenta si costruiscono sul posto. Possono lanciare pali acuminati, sassi o sfere di piombo anche oltre la distanza di 350 metri.
Sono agili, scattanti, affabili, persecutorie.
Tormenta sono mobili, e assecondano il movimento degli uomini con precisione, anche negli spazi stretti.
Manovrabili da un numero eletto di uomini, quelli con la vista migliore, capaci di empatia e amore, e di assegnare nomi alle macchine come ai cavalli o ai figli.
Tormenta si dividono in battaglioni, compagnie, plotoni. Piccolo e grande calibro, strumentazione più o meno sofisticata.
Producono un rumore che è un fischio, poi una contemplazione, un lampo, e una sorpresa.
Sempre più piccole unità di uomini possono manovrare tormenta, tormenta possono stare a digiuno più a lungo di un uomo, sono per tanti fattori più precise, più resistenti, meno inclini allo stupore e all’inceppamento.
Quanto è necessario a nutrire tormenta è calcolabile come il fabbisogno di più giorni, per più individui che si chiamano, indifferentemente, gruppi, ceppi, manipoli, formazioni, numeri, unità, reparti, suddivisioni, legioni, coorti, centurie.
Tormenta sono adatte per porre un assedio, come tra una collina e una piana, costruendo un fosso ed un terrapieno, sistemando palizzate fatte di tronchi con la punta aguzza rivolta contro, catapulte fissate sulle torri, con deviazione di un fiume per riempire il terrapieno, per annegare i fuggitivi, dare da bere agli alimentatori di tormenta, per più giorni, durante la razionalizzazione delle scorte, interrompendo dal terrapieno pieno di acqua la provvista di cibo agli assediati, che proporanno il suicidio, l’abbandono di donne e bambini e vecchi, la salvezza di donne, bambini e vecchi, la resa, il suicidio, l’attraversamento di quindici file di fosse con all’interno, conficcati nel terreno, tronchi con rami intrecciati e pungenti, e otto file di pali aguzzi camuffati con cespugli, e una fascia di pioli muniti di uncini di ferro, sotto la vista di tormenta, che pure utilizzano come gli uomini la luce per vedere, per camminare, colpire, ritirarsi.
Alla destinazione mancano i passi calcolati sulla marcia di Tormenta
senza rallentamenti o esitazioni sulla mira ferite che si infettano nella progressione pacata delle file.
Servono cucce ad ogni lampo dove la luce brucia. In più di uno, le donne i bambini e i vecchi muoiono per primi. Si proteggono per primi le donne i vecchi e i bambini conservandoli alle ginocchia di Tormenta nella richiesta di spegnere il fuoco, smorzare la luce, permettere il passaggio di cibo. Dormire.
Chi è coraggioso lanciarsi da un punto alto. Tormenta sono fatte della materia delle monete della folla che si decima dei bambini che nascono sempre in maggiore numero.
Tormenta appaiono in parcellizzazioni di onda/corpuscolo infinitesimi di frazioni di secondo (dopo) dentro e fuori l’assedio. Non è possibile, in questo tempo, invertire il verso, costruire fortificazioni lunghe millenni, fuggire alla gravità, modificare la consistenza del metallo e della carne, trovare un riparo anche tra le proprie mani.
È usuale perire nella luce, tutto ciò che si muove quando si afferra, statico. La sintesi, la genesi, la nascita e l’allevamento di Tormenta, sono pari all’efficienza e alla natura dei fiori che spargono semi e dei bambini.
I bambini continuano a nascere, a tentare di cavarsi gli occhi con le dita quando giocano.
istruzioni per la raccolta, immagazzinamento, in modalità ampia, colorata, affettiva di Tormenta
procuratevi della carta particolarmente bella su cui stamperete le impronte
stilate un elenco delle foto che volete scattare, in modo da non dimenticarne nessuna sul momento
tagliate una piccola ciocca di capelli dalla nuca (portate con voi una bustina di plastica)
tagliate le unghie (portate con voi una bustina di plastica)
stampate impronte delle mani e dei piedi con un cuscinetto d’inchiostro
tracciate il contorno delle mani e dei piedi su della bella carta
tracciate la silhouette del viso (proiettate il suo profilo su un foglio illuminando lateralmente il volto e ricalcatene l’ombra)
disegnate il contorno di tutto su un grande foglio
applicate un velo di rossetto e stampate l’impronta delle labbra
confezionate o acquistate un orsacchiotto di tessuto chiaro (o di peluche cortissimo). con l’inchiostro stampate le impronte delle mani sulle mani dell’orsacchiotto, le impronte dei piedi sulle zampe dell’orsacchiotto.
Esistono ciondoli a forma di cuore diviso in due. L’altra conservata da voi.
Destinate una bella scatola o una cassetta in legno a luogo in cui riporre tutti questi ricordi.
Processo
I
:vorrei fare solo precisazioni
:non ricordo, successivamente, credo di ricordare
:quanto c’era da decidere
:non è vero! Escludo
:ho la certezza di quanto dico
:i miei ricordi sono precisi
:sinceramente non presi alcuna iniziativa
:e allora come avvenne?
:c’era stata
:c’era stata?
:in uno dei tanti incontri parlammo genericamente di queste cose
:confermo quanto ho dichiarato
:certo è ben sicuro di tutto questo?
:e desidero ribadire
:informò preventivamente?
:questo non lo ricordo. Però
:esclude decisamente
:gli ho mostrato e poi ho parlato
:sicuramente gliene ho parlato.
:andò da solo?
:poi gli ho chiesto la sua opinione
:e come ha risposto?
:mi ha detto di essere d’accordo. Allora
:sulla necessità di salvaguardare
:gli ho fatto rilevare l’opportunità
:era importante come fatto psicologico
:chi era?
:era, ritengo
:lei conferma
:ma certo
:anche se la telefonata
:dato che io ero rimasto d’accordo
:non è vero niente!
:non mi sono mai occupato di fatti particolari
:non si riferisce solo ad un episodio, ma a diversi
:io non la capisco proprio
:mi dispiace
:escludo, lo ripeto
:io non so nulla!
:io non capisco questa sua paura
:senta: è ora di finirla
:voglio chiedere, se almeno leggeva i giornali
:io non ne sapevo nulla
:ricordo bene del tempo in cui se ne era parlato ripetutamente
:ripeto che non ne so niente!
:il caso non è un caso che possa mettere paura
:lasciatelo parlare
:non si può tollerare
:voglio chiedere
:di certo sì
:io non ne sapevo nulla
:ricordo bene del tempo in cui se ne era parlato ripetutamente
:mi stupisce che venga a dire che non ne sapeva nulla
II
Gli aghi. Storia degli aghi. Inizialmente gli aghi. Poi, durante e dopo. La crescita degli aghi. Il delitto con un ago. La prova dell’ago. Molti aghi, se ne producono più di quanti riescono a perdersi. Il fatto dell’ago. La corretta descrizione è: di forma allungata, appuntito ad una estremità. Istruzioni: se mancano gli aghi di metallo, si possono creare da spine di agave.
Arrivano per giocare. Una volta trovano una palla e iniziano a discutere della sua provenienza. Sono incerti sul da farsi, se proseguire, se portare la palla verso un centro.
Porta un collare da cane. Con su scritto una identità.
Il riconoscimento è immediato, anche se non parla.
Per suscitare parole, viene appesa a testa in giù, solleticata sotto le punte dei piedi.
Sezionano cosa contribuisce al suo peso, per pesarla.
Non riescono a trattenerla per i piedi, dritta, sicuramente il peso, ma non c’è possibilità di misura se non confrontando gli oggetti, le cose. Hanno preso provvedimenti, creano scale, dimensioni nuove e vuote come bolle.
Non si regge da sola, è impossibile reggerla per i piedi, senza che il valore venga alterato calcolato male.
III
:confermo parola per parola tutto quello che ho detto
:da queste dichiarazioni si evince che si vuole coinvolgere in queste vicende
:ha sempre e soltanto fatto solo quello che gli chiedevano
:non è vero niente! Io non mi sono mai occupato di problemi particolari
:chi sia lo accerteremo
:sicuramente. E vorrei aggiungere
:ho l’abitudine di conservare degli appunti
:e che cosa fece?
:rilasciai una breve dichiarazione
:no. Non l’ho letta
:ecco, ora ricordo, non si tratta di
:eppure è andata così
:escludo
:la realtà è ben diversa da quella che può apparire, ed è ben diversa da quella che, forse
:in buona fede, crede di ricordare
:giudicatemi pure
:vorrei essere giudicato serenamente
:in quel momento, ne sono certo, non c’ero
:cosa ha da dire?
:senz’altro
:estrasse da un cassetto un annuario con la copertina blu
:in quel momento non attribuivo al fatto grande importanza
da Viaggio al centro della terra
La terra sotto il suolo è piena di spelonche ventose, di laghi, stagni e fiumi che tracinano massi.
A volte le caverne crollano e fanno crollare le montagne. Nelle cavità c’è anche il vento che preme e fa piegare la terra
Lucrezio – De Rerum Natura
La fretta è stata quella di raggiungere al più presto il nucleo terrestre. Al centro della terra sta un nucleo, fatto di ferro e nichel.
Il nucleo è separato dal mantello da una discontinuità, detta di Gutenberg,
Il nucleo è fatto di ferro e nichel. Gira più velocemente del resto del pianeta, la velocità aumenta ogni anno di circa due gradi
è parso chiaro subito che raggiungere il centro della terra sarebbe stato impossibile, se non in sogno
non tramite trivellazioni della superficie. In ogni caso il buco creato non sarebbe abbastanza profondo, non raggiungerebbe mai la misura necessaria per tale follia
non è possibile raggiungere il centro della terra con comportamenti adeguati, una sana alimentazione che ripari i danni provocati da questa ostinazione
si chiama cielo, volta celeste, uranio. Al centro della terra stanno gli inferi, si brucia e non si vola la maledizione
alcuni elementi, parti di roccia, arrivano in superficie e stupiscono. Ne viene studiata la composizione, la densità. Perché mutano e cambiano forma come se la terra stessa digerisse il suo centro
una animazione ha studiato il viaggio verso il centro della terra
un manipolo di uomini decompressi, a due dimensioni, bianchi come un foglio di carta
a 1300 metri si incontra un verme, chiamato il verme del diavolo, Mefistole
durante il viaggio non c’è più spazio tra le creature mano a mano che si allontanano dalla superficie
l’unico progetto reale prevede una sonda un piccolo bombardamento atomico che fletta la terra come un terremoto impedendo ogni spiraglio d’aria per le mosche
una paura comune è quella di impazzire se sotterrati ognuno cercherebbe l’aria
nessuno per salvarsi il centro della terra
non è ben chiara la ragione di questo comportamento
da vulcani spenti, forse, si potrebbe calare e accedere al centro della terra
l’odore terribile è stato avvertito per la prima volta nel mese di gennaio, l’anno scorso
Cocktail Party
tra i coniugi la rottura pare inevitabile: entrambi hanno stretto una nuova relazione
è condannato a morte ma si avvelena
le liti si susseguono
la resa è totale, incondizionata
riprende il suo cammino e scompare
resasi libera, può sposarlo
benché riluttante e inorridito da se stesso, la uccide
rimasta ben presto vedova, dedica il suo denaro alle opere di beneficenza
muore giovanissimo, schiacciato dal peso di quella memoria
finisce per uccidere anche il suo creatore
torna al suo vecchio impiego dove potrà ricordare la sua singolare vicenda
incapace di comunicare persino con la madre che si disinteressa di lui, si uccide
decide di salvargli la vita e lo sottomette a una cerimonia espiatoria
viene liberato per ordine della regina, che gli conferisce anche un titolo nobiliare
trova infine pace
muore riconciliato con il padre
continua ad essere perseguitato da incubi in cui rivede le spiagge dell’isola dei pirati
misteriosamente salvato da qualcuno che non riesce ad individuare
confessa pubblicamente la propria colpa e muore, stroncato dall’emozione
in prigione, passa il suo tempo a scrivere, in attesa che venga eseguita la sentenza capitale
si offre alla loro vendetta e viene graziata
muore infine assassinata da Jack lo squartatore
passerà il resto della vita nella casa di famiglia
si getta sotto i proiettili dei suoi ex compagni
riesce a gestire il successo con moglie e figli
si avvia nobilmente al patibolo
*
Su Tormenta e Viaggio al centro della terra di Elisa Davoglio
di Giorgia Romagnoli
Tormenta
“Le prime, efficienti e strutturate machine da guerra si chiamano Tormenta.”
Questo testo ne definisce le capacità, le azioni; macchine che assecondano l’uomo, che è capace di controllarle, che si affeziona ad esse. Mezzi e armi di un nuovo conflitto, terribili e umane allo stesso tempo; fatte della stessa materia di cui è fatto l’uomo e create per sostituirlo, hanno bisogno di nutrimento anche se in misura minore.
Ne descrive la forma (“…parcellizzazioni di onda corpuscolo infinitesimi di frazioni di secondo…”), che rimanda alla doppia natura – corpuscolare e ondulatoria – della materia e della radiazione elettromagnetica. Forma mutevole e irriconoscibile in quanto i due stati non sono osservabili contemporaneamente per il principio di complementarietà.
Agiscono ponendo assedio, portando il “nemico” alla resa, al suicidio, interrompendo le scorte di cibo e di acqua, privandolo del sonno.
Un accento particolare è posto sull’affezione nei confronti di queste macchine: si tenta di ricordarle, di ricreare la loro immagine, di raccogliere oggetti e pezzi come se dovessero essere posti in una capsula del tempo – rigorosamente imbustati e sigillati – (impronte stampate, capelli, unghie) e “riesumanti” in un secondo momento.
Viaggio al centro della terra
Alle elementari ci spiegano che il pianeta terra è formato di diversi strati: crosta, mantello e nucleo terrestre fatto di ferro e nichel. Con l’aumentare della profondità aumenta la temperatura. Ci dicono inoltre che il nucleo è impossibile da raggiungere nonostante i numerosi tentativi: non ne abbiamo i mezzi. Questa impossibilità è percepita da un bambino come una proibizione, una questione non adatta alla sua età: quel posto non si può raggiungere “perché ci sono i mostri”, e quindi si accetta –quasi in tutti i casi – la spiegazione fornita.
L’ipotesi degli strati è frutto del calcolo della densità media della terra, che si ottiene applicando la legge di gravitazione universale e dividendo la massa per il volume. Con tale risultato si comprende che la densità interna è necessariamente molto maggiore di quella della crosta.
Questa teoria va a sovrapporsi ad un’altra sviluppatasi a partire dal XVII secolo secondo la quale la terra sarebbe cava al suo interno, il nucleo non sarebbe altro che un secondo sole che avrebbe permesso lo sviluppo di un’altra popolazione (teoria che sarebbe plausibile se non esistesse la forza di gravità). L’ingresso a questo mondo sotterraneo si troverebbe nei pressi dei due poli e si evolverebbe in centinaia di cunicoli.
L’idea di un mondo sotterraneo è collegabile sia alla convinzione antica dell’esistenza degli inferi, sia alla moderna teoria dei molti mondi. Quest’ultima – basandosi sul principio di indeterminazione secondo il quale non è possibile definire nello stesso istante la traiettoria e la quantità di moto di una particella – ipotizza l’esistenza di tanti mondi paralleli quante sono le possibilità che qualcosa accada o meno e dunque di diverse realtà probabili definite dimensioni. L’ultima dimensione possibile si traduce nella somma di tutti gli eventi passati, presenti e futuri accaduti o non accaduti.
“Esiste un mondo dove un uomo segue la strada che, nell’altro mondo, il suo sosia non ha preso” scrive Walter Benjamin nei Passages parisiens.
Questo testo passa dall’una all’altra teoria ipotizzando l’esistenza della vita sotterranea attraverso un viaggio immaginario, folle e onirico verso un mondo impossibile da raggiungere. Un mondo che si identifica con gli inferi, ma che allo stesso tempo dispone di una volta celeste. Una missione che potrebbe iniziare attraversando uno specchio (come nell’Orfeo di Cocteau) o osservando un’animazione su un monitor.
Verso un luogo percepito come un’altra dimensione in cui sono presenti “un manipolo di uomini decompressi, a due dimensioni, bianchi come un foglio di carta…” e che ricorda “Flatlandia” l’universo bidimensionale descritto da Edwin A. Abbott nell’omonimo romanzo.
Un viaggio attraverso le cavità della terra, in cui si incontrano creature (… un verme, chiamato il verme del diavolo, Mefistofele che è l’unica forma di vita pluricellulare presente ad una profondità considerevole nonostante le condizioni sfavorevoli) e si sperimenta la paura di impazzire dovuta al calore, alla mancanza di aria, di luce e di spazio sufficiente al movimento, alla respirazione e alla vita stessa.
*
Sui testi di Elisa Davoglio
di Fiammetta Cirilli
La sequenza di testi di Elisa Davoglio si apre evocando una macchina da guerra, Tormenta; e si chiude con la menzione di uno strumento di morte, lo strumento per eccellenza della morte imposta come forma estrema di “giustizia”, il patibolo. Tra un estremo e l’altro, altre macchine, altre situazioni di morte: e stralci di inquisizioni, di cronache minime, di minimi affioramenti di soggettività diffratte e anonime, soggettività a perdere, elencate rapidamente e surclassate da altre, in successione. Così, la descrizione pseudomanualistica delle macchine da assedio nelle prime lasse testuali di Tormenta. Il comporsi di quei marchingegni, su un piano visivo, a partire da definizioni che – più che delinearne la forma, la struttura, l’imponenza – ne colgono (paradossali “meraviglie” che adombrano le guerre tecnologiche del XX secolo) gli effetti: «Le prime, efficienti e strutturate macchine da guerra si chiamano Tormenta. | Quelle più pesanti funzionano per lanciare oggetti a caduta libera, pesanti, capaci di forare spesse mura e creare fuochi». Il loro implicare – per trascinamento, si direbbe – l’elemento umano: «In forma più leggera, ma sempre efficace, denominate scorpioni, possono essere trasportate su navi, affondare insieme ai marinai, fare luci con le esplosioni per avvertire dei pericoli in arrivo dal mare, ripetutamente segnalare perdite e l’avanzamento di danni» (il corsivo è mio). Il loro assumere, a tratti, connotazioni organiche, antropizzanti – anche nella loro accezione più sinistra: Tormenta «sono agili, scattanti, affabili, persecutorie». Sicché è assecondata una sorta di confusione tra le macchine e chi ne detiene il controllo: «Manovrabili da un numero eletto di uomini, quelli con la vista migliore, capaci di empatia e amore, e di assegnare nomi alle macchine come ai cavalli o ai figli». Tra le macchine e i combattenti in genere: «Tormenta possono stare a digiuno più a lungo di un uomo, sono per tanti fattori più precise, più resistenti, meno inclini allo stupore e all’inceppamento». Tra le macchine e chi ne subisce il potenziale distruttivo: i fuggitivi, gli assediati «che proporanno il suicidio, l’abbandono di donne e bambini e vecchi, la salvezza di donne, bambini e vecchi, la resa, il suicidio». In una progressione che ha il ritmo di una registrazione fulminea, indebita, implacabile, si va allora dalla/dalle macchina/macchine («Tormenta sono adatte per porre un assedio, come tra una collina e una piana, costruendo un fosso ed un terrapieno, sistemando palizzate fatte di tronchi con la punta aguzza rivolta contro») alla/alle macchina/macchine («otto file di pali aguzzi camuffati con cespugli, e una fascia di pioli muniti di uncini di ferro, sotto la vista di tormenta, che pure utilizzano come gli uomini la luce per vedere, per camminare, colpire, ritirarsi»). Includendo, quasi per inerzia, la guerra. O, ancora, includendo categorie e generi (non le esistenze, non le vite) sconnessi e messi fuori gioco per la guerra, nell’atto di scappare/resistere alla guerra (fuggitivi, assediati, «donne e bambini e vecchi», appunto). Del resto, è alle macchine – non certo agli esseri viventi – che tocca l’iniziale maiuscola: Tormenta (rispettando il plurale neutro latino: non le tormenta, né, tanto meno, i tormenti). Ed è sempre alle macchine che tocca una corporeità/riproduttività zoomorfa: «La sintesi, la genesi, la nascita e l’allevamento di Tormenta, sono pari all’efficienza e alla natura dei fiori che spargono semi e dei bambini». Dalla seconda metà in avanti, per altro, le lasse di Tormenta subiscono un viraggio: lasciando che affiorino – in contrasto all’apparenza stridente: frammenti di senso, di passaggi strappati a una narrazione ipoteticamente collettiva del farsi storia, dell’esercizio individuale per calcare la storia – una lista di «istruzioni per la raccolta, immagazzinamento, in modalità ampia, colorata, affettiva di Tormenta». Norme che evocano, nei loro assunti elementari, la composizione di un album, di un archivio privato della memoria: «procuratevi della carta particolarmente bella su cui stamperete le impronte || stilate un elenco delle foto che volete scattare, in modo da non dimenticarne nessuna sul momento || tagliate una piccola ciocca di capelli dalla nuca (portate con voi una bustina di plastica)», ecc. Fino, appunto, all’esortazione conclusiva: «Destinate una bella scatola o una cassetta in legno a luogo in cui riporre tutti questi ricordi».
Sull’esercizio della memoria (si pensi alle righe finali: al cenno quasi conclusivo all’«annuario con la copertina blu») insiste del resto anche il secondo testo di Davoglio, Processo: montaggio di voci – domande, risposte, parti di risposte: senza relazione, senza nessi, senza logica apparente nella progressione. Un interrogatorio (o lacerti di vari interrogatori) da voce a voce – voce (o voci) che inquisisce/inquisiscono, e (come ovvio) voce/voci che articola/articolano parole di difesa. Un esercizio del dire sul dire: perché – assenti azioni e situazioni, assenti eventuali attori –, sulla carta si imprime il girare a vuoto di un contraddittorio in cui sono per lo più l’atto del parlare e quello del ricordare – nella loro opinabilità e ambiguità, nel loro regime di immaterialità continuamente riplasmata e riplasmabile, inverificata, inverificabile – a essere invocati: come nelle prime lasse, per esempio: «:vorrei fare solo precisazioni | :non ricordo, successivamente, credo di ricordare | :quanto c’era da decidere || :non è vero! Escludo | :ho la certezza di quanto dico | :i miei ricordi sono precisi». O di seguito, nella terza sezione del testo: «:sicuramente. E vorrei aggiungere | :ho l’abitudine di conservare degli appunti | :e che cosa fece? | :rilasciai una breve dichiarazione || :no. Non l’ho letta | :ecco, ora ricordo, non si tratta di | :eppure è andata così | :escludo». La sezione centrale di Processo esula tuttavia da questo modus scribendi: il discorso si fa indiretto, e si concentra in poche, dense righe. Si fa, in qualche modo, storia: «Storia degli aghi» – aghi come individui, come figure/oggetti di cui si traccia la «crescita»/produzione («Molti aghi, se ne producono più di quanti riescono a perdersi»). Ma aghi, ancora, come potenziale strumento di morte («Il delitto con un ago») o di accidentale accesso a una non meglio precisata cronaca o racconto condiviso («Il fatto dell’ago»: al pari di talune narrazioni popolari di giovani donne uccise dall’ago che, conficcatosi sottopelle mentre ricamavano, penetrava nelle loro vene fino a risalire al cuore). Si accede così – previo “spezzamento”: l’accenno a qualcuno (bambini, presumibilmente) che «arrivano per giocare» e trovano una palla – alla sequenza nodale di Processo: con l’immagine dell’«appesa a testa in giù, solleticata sotto le punte dei piedi»: scrutata e “soppesata” («sezionano cosa contribuisce al suo peso, per pesarla»), in un tentativo tanto ottuso quanto cinico di misurazione («Non riescono a trattenerla per i piedi, dritta, sicuramente il peso, ma non c’è possibilità di misura se non confrontando gli oggetti, le cose. Hanno preso provvedimenti, creano scale, dimensioni nuove e vuote come bolle. || Non si regge da sola, è impossibile reggerla per i piedi, senza che il valore venga alterato calcolato male»).
Qualcosa di impossibile è del resto anche quel che si descrive nell’estratto da Viaggio al centro della terra, penultima sezione della scelta di Davoglio: dove la pretesa di oggettività scientifica («Al centro della | terra sta un nucleo, fatto di ferro e nichel. | Il nucleo è separato dal mantello da una discontinuità, detta di Gutenberg, | Il nucleo è fatto di ferro e nichel. Gira più velocemente del resto del pianeta, la | velocità aumenta ogni anno di circa due gradi») digrada “infernalmente” e dà adito a scenari da immaginario medievale («Al centro della terra stanno gli inferi, si brucia e | non si vola la maledizione»), non senza sussulti che riportano allo spunto iniziale («alcuni elementi, parti di roccia, arrivano in superficie e stupiscono. Ne viene studiata | la composizione, la densità. Perché mutano e cambiano forma come se la terra | stessa digerisse il suo centro»). Fino all’abbozzo di «animazione» che dovrebbe riprodurre virtualmente una eventuale missione scientifica («un manipolo di uomini decompressi, a due dimensioni, bianchi come un foglio di |carta») e al progetto di «bombardamento atomico | che fletta la terra come un terremoto». Ipotesi allucinatoriamente raffinate, e inadeguate, tanto da motivare in extremis il recupero di credenze antiche e vulgatissime (a proposito di quelle che, per eccellenza, erano viste come le bocche dell’inferno): «da vulcani spenti, forse, si potrebbe calare e accedere al centro della terra | l’odore terribile è stato avvertito per la prima volta nel mese di gennaio, l’anno scorso».
Cocktail Party, infine: testo di chiusura e, in qualche modo, di sintesi. Testo che (re)immette in un ordinario contemporaneo da cronaca (il più delle volte) nera: e che della cronaca mima appunto la sintassi e il lessico; il riferirsi a soggetti deprivati di identità; la prassi che ne inquadra in un rigo o due la biografia, o meglio, gli avvenimenti destinati a mettere in crisi una data biografia. «Tra i coniugi la rottura pare inevitabile: entrambi hanno stretto una nuova relazione | è condannato a morte ma si avvelena || le liti si susseguono | la resa è totale, incondizionata»: la carrellata si dipana segmento per segmento – titolo di cronaca dopo titolo di cronaca, si potrebbe immaginare: «benché riluttante e inorridito da se stesso, la uccide | rimasta ben presto vedova, dedica il suo denaro alle opere di beneficenza || muore giovanissimo, schiacciato dal peso di quella memoria | finisce per uccidere anche il suo creatore». Con l’irruzione di un umano iterato e svuotato di individualità, facile e necessario involucro a una ritualità collettiva ridotta all’osso, “economizzata”, per così dire: negli esiti della quale si percepisce una perdita (di senso, soprattutto) non inferiore alla perdita (quantificabile in termini materiali) prodotta dalle devastazioni di guerra: «passerà il resto della vita nella casa di famiglia | si getta sotto i proiettili dei suoi ex compagni || riesce a gestire il successo con moglie e figli | si avvia nobilmente al patibolo».
*
Prove d’ascolto è un progetto di Simona Menicocci e Fabio Teti
Tutto all’improvviso è immobile
di Stefano Iucci
[Pubblichiamo un estratto da Tutto all’improvviso è immobile. Poesie 2012-2016, Il seme bianco, Roma 2017]
È vietato cambiare.
Chi cambia muore
solo chi è fermo vive, non dissipa.
Sterile è il mutamento e falso moto
bisogna rimanere immobili
e fuori dal tempo
L’autore a se stesso
di Giuseppe Felice Matteo Givanni (con un commento di Roberto Antolini)
L’è za na sfilza d’ani, che ‘l refles
D’esser prest vechio* m’avea fat desmeter [*si legga: vecio]
Dal far versi ‘n la lengua del paes
E pena ‘n carta per esnsim de meter;
Perché quel che ‘ntum zovem no rencres,
Un vechio no se pol mai comprometer,
Che se ‘l lo fa, e orevesi, e saltori
A sentirlo no i diga: oh mat Bidori!
Ma come no l’è colpa de l’infermo
Quel so sbater de polsi, ma del mal,
Cossì, se de componer no me fermo
El pecà l’è tut quant del natural,
Natural che ve zuro, e ve confermo,
L’è ‘l sol ereditari capital,
Che porto da la vechia* me genia; [*si legga: vecia]
Che chi de gata nasse sorzi pia**.
**NOTA dell’A.: “proverbio trito”
TRADUZIONE
È già una fila d’anni che il riflesso, d’essere presto vecchio mi aveva fatto smettere di far versi nella lingua del paese e persino di mettere penna su carta; perché quello che in un giovane non rincresce, un vecchio non se lo può mai permettere, che se lo fa, e orefici e sarti a sentirlo non dicano: oh matto (come) Bidori! [nome di un matto effettivamente vissuto a Rovereto, divenuto poi proverbiale nella cultura cittadina] / Ma come non è colpa dell’infermo quel suo sbatter di polsi, ma del male, così, se non smetto di comporre, il peccato è tutto quanto del naturale, naturale che vi giuro, e vi confermo, è il solo ereditario capitale, che porto dalla mia vecchia stirpe; che chi di gatta nasce prende topi.
Questo testo dialettale pressoché inedito[1] viene composto sicuramente negli ultimi anni vita del sacerdote Giuseppe Felice Givanni (Rovereto 1722-1787), ed è dunque attribuibile agli anni ’80 del Settecento. È una appassionata confessione del suo bisogno di scrivere ribadito dalla soglia dell’ultima età, ed una difesa della sua vocazione letteraria dialettale, di quel suo «far versi ‘n la lengua del paes», che l’autore fa risalire al suo «natural», cioè alla sua indole, che afferma – con gran consapevolezza personale e storica – essere «‘l sol ereditari capital, Che porto da la vechia me genia», cioè tutto quanto aveva ricevuto dalla sua storia familiare.
Giuseppe Felice Givanni vive nella fascia centrale del Settecento nella cittadina di Rovereto, geograficamente periferica – a sud di Trento, lungo la “via imperiale” fra Verona ed il Brennero – ma ricca, per il grande sviluppo della “arte della seta” (cioè della produzione serica), che vi fiorisce nel Sei- Settecento. Rovereto è in quest’epoca il principale centro di produzione serica dei possedimenti asburgici, ed esporta i suoi filati in tutta l’Europa centrale. Da questa attività produttiva e commerciale trae origine una locale borghesia, spesso agli inizi di origine immigrata – dalla Germania e dal veronese – che nel Settecento, dopo oltre un secolo di arricchimento, subisce un processo di acculturazione, ed emana dal suo seno un ambiente letterario ispirato ai principi del razionalismo arcadico-erudito, con punte che arriveranno alle soglie di una specie di riformismo illuminato, a cui si può forse arruolare, pur con molta moderazione, anche il Givanni. Lui proviene da una famiglia di piccoli imprenditori trasferitisi nella zona Rovereto (probabilmente dall’alto veronese, dove era molto diffusa la bachicoltura) a metà Seicento, per inserirsi nello sviluppo dell’industria serica che la zona stava conoscendo. La famiglia migliora la sua posizione generazione dopo generazione, fino al notevole successo economico, coronato verso il 1739 dall’acquisizione di un titolo di bassa nobiltà, di Giacomo Givanni (1665-1759), uno zio del poeta.
Giuseppe Felice Givanni è quindi un poeta di origine e cultura boghese (anche se lui personalmente non sarà mai ricco). Ma proviene da una borghesia “ruspante”, che si da un gran da fare: impianta filatoi per la seta, forni e cartiere, inseguendo con le unghie e con i denti la ricchezza e l’affermazione sociale. È una origine borghese che il nostro poeta sente ancora immersa nella vita popolare, e la sua “scelta dialettale” usa il dialetto per fondare una sua identità letteraria solidamente impiantata nella cultura popolare, lontana dalla ambizioni – per lui evidentemente astratte – di quei «siori» che «com pu che i vol parlar en quincis quancis, tant pu i casca ‘n tel bazzom»[2] [quanto più vogliono parlare in quincis quancis – in modo affettatamente raffinato – tanto più cascano nel secchio-pozzanghera]. Nella premessa al manoscritto autografo in cui è raccolta tutta la sua produzione (che viene conservato presso la Biblioteca Capitolare di Verona) afferma, parlando scherzosamente a/di sé stesso «voi se ‘l vero retrat dei vossi antichi Noni, e Barbi, i quai s’ha sempre segnalai co le so bizarie e facecie. Oh! Se quei fus ancora al mondo, che legrezza no avariei a vederve voi, che avè mes en rima pu de una de quele stesse lezarie, che quando ere ‘n fraschet grand come‘n zom, tegnantve tra i zinochi, i ve conteva su, e voi steve lì con na spanda de boca atent a scoltarle?»[3] [voi siete il vero ritratto dei vostri antichi nonni e zii, i quali si sono sempre segnalati con le loro bizzarrie e facezie. Oh! Se fossero ancora al mondo, che allegria ne avrebbero a vedere che voi avete messo in rima più di una di quelle stesse leggiadrie, che quando eravate un ragazzino grande come un birillo, tenendovi tra le ginocchia, vi raccontavano, e voi stavate lì con una spanna di bocca attento ad ascoltarle?]. Givanni si sente erede di quelle «lezarie», cioè della cultura popolare dei suoi avi, ed usa la sua attività letteraria per traghettarle nella cultura scritta nella loro lingua naturale, il dialetto. Anche queste nostre «strofe» terminano con la trascrizione all’interno della poesia di un «proverbio trito», quel «chi de gata nasse sorzi pia» che troviamo drammaticamente documentato nella zona di Rovereto già nel secolo precedente: era servito infatti in un seicentesco processo alle streghe tenuto in un paesetto di fronte a Rovereto (Nogaredo), per incriminare una sventurata diciasettenne, figlia di una madre già precedentemente incriminata e torturata.
NdA: Una delle novelle in versi dialettali di Giuseppe Felice Givanni la si può trovare in rete all’indirizzo:
[1] È stato pubblicato da me, ma en passant all’interno di un articolo di storia: Roberto Antolini, Origine familiare e condizione sociale del sacerdote roveretano Giuseppe Felice Matteo Givanni, poeta dialettale (1722-1787). In “Studi Trentini. Storia”, A.92 (2013) n.2, p. 432
[2] Roberto Antolini, La ‘Musa Sgrovia’ di Giuseppe Felice Givanni, In “Atti della Accademia Roveretana degli Agiati”, s. 9, vol. 4 (2014), fasc. 1, p. 23
[3] Idem, p. 23
Letteratura e memoria/1: Annie Ernaux
di Stefano Gallerani
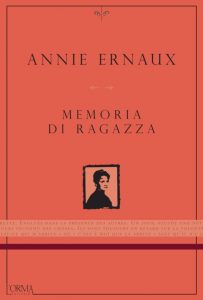
Annie Ernaux
Memoria di ragazza (traduzione di Lorenzo Flabbi)
pp. 256, € 16,20
L’orma editore, “Kreuzville Aleph”
Roma, 2017
Dopo il successo de Gli anni, Il posto e L’altra figlia, L’orma editore torna a proporre, con Memoria di ragazza (traduzione di Lorenzo Flabbi, “Kreuzville Aleph”, pp. 256, € 16,20), la scrittrice francese Annie Ernaux Come già i precedenti titoli, anche in questo caso si tratta di una narrazione autobiografica, eppure ciò che continua a sorprendere è il modo in cui Ernaux declina l’esperienza personale ben oltre l’ovvia considerazione che, qualsiasi cosa scriva, uno scrittore non faccia che parlare di sé, in un modo o nell’altro.
Il messaggio è questo

di Andrea Inglese
Cerchiamo di farci un’idea chiara almeno di questo, che questo è un messaggio, e come si studia un messaggio e come se ne parla, come va e viene, e l’emittente, e il disastro, e il ricevente.