di Ugo Fracassa
(Il testo compare come Nota all’edizione nel sito www.princesa20.it)

“Qualcosa abbiamo già nello scaffale. Un giorno li ricorderemo come piccoli classici della letteratura immigrata”: così iniziava l’articolo pubblicato in controcopertina sul primo fascicolo della rivista “Caffè. Per una letteratura multiculturale”, nel settembre del 1994. Tra i “cinque o sei libri” cui si alludeva, Princesa, vent’anni dopo, non ha finito di dire quel che aveva da dire; se ciò non basta a farne un classico a tutti gli effetti [1] giustifica però la previsione formulata in quell’occasione. In altre parole, sembra giunto il momento di istruire ed avviare il processo di canonizzazione per un’opera che, inizialmente, sembrava dover esaurire il proprio raggio di azione e ricezione entro i ristretti ma mobili confini delle cosiddette “scritture migranti”. Se, nel frattempo, quelle scritture hanno compiuto la maggiore età, [2] il libro di Fernanda Farias de Albuquerque e Maurizio Iannelli ha incontrato lettori ben oltre la cerchia degli addetti ai lavori [3] e, in particolare, ha contribuito a creare l’habitat idoneo al fiorire attuale dei “nuovi realismi italiani” [4]. Ha affermato recentemente Bruno Racine, direttore della Bibliothèque Nationale Française, a proposito delle 120 giornate di Sodoma – un classico che, al pari di Princesa, intra–vide la luce in carcere: “È senz’altro un testo atroce e radicale ma bisogna riconoscerne il valore storico e culturale”, tale da costituire “patrimonio nazionale” [5]. Del resto, era stato Michel Foucault a portare ad esempio proprio la figura del marchese de Sade, nelle celebri pagine dedicate alla questione Che cos’è un autore:
Se un individuo non fosse un autore potremmo dire che ciò che egli ha scritto o detto, ciò che egli ha lasciato fra le sue carte, ciò che è stato riportato dai suoi commenti potrebbe essere chiamata un’ opera? Finché Sade non è stato un autore che cos’erano le sue carte? Solo dei rotoli di carta sui quali, all’infinito, durante le sue giornate in carcere, egli elaborava i suoi fantasmi [6]
Maurizio Iannelli è oggi certamente un autore, premiato e riconosciuto per alcune serie di docufiction televisiva costruite intrecciando vita reale, documenti processuali, cronaca nera e finzione narrativa. [7] Quando riordinava, trascriveva e rielaborava, nel carcere romano di Rebibbia, i manoscritti di Fernanda, tuttavia, era consapevole di maneggiare un materiale grezzo cui forniva, oltre ad una veste linguistica apparentemente standard, lo scheletro diegetico atto a sostenerne la forma editoriale. Non per questo avrebbe sottoscritto le parole di Cesare Lombroso, prefatore dei Palimsesti del carcere:
Se, nel fingere il linguaggio dei demoni, il Poeta non poté non esprimersi in versi sudici, a me, ch’ero il paleografo, il trascrittore dei pensieri di questa specie di demoni terrestri, non era certo dato far meglio [8]
La relazione coautoriale, infatti, era fondata sulla condivisione dello stato di detenzione e sulla consapevolezza di un’affinità che, al di là delle apparenze, univa la condizione esistenziale di un detenuto politico in “piena crisi d’identità” con quella transessuale di un criminale comune. Prima ancora del diritto all’autorialità, perciò, Iannelli riconosceva all’estensore di quei manoscritti il diritto alla biografia. “Non tutti gli individui che vivono in una determinata società hanno diritto ad una biografia. Ogni tipo di cultura elabora i suoi modelli di uomini senza biografia” [9], ce lo ha insegnato Jurij Michailovič Lotman il quale ci fornisce pure una minima tipologia delle relazioni tra testo e contesto che, di volta in volta, nei vari frangenti storico-culturali, decidono dell’artisticità di un’opera letteraria. Si dà, per esempio, il caso di uno scrittore che “non crea il testo come opera d’arte ma il lettore lo recepisce come opera d’arte”: qual è la posizione del lettore di Princesa, venti anni dopo, rispetto all’avantesto che finalmente viene reso disponibile nell’archivio del sito [10]? Posto che “il quadro offerto dalla storia della letteratura ai diversi stadi del suo sviluppo è considerevolmente più complicato” [11] dello schema elementare cui ci si richiama, si potrebbe qui ipotizzare un caso di “artisticità retroattiva” poiché è evidente – a scorrere appunti, interviste, pagine di diario, trascrizioni di favole nordestine, anamnesi oniriche, schizzi di mappe prodotti da Farias de Albuquerque in un biennio di pratica scrittoria coatta – che l’aura di letterarietà acquisita dal racconto della vita di Fernandinho / Fernanda / Princesa nei due decenni della sua storia editoriale [12] riverbera oggi sui manoscritti accumulati in carcere.
*
Sia detto però fin da ora che l’eccezionalità di un’eventuale inclusione di Princesa nel canone della nostra letteratura – quella che un tempo si definiva italiana, nazionale e che oggi, nel contesto dei processi di globalizzazione culturale, è talvolta detta italòfona – è più apparente che reale, se ci si riferisce alle peculiari caratteristiche genetiche dell’opera. Raccontare le proprie esperienze “migratorie” ad un compagno di prigionia che le trascrive in un altro codice linguistico (letterariamente codificato), in cui filtrano però dall’oralità alcuni dialettismi, prima che quel racconto vada incontro a nuove versioni, riscritture e riduzioni, è precisamente ciò che fece Marco, alla fine del Duecento in un carcere genovese, al cospetto di Rustichello da Pisa, compagno di sventura. Ne sortì Le divisament dou monde, ovvero la redazione in lingua d’oïl del libro che, in versione toscana, è meglio noto come il Milione di Marco Polo, classico della letteratura nazionale.
*
Quanti hanno riflettuto sull’antica e nobile tradizione della “letteratura carceraria”, provando in qualche caso ad estrarre le invarianti di un “genere” che, da Cervantes a Mandel’stam, annovera alcuni tra i maggiori scrittori di tutti tempi, concordano sulla ragione primaria che conduce alla scrittura nelle istituzioni “complete e austere”, come le definiva L.P. Baltard nel 1829, o “totali”, secondo la più recente definizione foucaultiana: “far sopravvivere la propria integrità, in tutti i sensi”. [13] Era questo il progetto alla base dei laboratori di scrittura organizzati a Rebibbia, da cui prese le mosse l’attività editoriale di Sensibili alle foglie, e lo stesso Giovanni Tamponi, che per primo esortò Fernanda a mettere nero su bianco i propri ricordi, aveva autonomamente sperimentato e propagandava le potenzialità terapeutiche di una tale pratica. Iannelli che quelle carte contribuì a suscitare, raccolse e manipolò, ultimo arrivato nel trio di “funamboli” [14] della scrittura a Rebibbia, riuscì a neutralizzare l’“individualizzazione coercitiva” che fonda l’istituzione carceraria [15] – aggirata dai primi due grazie ai benefici di mobilità derivanti dalle mansioni svolte tra i reparti – in modi talvolta rocamboleschi (per esempio comunicando attraverso la grata che dava sul passeggio dei transessuali, limitrofo alla cappella della casa di reclusione). Insomma, come è stato notato, “Voler raccontare tutta la storia è un’altra forte motivazione per lo scrittore imprigionato”, ciò che non inficia la riuscita dell’opera dal momento che “l’autenticità della voce del narratore contribuisce alla buona qualità della letteratura”. [16] Ma al di là dell’attendibilità di una voce che, nel caso di Princesa, si dimostra essere la risultante di una miscela polifonica (quando non di un atto di vero e proprio ventriloquismo), ciò che di autentico si sperimenta in condizioni di restrizione coatta è innanzitutto “il modo in cui i rapporti di potere possano passare materialmente nello spessore stesso dei corpi senza che neanche debbano essere trasformati nella rappresentazione dei soggetti”. [17] In una storia di vita transessuale come quella di Princesa aleggia minacciosa, ben al di là dei pur frequenti ed espliciti episodi di violenza privata e di repressione poliziesca, la sovradeterminazione biopolitica di ogni scelta di genere. Se la sessualità è coestensiva al potere – Foucault afferma e Judith Butler conferma [18] – sono proprio gli individui in transizione intersessuale, oltre ogni retorica di liberazione, a pagare il prezzo più alto:
En réalité, il en va des catégories qui organisent notre monde, soit de l’ordre sexuel et de sa violence, tant symbolique que physique, dont les personnes intersexes sont le révélateur en même temps que l’emblème [19].
Da questo punto di vista non cessa di stupire, per il grado di consapevolezza politica implicata, il corto circuito che connette, nell’intervista rilasciata da Farias e Iannelli per il citato primo fascicolo del “Caffè”, condizione transessuale e condizione postcoloniale o migrante [20]:
Come che è una scrittura bella, chi lo leggerà [Princesa] troverà un po’ di sentimento perché è una storia di realtà, una storia di vita transessuale ma anche di vita con tutta l’esperienza al mondo maschile, il fatto di come vive un transessuale in mezzo alla società, per affrontare le varie conseguenze che esistono […] con il problema che accade ai confronti di queste persone che sarebbe le persone del terzo sesso, o persone del terzo, diciamo, mondo [21].
*
Il bello della scrittura in Princesa, appunto. Chi ha analizzato il libro fin qui ha più spesso parlato di tradimento, da parte del coautore italiano, rispetto alla ricchezza non omologabile dell’impasto linguistico originario, del resto pressoché sconosciuto ai più, se non per un paio di brevi stralci pubblicati nel ‘94. Si è detto della standardizzazione imposta da un editing invasivo, della medietà di un dettato depurato da scorie dialettali o allofone. Per descrivere una lingua così – disanimata, ossificata – si potrebbe utilmente recuperare il giudizio espresso da Leonardo Sciascia nella relazione di minoranza alla commissione parlamentare d’inchiesta sulla strage di Via Fani:
Gli esperti sono stati invece adibiti a studiare il linguaggio delle Brigate Rosse: e non c’era bisogno di esperti per scoprirlo poveramente pietrificato, fatto di slogan, di idées reçues dalla palingenetica rivoluzionaria, di detriti di manuali sociologici e guerriglieri […] L’italiano delle Brigate rosse è semplicemente, lapalissianamente, l’italiano delle Brigate rosse. [22]
oppure quello, analogo, rilasciato in occasione di un incontro del 1978 con i militanti di Lotta continua: “Ma a me sembra una cosa proprio ossificata, senza vita, disanimata, una specie di burocrazia del fanatismo. Questo loro amore per le sigle…” [23]. Allo stesso Iannelli, del resto, come ad alcuni leader storici dell’organizzazione terroristica, quel linguaggio era destinato ad apparire, col senno di poi, indigeribile:
Già allora [sequestro Moro] quel linguaggio mi appariva tremendo. Rileggendoli a posteriori, mi sono chiesto non tanto come avevamo fatto a scriverli [i comunicati] – non li rinnego, un senso lo avevano, eccome… Certo non ne ho conosciuto uno, di compagno, che sia entrato nelle Br perché conquistato dalla lettura di una Risoluzione strategica. [24]
Per questa ragione Sciascia indovinava, tra le fila dei brigatisti, una scarsissima confidenza col romanzesco: “Quelli che hanno scritto quei comunicati sono sicuramente gente che non ha mai letto un romanzo…”, al punto da “condannarli” per contrappasso ad un severo apprendistato letterario: “Che romanzi consiglieresti alle Br? Per contrasto un po’ di Proust andrebbe bene. Ma certo se leggessero un po’ di Voltaire e un po’ di Diderot, non sarebbe male… Poi anche il Vangelo” [25]. Prende forma qui, tra l’altro, un’imprevista ma suggestiva analogia: ne Il bacio della donna ragno, fortunato romanzo dell’argentino Manuel Puig (pubblicato nel 1976 e prontamente tradotto in Italia nel 1978), all’immaginario hollywoodiano e mélo grazie al quale l’omosessuale Molina riesce a dimenticare la dura realtà della detenzione, il compagno di cella Valentìn, guerrigliero incarcerato per motivi politici, oppone gli slogan del materialismo dialettico – “I miei ideali… Il marxismo, se vuoi che ti definisca tutto con una parola” – al punto da provocare questa reazione stizzita:
non gli racconterò neanche più una parola delle cose che mi piacciono, se la rida pure che io sono uno smidollato, vedremo se lui non molla proprio mai, non gli racconterò più nessun film di quelli che mi piacciono, me li tengo per me, nel mio ricordo, che non me li rovinino con parole sporche, ‘sto figlio di puttana e la sua porca merda di rivoluzione. [26]
Ma l’incontro tra Farias e Iannelli non è letteratura; la vita, per dirla con Zeno Cosini, “non è brutta né bella, ma è originale!” e forse per questo le cose a Rebibbia sono andate diversamente. Alla fine, proprio colui che era sospettato di non aver mai letto romanzi ne ha scritto uno. Bisogna, insomma, riaprire il caso Princesa, proprio a partire da quella scrittura che alla protagonista del racconto era parsa bella.
Tanto per cominciare, la “nuova lingua”, inaugurata nel libro del 1994, risulta dalla chimica di tre lingue materne. Il portoghese, l’italiano e il sardo [27], e il coautore non esclude che “mani e provenienze culturali diverse [siano] forse rintracciabili anche nella sua stesura ultima.” Se il libro deriva da un brogliaccio cui non si fatica ad attribuire le peculiarità dell’art brut, insieme autentica e unadorned (ma già disposto in fabula da Iannelli, in quella “copia iniziale di lavoro conforme all’originale manoscritto” che porta il sottotitolo “Sono venuta di molto lontano”), almeno una traccia della stesura originale di Farias è rimasta nel Glossario stampato in appendice al volume edito da Sensibili alle foglie. Burití, caatinga, caboclo, cajù, urutu: vale la pena di notare che le cinque voci elencate erano già presenti nel glossario che Edoardo Bizzarri allegava alla sua traduzione del Grande Sertão di João Guimarães Rosa (la traduzione è del 1970 mentre il romanzo risale al 1956) e che si tratta di definizioni relative ad aspetti naturali del territorio nordestino. Nel fitto epistolario che lo scrittore brasiliano intrecciò con Bizzarri [28] si legge dell’imbarazzo per quanto di “esotico” transita nella versione italiana e resiste tuttavia alla traduzione: “Quel che deve aumentare i grattacapi del traduttore è che la parte concreta è esotica e mal conosciuta” [29]. È stato lo stesso Iannelli ad indicare nel fluviale racconto di Guimarães Rosa – che narra della storia d’amicizia e d’amore tra Riobaldo, un guerrigliero jagunço [30] e il suo compagno Diadorim che, caduto in battaglia, rivelerà la sua natura femminile – una fonte preziosa per il suo primo ed unico libro. [31] Inoltre, la figura dello jagunço o cangaço era ben presente alla stessa Fernanda che, richiesta da Maurizio, ne offre una definizione nell’intervista sul Carnevale (la trascrizione che segue è incompleta a causa delle sottolineature accumulate da Iannelli in questa zona del testo): “M – Invece gli uomini come erano vestiti? F – Gli uomini si vestivano come cangaçeiros […] M – Ah, il cangaçeiro è una specie di bandito-rivoluzionario. F – Sono [illeggibile] dei banditi che combatevano contro la polisia” [32]. L’influenza del capolavoro di Guimarães Rosa è riconosciuta però limitatamente all’acquisizione dell’immaginario legato al folklore nordestino e, in particolare, alle leggende connesse col fantastico e demoniaco paesaggio della caatinga. Non sorprende perciò riconoscere in Princesa la traccia di detti popolari, come il seguente, letteralmente estratto dal romanzo: “Ragazzini-roba del diavolo” (Princesa); “Non c’è forse il detto: ragazzino – roba del diavolo?” (Grande Sertão ). Il riferimento al vitello che compare in uno dei primi paragrafi di Princesa, inoltre, variando riecheggia l’incipit del Grande Sertão. Il romanzo del ’56 si apre infatti all’insegna di un bestiario – “un vitello bianco, erratico, gli occhi che manco un cristiano – che era apparso; e con faccia di cane” – che ricorre nei giochi d’infanzia di Fernandinho ed assume, nella trascrizione di Iannelli, coloriture diaboliche estranee all’originale manoscritto:
Io ero la vacca. Genir il toro, Ivanildo il vitello. Camicette e pantaloncini sfilavano via in mezzo al bosco. Lontano da tutti, era il segreto. Genir muggiva e m’inseguiva. Una fantasia di spinte, toccamenti e fiato grosso. Montava la vacca, indiavolava sopra di me.
A chi scrive, tuttavia, il debito contratto da Iannelli con l’ipotesto brasiliano pare investire anche il versante stilistico, della scrittura. A tratti, sembra quasi che l’italiano abbia introiettato il metro sul quale si dispiega la saga latinoamericana, quel procedere per densi fiotti estratti dal parlato e come rigurgitati. Così la prosa del brasiliano nella traduzione di Bizzarri: “Faccia di gente, faccia di cane: decisero – era il demonio”. “C’erano tutti, e con loro la mia diffamazione: Signor Diaz, ha visto Fernandinho! Cammina come una femmina! Rildo vociava come un forsennato”; “È pericoloso andare solo per il bosco, c’è il gatto selvatico, il serpente! Povero Francisco, la sua ingenuità”; “Lui abbassa il finestrino, lei entra tutta spalle e natiche in esposizione. Lui si accorge e urla di spavento: Vattene, mostro”; “Mi confondo nella folla. Sono tuttapposto e passo liscia, presente e invisibile nella distrazione della gente: una donna”: così quella dell’italiano, che dissemina il testo di tessere prosodicamente calcate sulla traduzione del prototipo nordestino. Oltre l’apparenza di una superficie linguistica livellata sugli standard veicolari di un italiano ipermedio, perciò, la scrittura di Iannelli nasconde un doppio fondo. Quella “nuova lingua” è il risultato di negoziazioni condotte a vari livelli, dalla reale consistenza del parlato, attraverso una normalizzazione della meccanica comunicativa (che può conservare memoria di usi linguistici legati alla trascorsa militanza politica), alla frequentazione di un modello letterario di seconda mano. Una lingua costruita per dare conto di vicende intimamente connesse coi contemporanei processi di globalizzazione e che trova il proprio modello nella traduzione di un idioma postcoloniale. Scrive Giuliana Benvenuti: “la traduzione è il luogo privilegiato della mediazione e della negoziazione e la sua funzione interseca questioni legate al genere, alle migrazioni, all’informatizzazione e alla biopolitica” [33]. In questo senso, l’operazione di Iannelli va ripensata nel quadro dei processi di denaturalizzazione dei legami tra lingua, cultura, nazione e cittadinanza in atto in epoca globale. Era, del resto, lo stesso Guimarães Rosa il primo ad esserne consapevole e a rivendicare per sé l’utilizzo di un codice letterario come lingua seconda:
Quando scrivo un libro, mi comporto come se lo stessi ‘traducendo’ da un altro originale, esistente altrove, nel mondo astrale o sul piano delle idee, degli archetipi, per così dire. Non so mai se sto riuscendo o fallendo in questa ‘traduzione’. Perciò, quando mi ‘ri-traducono’ in un altro idioma, non so mai, in caso di divergenze, se non è stato il traduttore che di fatto ha azzeccato, ristabilendo la verità dell’originale ideale che io avevo distorto [34].
Quel registro traduttese sul quale è giocata la prosa di Princesa, perciò, denuncia innanzitutto una relazione non lineare del coautore con la propria lingua nel momento in cui questa è chiamata a farsi carico di esperienze, biografiche e culturali, non autoctone, di migrazione, in una parola: postcoloniali.
*
Edoardo Albinati col suo Maggio selvaggio. Un anno di scuola in galera (Mondadori, 1999) sta di diritto, insieme a Walter Siti, Edoardo Affinati, Antonio Franchini e altri, nel canone degli autori cui si attribuisce la paternità dei “nuovi realismi italiani”, quella galassia narrativa intorno alla quale il dibattito è stato inaugurato sulle pagine della rivista “Allegoria” [35]. Il diario di Albinati contiene un appunto, datato fine estate 1998, che funge da cavallo di Troia per il trasferimento di Princesa dentro la nuova temperie. Si tratta di un episodio nel quale l’insegnante riveste il ruolo di mero spettatore, al punto di dover chiedere lumi ad un detenuto circa l’identità di un personaggio osservato al passeggio. Questa pagina, che contribuisce a focalizzare la presenza transessuale in carcere, registra pure la fortuna cinematografica del carcere romano, a testimonianza di un “ritorno al reale” che non investiva, alla fine del primo millennio, la letteratura soltanto:
In questa fine estate infuriano le polemiche riguardanti il carcere, soprattutto Rebibbia, a leggere il giornale pare che la metà dei film presentati al festival di Venezia siano stati girati lì – come dice la canzone, “apposta per scandalizzare”. Ammetto di essere infastidito e preoccupato di questa spettacolarizzazione permanente, un paiolo di frasi fatte in cui il giornalismo rimesta stancamente la sua lunga pertica. […] A quello girato da Fioravanti & Co. si aggiunge un documentario su un trans brasiliano, Princesa, ricordo il giorno che a Rebibbia la riprendevano in pose molto glamour, piantata in mezzo al piazzale, tutti gli occhi puntati addosso a lei, aveva un culo magnetico e somigliava, non a Sonia Braga come dicono sul giornale, bensì a Florinda Bolkan (giustamente me lo fece notare Croccolo seduto accanto a me), una Bolkan pompata e assai più donna dell’originale, mito androgino dei film morbosi di quando stavo alle elementari, Metti, una sera a cena ecc. Ricordo che ero seduto sugli scalini insieme a un gruppetto guardando, con un lieve sorriso sulle labbra, la scena, il set fotografico […] sicché mi permisi di chiedere all’orecchio del vecchio Croccolo chi fosse quella fata, e lui che conosce i peccati del mondo mi raccontò la storia di Princesa, cominciando così: “A lei ruppero il culo che teneva solo sei anni…”
L’autore non pare consapevole dell’esistenza del libro dedicato alla Princesa ripresa al passeggio, o almeno sceglie di non dar peso alla cosa, nonostante l’omonima canzone di De André e Fossati avesse nel frattempo dato vasta popolarità al personaggio, né poteva conoscere regista e titolo del documentario delle cui riprese si era trovato ad essere involontario testimone: Le strade di Princesa di Stefano Consiglio (1997).
Uno dei modi narrativi in uso in molti esemplari riconducibili alla recente voga reali(ty)sta [36] è quello dell’autofiction, col quale elementi autobiografici vengono liberamente immessi in un tessuto di invenzione romanzesca, talvolta su uno sfondo ostentatamente cronachistico, nel quale è dato riconoscere luoghi, vicende e personaggi reali, anche grazie all’uso di documenti (carte processuali, pagine di diario ecc.). Ebbene, con qualche anticipo sulla manifestazione della nuova tendenza a livello di mainstream editoriale, procedimenti non dissimili erano in opera nell’ambito delle scritture migranti, in particolare quando, nella prima metà degli anni Novanta, si rendeva ancora necessaria la collaborazione di un coautore italiano.
In libri come Princesa, appunto, o Immigrato di Mario Fortunato e Salah Methnani la proiezione autobiografica sulla narrazione risulta, se possibile, più complessa ancorché non sempre consapevole, derivando da ben due biografie spesso inopinatamente miscelate. Così Mario Fortunato nella premessa alla riedizione del 2006:
Lui raccontava, io facevo domande. Qualche volta prendevo appunti. Quasi mai abbiamo usato il registratore. La storia che si dipanava aveva per me un valore innanzitutto romanzesco, narrativo Per me si trattava di un romanzo il cui contenuto aveva realmente avuto luogo […] In un secondo momento me ne andai da solo in Calabria […] In quattro settimane di lavoro ininterrotto, il testo era scritto. Lo avevo scritto come si trattasse di una storia interamente mia […] sciorinavo la storia di Salah come fosse la mia propria storia. [37]
Anche Maurizio Iannelli ricorda come il processo creativo prese slancio nel momento della separazione da Fernanda: “Perché il testo, il dialogo col testo di Fernanda, è iniziato nel momento in cui ci siamo separati. Nel momento in cui mi hanno trasferito in un altro istituto”. Così Iannelli, ancora nel 1994, nell’intervista al “Caffè”:
La mia scrittura è un’altra scrittura. È indubbio che alla fine, e non solo tecnicamente come scrittura, penso che ci sia molto di me. Anche se introdotto in un modo del tutto clandestino, in un gioco di assunzione di ruoli, e di costruzione poi del personaggio […] Insomma, Princesa è stato anche un libro di rapina se volete. […] Scrivere un’autobiografia in due implica un cortocircuito. [38]
Analoghe riflessioni proporrà, nel 2008, intervistato a proposito della sua docu-soap Reparto Trans (girata insieme a Marco Penso) e, più in generale, della nuova attività di regista e autore televisivo:
in ogni caso, con le scelte di regia, il posizionamento della macchina , il montaggio, l’autore parla sempre di sé, anche quando parlano gli altri, la sua presenza non si risolve nel mero artificio stereotipo della voce narrante. La presunzione di poter rappresentare oggettivamente l’altro è un’illusione (neanche l’altro si conosce realmente per come è). Il regista, e così l’autore, racconta alla fine se stesso ed il lettore-spettatore è innanzitutto chiamato a decifrare questo. [39]
Appartengono certamente al coautore italiano, e alla sua storia personale durante gli “anni di piombo”, le scelte espressive che portano ad enfatizzare costantemente gli episodi di violenza poliziesca registrati nei manoscritti di Farias, dove tuttavia vengono spesso risolti con un breve giro di frase. Sono suoi gli innumerevoli riferimenti al diavolo che, pur presente nell’immaginario nordestino esemplato dal Grande Sertão, non sono estranei alla nostra tradizione cattolica. Riguardano l’esperienza del terrorismo pure alcune particolari consonanze con la fonte brasiliana: Iannelli che avrebbe sottoscritto, nella lettera a Rossana Rossanda pubblicata sul “Manifesto” nel 1987, l’auspicio di uno “sbocco politico e sociale” della lotta armata, non poteva non leggere nelle pagine del romanzo dedicate al pentimento di alcuni guerriglieri jagunços l’eco di avvenimenti che stavano caratterizzando il destino carcerario di alcuni ex appartenenti alle Brigate rosse. La scelta, infine, di terminare il racconto di Princesa con l’arresto della protagonista è, nella sua natura omissiva (gli appunti di Fernanda riguardano anche la quotidianità carceraria), un gesto che pertiene alla responsabilità dell’autore:
Senza sforzo, nelle braccia del demonio, in Europa, ci si arriva a bassa voce, silenziosamente. Qui da voi, non si muore fragorosamente. Sparati o di coltello, tra urla e sforbiciate. Qui si sparisce zitti zitti in sottovoce. Silenziosamente. Sole e disperate. Di aids e di eroina. Oppure dentro una cella, impiccate a un lavandino. Come Celma, che vorrei ricordare. Dormiva nella cella a fianco, dentro quest’altro inferno dove ora vivo e che ho deciso di non raccontare.
Mai come in questo caso diventa palese l’avvenuta sovrapposizione della voce di Iannelli, mediatore autoctono, a quella di Farias, testimone immigrata. Sotto finale, insomma, l’implicita doppiezza della prima persona nella quale la vicenda è narrata resta allo scoperto, essendo quella di Iannelli l’unica cui ragionevolmente attribuire le ultime parole del libro: “ho deciso di non raccontare”. E, come detto, omettere è, almeno quanto raccontare, specifico compito dell’autore. Se un lettore d’eccezione come Fabrizio De André attribuiva integralmente la paternità di Princesa – che la coautrice brasiliana apertamente definisce nel documentario di Stefano Consiglio: “questo mio libro”- al coautore italiano: “ho tratto [Prinçesa] da uno splendido, breve romanzo [di Iannelli] in effetti una biografia”, allo stesso modo Cesare Segre sottolineava il carattere uno e bino dell’autore del Milione, senza che questo interferisse, peraltro, con il dato acquisito del valore artistico dell’opera. [40]
Quanto il laboratorio di Princesa sia risultato decisivo per certi sviluppi della docufiction in Italia, ovvero per la variante televisiva del “ritorno alla realtà”, è dimostrato poi dalla più recente stagione professionale del coautore di Princesa. Dopo aver ideato, diretto e prodotto le docu-story Residence Bastoggi (2003), Liberanti (2006) e Reparto trans (2008) – ancora gravitanti, queste ultime, intorno all’universo carcerario di Rebibbia – Iannelli è oggi autore di un fortunato format televisivo (ideato insieme a Matilde D’Errico e Luciano Palmerino). La serie RAI Amore criminale (in onda dal 2007), che ha contribuito a portare all’attenzione dell’opinione pubblica la drammatica realtà del “femminicidio”, ripropone, per diretta ammissione del regista, [41] il medesimo metodo di lavoro inaugurato all’epoca della stesura di Princesa: costruire la narrazione attraverso l’uso integrato e la contaminazione tra materiali documentari e invenzione letteraria.
*
La forma comunicativa che sta all’origine di Princesa è la conversazione, sebbene nei modi necessitati e precari che il carcere tollera o consente dentro uno stringente disegno di “individualizzazione coercitiva”. Questa nuova edizione, annotata on line, del libro di Fernanda Farias de Albuquerque e Maurizio Iannelli restituisce innanzitutto l’opera ad un ambiente comunicativo fondato sull’ “oralità di ritorno” tipica dei media elettronici. [42]
La nuova struttura dialettica dell’ipertesto finirà per spingerci come sottolinea Derrida, a “rileggere gli scritti del passato secondo una differente organizzazione dello spazio”. Non soltanto è oggi possibile trasferire in una forma compatibile con il computer testi scritti originariamente a mano o a stampa, ma anche dare loro strutture ipertestuali. In qualche caso questa operazione di traduzione restituirebbe loro l’antico tono di conversazione. [43]
Proporre oggi l’edizione critica di un “piccolo classico” della scritture migranti, per ratificarne e insieme promuovere l’inte(g)razione col canone letterario nazionale, comporta perciò l’immediata apertura ad un orizzonte digitale, capace di contenere e restituire la dimensione intertestuale e transmediale. Solo in questo modo è possibile radunare come “braci di un’unica stella” [44] gli elementi della costellazione audio- video-testuale di nome Princesa. Se il potenziale di un libro “così poco letterario”, come il Milione di Marco Polo si misura, infatti, secondo Cesare Segre, sulla varietà di letture e riscritture che ne hanno fatto la fortuna (almeno fino alle Città invisibili di Italo Calvino) [45], nel mutato contesto culturale [46], la fortuna della “così poco letteraria” Princesa consiste nell’attitudine a migrare, non soltanto tra testi, ma tra media diversi. La fortuna, appunto, di migrare.
[1] In Perché leggere i classici (1991), Italo Calvino offre la seguente come sesta definizione del genere: “Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire”.
[2] Cfr. Leggere il testo e il mondo. Vent’anni di scritture della migrazione in Italia, a cura di F. Pezzarossa, I. Rossini, Bologna, CLUEB, 2011.
[3] Anche grazie alla riscrittura in forma di canzone – Prinçesa – realizzata da Fabrizio De André e Ivano Fossati nel 1996.
[4] Cfr. Ritorno alla realtà? Narrativa e cinema alla fine del postmoderno, a cura di R. Donnarumma, G. Policastro, G. Taviani, in «Allegoria», 57, gennaio-giugno 2008. Del tema si continua a discutere, in Italia e all’estero: cfr. Les nouveaux réalismes dans la culture italienne, Colloque international, 12-14 juin 2014, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3.
[5] La dichiarazione è stata riportata in: A. Ginori, Il testamento maledetto. Un intrigo internazionale per il manoscritto di De Sade, “la Repubblica”, 1.6.2013, p.39.
[6] M. Foucault, Scritti letterari, a cura di C. Milanese, Milano, Feltrinelli, 1971, pp. 4-5.
[7] Iannelli ha visto premiato il proprio lavoro di documentarista al Torino Film Festival (Un bel ferragosto, 2001) e al Roma Fiction Fest del 2008 per Città criminali. Ha girato nel carcere di Rebibbia la docu-soap Reparto Trans (Sky, 2008) ed è attualmente autore e regista della trasmissione RAI Amore criminale.
[8] Scriveva Cesare Lombroso nella nota “Al lettore” premessa ai Palimsesti: “Il volgo […] crede che il carcere sia muto ma [ …] quest’organismo parla […] sulle mura del carcere, sugli orci da bere, sui legni del letto, sui margini dei libri che loro si danno nell’idea di moralizzarli, sulla carta che ravvolge i medicamenti, perfino sulle molli sabbie delle gallerie aperte al passeggio, perfino sui vestiti, in cui imprimono i loro pensieri col ricamo” (C. Lombroso, Palimsesti del carcere, Torino, Fratelli Bocca, 1888. La citazione nel testo deriva dalla pagina 38 dell’edizione curata da G. Zaccaria per l’editore fiorentino Ponte alle grazie nel 1996).
[9] J. M. Lotman, La semiosfera. L’asimmetria e il dialogo nelle strutture pensanti, a cura di S. Salvestroni, Venezia, Marsilio 1985, p. 181.
[10] Brevi stralci del materiale sono stati pubblicati sulla rivista “Caffè. Per una letteratura multiculturale”, nel 1994. Il dattiloscritto intitolato Princesa. Sono venuta di molto lontano, copia iniziale di lavoro sulla quale Iannelli ha elaborato la forma testuale definitiva di Princesa, è stato pubblicato per la prima volta in allegato alla tesi dottorale: A. Proto Pisani, Dans une autre langue. Écrire l’altérité : femmes, migrations et littérature en Italie (1994 – 2010), Doctorat d’Aix-Marseille Université, 2013.
[11] J. M. Lotman, La struttura del testo poetico, a cura di E. Bazzarelli, Milano, Mursia, 1972, p. 336.
[12] Dopo essere stato pubblicato o per i tipi di Sensibili alle foglie nel 1994, e concesso in licenza prima a CDE Milano, nel 1995 e, due anni dopo, all’editore Tropea (col richiamo in copertina: “da questo libro Fabrizio de André ha tratto ispirazione per Princesa”ed il sottotitolo Dal Nordeste a Rebibbia: storia di una vita ai margini), il libro viene periodicamente stampato on demand, in tirature limitate, dalla casa che ne detiene i diritti.
[13] Così Sioban Dowd nell’introduzione a Scrittori dal carcere, Milano, Feltrinelli, 1998, p.261.
[14] Così Iannelli nelle citate Brevi note di contesto premesse all’edizione di Princesa: “Come tre funamboli ci inseguimmo incerti lungo il filo di una spirale epistolare che ci portò oltre le mura, oltre il carcere. Così Princesa è nata. Da un incontro irregolare, da tre storie, tre persone che approdano al carcere lungo itinerari diversi: la lotta armata delle Brigate rosse il mio, la prostituzione transessuale quello di Fernanda, la vita pastorale e la rapina quello di Giovanni”.
[15] M. Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino Einaudi 1976, p. 261.
[16] S. Dowd, Introduzione, Scrittori dal carcere, cit., p. 21.
[17] M. Foucault, Dalle torture alle celle, Cosenza, Lerici, 1979, p. 122.
[18] Cfr. J. Butler, Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell’identità, Roma-Bari, Laterza, 2013 [1990].
[19] E. Fassin, Le vrai genre, in Herculine Barbin dite Alexina B., Paris, Gallimard, 1978, p. 237.
[20] Sandro Mezzadra nel suo La condizione postcoloniale (Verona, Ombre Corte, 2008), rintraccia l’eredità del colonialismo nelle politiche europee di controllo delle migrazioni. A proposito di colonialismo, ecco quanto afferma Fernanda (foglio 25 dell’ Intervista sul Carnevale rilasciata a Iannelli e disponibile nell’Archivio del sito): “nella colonissasione del Brasile come lo sai che la popolasione brasiliana era indios e ogni rasa aveva un nome come qui in Italia c’è i napoletani sardi sisiliani”.
[21] La figura di una donna, “Caffè. Per una letteratura multiculturale”, 1, settembre 1994, p. 4 (miei i corsivi).
[22] L’estratto è citato in esergo a G.Bianconi, Mi dichiaro prigioniero politico, Torino, Einaudi, 2003.
[23] L. Sciascia, Incontro con Lotta continua (1978), “Lo Straniero”, 173, novembre 2014, p. 8.
[24] M. Moretti, Brigate rosse. Una storia italiana, Milano, Anabasi, 1994, p.141.
[25] L. Sciascia, Incontro con Lotta continua (1978), “Lo Straniero”, cit., p. 13. Per onore del vero – e in omaggio alla teoria degli opposti estremismi – Sciascia diagnosticava la stessa incompatibilità romanzesco-proustiana alla casta degli aristocratici ancien-régime: “Perché non ho mai letto un romanzo. Il romanzo è una sconvenienza, una volgarità […] non ricordo Marcel Proust. Anche in certi luoghi alti, che lei ancora non conosce, e dove mi aspettavo di dover rispondere dell’amore e dell’odio, la prima e sola domanda che mi hanno fatto è stata questa: ‘si ricorda di Marcel Proust?’. No, non mi ricordo: sono un’anima persa” (il brano è tratto dall’ Intervista a Maria Sofia ultima regina di Napoli, testo elaborato da Leonardo Sciascia per la serie radiofonica delle Interviste impossibili).
[26] M. Puig, Il bacio della donna ragno, Torino, Einaudi, 1978, p.87.
[27] Si parafrasa qui quanto è scritto nelle Brevi note di contesto premesse al racconto: “Per comunicare con Fernanda partecipai e contribuii al farsi della nuova lingua. Alla variazione, scritta e orale, che risultò dalla chimica delle nostre lingue materne. Il portoghese, l’italiano e il sardo”.
[28] La relazione epistolare con Guimarães Rosa ebbe inizio nel 1959 e durò per otto anni. Nel 1981 le lettere furono pubblicate con il titolo João Guimarães Rosa: correspondência com o tradutor italiano Edoardo Bizzarri.
[29] Il passo si legge nella traduzione di Vincenzo Barca e deriva dall’articolo “Che Dio protegga il traduttore” di Davi Pessoa, ora in http://strademagazine.it/2013/01/20/che-dio-protegga-il-traduttore/
[30] Si riporta qui la definizione offerta da Bizzarri nel citato Glossario annesso alla sua traduzione del Grande Sertão: “Fuorilegge in un contesto socioeconomico che non permetteva il funzionamento effettivo della legge […] il jagunço presenta, quale figura umana, un’assai ricca gamma di situazioni umane, dall’idealista difensore degli oppressi al mero bandito di strada”.
[31] “Poi sono andato a leggermi subito, d’un fiato, il Grande Sertão” dichiarava Iannelli a pagina 5 del citato fascicolo del “Caffè”.
[32] Foglio 13 della citata Intervista sul Carnevale.
[33] G. Benvenuti, R. Ceserani, La letteratura nell’età globale, Bologna, il Mulino, 2012, p 160.
[34] La citazione, tratta da João Guimarães Rosa: correspondência com o tradutor italiano Edoardo Bizzarri , è riportata da Davi Pessoa nel citato articolo: “Che Dio protegga il traduttore”.
[35] Nel fascicolo intitolato al “Ritorno alla realtà”, numero 57 del gennaio- giugno 2008
[36] Realitysmo è un’altra definizione proposta, per gli esemplari narrativi coinvolti nel “ritorno alla realtà” negli anni zero del 2000 ed è presente, ad esempio, nel Manifesto del nuovo realismo di Maurizio Ferraris del 2012.
[37] M. Fortunato, S. Methnani, Immigrato, Milano, Theoria, 2006 [1990], p. 6
[38] La figura di una donna, in “Caffè. Per una letteratura multiculturale”, cit., p 5.
[39] Trascrivo dall’intervista rilasciata nell’incontro organizzato presso “Il Cassero”, LGBT Center di Bologna, l’undici novembre del 2008 (disponibile in rete all’indirizzo:. http://www.puta.it/blog/2008/11/11/queer/reparto-trans-al-cassero)
[40] Sulla questione si veda: C. Segre, “Introduzione”, M. Polo, Milione. Divisament dou monde, Milano, Mondadori, 1982, pp. XII-XIII; V. Bertolucci Pizzorusso, “Introduzione”, M. Polo, Milione, Milano Adelphi, pp. IX-XXI
[41] Ancora dall’intervista bolognese per il Cassero del 2008: “sul piano del montaggio le docu-storie hanno una struttura narrativa che vuole applicare al documentario le scansioni narrative della fiction”.
[42] Più di trenta anni fa, Walter J. Ong prefigurava la comunicazione culturale del futuro all’insegna di una oralità di ritorno : “Solo ora, nell’era dell’elettronica, ci rendiamo conto delle differenze esistenti fra oralità e scrittura; sono stati infatti le diversità fra i mezzi elettronici e la stampa che ci hanno reso consapevoli di quelle precedenti tra scrittura e comunicazione orale. L’era elettronica è anche un’era di oralità di ritorno, quella del telefono, della radio, della televisione, la cui esistenza dipende dalla scrittura e dalla stampa”: W. J. Ong, Oralità e scrittura, Bologna, il Mulino, 1986 [1982], p 21.
[43] J. D. Bolter, Lo spazio dello scrivere. Computer, ipertesti e storia della scrittura, Milano, Vita e pensiero, 1993, p. 150.
[44] Si cita qui il verso della canzone Prinçesa.
[45] Né è mancata, tra le forme di riscrittura, la canzone: è del 1984 Marco Polo, il concept album del cantautore romano Flavio Giurato.
[46] “Con il concetto di rimediazione (remediation) da un decennio ci si riferisce alla necessaria interpenetrazione dei media in un contesto storico dove la digitalizzazione ha imposto la sostanziale convergenza di tutti i mezzi di trasmissione, di tutti i format comunicativi e dei codici semiotici entro un sistema interconnesso, interattivo e integrato, al punto che il contenuto dei media digitali sono tutti gli altri media” (S. Calabrese, Il romanzo della Globalizzazione, Enciclopedia Treccani on line, http://www.treccani.it/enciclopedia/il-romanzo-della-globalizzazione_%28XXI-Secolo%29/




 di Francesca Fiorletta
di Francesca Fiorletta 



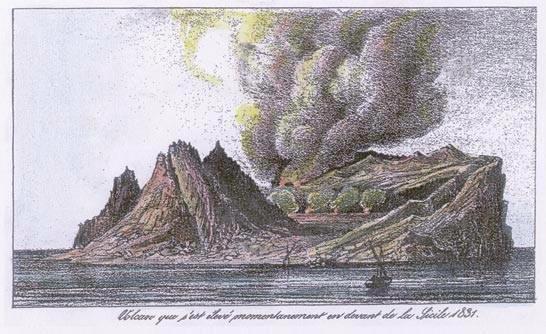
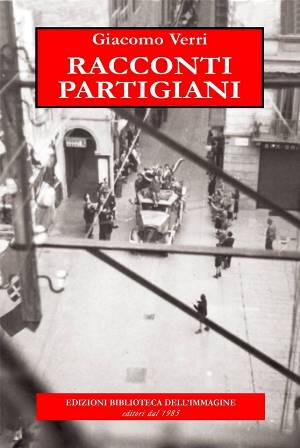
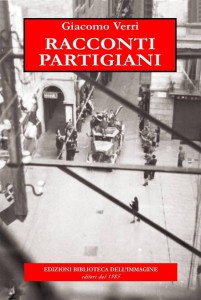







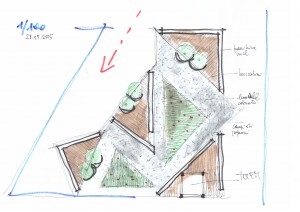


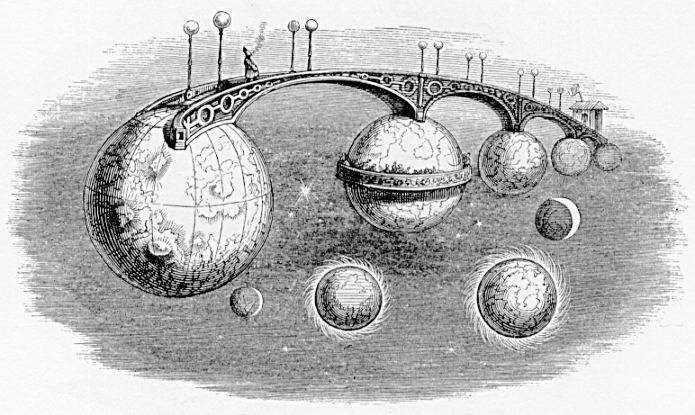


 di Francesca Fiorletta
di Francesca Fiorletta 


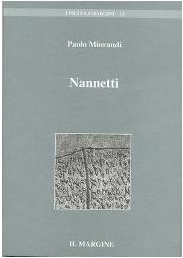 Estratti da Nannetti, Paolo Miorandi, il Margine 2012
Estratti da Nannetti, Paolo Miorandi, il Margine 2012