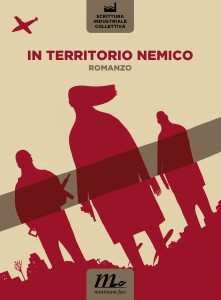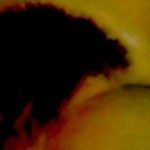In territorio nemico, a Milano. (Con un estratto dal romanzo).
Libreria Popolare,
via Tadino 18, Milano
Conversazioni in libreria
Martedì 23 aprile, ore 21
In territorio nemico
di SIC (Scrittura Industriale Collettiva)
Minimum Fax, 2013.
Ne discutiamo con Jacopo Galimberti (uno dei 115 autori),
Alessandro Broggi, Paolo Giovannetti, Italo Testa, Paolo Zublena.
E con Gregorio Magini e Vanni Santoni, i due fondatori di SIC.
Coordina Antonio Loreto
SIC – Scrittura Industriale Collettiva indica un metodo di scrittura collettiva ideato da
Gregorio Magini e Vanni Santoni, la comunità aperta che lo utilizza e il gruppo di 115 scrittori, coordinato dai due fondatori, che ha realizzato il romanzo In territorio nemico.
Ne abbiamo parlato recentemente su Nazione Indiana qui e qui.
[Un estratto dal libro]
[…] «I Comandi tedeschi», disse Maiolica,
Frattanto…
di Daniele Ventre
Quando il trattato di Parigi del 1951 e i due trattati di Roma del 1957 ebbero poste le basi delle comunità europee, le classi politiche delle nazioni uscite dall’ultima guerra definirono un preciso piano di integrazione, che avrebbe dovuto condurre col tempo, attraverso il passaggio necessario di uno Zollverein continentale, al costituirsi in Europa occidentale di un organismo politico sovranazionale federativo, che bandisse per sempre dal continente il pericolo di conflitti sanguinosi e il ritorno di bioregimi totalitari di stampo nazi-fascista. Con il trattato di Maastricht e la creazione dello spazio Schengen fra il 1992 e il 1995, la nascita dell’Unione Europea sembrava aver dato inizio a una nuova fase, di cui l’approdo ultimo al costituirsi degli Stati Uniti d’Europa, tutela del benessere e dei diritti di tutti i cittadini europei, sembrava l’esito naturale. Nel 2013, a cinque anni dall’esplosione della crisi globale, e a sei dall’ingannevole trionfalismo del cinquantenario dei trattati di Roma, lo scenario socio-economico dell’Unione è alquanto diverso da quel che ci si attendeva.
L’Europa delle vestali dell’austerità appare troppo compiaciuta del suo misticismo finanziario cieco e sordo, per prestare ascolto ai moniti del FMI in tema di eccesso di rigorismo (né certo si può accusare il FMI di perverse inclinazioni neo-bolsceviche). Mentre l’Inghilterra, chiusa nel suo tiepido isolamento, celebra fra battute giustamente maligne, omaggi ipocriti postumi e revivals dei Pink Floyd la memoria di Maggie Thatcher the milk-snatcher (evocata peraltro come modello da qualche improvvido idiot-savant del giornalismo d’opinione e del saggio socio-politologico), l’Europa della BCE e dei debiti sovrani, l’Europa dei Draghi e dei Van Rompuy, appare di fatto sempre più lacerata sul piano politico, ed economicamente sempre più esposta all’alea delle trame speculative, dove che sia il loro punto di origine nel moto browniano della finanza transnazionale. La Germania, in cui non è tutt’oro quel che luce, vista la passività media di 4600 euro annui delle famiglie più povere, la locomotiva Germania che ha per lungo tempo scaricato sull’Europa orientale e sull’area mediterranea i residui semicombusti delle passività potenziali della sua economia, guarda ora con freddo disprezzo (e ansia crescente) al deragliamento progressivo, e forse irrecuperabile, dei PIIGS, denominazione quanto mai omologante, e perciò erronea, della periferia dell’euro-impero. I sacerdoti del rigorismo finanziario teutonico, sordi alle sinistre insinuazioni di un Soros in tema di eurobond e di eventuale uscita della Germania dall’euro, premono per l’attuazione, dal centro, di provvedimenti estremi, fra prestiti forzosi e congelamenti dei prelievi agli sportelli. Di quale decisionismo dia prova l’Unione in fatto di materia bancaria, ci si è accorti nel caso della crisi delle banche cipriote, quando i tecnocrati contigui alle politiche di egemonia finanziaria della Germania sono stati fin troppo inclini a puntare il dito contro gli interessi finanziari russi, dimenticando che l’altra metà della putrefatta torta di Cipro era appannaggio quasi esclusivo della speculazione finanziaria tedesca. E nel frattempo iniziative di relativa autonomia e di recupero parziale di sovranità bancaria, quali quelle attuate, nemmeno tanto di soppiatto, dal governo irlandese, nell’ambito dello spazio di manovra ancora concesso, hanno lasciato interdetto il centro egemonico dell’Eurozona, costituendo un pericoloso precedente, e un fattore di collasso, di cui non a caso non si parla poi molto.
Nudo di uomo
Al Ludwig Museum, Museo di arte contemporanea di Budapest, da qualche settimana e fino al 30 giugno c’è una mostra temporanea intitolata The Naked Man. Ci sono capitata per caso, visitavo questo museo che non conoscevo, ho visto il titolo e l’affiche, ho esitato temendo una mostra accalappia turisti voyeurs, una versione al maschile di nudi artistici femminili, ho finito per entrare e ho fatto bene davvero. La mostra ripercorrere l’evoluzione della rappresentazione del corpo nudo maschile, a cominciare dalla Vienna di inizio Novecento e fino ai nostri giorni, dando ampio spazio ad artisti d’Europa centrale, ma non solo. Già esposta al museo di Linz, la mostra ha tre curatrici austriache, cui si sono aggiunte due curatrici ungheresi per la ripresa a Budapest. Chi capisce il tedesco, può andarsi a vedere e ascoltare la presentazione sul sito del museo Lentos di Linz http://www.lentos.at/html/en/2267.aspx, mentre sul sito del Ludwig Museum c’è un breve testo di presentazione in ungherese e inglese e ci sono diverse immagini http://www.ludwigmuseum.hu/site.php?inc=kiallitas&menuId=43&kiallitasId=848
Sulla rappresentazione del corpo femminile, nudo e seminudo, sul canone estetico e sui modelli imposti, sull’oggettivizzazione, lo sfruttamento e l’avvilimento, è stato detto e c’è senz’altro ancora da dire (e tra quello che c’è da dire, andrebbe proseguita l’opera di denuncia come quella dell’agghiacciante documentario “Il corpo delle donne”, il quale tra l’altro mostra come anche le donne abbiano introiettato lo sguardo maschile sul loro corpo).
E sulla rappresentazione del corpo maschile? Mentre guardavo quadri, sculture, fotografie, video della mostra The Naked Men, mi sono resa conto di non aver mai pensato al corpo nudo dell’uomo come a un soggetto di riflessione. Eppure, le problematiche sono molteplici, come evidenziato nei bei testi di presentazione delle varie sezioni (purtroppo non ripresi nel catalogo né sui siti). Il corpo nudo maschile è emblematico di diversi momenti di crisi che possiamo sintetizzare in antieroismo e anticlassicismo, nella messa in discussione del ruolo maschile tradizionale e ricerca di alternative. Molta attenzione è portata allo sguardo: dell’artista maschio su di sé o sull’altro, dell’artista femmina sul corpo nudo maschile; lo sguardo erotico o lo sguardo razziale; altrettanta attenzione al significato politico e ai rapporti di potere legati al corpo maschile, in particolare nei paesi dell’est prima della fine dei regimi comunisti. Insomma una ricchezza tematica stimolante, ma anche dei begli oggetti esposti, di artisti noti (Egon Schiele, Robert Mapplethorpe, Oskar Kokoschka, Louise Bourgeois, Eduard Munch, Andy Warhol, Gilbert & George, David LaChapelle, Marlene Dumas) e meno noti, quantomeno a me, forse perché come ho detto molti sono di paesi d’Europa centrale.
Sogno di una notte di mezza primavera
di Antonio Sparzani
(Notte, stanza con due brandine nella sede del Partito, sotto i cuscini niente Kalashnikov ma cellulari silenziati, le tre del mattino)
Pierluigi: Ehi, Enrico!
Enrico (che dorme, come quasi sempre): Eheee?
P.: Ma che fai, mica vorrai dormire?
E.: Ma senti, capo, almeno Palmiro ai tempi suoi dormiva con la Nilde e semmai svegliava lei, ma tu adesso cosa vuoi?
P.: Ho sognato il giaguaro
Proviamo a ballare insieme quest’ultimo valzer
di Helena Janeczek
Tanto volle sopravvivere che poi morì. Tanto vollero sopravvivere che poi morirono.
Lo dico con rabbia perché la cosa che più mi sento stamane è incazzata. Mi pare bene, però, potenzialmente. Mi pare bene che si sia rotta la coltre del Non-Ci-Sono-Alternative, di rassegnazione al meno peggio. Ieri sono successe due cose, in rapida e ineluttabile sequenza.
Walter Siti e l’impossibile
Ci sono scrittori che prediligono titoli piani, anonimi, che passino sotto silenzio, che magari colpiscano proprio in virtù della loro genericità: Ammaniti con Io e te, ad esempio, uscito lo stesso anno del Leielui di De Carlo; ce ne sono altri che invece provano a toccare il lettore che vaga per gli scaffali della libreria con una sola ma incisiva parola: la Violazione di Sarchi o lo Spaesamento di Vasta; ci sono autori, poi, che con un titolo aprono interrogativi a cui talvolta neanche la lettura riesce completamente a rispondere: è il caso di Woobinda di Aldo Nove o, oltreconfine, del 2666 di Bolaño. Poi ci sono gli scrittori che quando devono scegliere il titolo della loro ultima fatica decidono di far squillare le trombe della propria fanfara: Walter Siti, almeno da qualche anno a questa parte, è uno di questi. Tralasciando Autopsia dell’ossessione (2010), che al lettore esperto suonava già familiare, con quel suo esplicito richiamo alla funerea e patologica mania che abita il personaggio protagonista dei suoi principali romanzi, lo scrittore modenese, esegeta e in qualche modo emulo del Pasolini narratore, ci regala, a stretto giro di posta, Resistere non serve a niente (Rizzoli 2012) e Il realismo è l’impossibile (nottetempo 2013): un romanzo e un saggio (“libretto” lo chiama Siti) che a un tempo segnano una cesura nella produzione dello scrittore e provano a gettare uno sguardo retrospettivo su tutta la sua opera. Niente di male, fin qui. Se non fosse che, allo scandalismo provocatorio e moralistico dei due titoli, non sembra corrispondere un altrettanto illuminante contenuto.
Considerato da molti il romanziere italiano più importante degli ultimi quindici anni, Walter Siti sembra aver già dato il meglio di sé, e soprattutto, sembra essersene accorto da solo. Dopo aver stupito tutti con la creazione del più emblematico e riuscito protagonista autofinzionale che la letteratura italiana possa vantare, l’autore si trova in un’impasse. Quel «Walter Siti come tutti» di Troppi paradisi (2006) – già abbozzato in Scuola di nudo (1994) e poi sostanzialmente riproposto nel Contagio (2008) e nell’Autopsia –, cinico profeta della fine di qualsiasi engagement per un intellettuale chiamato piuttosto a dar sfogo alle proprie pulsioni più depravate e ipocrite, e allo stesso tempo sonda esplorativa di un universo borgataro di esplicita impronta pasoliniana, aggiornato alla società liquida (personaggi privi di rotondità psicologica) e televisiva (il mondo della TV come sogno degradato per un riscatto facile quanto deperibile, ma anche come modello di comportamento e specchio di una nuova direzione dell’evoluzione sociale), quel “Walter Siti”, si diceva, sembra aver esaurito la propria missione di perlustrazione. Lo scavo, della psiche dell’io (unico soggetto su cui egoticamente valga la pena concentrare lo sguardo) e della società popolare (ridotta a funzione delle nichilistiche e masochistiche perversioni dell’io), è stato compiuto. Servono nuovi orizzonti: ecco allora giungere in soccorso dell’autore l’ancora inesplorato mondo delle collusioni tra camorra e alta finanza, pur sempre incistato nella realtà popolare di Roma e delle sue periferie. È il panorama che offre Resistere non serve a niente. Ora gli orizzonti necessariamente si aprono: a fianco della capitale compaiono altri set, internazionali ed esotici, dalle vacanze ai Caraibi su aerei privati ai viaggi in trimarano al largo delle Canarie, fino alla più “classica” delle seconde case a Cortina. I “Tommaso” e le “Stella” (nomi tipicamente pasoliniani, riconosce lo stesso Siti) non sono più chiamati a battersi in una disperata lotta per la sopravvivenza, ma diventano protagonisti di un’altra spietata competizione; quella di un mondo, tra capitalismo finanziario, jet set e criminalità organizzata, che porta al massimo grado posta in gioco e violenza d’azione, anche se sembra conservare intatte certe logiche proprie anche dell’universo borgataro (le clientele, la mercificazione del corpo, il cinismo disincantato di fronte alla vita).
Cambiando il mondo rappresentato, però, cambia inevitabilmente anche la posizione dell’io, costretto in Resistere non serve a niente a declinare diversamente il suo egotico desiderio di “fare centro” per raccontare la storia di Tommaso Aricò, «un sellerone mal cresciuto, un formichiere allevato in una tana di furetti; la mascella rettangolare e le labbra sottili, tutto quello che odio di un uomo» (p. 26). Avere accesso a tutti i segreti dell’esistenza di un broker miliardario, affermatosi attraverso “delitti” efferati e pegni impronunciabili, consente però a “Walter Siti” di recuperare per via indiretta il suo ruolo preferito, ovvero trovare le parole per dire ciò che nessuno si confesserebbe mai, e che in questo caso trova una doppia conferma: non solo dall’esperienza moralmente inaccettabile del protagonista, ma anche dalla defezione etica con cui il suo biografo decide di aderirvi integralmente. La legge della verosimiglianza, «verde praticello in declivio dove non si rischiano né querele né accuse di esibizionismo» (165), impone di lasciare a qualcun altro l’onere di fare esperienza diretta del mondo oscuro delle bolle speculative e del surfing finanziario; tuttavia, facendosi specchio deforme della storia altrui, “Walter Siti” riesce ancora una volta a mettersi nella posizione di chi fa scandalo: «credo di dire cose intelligenti solo perché le sparo grosse… sento fraterno chi si mette fuori dall’umano, come se fuori dall’umano ci fosse qualcosa…» (170). A colpire chi legge, allora, non saranno più le scene di sesso libertino e orgiastico, né l’esistenza di quest’individuo al di là di qualsiasi norma etica o sociale: il colpo più duro lo infligge ancora una volta l’autore, o meglio, il suo doppio narrativo, quando rinuncia a farsi filtro imparziale per prendere e dichiarare la propria posizione. Una posizione che non può che essere quella sbagliata, unica possibile per chi ha perso ogni speranza nell’uomo e non attende altro che il suo definitivo esaurimento. Non è “Walter Siti” a confessare il rapporto sessuale avuto con la figlia minorenne di un “socio” in difficoltà economiche, tuttavia è “Walter Siti” a dichiarare la struggente tenerezza procuratagli dal vedere un uomo distrutto dal piacere provato per un atto tanto meschino.
Così, confermando il paradigma dell’intellettuale decaduto e nichilista (in questo romanzo acuito anche dalla precarietà abitativa del protagonista, che accetta l’ingaggio di Aricò per potersi garantire una casa), lo scrittore propone ancora una volta l’immagine di un personaggio che ha deciso di contravvenire tutte le “convenzioni” del consorzio civile, che si denigra per ogni compiaciuta infrazione, ma che non riesce mai a spostare questa infrazione dal piano del discorso a quello dell’esperienza. “Walter Siti” osserva sempre da fuori, accontentandosi di «un’esperienza mediata da una protesi» (Giglioli, Senza trauma, p. 80): «….forse sei il mio stuntman, quello che esegue per me le scene pericolose…un prototipo della mutazione…o forse, più in profondità, sei il mio vendicatore» (314).
A questo punto, però, bisogna ritornare allo spunto da cui sarebbe voluto partire questo intervento, ovvero il breve saggio Il realismo è l’impossibile, con cui Siti decide di mettere sul tavolo le proprie carte di scrittore. Il lettore meno esperto, che si avvicina con curiosità ingenua ma ricettiva a questo “opuscolo” (80 pagine in formato 10×15), si fa coinvolgere dalla grande enciclopedia che Siti dispiega per esemplificare i passaggi principali dell’annosa questione del realismo (e, detto per inciso, non saremo mai abbastanza grati a chi riesce a rendere chiari e comprensibili concetti di non immediata evidenza, come il barthesiano «effet du réel» o l’astrattissima “semiosi illimitata”). E allora ecco brillanti aneddoti provenienti da differenti latitudini della nostra letteratura, come di quelle straniere, e soprattutto dai più disparati campi di quelle che vengono orrendamente definite “scienze umane”: dalla pittura al cinema, dalle arti performative fino alla storia delle religioni. Siti convoca tutto quanto può contribuire a inserire il discorso sul realismo entro un quadro che comprenda l’intera civiltà occidentale, con tutto il peso della sua tradizione (dove Stanislavskij e Warhol possono stare vicini a Dante e Dostoevskij).
Al lettore più attento, invece, che conosce l’opera del romanziere (e chissà, magari anche del giovane accademico che a 26 anni scriveva Il realismo dell’avanguardia, uscito per Einaudi nel 1973), una volta superata la prima piacevole quanto piatta parte metodologica, viene spontaneo misurare le dichiarazioni più oggettive dell’autore sui modelli rappresentativi del romanzo con la sua ultima e discussissima fatica. E non si tratterebbe certo di un’operazione capziosa. Innanzitutto perché in chiusa di Resistere non serve a niente (312), quando “Walter Siti” e Tommaso Aricò fanno i conti – un po’ didascalici in effetti – sul rapporto che li ha legati durante il periodo della stesura del romanzo, il narratore cita quell’Origine del mondo, tela di Gustave Courbet, che campeggia nelle prime pagine del saggio come modello della sfida all’informe finitezza del mondo a cui si vota il realismo (quadro che avrebbe fatto dire a Picasso: «Le réalisme, c’est l’impossible»). Ma in secondo luogo, perché a chiederci di leggere questi due testi uno di fianco all’altro (e con un occhio anche agli altri romanzi) è lo stesso Siti: «tanto è chiaro che il pudore è andato a farsi benedire e che questo non è un saggio sul realismo ma una bieca ammissione di poetica» (48).
Infatti, una volta conclusa la ricognizione sugli attributi “classici” del realismo (il rapporto conflittuale con il verosimile, la necessaria complicità con verità e menzogna), l’autore decide di esporre la sua specifica posizione al giudizio del proprio lettore. È una strategia ormai nota, quella di Siti, messa alla prova, come si è visto, in tutti suoi romanzi autofinzionali, dove l’io protagonista non teme di scadere nel patetico (che al contrario sembra una corda molto consona a Siti) per chiedere venia al lettore dei propri orribili e bellissimi peccati. Qui non si ha più a che fare con giovani aitanti che si mantengono ricattando i propri protettori, né con l’irresistibile attrazione suscitata da chi si mostra potente e dannato. Qui la posta in gioco è più sottile e astratta, ma forse più importante (almeno per giudicare uno scrittore): si tratta infatti di giustificare le proprie scelte estetiche, le opzioni tecniche e stilistiche dei propri romanzi.
Anche in questa circostanza l’autore non può fare a meno di mettere in campo il proprio armamentario di ammissioni, scusanti e sensi di colpa, inscenando il consueto autodafé. Tuttavia, se è legittimo, e anzi naturale, concedere allo scrittore di fondare la propria formula rappresentativa (il «realismo gnostico») su una personale percezione della realtà («Per stare in equilibrio tra cronaca e lirica, tra amore per la realtà e rancore per quel che la realtà non ha saputo essere per me (o io per lei) […] il metodo che mi sono abituato a usare è l’assorbimento dei miti», 61), meno corretto è che egli ricorra alla sua esperienza emotiva anche per dare conto e giustificare pregi e difetti dei risultati raggiunti in virtù di quella scelta estetica. In questo senso, l’autofiction come tecnica rappresentativa privilegiata di fronte al reale diventa l’esito di una scelta funzionale al confronto tra lo scrittore e i suoi demoni interiori, ovvero una questione “privata”, se è vero, come ci dice Siti, che a determinarla è stata la «paura di morire muto, paura che se parlavo [sic!] sinceramente tutti mi avrebbero abbandonato, paura di sostenere le mie idee senza nascondermi dietro il piagnucolio» (76). Con questa pratica ricattatoria, Siti si mette al riparo da qualsiasi eventuale critica: nulla è più personale e conta di più del rapporto tra uno scrittore e la sua coscienza, non è possibile sindacare su una scelta radicata così a fondo nell’esperienza emotiva dell’uomo. Solo che, in questo modo, il lettore e il critico sono messi fuori gioco, esautorati della loro funzione di interpreti: non possono far altro che constatare, al massimo condividere. Ma a livello empatico, nulla di più. E questo fatto diventa emblematico nel momento in cui Siti, non pago, decide di assecondare la sua vena autocommiserativa e autocompiaciuta (ormai diventata maniera) per mettersi spontaneamente sul banco degli imputati, riconoscendo i propri torti: «ricorro agli stereotipi quando non ho il coraggio di andare a vedere, anche sul piano della poetica il mio nemico è la paura. […] non sono contento di me quando tradisco il realismo per il bozzetto» (77-78).
Siti si costituisce e si consegna alle forze dell’ordine del Realismo: a noi, lettori e critici, non resta che prendere atto dell’ennesima messa in scena di un io che non può rinunciare a esibirsi e demolirsi, che non può fare a meno di imporsi con lo scandalo di un’esasperata autocoscienza. Con maliziosa consapevolezza Siti si mostra ancora una volta in cerca di un’assoluzione che la sua macchina retorica dovrebbe indurre automaticamente. Questa volta, però, è nostro dovere non concedergliela. Se anche possiamo accogliere la sua definizione “residuale” di realismo (per cui lo scrittore non è altro che «uno stolto demiurgo che cerca di mimare una Creazione che non conosce», 59), non possiamo accettare di farne un cavallo di troia che apra il campo a una scrittura sempre più rinunciataria, nelle intenzioni così come nei risultati. Siti ha rivelato il «ricatto dell’argomento» con cui ha cercato di tenere i lettori avvinti ai propri romanzi: ora questo non basta più. La sensazione è che queste pagine teoriche finiscano con il torcersi contro il loro autore, mostrando uno scrittore che, anche nel momento del colloquio più diretto e “sincero” con il proprio lettore, non rinuncia a mettersi in maschera, tanto da lasciarci con il dubbio che quelle che leggiamo siano ancora una volta le parole di un suo doppio finzionale, ennesima manifestazione di un io senza corpo, perso tra i riflessi di un incontrollabile gioco di specchi.
In questo tempo di poetiche incerte ed estetiche ambigue, non credo che alla letteratura italiana serva uno scrittore dallo statuto tanto debole da accettare di farsi teorico solo a patto di non infangarsi sul campo del pubblico agone (e si veda infatti come Siti schivi, e anzi sminuisca, le attuali discussioni sul «nuovo realismo», e al contrario si erga a giudice dei risultati, non dei progetti, dell’odierna narrativa italiana). È vero, Siti ha ragione, sporgersi è il verbo che dovrebbe compendiare ogni forma di realismo, e più in generale di scrittura. E ha ragione anche quando ci ricorda che questo sporgersi non è messo a rischio solo quando si ricorre agli stereotipi, ma anche, o soprattutto, quando si rinuncia a mettersi in gioco. Il problema sta nel capire fino a che punto il gioco che lui ha in mente ci riguarda tutti.
No, il dottor sottile no, per favore no
Tutto, ma non il pochissimo amato, vetero-craxiano e guerrafondaio Giuliano Amato. Ricordate e rileggete questo, per favore.
Pesce di lago per il pranzo della domenica

di Giovanni Dozzini
Una domenica mattina d’inverno di quarant’anni fa arrivò con la sua Seicento e si prese subito a male parole con mio cognato, che a quel tempo era uno dei camerieri del ristorante e ormai da un pezzo fa compagnia alle anime dei nostri vecchi al camposanto. Scese tronfio e grasso come un pachiderma, si tolse gli occhiali da sole e chiese urlando se qualcuno gli potesse preparare un tavolo per pranzare in fretta, anche se era solo mezzogiorno.
Il Manifesto di un libraio
Se io avessi previsto tutto questo
di
Claudio Moretti
vd intervista qui
Qualche giorno fa, poco dopo aver aperto la libreria, il postino entra e mi recapita due buste verdine. Multe. Sarà la sosta vietata di qualche mese prima. Apro senza timore. Prendo il bollettino e leggo la cifra. Iniziano a girarmi. Guardo meglio il foglio del verbale: non è un divieto di sosta, è una locandina abusiva. Mille euro. Una locandina. Di multa. Senza timbro. Mille. Attaccata sulla pietra. Con lo scotch. Milleesettevirgolazerosette.
Si fa tanto parlare di questi tempi del ruolo delle librerie del futuro, di come potranno restare a galla, di chi ce la farà. Sembra di stare in un film,quello degli immortali della serie “solo uno sopravviverà”. Ma tutti concordano che la libreria non potrà più essere quella a cui siamo abituati. Forse perchè se ci fossimo abituati, se si fosse creata un’abitudine alla libreria, significeherebbe che qualcuno ha l’abito o l’abitudine di andarci e magari comprarci qualcosa e forse non ci sarebbe nessun problema. Comunque si abitueranno alla libreria del futuro dove oltre al libro ci troverai il caffè, il libraio avrà fatto il corso di libreria 1, libreria 2 e complementi di libreria, e soprattutto la libreria sarà un punto di aggregazione delle persone perchè altrimenti che ci vanno a fare se il libro lo possono comprare dal divano di casa?
Tutte queste teorie hanno la loro validità, non sia mai che io osi dubitarne. Ma la mia libreria segue due filosofie: deve arrivare a fine mese tutti i mesi e deve piacermi, la libreria e lavorarci dentro. I libri li scelgo io, quelli che voglio. Mi permetto di ignorare delle novità. Non seguo le campagne promozionali. Adesso gli editori cercano di avere un rapporto diretto con i librai, hanno capito che è una grande opportunità per essere visibili. Bravi. Nella mia libreria, da quando vendo anche libri nuovi, il rapporto diretto con gli editori è stata la regola.
Da tre anni ho iniziato a fare presentazioni di libri, incontri con gli autori. Penso che una libreria possa farne a meno, la mia no. Lavoro in libreria ma i festival della letteratura ho proprio difficoltà a seguirli, vorrei andarci ma non trovo il tempo. Allora lo faccio in libreria: chiamo l’autore il cui libro mi è piaciuto. Lo sento parlare alla radio e mi piace, provo a vedere se viene in libreria da me. Ci deve essere qualcosa che scatta, un interesse per il libro, per l’autore che fa diventare l’incontro prima di tutto un incontro fra autore e libraio e, dopo, fra autore e lettori.
La locandina pubblicizzava una lettura ad alta voce fatta in libreria. L’autore leggeva brani da dei suoi libri vecchi, pubblicati anni fa. Una sorta di addio a quel genere di libri, il mese dopo sarebbe uscito un suo nuovo libro di tutt’altro genere. Un omaggio ad un autore che apprezzo e alla sua opera. Copie vendute: zero, non c’era nulla da vendere. Nella maggior parte dei casi, le vendite delle presentazioni non coprono le spese.
Sono un commerciante di libri o un operatore culturale? In questo dilemma si stanno arrovellando in molti. Quando scelgo un libro da mettere in vetrina posso farlo per motivi non commerciali ma voglio che sia venduto. Quando chiamo un autore non lo faccio per vendere i suoi libri a pacchi però so che ad ogni incontro in più la libreria accresce la sua credibilità. I due aspetti, commerciale e culturale, sono intrecciati e non si possono separare. Nè lo vorrei. Non vorrei una libreria sovvenzionata come non voglio una libreria supermercato.
Vorrei la mia libreria, non sovvenzionata ma almeno sostenuta, riconosciuta nella parte culturale che svolgo. Conosciuta e riconosciuta.
Invece fino ad oggi è mancata proprio la consapevolezza di quello che la libreria ha fatto e fa. Per capirlo c’è stato bisogno prima di una serie di chiusure annunciate di librerie veneziane che rende ancora più desertificato il panorama libraio in laguna e poi della protesta a causa di questa multa. Per un giorno le vetrine della libreria sono state oscurate: Venezia città delle librerie invisibili, come tante altre città di librerie che non sono conosciute e che non vengono apprezzate per il lavoro che fanno. Solo quando chiudono si sente la loro mancanza.
Adesso a Venezia sembra che le cose stiano cambiando, grazie anche all’impegno degli scrittori veneziani che hanno deciso di riunirsi e di avere una voce unica a difesa delle librerie.
Per ora, la multa resta. Ma oltre la multa, resta la certezza che adesso in molti si sono svegliati, quelli che sono venuti a protestare al nostro fianco, quelli che ci dicono di non mollare, quelli che adesso ci seguono con più fervore sapendo che è per loro e grazie a loro che una libreria esiste.
Da Costa a Costa
di Lorenzo Bracco e Dario Voltolini
Un medico psicoterapeuta e uno scrittore suo paziente si imbarcano spavaldi su una nave da crociera (viaggio in superofferta!),scrivono un diario comico e con quello si avviano verso il premio Strega. Le pagine sotto sono un estratto del libro pubblicato da Booksprint.
L una notte soffrendo d’insonnia si mise a navigare con l’iPad, cosa da non fare se non si è disposti a conoscere l’ignoto. L’iPad è uno strumento strano, incredibile, vuoi vedere una cosa e te ne esce un’altra, come nelle favole in cui, per intervento della bacchetta magica della fata, compare qualcosa dopo uno scintillio.
Tre poesie
di Gian Maria Annovi
Da Italics, Aragno/I domani, 2013.
LA GLORIOLA
La gloriola...
O povero fanciullo!
Giovanni Pascoli
la neonata dentro il cassetto
forse dimenticata nella credenza
o dietro la pila dei giornali di ieri
ha certamente fame
(morirà, probabilmente)
tu invece sopravvivi
al cadere dei tronchi di pino
nella legnaia
alla lezione su Dante
nel fienile:
la gloria della lingua
(pare)
non piange per farsi nutrire
ma se la gloria è gloria
(dunque)
sappia dire la gloria delle cose
ad esempio
il nome per dire
l’ossatura delle piante:
legnanza o legnagione o
legnosura oppure semplicemente
un segno inciso sulla corteccia del cervello
illeggibile se non ti spaccano la testa coi manganelli
sappia dire le cose nuove
ad esempio
il nome dei suoi nuovi cittadini
il nome del paese che ha confini
di corpi affogati e vulcani:
(questo paese ha un nome
impronunciabile)
lingua che cede e cade dalle gengive
che dica l’assoluto tremore
di questa donna: sulla barca che sbanda
di notte col neonato schiacciato
tra le cosce
che non respira
. . . per mantenersi quella reputazione che non avevono meritata . . .
Dopo gli ozi letterari (1516-17), Niccolò Machiavelli, quasi cinquantenne, riesce a ricucire i suoi rapporti con i Medici e viene incaricato di scrivere quelle che diventeranno le «Istorie fiorentine». La scrittura va dal 1520 al 1525 e Machiavelli presenta l’opera a Giulio de’ Medici nel frattempo diventato papa col nome di Clemente VII, nel 1526. Varie vicende ritardano la pubblicazione dell’opera, tra cui la morte di Machiavelli nel 1527, così che le Istorie vedranno la luce solo nel 1532, postume. Vi copio qui il capitolo I del libro V, che mi pare contenga vari spunti che ci fanno risuonare qualche campanello nella testa.
Sogliono le provincie, il più delle volte, nel variare che le fanno, dall’ordine venire al disordine, e di nuovo di poi dal disordine all’ordine trapassare; perché, non essendo dalla natura conceduto alle mondane cose il fermarsi, come le arrivano alla loro ultima perfezione, non avendo più da salire, conviene che scendino; e similmente, scese che le sono, e per li disordini ad ultima bassezza pervenute, di necessità, non potendo più scendere, conviene che salghino, e così sempre da il bene si scende al male, e da il male si sale al bene. Perché la virtù partorisce quiete la quiete ozio, l’ozio disordine, il disordine rovina, e similmente dalla rovina nasce l’ordine, dall’ordine virtù, da questa gloria e buona fortuna. Onde si è da i prudenti osservato come le lettere vengono drieto alle armi, e che nelle provincie e nelle città prima i capitani che i filosofi nascono. Perché avendo le buone e ordinate armi partorito vittorie, e le vittorie quiete, non si può la fortezza degli armati animi con il più onesto ozio che con quello delle lettere corrompere; né può l’ozio con il maggiore e più pericoloso inganno che con questo nelle città bene institute entrare. Il che fu da Catone, quando in Roma Diogene e Carneade filosofi, mandati da Atene oratori al Senato, vennono, ottimamente cognosciuto; il quale, veggendo come la gioventù romana cominciava con ammirazione a seguitarli, e cognoscendo il male che da quello onesto ozio alla sua patria ne poteva risultare, provide che niuno filosofo potesse essere in Roma ricevuto. Vengono per tanto le provincie per questi mezzi alla rovina; dove pervenute, e gli uomini per le battiture diventati savi, ritornono, come è detto, all’ordine, se già da una forza estraordinaria non rimangono suffocati. Queste cagioni feciono, prima mediante gli antichi Toscani, di poi i Romani, ora felice ora misera la Italia. E avvenga che di poi sopra le romane rovine non si sia edificato cosa che l’abbia in modo da quelle ricomperata, che sotto uno virtuoso principato abbia potuto gloriosamente operare, non di meno surse tanta virtù in alcuna delle nuove città e de nuovi imperii i quali tra le romane rovine nacquono, che, sebbene uno non dominasse agli altri, erano non di meno in modo insieme concordi e ordinati che da’ barbari la liberorono e difesero. Intra i quali imperii i Fiorentini, se gli erano di minore dominio, non erano di autorità né di potenza minori; anzi, per essere posti in mezzo alla Italia, ricchi e presti alle offese, o eglino felicemente una guerra loro mossa sostenevono, o ei davono la vittoria a quello con il quale e’ s’accostavano. Dalla virtù adunque di questi nuovi principati, se non nacquono tempi che fussero per lunga pace quieti, non furono anche per la asprezza della guerra pericolosi; perché pace non si può affermare che sia dove spesso i principati con le armi l’uno l’altro si assaltano; guerre ancora non si possono chiamare quelle nelle quali gli uomini non si ammazzano, le città non si saccheggiano, i principati non si destruggono: perché quelle guerre in tanta debolezza vennono, che le si cominciavano sanza paura, trattavansi sanza pericolo, e finivonsi sanza danno. Tanto che quella virtù che per una lunga pace si soleva nelle altre provincie spegnere fu dalla viltà di quelle in Italia spenta, come chiaramente si potrà cognoscere per quello che da noi sarà da il 1434 al ’94 descritto dove si vedrà come alla fine si aperse di nuovo la via a’ barbari e riposesi la Italia nella servitù di quelli. E se le cose fatte dai principi nostri fuori e in casa, non fieno, come quelle degli antichi, con ammirazione per la loro virtù e grandezza lette, fieno forse per le altre loro qualità, con non minore ammirazione considerate, vedendo come tanti nobilissimi popoli da sì deboli e male amministrate armi fussino tenuti in freno. E se, nel descrivere le cose seguite in questo guasto mondo, non si narrerà o fortezza di soldati, o virtù di capitano, o amore verso la patria di cittadino, si vedrà con quali inganni, con quali astuzie e arti, i principi, i soldati e i capi delle repubbliche, per mantenersi quella reputazione che non avevono meritata, si governavano. Il che sarà forse non meno utile che si sieno le antiche cose a cognoscere, perché, se quelle i liberali animi a seguitarle accendono, queste a fuggirle e spegnerle gli accenderanno.
Note-book: Parole sante di Eva Clesis
Nota sull’ultimo libro di Eva Clesis, Parole Sante.
Canto e controcanto
di
Francesco Forlani
C’è in Eva Clesis una tale naturalezza nello stile, nella frase, nelle sequenze, che mi sono a lungo chiesto se in lei la narrazione, qualunque tipo di narrazione, si “facesse” con la scrittura, se solo grazie alla parola le cose potessero essere. Insomma, nei libri di Eva Clesis accade qualcosa di simile a un’invenzione da stregoneria, di uno sciamanesimo però di tipo popolare, non esoterico, aristocratico. Le cose, insomma. è come se si parlassero prima fra loro, intrecciate a strani rituali, credenze, segreti di famiglia, ancor prima di rivelarsi al narratore, al lettore, quasi prescindendo dall’uno, dall’altro.
C’è in queste “parole sante” di Eva Clesis, un’inversione sintattica imprescindibile; perché ci si possa salvare, bisogna dapprima “intendere” la parola, sentirla e poi si vedrà se, insomma, sono sante o meno. Si tratta di un polar? Di un noir? L’intrigo è solido, i colpi di scena non mancano certo, e sempre al tempo giusto, eppure non è soltanto un noir, nè solamente un polar.
Si tratta di una scrittura in un ritmo che conviene a quegli strani paesaggi del Sud Italia in cui perfino quando le strade evaporano al sole, e il calore appesantisce i passi, la parola è nervosa, rapida, veloce come una fucilata. Quasi il contrario di quanto accade al nord, dove il passo è sicuramente veloce, il movimento rapido, ma non la parola, rarefatta e che nelle conversazioni sembra sempre evaporare insieme al vino, al respiro.
La dimensione del racconto è meridiana. Per quanto lo spessore del volume superi le duecento pagine l’architettura è quella del racconto, più che del romanzo, i capitoli compiuti, mano a mano, rendendo la lettura agile, accattivante (e cattiva). Meridiana è la dimensione perché è una narrazione che può esistere solo attraverso l’esperienza comune e comunitaria. La lingua madre, locale, scàlpita in tensione continua con quella matrigna, globale, standardizzata. Una storia venata, anzi svenata, di credenze, è “Parole sante”, abitata, anzi domiciliata da mostruosità più o meno taciute, segreti più o meno confessati, che anche quando sembra arrecare sollievo, ” in fondo qui siamo una grande famiglia” in un tempo che atomizza ogni cosa, isola senza solitudine i propri abitanti, di colpo, ma non all’improvviso, ti vomita addosso il male, la condanna di essere una terra, una cultura come la nostra, meridiana e meridionale, incapace di raccontarsi come altro, da una grande famiglia.
Animus e Anima: Beppe e Maria tra Jung e Collodi
Francesca Palazzi Arduini
Sembra incredibile ma oggi l’Italia offre due personaggi dai nomi biblici, Giuseppe “Beppe”, e Maria, come catalizzatori sociali dell’opinione pubblica e dell’affettività. Maria, severa ma compiacente amica che conduce all’espressione dei propri sentimenti, dell’affettività, del proprio talento artistico, e guida benevola le persone nell’espressione di sé, amorevole Avvocata (termine usato anche per la Madonna che intercede e aiuta) di tutti che permette a tutte/i di esprimersi perché ognuno può essere anche solo per un attimo al centro dell’attenzione. Maria la sacerdotessa della tv fatta dalla gente, distinta e discreta manovratrice in sordina di un immenso potere gestito dietro le quinte, forse vestale di ritualità, di sottomissione e di gioco cruento paludato poi sullo schermo da una infinita dimostrazione di lealtà. Maria l’Anima, la parte permeabile e ‘passiva’ di noi, che gestisce le nostre timidezze e invita pacata ad aprire i cuori, poi si fa l’Altra, colei che ragiona, che ammonisce le passioni incontrollate e il trascendere, che invita all’equilibrio tra i desideri e la realtà.
A questo personaggio che “fa parlare” e spesso solo guarda e tace, dittatrice della scena televisiva, per ogni età, e regna nei salotti e nelle cucine, fa da contraltare il Re delle piazze, Giuseppe detto Beppe. Lo stereotipato principio maschile quanto cozza con Maria! Lui è incontrollato, la scena dal vivo è solo sua, non fa parlare gli altri se non per concedergli un millesimo del suo spazio, gli altri sono coloro di cui è portavoce, ai quali fa da promoter, che vuole portare con sé alla vittoria … ma sono pur sempre quasi muti e grigi nell’arena. Il pubblico, i militanti, gli elettori, possono se vogliono scrivere dei loro desideri in uno spazio che è il regno di Giuseppe, e anche sua proprietà. La rabbia, l’aggressività verbale, l’intolleranza di chi non ne può più, è espressa da Lui, che gesticola, urla, sfida e impreca. Compito della sua Massa è lavorare per giungere agli scopi indicati come comuni. Lì, nella banale e quotidiana manovalanza, c’è per loro soddisfazione e parola, lì le energie di Beppe confluiscono come a Pentecoste nel loro discorso. Viene in mente il breve saggio “Psicologia del reclutatore”, nel quale Patrizia Santovecchi, citando G. Le Bon, scrive: “Il leader deve saper cogliere le aspirazioni segrete della folla e proporsi come colui che è capace di realizzarle; come l’incarnazione stessa di tali desideri”. Ma chi oserà riconoscere l’incredibilità, e la scontatezza, di questa situazione psicologica? Pochi, in una società nella quale l’inconscio, lo dice bene Recalcati, è non più un sintomo di qualcosa da scoprire ma un difetto da truccare.
Se Maria gestisce quindi il suo potere con dedizione ma non si pone come modello con la sua vita privata e le sue opinioni personali, che semmai dirigono il gioco ma non si paludano da Verità, lui, contrariamente al Giuseppe evangelico, salta alla ribalta con prepotenza e afferma di possedere la Verità. Ogni cosa che dice è una trovata risolutiva, ogni accenno che fa è dimostrazione di saperne più degli altri, di avere in mano la soluzione dei problemi, con la parola. La parola diventa arma che sconfigge la complessità, le lunghe frasi e le tematiche pesanti per la loro storia e la loro composizione si sciolgono in poche frasi, la parola d’ordine è: unanimità. Così chi lo sostiene lo fa per disperazione politica, passando sopra a quella veemenza e allo strisciante superleaderismo (come definito da Federico Boni), o perché “ha scoperto i problemi dell’economia ascoltandolo”. Qui Beppe è l’ago che rompe la bolla autistica del cittadino senza più classe sociale e appartenenze e lo introduce in una nuova più accogliente bolla totale, la “piattaforma”, progetto di una connessione web non più caotica ma da lui amministrata ed ispirata sulla base di una visione generale non del tutto esplicita.
Anche la vita privata di Beppe è poi oggetto che incarna i desideri del giovane maschio italiano: Beppe ha vissuto e vive di parole, artista e libero da condizionamenti, è ciò che l’italiano mite, precario o sottomesso al lavoro non sa e non può; fa jogging, nuota e va in barca, ha una moglie (il nome non importa, non è nemmeno compagna di lotte o first lady, è lì e basta) piacevole e non italiana, un discreto conto in banca accumulato con i click degli AdWords di Google. Non vecchio né giovane, ondeggia nella mezza età, capace di catalizzare con spirito giovanile, la chioma brizzolata del saggio richiama il personaggio di Pinocchio. Ecco un’altra versione di animus e anima nell’inconscio collettivo italiano: La Fata turchina è Maria. Il Grillo parlante, che ha avuto il compito di fare da Super-io al burattino di legno, è Beppe. E si sa, il Super-io è bravo a stabilire le regole e ha il compito di punire le trasgressioni, è concentrato fuori da sé, un po’ come Travaglio (ma senza Complessità aperta in mano). Mentre Maria quindi è incarnazione dell’interno, del principio femminile, vero o falso che sia, del dialogo e dell’emotività, Beppe è l’incarnazione della rabbia punitiva verso gli altri e liberatoria verso se stessi, la fase finale della ricerca di libertà (dalle tasse, dai caporali? La libertà svolazzante del mondo virtuale diviene modello per quello reale, ben differente nella sua concretezza materiale), quella libertà spesso venduta dai truffatori del Paese dei balocchi o della Casa delle libertà, a caro prezzo, agli ingenui cittadini. Giuseppe è a volte anche Mangiafuoco nella fantasia degli italiani (e di Bersani), la volontà che si crede potenza, della finalità del rendere tutti unanimi, della conquista della maggioranza assoluta che trasforma tutti i burattini.
Così, gli adepti di Maria vengono scelti per ubbidienza e dedizione ma premiati con lo spettacolo di se stessi, mentre quelli di Beppe il Reclutatore restano incagliati nel sogno del potere assoluto, raggiungendo il quale, allora e solo allora, sarà possibile ottenere ciò che si vuole, sconfiggere il “sistema” corrotto ed essere protagonisti, al fianco di Beppe, della Storia. Già le cinque stellette sembrano cucite sulle mostrine … riuscirà la massa a vedersi per quello che è e rendersi autonoma? L’Animus scuote la testa: l’altro, il contagioso, il marcio, il corrotto, il vecchio, l’ottuso, è il pericolo; facendo questo mostra una realtà inesistente, in cui tutti i mali sono stati causati da Altri. L’interlocutore, cioè, è presentato sempre come nemico e come un falso, al massimo come un inetto. Gli individui non iscritti, quindi “nemici” o incapaci, scompaiono dietro l’ombra delle loro opposte e varie fazioni: non può esservi dialogo perché solo noi stessi rappresentiamo ciò che è degno e meritevole, non c’è bisogno di rappresentazione, di scenario e di soggetti differenti, con diverse storie, visioni ed esigenze. La politica dunque è un gioco senza senso (che brutta parafrasi del ‘Bene comune’ e di Simone Weil!), giostrato da chi si diverte a presentarsi “diverso” ma non lo è, perché l’unica “differenza” valida e vera deve essere contenuta in chi segue Beppe e lo sceglie come voce. L’iperbole del partitismo si accartoccia nel totalitarismo digitale per Beppe, l’iperbole dell’emozione si allarga nel circo della banalità per Maria. Così il qualunquismo diviene virtù, sia quello che ha solo amici, di Maria, che quello che ha solo Nemici, di Beppe.
3 aprile 2013
*
[Testo preparatorio per il lavoro d’artista di Saverio Feligini alla quinta Biennale d’arte contemporanea promossa da Satura, Genova 2013. Di Saverio Feligini è l’immagine collage in apertura.]
L’ombra del Grillo
di Nicola Fanizza
Uno spettro si aggira fra le tenebre trasparenti che avvolgono la nostra penisola: lo spettro del grillismo. Che si fa latore di inedite speranze di salvezza, di nuovi sogni e, insieme, di nuovi incubi. Alcuni fra i nostri direttori di coscienza ritengono che il M5S si configuri addirittura come un fenomeno di rinascenza del fascismo. Da qui il loro invito a combattere contro il nuovo mostro bicefalo. La consegna è una sola: instillare nelle masse il germe della paura.