Diventa leghista con l’ipnosi / Cuore. 1993
Minuti omicidi di casa mia
di Giacomo Sartori
In settembre mi trovavo all’estero. È da lì che ho letto sul sito di un quotidiano nazionale che c’era stato un infanticidio in provincia di Trento. Mi sono quindi spostato su un quotidiano locale, ma senza affrettarmi: davo per scontato, me ne sono accorto dopo, che si trattasse di una valle periferica, di uno dei tanti paesi strattonati tra sfilacciamento postindustriale e impossibile arcadia turistica. E invece il nome nei titoli era proprio quello del comune dove sono cresciuto e dove abito: Cognola. Stentavo a crederlo, ma il delitto si era svolto proprio lì. Come è ovvio mi sono precipitato a cliccare su quello che sembrava essere l’articolo più importante.
Prima ancora di cominciare la lettura sono incappato nella fotografia di una vecchia villa che conosco molto bene fin da bambino, e nella quale abitava una lontana cugina di mio padre. Non solo il fattaccio era avvenuto al mio paese, ma nella casa della B. Ogni volta che ci passavamo davanti qualcuno dei miei familiari esclamava “questa è la casa della B.!”. Poi ci ero transitato davanti infinite altre volte da solo, quando in città ci andavo in motorino, anche con quindici gradi sotto zero, e poi tornavo in piena notte: in attesa di partire davvero. Ora evidentemente – e con la lontananza mi ero perso anche questo – la B. era morta, e l’antica casa patrizia mai rintonacata, e proprio lì sta il suo fascino, era abitata da qualcun altro, la famiglia del dramma.
Secondo le prime ricostruzioni dei quotidiani, la nipote dell’anziano proprietario, che aveva una quarantina di anni, era a cena a casa del nonno con il compagno, e alla festicciola partecipavano anche il padre, che sarebbe ripartito il giorno dopo per le Antille, dove risiedeva, e un medico amico di famiglia. Stando ai giornali a un certo punto la donna si era sentita male. Si era alzata, e era andata in bagno. Poi dopo un quarto d’ora era tornata, e si era rimessa a tavola. Il proseguo del pasto era stato però disturbato da rumori insistenti che facevano pensare ai miagolii di un gatto. Alcuni dei commensali si erano alzati per vedere cosa succedeva, e tra questi la donna. E proprio lei aveva preso tra le braccia il fagotto posato nel sottoscala da cui venivano i lamenti. Era un gatto che era stato investito da un’auto davanti alla casa, aveva detto tenendolo contro il petto. Poi aveva stretto la parte superiore dell’involto fino a fare cessare i miagolii. In realtà era il figliolo che aveva partorito nel quarto d’ora di assenza da tavola, e lo aveva soffocato. La badante polacca che aveva assistito alla scena aveva avvisato i carabinieri, seppure con tre mesi di ritardo, e questi avevano subito cominciato le indagini.
Si dà il caso che in passato abbia lavorato a un romanzo che centrato attorno a una madre infanticida. E come sempre mi succede quando abbordo un tema che conosco poco, ho letto tutto quello che ho trovato, spaziando dai lavori dei criminologi a quelli degli psichiatri/psicanalisti, passando per i casi concreti e le testimonianze, in Italia come in altri paesi. Un’immersione affannata e totale che includeva naturalmente anche il nodo della maternità in generale, e le sue difficoltà e implicazioni, le possibili degenerazioni. Un lavoro enorme che fa sì che io che non ho figli, ne sappia forse di più di chi ha figli. Me ne accorgo quando coppie di amici più giovani mi parlano del bimbo che aspettano, o che già hanno. Mi capita addirittura di tanto in tanto di prestare qualche libro sul tema, come appunto potrebbe fare una persona che ha qualcosa da insegnare. E invece il mio è il tipico sapere sterile del romanziere, disincarnato e interessato, volto alla scrittura, non alla vita. Del resto quel romanzo al quale ho lavorato tanto non l’ho poi pubblicato, e forse non lo pubblicherò mai.
Queste mie conoscenze libresche mi dicevano che moltissimi elementi del dramma avvenuto in una casa che conosco del mio paese erano piuttosto frequenti in altri episodi analoghi. Era normale per esempio che nessuno, a partire dai colleghi dell’asilo, e neppure il convivente, con il quale la donna viveva e si presume dormisse ogni sera, si fosse accorto della gravidanza. Del resto la donna era un po’ grossetta, come appunto spesso in casi del genere. E era normale che i superiori e i genitori dei bimbi la considerassero una maestra esemplare, una persona di assoluta fiducia. E anche il parto nel bagno non è raro. In qualche caso addirittura la madre stessa non è cosciente di essere gravida, e pensa che si tratti di una normale defecazione.
Può succedere in qualsiasi ambiente e in qualsiasi posto, anche questo sapevo. E questa volta era accaduto nel mio paese, in una antica casa davanti alla quale ero passato infinite volte e che quindi faceva parte del mio paesaggio interiore. Quello che era molto meno normale era che i familiari e il medico presenti, tutte adulti e vaccinati e stimati, si fossero messi di buzzo buono per occultare il cadavere. E che l’avessero fatto nella maniera più impressionante che si potesse immaginare. L’essere stati colti di sorpresa non poteva in nessun modo costituire una scusante.
La vicenda aveva tutti gli ingredienti, si sarebbe potuto pensare, per diventare un caso alla ribalta su tutti i media nazionali, con quotidiani aggiornamenti e colpi di scena, e con gli ineludibili commenti e analisi di personalità e esperti. Basta che un episodio abbia le caratteristiche adatte, si pensa, e la macchina mediatica parte all’impazzata. In realtà nessun giornale nazionale ha parlato diffusamente di questo dramma, e tantomeno ha seguito il divenire delle indagini. Il fatto, molto banalmente, è che in quei giorni la ribalta era già interamente occupata da un’altra agghiacciante vicenda successa al sud. E naturalmente ogni nuova puntata di questa seguitissima narrazione, fremente della febbre voyeuristica della presa diretta, avrebbe risentito della concorrenza di un’altra tragedia familiare altrettanto, se non maggiormente, conturbante, un po’ come quando due gialli con tema simile sono mandati in onda su due canali diversi quasi alla stessa ora: quello meno famoso, o anche solo programmato un po’ più tardi, ne risente.
Ogni giorno venivano alla luce nuovi terrificanti dettagli. I giornali nazionali continuavano però a ignorare il caso, e era ormai chiaro che avrebbero continuato a farlo. Il che confermava che il passaggio dalla provincia alla dimensione nazionale non è affatto scontato. I crimini e le tragedie sono tanti, e solo alcuni assurgono a tormentoni nazionali. La provincia, e questo vale per gli scandali della politica come per la cronaca nera, come primo riflesso tende a attutire, a smorzare, a trovare scusanti. In provincia tutti si conoscono direttamente o indirettamente, è difficile trovare un ardito disposto a lanciare a viso scoperto la prima pietra. Certo proprio per la consapevolezza della prossimità non solo fisica, la paura del contagio è più grande. È solo mettendo le distanze, approfittando dell’anestesia dell’ignoranza dei luoghi e delle persone, che la belva dell’informazione può accanirsi e dare il meglio di se stessa. Ma appunto non è detto che succeda.
La notizia che apparve un giorno sui siti della stampa locale mi parve confermare la tendenza a fare quadrato contro l’irruzione della sconvenienza. I sindaci che si erano succeduti negli ultimi quarant’anni alla guida del comune dove esercitava il medico condotto amico di famiglia si erano riuniti, e avevano espresso in una lettera ufficiale il loro incondizionato sostegno al professionista sospettato di aver abbandonato, e proprio in quella zona, il cadavere di un neonato in pasto agli animali. Il comunicato esprimeva la riconoscenza all’indagato per quello che aveva fatto in tanti anni per la popolazione, e l’augurio che continuasse presto a riprendere la sua preziosa missione. I sei firmatari utilizzavano insomma la loro autorevolezza di primi cittadini per lottare contro l’invasione del disordine, senza domandarsi se quel loro intervento potesse configurarsi, se non altro sul piano morale, come una connivenza.
I quotidiani locali insistevano molto sulla villa signorile e sul fatto che la nonna fosse una famosa pittrice, deceduta da qualche anno, della quale proprio nei giorni del delitto si inaugurava un’importante retrospettiva: enfatizzavano una supposta coloritura alto-borghese della vicenda. Io invece vedevo una tipica famiglia aperta dei nostri giorni, dove il nonno, in realtà un secondo marito della nonna, rimasto vedovo aveva la badante straniera, dove il padre dopo essersi separato viveva ai Caraibi con una donna del posto, dalla quale aveva avuto altri figli, la protagonista della vicenda lavorava in un asilo e conviveva con un uomo separato che aveva già due figli. Certo c’era qualche quarto di nobiltà culturale, la nonna pittrice, per quel che può contare al giorno d’oggi la cultura, e c’era il rispettato medico amico di famiglia, ma i protagonisti di quel fatto raccapricciante mi sembravano pur sempre quelle stesse persone che osservavo mentre facevo la spesa, che incrociavo dal giornalaio o in farmacia, che vedevo montare su automobili non certo da poveracci, domandandomi chi fossero e che vita facessero. Quelle persone certo più o meno facoltose, con tutto ciò che comporta, ma che guardavano pur sempre gli stessi programmi alla televisione, entravano nello stesso supermercato e acquistavano prodotti analoghi, evitavano i miei occhi con lo stesso disinteresse, circolavano sulle stesse strade dove nessuno andava più a piedi. Quegli individui che approfittando della mia assenza avevano preso possesso dei luoghi della mia infanzia, come un organizzato esercito di invasori che parlasse una lingua che non conoscevo. Un esercito motorizzato.
Poi però al mio rientro in Italia è successa una cosa che non mi aspettavo. O meglio, mi sono accorto che era successa, come accade quasi sempre nella vita. L’ho realizzato muovendomi tra i corridoi del supermercato. Può sembrare incongruo, ma mi sembrava di capire meglio quei visi e quei luoghi che non erano più i miei ma che per altri versi mi appartengono. Anzi, proprio l’epifania della bestialità scevra di convulsioni e anzi quasi leggiadra che si era consumata in contemporanea con i fuochi di artificio nel giorno del patrono, e che era venuta a galla solo in autunno, come per non guastare lo spensierato clima estivo, per non rompere la bolla di sapone turistica, me li rendeva di nuovo vicini, rendeva intellegibile tutto il resto. Adesso lo sapevo, chiunque rifiutasse la troppo facile indignazione dei giornali, e gli smaccati stratagemmi di distanziazione, chiunque non nascondesse la testa nella sabbia, lo sapeva: sotto l’asettica facciata di spigliata modernità covava la possibilità di uccidere. Il velo dell’innocenza era stracciato: quegli uomini e quelle donne con gli occhi vuoti erano potenziali assassini, in qualche caso forse assassini veri e propri. L’ansia per molti versi giustificata di godere di ogni giornata e di dribblare le angosce valeva ben qualche sacrificio, qualche omicidio. E io non ero certo innocente, anche se per molti aspetti mi tenevo in disparte, e vedevo corrispondenze e sintomi che a molti forse sfuggivano. Gli individui isolati si rivelano molto spesso i più pericolosi. Potevamo uccidere, qualche volta uccidevamo. Esattamente come succedeva un tempo nelle dinastie di mezzadri che avevo conosciuto io: idealizzare il passato non aveva senso. Se possibile ci coprivamo a vicenda, perché era nel nostro comune interesse, e perché la famiglia deve pur servire ancora a qualcosa anche in questi tempi di esistenze atomizzate e nevrotiche. E poi tornavamo di nuovo al supermercato e caricavamo altre borse della spesa sui nostri fuoristrada o pur sempre rutilanti veicoli, rientravamo ciascuno nel suo conforme e presentabile inferno, comunicando all’esterno via internet.
Del resto il male non era poi assoluto. A quanto risultava dalle notizie più dettagliate sulle indagini che cominciavano a circolare forse non era stata la badante la prima a parlare. La versione della spessa cortina familiare rotta dall’indigente straniera era troppo seducente, troppo perfetta, per essere vera. A quanto pare a contattare i carabinieri poteva invece essere stato proprio il nonno, le cui condizioni di salute si erano aggravate subito dopo quella serata, tanto che era stato ricoverato in ospedale per un mese, passando addirittura per un coma. Forse in lui aveva prevalso il pentimento.
E poi non dovevo fidarmi troppo della memoria. Parlando con un lontano parente mi sono reso conto che mi sbagliavo di grosso, la B. non aveva mai vissuto in quella villa. Abitava effettivamente in quella zona, ma sotto la strada, non sopra. Del resto non era affatto morta: seppure molto anziana era in discreta salute. A quanto pare da bambino avevo interpretato male le frasi dei miei familiari, e poi per decenni passando davanti a quella vecchia casa avevo riesumato la falsa informazione. In realtà per anni il palazzotto era rimasto disabitato, e già da molto tempo ci vivevano la pittrice con il secondo marito. Dopo la morte di lei lui era rimasto solo. Avevo preso un enorme granchio. Come avevo certo capito male o frainteso anche molte altre cose.
(questo testo è apparso, in forma più estesa, sul vol. 56 (2011) di Nuovi Argomenti)
3 anni

Il 30 marzo scorso, allo Spazio Baluardo, nel quartiere milanese di Quarto Oggiaro, abbiamo parlato con Alessandro Chiappanuvoli del terremoto dell’Aquila, di Terzigno, di No-Tav, di emergenze democratiche e di tanto altro.
Pubblico un’intervista video fatta ad Alessandro quella sera, che ho trovato qui.
Oggi. Per ricordare che sono già passati 3 anni.
Qui sotto il link all’intervista:
METTI_UN_AQUILANO_A_TERZIGNO.aspx
La moglie del colonnello
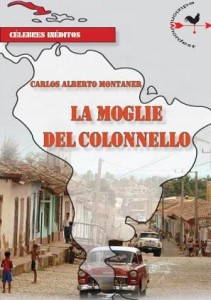
Esce oggi, per le Edizioni Anordest, il romanzo di Carlos Alberto Montaner, La moglie del colonnello, tradotto da Marino Magliani. Per gentile concessione dell’editore, ecco un’anteprima del capitolo VIII:
Il convegno ebbe inizio esattamente alle dieci del mattino, come da programma. La piccola sala conferenze, situata al primo piano dell’hotel,
Letto su un telegramma non firmato
Di Andrea Inglese
Fu proprio in quel momento che un uomo con la barba d’argento
(un vecchio?)
Morgantina
di Massimo Bonifazio
che qui non ci fossero: svolte, pensieri bastanti
a pensare il vasto campo lavico che dalla sua,
o poco distante, avesse: una più mite, un’altra:
logica, luminosa di foglie e di erba che nessuno,
per millenni, aveva calpestato; e rocce rimosse,
altari, gradini di un unico grande teatro
dal cui omphalos mancante la tua voce
potesse finalmente arrivare, spezzarsi
contro l’ammasso di tufi, calcari;
L’onore dei Kéita
 di Gianni Biondillo
di Gianni Biondillo
Moussa Konaté, L’onore dei Kéita, Del Vecchio Editore, 118 pagine, traduzione di Ondina Granato
Pensare che il “giallo” sia solo una moda nazionale passeggera significa non aver compreso appieno quanto invece sia un fenomeno globale davvero particolare. Tutti, oggi, scrivono gialli. Dappertutto. E, brutti o belli, sono diventati a tutti gli effetti sintomi, indicatori di un preciso momento storico. Fra le varie ragioni di tanta fortuna, credo che la principale stia nella duttilità del genere, nella capacità di adattarsi alla realtà che cerca di narrare, d’essere al contempo riconoscibile nella sua essenza e plasmabile a seconda dei narratori che ne fanno uso.
L’onore dei Kéita, per dire, è un giallo africano, maliano per la precisione. Lontanissimo dagli scenari delle metropoli nordamericane, racconta di una indagine del commissario Habib e del suo assistente, ispettore Sosso (tipologia, quella del duo, ricorrentissima nel giallo), i quali, alla ricerca del colpevole di un omicidio, dovranno addentrarsi in un sperduto villaggio governato da un nobile irascibile, custode della tradizione familiare.
Questo di Moussa Konaté non è un noir, bene e male sono ben distinti, e i protagonisti non hanno ombre o psicologie contorte. È piuttosto un giallo classico, un tipico enigma della camera chiusa allargata all’intero villaggio. Scritto senza particolari fronzoli, spesso con una lingua ingenua e dialoghi semplici, il romanzo ha la sua forza nello scenario che racconta, cioè nella realtà che tratteggia e nell’immaginario che ne trapela, davvero nuovi per noi lettori occidentali e allo stesso tempo descritti da dentro, lontano perciò da facili esotismi.
Parlare di delitti per Konaté significa ragionare attorno ai concetti di onore, casta, clan. La legge scritta e la vita moderna, cittadina, devono confrontarsi con consuetudini tribali, spesso implicitamente condivise dall’autore stesso. L’onore dei Kéita è l’ennesima prova di quanto il genere sia ben lungi dall’essere una gabbia. È piuttosto uno strumento. Saperlo usare o meno sta nel talento dell’autore.
[pubblicato su Cooperazione n° 4 del 24 gennaio 2012]
Orazio, Odi, I, 9
di Raffaele Di Stasio *
Horatii Carmina I,9
Vides ut alta stet nive candidum
Soracte, nec iam sustineant onus
silvae laborantes geluque
flumina constiterint acuto.
Se il lavoro non c’è
di Helena Janeczek
“Ma fatemi capire: perché abolire l’art.18, per far cosa, se il lavoro non c’è?”. L’ha detto M., la mia estetista, che sarebbe una piccola imprenditrice, anzi persino un’”imprenditrice di se stessa”, secondo la formula magica del pensiero neoliberista. Raccontava che per ora lei se la cava, mentre le amiche che hanno investito in centri più grandi saranno costrette a mandare a casa l’unica dipendente se, con la bella stagione, il lavoro non aumenta.
La lista dei desideri di Robert Boyle: medicina e geografia
di Antonio Sparzani

Come, ehm, certamente ricorderete da questo post di quasi quattro anni fa, l’illustre Christiaan Huygens (13 anni più vecchio di Newton), per persuadersi che il suono per propagarsi aveva bisogno dell’aria, ricorreva a “la macchina che Mr Boyle ci ha fornito, e con la quale ha fatto così tante belle esperienze.” : questa gli permetteva di togliere l’aria da un recipiente a tenuta e di toccare con mano, per dir meglio, con l’orecchio, che il suono non si trasmetteva in assenza d’aria.
Personaggi Precari 2012 – Six for Perseus
Massimo
– Ma come facevamo quando non c’era Internet, eh Massi?
– Senti. Io non so come tu faccia a parlare di cose del genere con tanta leggerezza. Datti una regolata, perdio.
Fortini – Lezioni sulla traduzione
di Domenico Pinto
 A Napoli, nel 1989, il magnetofono registra per dodici ore la voce di Fortini. Su invito di Vittorio Russo sta conducendo un seminario nelle sale dell’Istituto di Studi Filosofici. Le esperienze radunate in oltre quarant’anni di traduzione, da Un cuore semplice (1942) alla Colonia penale (1986), e culminate nell’impresa del Faust (1970), confluiscono in queste lezioni che salpano tutte le sue reti teoriche e poetiche.
A Napoli, nel 1989, il magnetofono registra per dodici ore la voce di Fortini. Su invito di Vittorio Russo sta conducendo un seminario nelle sale dell’Istituto di Studi Filosofici. Le esperienze radunate in oltre quarant’anni di traduzione, da Un cuore semplice (1942) alla Colonia penale (1986), e culminate nell’impresa del Faust (1970), confluiscono in queste lezioni che salpano tutte le sue reti teoriche e poetiche.
partita / antonio porta. 1967
Partita di Antonio Porta in versione ebook .pdf su GAMMM
La barca sta affondando, è questo che vogliamo, è una gondola più larga e lunga del normale, dipinta di bianco, dove tutti possiamo stare seduti comodamente, senza urtarci, senza doverci stringere troppo:
Scusate il cross-posting ma è a fin di bene. Leggete, godete, condividete!!!
Poesie # 3
di Franco Buffoni
Viale dei tigli
Sono ottantenni gli alberi e le cime
Ergono su la presenza di liceo
– Il bar con i panini.
Per durezza potata
Ne indovini la forma-foglia:
L’ablativo del ramo
Se veramente interrogato
Risponde i giorni delle mamme giovani
A ripassare cartoline.
E ora, pubblicità
Care lettrici e cari lettori, da oggi su Nazione Indiana trovate una piccola novità. Sono le inserzioni pubblicitarie che abbiamo deciso di ospitare sul sito, dopo lunghe e travagliate riflessioni e non poche esitazioni.
Siamo convinti infine che sia un servizio utile: a noi, che contiamo di finanziare le attività della nostra associazione, a voi lettori, che potrete trovare informazioni affini ai vostri interessi, e agli inserzionisti che possono incontrare un pubblico attento e vivace.
[continua dopo la pubblicità]
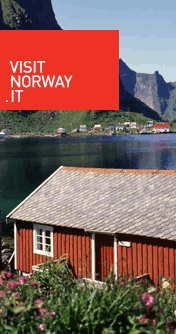
Come siamo arrivati a questa decisione?
Nazione Indiana si è finora mantenuta indipendente autofinanziandosi (leggi: paghiamo tutto di tasca nostra), ma è arrivato purtroppo il momento in cui questo non basta più e dobbiamo affrontare seriamente (ed oggi anche urgentemente) la copertura delle spese della nostra attività.
Abbiamo esaminato attentamente le alternative disponibili, e crediamo che la via percorribile in questi tempi difficili per tutti sia la messa a valore del marchio e della storia di Nazione Indiana, senza falsi moralismi o pretese di purezza.
Crediamo infatti che un rapporto etico con sponsor ed inserzionisti possa coprire, stando alle proiezioni, una parte dei costi senza intaccare i valori fondanti del nostro progetto e del nostro rapporto con voi lettori.
Quali sono i criteri per le inserzioni pubblicitarie?
Pubblicheremo subito inserzioni in home page e nelle pagine di servizio (archivi, temi e tag), mentre per i singoli articoli e per tutto l’archivio procederemo gradualmente con un meccanismo di opt-in (assenso) degli autori. Oltre a semplici inserzioni delle reti concessionarie vi saranno campagne mirate (ad esempio, da parte di partner) e la presenza di sponsor, con eventuali shout-out (redazionali), sempre chiaramente identificati.
Lavoreremo per assicurare la massima qualità degli sponsor e dei temi trattati: limitiamo già in partenza le inserzioni su politica, religione, sesso, azzardo e piscicoltura, ma potete segnalarci eventuali argomenti controversi scrivendo a nazioneindiana@gmail.com con oggetto “pubblicità sgradita”.
E’ un passo sofferto, ma importante. Contiamo sul vostro sostegno, perché questa continui ad essere sempre una Nazione Indiana.
Jan Reister
[nota per i futuri lettori d’archivio: leggete la data di pubblicazione]
Ancora minacce a Giulio Cavalli
 una nota di Gianni Biondillo
una nota di Gianni Biondillo
Carlo Cosco, ieri, pochi minuti prima di essere condannato all’ergastolo per l’omicidio della sua compagna – Lea Garofalo, sciolta nell’acido – ha minacciato Giulio Cavalli, presente nell’aula della Prima sezione della Corte d’assise. Ha gridato, rivolto all’attore: “Perché scrivi sui libri che siamo mafiosi?” La risposta l’ha data uno dei fratelli di Cosco, pure lui condannato: “Scrivi perché sei un cornuto e un infame.” Ancora di più, a maggior ragione, ribadisco la mia vicinanza, la mia fratellanza a Giulio. Non sei solo. Il mio abbraccio sarà ancora più stretto. Questa è una minaccia.
Lapoesiamanifesta che…
Giornata Mondiale della Poesia all’Aquila
di Alessandro Chiappanuvoli
(dal blog WordSocialForum)
“Un buco con la periferia intorno”, “una Pompei con i bar”, “un’avanguardia: L’Aquila è l’Italia tra 5 anni” – solo alcune definizioni aggiornate – L’Aquila, sia chiaro, non è più solo una città terremotata. All’Aquila sono passati tre anni.
Overbooking: Attilio Wanderlingh

di
Gigi Spina
Ho appena finito di leggere “Prima del disincanto” di Attilio Wanderlingh (Intra Moenia, Napoli 2012), “diario di una generazione in qualche racconto 1968-1980”, e ho subito cercato di individuare il posto dove collocarmi e, di lì, parlarne. L’ho trovato dopo l’ultimo rigo di pagina 84, alla fine del capitolo intitolato “Carlos”, in quello spazio bianco che prepara il capitolo successivo, “Praga”. Lì ho potuto ricordare quello che già la foto di copertina mi aveva fatto balenare: l’autore ‘guerrigliero’ con tanto di mitra, in mezzo a due molto più duri di lui, che sorride spavaldo. Misi piede nella sede del Manifesto di Napoli, in via Pessina, nell’autunno del 1970 (mi pare), perché curioso di ascoltare un tale Attilio Wanderlingh che avrebbe parlato delle sua esperienze in Medio Oriente. Al Manifesto di Napoli si parlava di politica, internazionale e interna, con alcuni storici dirigenti usciti dal PCI; al Manifesto di Salerno, che avevo cominciato a frequentare nel mio incipiente pendolarismo, l’attivismo era forse più ideologicamente giovanile e ‘intergruppi’. Ricordo una stanza in cui le compagne, fra cui Lucia (forse Annunziata?), preparavano striscioni, mentre un compagno, Michele (forse Santoro?), leggeva ad alta voce il libretto di Mao.
Ecco, da questo piccolo spazio bianco, da questo punto di vista datato e sinceramente confessato, e per nulla autocriticato, comincio a dire che Attilio Wanderlingh, il cui cognome continua a conservare un fascino misterioso (per questo lo siglerò AttilioW), ha scritto uno dei pochi libri che risponde alla domanda che apre la quarta di copertina: “è possibile narrare la generazione che ha fatto il ’68 e ha attraversato gli anni ’70, senza cadere nella retorica, o all’opposto nella cupezza?”. Non solo è possibile, sarebbe necessario e salutare mettere a confronto esperienze e riflessioni personali, individuali, che riuscissero a rendere più comprensibile la vicenda complessa e per nulla uniforme e monocorde di tanti protagonisti di quelle generazioni di militanti, giovani e meno giovani. Francesco De Sanctis ha scritto, in un saggio su George Gottfried Gervinus, lo storico tedesco neoliberale vissuto in pieno XIX secolo: “Verrà un tempo che il concetto di umanità sarà sostituito a quello di nazionalità: né però gli storici futuri avranno il diritto di censurare il movimento nazionale odierno” (“Saggi critici”, I, p. 226).
Ciascuno potrà cambiare i termini che ho indicato in grassetto con quelli che rappresentino, a suo avviso, il lessico forte delle ‘sostituzioni’ di questi ultimi quarant’anni, purché rimanga fermo l’assunto finale. Censurare a distanza è molto comodo, come anche ‘pentirsi’ e cambiare parere sui se stessi di allora. Diverso è, invece, come mi pare faccia AttilioW lucidamente, ripensare un periodo col filtro dell’oggi (che AttilioW battezza programmaticamente ‘disincanto’), cioè con le sue conseguenze storiche, ma senza perdere la sostanza profonda delle idee, delle ingenuità, delle forzature, e anche delle vere e proprie colpe dell’ieri. Il dibattito che si sta aprendo, ad esempio, sul film “Romanzo di una strage” di Marco T. Giordana, rischia davvero di riproporre difese e accuse stereotipate, in mancanza di voci meno retoriche e meno cupe (e più oneste intellettualmente).
Ma torniamo ad AttilioW e al suo racconto. Che è diviso in sei capitoli, i primi cinque internazionali (Morte per fucilazione, Acqua, Beirut, Carlos, Praga), solo l’ultimo, per così dire, più italiano: La contestazione. Il tempo del racconto non è lineare, non coincide con quello della storia, si va avanti e indietro sull’onda del ricordo. Ciascun viaggio, con i suoi pericoli e le sue ostinate progettualità, è una storia a sé, che però si lega agli altri con un filo rosso riconoscibile: la sensazione che lo scacchiere su cui muoversi politicamente, scoprirsi protagonisti della propria vita, potesse essere solo internazionale. L’idea che una manifestazione con i suoi slogan diretti o una riunione in una piccola sezione potessero condizionare azioni e decisioni in paesi lontani era introiettata e vissuta senza problemi. Sentirsi parte di un movimento internazionale e, a questo titolo, rivendicare il proprio diritto di parola, di giudizio e di intervento, prima ancora che essere valutato, a distanza, come ingenuità, furbizia o solo pessima retorica (ciascuno scelga), andrà riletto come esigenza sacrosanta alla lunga inevasa. Domande che restano e magari si incanalano oggi sul web, creando comunità altrettanto ‘ingenue’, per certi versi, sulle quali si discuterà fra qualche decennio (allora ricordiamoci di quello che ci muove e ci spinge adesso). Ma forse lo stacco, la frattura più forte che i racconti di AttilioW – le sue esperienze rischiose – mettono in luce, per chi le ricordi e ne scriva oggi, è la sensazione di due realtà che si muovevano parallelamente, quasi a rispecchiare i ragionamenti marxiani su ‘struttura e sovrastruttura’ sui quali ci si accapigliava in quegli anni.
E ‘noi’, forse, facevamo parte di quella realtà di superficie più visibile e loquace, e come tale più esposta alle manovre dell’altra, che continuava a organizzare e dirigere meno esposta. Quella che AttilioW fissa, nel capitolo sull’invasione sovietica di Praga (p. 100), come “la frattura fra la partecipazione corale della gente e l’impossibilità di uno sbocco politico, o meglio l’insostenibilità di un rapporto di forze fra chi aveva solo la voce e chi invece le armi”, potrebbe essere la realistica riflessione sull’esperienza di quegli anni in tanti paesi europei, in Italia in particolare. Solo che, chi pensò di ridurre questa frattura o alleviare l’insostenibilità mettendosi dalla parte delle armi, invece di tentare di ampliare il numero e il volume di quelle voci, finì con l’indebolire le voci stesse, oltre che mettersi dalla parte degli assassini, a quel punto davvero senza colore. Cicerone, nel passaggio cruciale fra repubblica e impero, auspicava che “cedessero le armi alle toghe”, alla parola degli oratori. Segno di un conflitto non risolto una volta per tutte, o forse non risolto mai.
I racconti di AttilioW, racconti individuali e collettivi insieme, mostrano come una parte importante di quella generazione continuò a scegliere la via delle voci, che rimane il patrimonio più prezioso affidato alle generazioni successive. L’urgenza di narrare, di tracciare bilanci, di esporsi agli altri anche quando si è meno sicuri e meno ottimisti, porta AttilioW a delimitare i suoi racconti con la cornice costituita dall’esergo pasoliniano e dalle ultime parole del libro. Entrambe queste voci definiscono il ‘disincanto’ del titolo. Pasolini scriveva ne “La religione del mio tempo”: …il doloroso stupore / di sapere che tutta quella luce, / per cui vivemmo, fu soltanto un sogno / ingiustificato, inoggettivo, fonte / ora di solitarie, vergognose lacrime”. AttilioW conclude (p. 127): “Tale era l’accaduto dell’epoca come io lo vissi, e nulla ancora si sapeva di questo nostro attuale diffuso grande niente”. Fra la luce di un sogno ingannatore e il diffuso grande niente non si saprebbe cosa scegliere: se il disincanto, appunto, che porta alle lacrime, o l’inerzia inattiva del nulla. Devo dire, però, che nelle ultime righe della quarta di copertina appare la risposta più vera e personale che lo stesso AttilioW si è data, e che forse fa anche del disincanto una fase passata, ‘sostituita’: “vive sei mesi all’anno in Africa per continuare a illudersi di fare qualcosa di utile”. Il disincanto uccide, se lo si blocca come momento fondante della propria vita, l’illusione attiva, fatta di obiettivi concreti e ‘sostenibili’ – come scavare pozzi per l’acqua per i villaggi dell’interno in Kenya – ricostruisce una interazione di cui possono avvantaggiarsi in molti. E non è detto che debba trasformarsi anch’essa in disincanto.
Nuovi autismi 18 – Le bugie degli scrittori
di Giacomo Sartori
 Nei miei testi cosiddetti narrativi ho scritto un mare di bugie. Ho scritto per esempio che mio padre è morto per aver mangiato molta verdura contaminata dall’incidente di Chernobyl, il che è una smaccata falsità. Certo mio padre ha mangiato tantissima verdura altamente radioattiva,
Nei miei testi cosiddetti narrativi ho scritto un mare di bugie. Ho scritto per esempio che mio padre è morto per aver mangiato molta verdura contaminata dall’incidente di Chernobyl, il che è una smaccata falsità. Certo mio padre ha mangiato tantissima verdura altamente radioattiva,
Gundam e Evangelion
Gundam e Evangelion, due paradigmi narrativo-commerciali dell’animazione nipponica
di Gualtiero Bertoldi
Sono oramai diversi decenni che l’animazione nipponica, nella fattispecie della serie televisiva a cartoni animati (o anime, per essere più precisi), si è diffusa nel mondo come forma di narrativa seriale a largo consumo. Con questo articolo si vogliono presentare due serie televisive che hanno avuto un grande impatto sia sulle modalità della narrazione televisiva, sia sulla cultura di massa giapponese, ponendole quindi a confronto fra di loro per dare conto non solo di un differente approccio alla narrazione, ma anche di una trasformazione più generale nel mercato legato a questi cartoni animati, e di come questi fattori si sono influenzati gli uni con gli altri.




 (Riceviamo e volentieri pubblichiamo. G.B.)
(Riceviamo e volentieri pubblichiamo. G.B.)