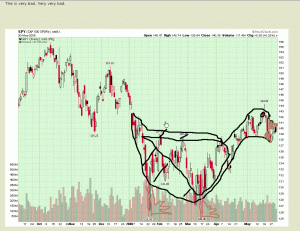di Chiara Valerio
Niente mappa delle strade. Bussola da tasca. Un perfetto labirinto. Strette. Chiuse, serrate. Se uno almeno potesse salire in alto sarebbe facile capire come uscirne. Se uno potesse arrampicarsi su un albero. Sovrastare il labirinto. Ma no. Strade senza nome, non meno anonime dei sentieri naturali che attraversano i boschi. Niente numeri. Niente di niente. Herman Melville. Ho sempre avuto una grande passione per i libri di avventura. Come credo tutti i bambini. Sono stata a Tortuga, nella giungla indiana, ho viaggiato sul Generale Grant e su una zattera sul Mississippi, ho assistito al mio funerale, e sono stata il Signore delle Mosche, sono andata fino Al faro e cavalcato il Fortunadrago, ho rinunciato all’anello del potere, ho sposato Wilhelmina Harcker, in due età diverse, e anche Lestat. Ho avuto una bussola, una mappa, un bastone da passeggio, un vestito da principessa e uno da Piccolo Lord. Ho impugnato una spada. Mi sono svegliata scarafaggio. Nonostante da bambina avessi atlanti, libri ed enciclopedie a disposizione, un microscopio e un cannocchiale e mi servissi di tutto con frenesia per visualizzare particolari sociali, geografici, celesti o entomologici, c’era sempre qualcosa che, rimanendo indefinito, permetteva alle mie paure, alle mie esitazioni, alle mie emozioni e ai miei bardi abbrivi di fare eco nella testa, di replicarsi. C’è qualcosa nei libri di avventure che è sempre anche qualcos’altro. I sentimenti che uno prova, suo malgrado, in questa città, ne guastano la bellezza. Chateaubriand. Da quando ho in mano Il romanzo di Costantinopoli (Einaudi, 2010) di Silvia Ronchey e Tommaso Braccini sono tornata la bambina dei romanzi di avventure alla quale sfugge (assai più di) qualcosa.