di Mariasole Ariot
Fotografie dal passato remoto – quando tutto è fermo, quando il tempo ricorda la sostanza



















* fotografie scattate alla Grotta Mangiapane, Sicilia (un mattino che non porta una data)
di Mariasole Ariot
Fotografie dal passato remoto – quando tutto è fermo, quando il tempo ricorda la sostanza



















* fotografie scattate alla Grotta Mangiapane, Sicilia (un mattino che non porta una data)

di Francesca Ranza
Al Bar Brera sta seduta una giornalista bionda della tv. È piena così di botox e si fa i selfie con una bambinetta – sarà la figlia, è la figlia – di nome Clarissa. “Clarissa, Clarissaa, Clarissaaa!” la chiama per farla guardare in camera. A Clarissa non importa di uscire bene in foto e la giornalista è preoccupata, molto preoccupata: con questo atteggiamento menefreghista non andrà da nessuna parte. Clarissa è distratta, guarda per aria, guarda i piccioni, guarda il golden retriver di una spin doctor ricoperta di auricolari dalla testa ai piedi che si è accaparrata uno dei posti in prima fila e ha l’aria di essere lì già da almeno due ore. Clarissa allunga una manina verso il cane, quando le sono venute queste dita così tozze, pensa la giornalista con orrore. La strattona, mette il filtro gatto. “Dai sorridi, ho messo il filtro gatto.” La spin doctor si gira, guarda Clarissa un po’ così; non è che i bambini le piacciono tantissimo, e comunque avere un cane è già parecchio impegnativo. Non solo perché tocca spendere un patrimonio in cibo per il cane, baby sitter per il cane, impermeabili per il cane. Ma anche e soprattutto perché il cane è il correlativo oggettivo di un ragioniere di Varese, grande appassionato di lettini abbronzanti, cocaina e magliette con le scritte (“Non mettermi alla prova”, “Startup”, “Uomini forti, destini forti”), schivato come una palla di cannone e non senza spargimenti di sangue nell’inverno del 2017. Adesso lui gestisce un negozio di sigarette elettroniche. Guardare il cane (si chiama Thor, naturalmente si chiama Thor) è come guardare in un multiverso di cristallo. Uno in cui lei sa tutto di sigarette elettroniche e niente della vita, uno in cui la cocaina è solo grigina e grumosa e non la polvere di fata bianca, etero e cisgender che gira nei bagni di Montecitorio. Ma Thor, povera creatura, non c’entra niente con quel disgraziato (è stato lui a regalarglielo, chiuso, tappato in una scatola di cartone rossa col coperchio, al collo uno di quei fiocchi tondi che si mettono sugli specchietti delle macchine ai matrimoni). “Clarissa se vuoi accarezzarlo devi chiedere il permesso alla signorina,” sibila la giornalista. Ma Clarissa se ne frega. In un attimo è a terra a quattro zampe, la faccia spalmata contro quella pelosa e bavosa di Thor. Se non fosse che le è costata una vaginoplastica in Svizzera, se non fosse che ha visto quel testone bitorzoluto uscire da lei stessa e strillare prima ancora che fosse uscito tutto il resto, la giornalista si chiederebbe di chi è figlia questa cinquenne goffa, lagnosa, leggermente in sovrappeso, che si comporta come un vandalo, si rifiuta di imparare le buone maniere, ed è ancora del tutto ignara di che cosa e quanto pericolosi siano i germi, i batteri, i bacilli, i funghi e tutto il resto che si può tirare su da terra o dal pelo di un cane pure se si è in via Brera. Fa per gridarle qualcosa, tipo “Clarissa vieni via subito da lì”, o “Clarissa non lo vedi che stai disturbando” o “Clarissa! ” e basta, ma la spin doctor ha attaccato una skype call. “Andrea? Pronto? … Dov’è che sei? … E fa caldo lì? Senti qui si muore … Pensavo di fare così: mandiamo lo stesso testo al sindaco e al prefetto. Mi sembra una buona… come si dice… sintesi! Una buona sintesi della situazione. … Anche per far vedere quello che abbiamo fatto, sennò sembriamo veramente inadempienti. … Allora d’accordo. … Ciao, ciao, cià, cià, cià.” La giornalista scatta come un puma, è ora o mai più. È adesso che deve tirare fuori quella selvaggia da sotto al tavolo e sperare che non si sia già presa le pulci o peggio. Ma la spin doctor è più veloce. L’ha riconosciuta, le dice “ma dai, ma che piacere, ma che coincidenza”, le dice che la ammira tanto, proprio tanto, che si ricorda di quando stava in parlamento. Con chi è che era in parlamento? “Ah vedi, che bel percorso”, dice la spin doctor. La giornalista è caduta nella rete come un moschino: c’ha quegli occhi tutti stellanti che vengono solo quando ripensi a un periodo in cui ti piacevi almeno duemila volte di più di quanto ti piaci adesso. Fosse anche solo perché era prima del botox, della vaginoplastica e di Clarissa, che ormai è sparita completamente sotto al tavolo, e la si sente solo grufolare e fare conversazione col cane e dire cose da bambina ipersensibile tipo “bel cagnolone, bello, bello, come. sei. bello. Ti voglio bene!”.
“…sono ancora una donna di destra, ma adesso sono un po’ più liberale. E non ho nessunissimo problema ad ammetterlo, ci mancherebbe altro. Ti dico, anche da parlamentare, io sono sempre stata molto sincera. E molto diretta. Forse anche troppo.”
“Eh, ma essere sinceri in politica non è che…”
“Ma appunto! Non paga, brava. Vedo che ci capiamo.” Clarissa, che a questo punto deve aver percepito una specie di vibrazione nella forza, un impercettibile calo ponderale nel livello di attenzione di sua madre per qualunque cosa stia combinando là sotto, sbuca fuori e scoppia in un pianto disperato. Spaesata, la spin doctor prova a chiudere il suo rituale di seduzione in fretta e furia. “Senti ma magari mi lasci il tuo numero? Così una volta…” Ma Clarissa sta gridando come un’ossessa, grida come se una banda di ragazzini in Fred Perry nera la stesse prendendo a calci di notte in un parchetto senza lampioni di Southwark. Grida che anche lei vuole un cane, che non è giusto, che lo vuole adesso, immediatamente. La giornalista prova a ignorarla ma è praticamente impossibile (certe cose a Brera sono un po’ più difficili da ignorare). “Guarda facciamo un’altra… CLARISSA! Clarissa piantala. Vieni, andiamo dal giornalaio, ti compro un…”
“Ma certo, certo. Ciao ciao Clarissa, è stato un piacere conoscerti!”, tuba la spin doctor agitando la mano. Stupida bambina. Stupida bambina viziata e stupida.
*
Sul sedile dietro di una macchina blu coi vetri oscurati, Clarissa chiude gli occhi e sogna. Ma non dorme, quindi non sogna, ma le sembra di stare sognando. Nel sogno ci sono i cinque biscotti Digestive che ha mangiato stanotte in piedi, in mutande, di fronte al mobile bar di una stanza d’albergo brutta e gelida e identica spiccicata a tutte le altre che ha visto. Quante ore di corsa ci vogliono per bruciare le calorie di cinque biscotti Digestive? Clarissa non lo sa di preciso, ma devono essere almeno un milione di ore. Ci sono cinque uomini vestiti per bene – la giacca, la cravatta e tutto il resto – che escono dalla sua stanza in fila indiana. Le danno la buonanotte e sorridono, ma poi la lasciano lì sul letto, da sola. Ci sono le sue foto dappertutto su internet. Quando mi sono venute queste cosce così grosse pensa Clarissa con orrore. C’è Anne Sophie nel bagno delle femmine al liceo. Ha uno spazzolino da denti in mano, dice “per vomitare lo devi infilare in gola almeno fino a qui”. Ma Clarissa non impara mai a vomitare. C’è il prossimo albergo dove la porteranno. Spera che dentro ci sia una palestra, o almeno un vecchio tapis roulant, o almeno una sauna dove tapparsi a sudare via tutto. I sensi di colpa, i biscotti Digestive. Mica si può sudare via un biscotto. O sì? C’è uno – è alto e bello e la fa ridere e qualche volta le legge delle poesie – che non si trova più da nessuna parte. Sparito. Puf. Se si potessero sudare via i biscotti. Se lui ci fosse ancora. Il tizio che guida la macchina – potrebbe essere lo stesso di ieri, sì potrebbe – spegne il motore. “Siamo arrivati, Presidente” dice. Ma Clarissa non si muove.

di
Claudio Loi
PLAYLIST 2024. 15 album da sentire ( e ascoltare )
15 album in rigoroso ordine alfabetico per ricordare il 2023 e affrontare le insidie del quotidiano con il piglio giusto. Perché la musica, quella giusta, è la migliore medicina che si possa trovare sul mercato. Buon ascolto!
Algiers. Shook (Matador)
Il quarto album della band è una conferma assoluta e un nuovo punto di partenza. Un disco che raccoglie i frutti della semina di questi anni e ci consegna una band difficile da inquadrare, sospesa tra umori post-punk, una forte componente black e una voce che non ha eguali. Tutte queste belle cose convivono in perfetto equilibrio e la rabbia che trapela da queste canzoni non e mai fine a sé stessa. Una band necessaria e imprescindibile.
https://algierstheband.bandcamp.com/album/shook
Altin Gün. Ask (Glitterbeat)
Ascoltare questa musica ci fa rimbalzare in un loop temporale che comprende la psichedelia degli anni Settanta, le lontane derive elettriche ed elettroniche tipiche della controcultura di quella che un tempo si chiamava mitteleuropa, i corrieri cosmici, la diaspora turca e un leggero senso di stordimento psicotropo. Sono turchi ma sono anche olandesi, sono fieri portatori sani di miti e leggende che furono ma sono anche figli di questi tempi e proiettati in un futuro incerto. È la musica giusta per capire il grande caos del pianeta, aprire la mente e stimolare i sensi.
https://altingun.bandcamp.com/album/a-k
Aphex Twin. Blackbox Life Recorder 21f (Warp)
Le ultime prove discografiche di Aphex Twin sono lontane nel tempo ma sono ancora dei parametri estetici su cui ragionare e queste poche tracce non spostano di molto la sua biografia. Ma è sempre emozionante capire cosa frulla nella testa di questo signore, entrare nel suo mondo frammentato, spezzato, confuso, nervoso e percepire un forte senso di angoscia e turbamento. La sua storia è stata raccontata in modo sublime da Valerio Mattioli e queste nuove composizioni potrebbero essere una buona scusa per andare a rileggere quelle pagine. E poi dalla Warp non arrivano mai cose scontate così come non lo è questa musica che ad ogni ascolto rilascia nuove sensazioni.
https://aphextwin.bandcamp.com/album/blackbox-life-recorder-21f-in-a-room7-f760
Bar Italia. Tracey Denim (Matador)
Sono di Londra, se la tirano da morire (e ne sono ben coscienti), sanno come ci si deve muovere tra i meccanismi dello showbiz, non fanno nulla di nuovo ma lo fanno benissimo. E poi con quella ragione sociale toccano le corde del nostro orgoglio italico così come succede anche con Italia 90 altra band dal nome piuttosto strano. Detto questo suonano freschi, citano bene le opere passato, hanno un suono piacevole e ben educato e sono lanciati verso un futuro radioso. Nel 2023 hanno addirittura pubblicato due album ma questo è quello che preferisco, quello che fa risaltare meglio la voce di Nina Cristante e il mixing di Marta Salogni (altra gloria italica in fuga dal belpaese). Se siete alla ricerca di un bar nel quale soffocare le vostre angosce Bar Italia è il posto giusto.
https://baritalia.bandcamp.com/album/tracey-denim
C+C=Maxigross. Cosmic Res (Dischi Sotterranei)
Sono di Verona ma questo è un particolare di poco conto. La loro musica è tanto italiana quanto figlia di umori e sapori che arrivano da altre latitudini, non solo geografiche. Questo nuovo album ha il sapore agrodolce della perdita, di un amico caro che non c’è più almeno nella sua manifestazione terrena. Miles Cooper Seaton ci ha lasciati nel 2023 ed è difficile prenderne atto ma è anche giusto accettare il destino di essere umani. Conta invece che si potrà contare sulle sue idee, sulle sue intuizioni, sulla sua voglia di esplorare e quest’album è il giusto tributo a un artista che ha lasciato un grande patrimonio culturale. Loro sono forse più apprezzati fuori dalle nostre terre a conferma di un suono che va oltre l’appartenenza a un perimetro definito e diventa messaggio universale. Psichedelia di grana fine, testi molto accurati e incursioni elettroniche nella giusta proporzione e un incedere svagato e meditativo. Come sarebbe piaciuto a Miles.
https://ccmaxigross.bandcamp.com/album/cosmic-res
Fire! Orchestra. Echoes (Rune Grammofon)
Mats Gustafsson chi ha abituati a cose sempre fuori dal comune e in questo frangente riesce persino a stupire sé stesso. Ha coinvolto quarantatré musicisti per oltre due ore di musica che va oltre quanto già avevamo appreso dalle sue lezioni. Si respira aria di sperimentazione tosta, di libertà creativa controllata e disciplinata, di qualcosa che parte dal jazz e approda verso lidi che profumano di post-rock, di avant-jazz, di free forms, di ambient, di avanguardie di questo e dell’altro secolo. Un’opera monstre che non possiamo permetterci di ignorare e sottovalutare. Operazioni come queste se ne sentono poche e hanno bisogno di tutte le nostre cure e attenzioni.
https://fireorchestra.bandcamp.com/album/echoes
Iosonouncane. Qui noi cadiamo verso il fondo gelido (Concerti 2021-22) (Tanca)
Quello che vale per Gustafsson vale anche per Jacopo Incani nel quale ritroviamo la stessa voglia di sfidare le leggi del conosciuto e proporre opzioni estetiche sempre fuori margine. Il nuovo disco è una raccolta di brani registrati dal vivo negli ultimi anni ma non è il classico album live che da sempre ha caratterizzato la scena rock e si palesava come una sorta di “il meglio di…”. Qui è tutto diverso e pensato in altre direzioni: la maggior parte dei brani sono inediti e quelli già editi hanno nuove sembianze. Il disco raccoglie tre anni di concerti in giro per l’Europa con formazioni diverse ma con lo stesso respiro e con la solita e ostinata ricerca di qualcosa di sempre inedito con un suono che ormai è riconoscibile e certo. Si respira ancora qualcosa della Sardegna ma è tutto più sfumato e filtrato da correnti elettriche che devastano e destrutturano. Un suono possente e imperioso caratterizzato dalle macchine, una lunga e solenne marcia verso non si sa dove e forse non è questo l’importante. Quello che conta è la manifestazione di un artista che non si accontenta e continua a sfidare le leggi della musica e della vita.
https://www.deezer.com/it/album/510910521
Daniela Pes. Spira (Tanca)
Una delle più belle sorprese di questo 2023 non a caso ospitata nella stessa Tanca di Iosonouncane. Daniela Pes è rimasta in silenzio per un bel po’ di tempo e si capisce perché. Aveva bisogno della giusta concentrazione per capire da che parte andare, trovare le persone giuste e il giusto mood. È giusto così se credi in quello che fai e lo vuoi far diventare parte integrante della tua vita e Spira è la migliore risposta a tutti i nostri dubbi. Al disco è seguita una lunga serie di concerti e persino il prestigioso riconoscimento della Targa Tenco come miglior Opera Prima a conferma di un lavoro che va oltre le migliori aspettative. Una voce fuori dal coro di indiscutibile valore assecondata da una produzione attenta e responsabile, una lingua nuova che si fa accompagnare da umori elettronici mai invadenti o fuori misura. Si re/spira da queste parti la gelida brezza del maestrale e si trova conforto in una tanca che è ormai un approdo certificato.
https://trovarobato.bandcamp.com/album/spira
PJ Harvey. I Inside the Old Year Dying (Partisan)
Una delle poche certezze nella nostra vita di discopati impenitenti. Difficile trovare punti deboli in una carriera iniziata alla fine degli anni Ottanta e costellata di perle di inestimabile valore. E allora dobbiamo arrenderci alla sua grazia e riconoscere che ci si trova di fronte a un artista fuori dal comune e anche questa nuova uscita assurge a livelli che pochi artisti si possono permettere. Tutto questo fatto con poche semplici mosse: gli amici di sempre, una produzione non troppo invadente che privilegia la presa diretta per preservare la sacralità dell’esecuzione, un maniacale lavoro sulla lingua e poco altro: solo un infinito e smisurato talento e un continuo impegno ad arrivare all’essenza delle cose, abbandonare il superfluo e sdraiarsi in attesa che il tempo faccia la sua parte come quel ramoscello della copertina levigato dalla vita che passa. Poco altro da aggiungere se non lasciarsi stordire da questa magia che profuma di infinito.
https://pjharvey.bandcamp.com/album/i-inside-the-old-year-dying
Rozi Plain. Prize (Memphis Industries)
Ancora una voce che arriva dalle brume inglesi e che all’anagrafe è registrata come Rosalind Leyden. Il suo nuovo album è passato quasi inosservato da queste parti e invece merita più di un ascolto distratto. Composizioni sono fragili racconti di vita quotidiana, stanze segrete dove riporre segreti e paure ancestrali. Pochi ingredienti, quelli giusti e ben calibrati, minime sfumature di suono e suffumigi elettronici che aiutano a respirare meglio. Tutto appare sfumato, delicato e leggero, una sorta di minimalismo che parte dalle pieghe dell’anima e si disperde come incenso nell’ambiente. Se si dà uno sguardo alle tante collaborazioni presenti in questo disco ecco che tutto prende altre forme e si apprezza ancor di più il valore di quest’opera. Un ascolto che è paragonabile a quello che si prova quando ci si immerge una pozza di acqua calda e osservare le stelle sopra e dentro di noi.
https://roziplain.bandcamp.com/album/prize
Sleaford Mods. UK Grim (Rough Trade)
Ogni nuovo lavoro degli Sleaford aggiunge qualcosa di nuovo a un format che solo in apparenza è sempre uguale a sé stesso. La formula è quella consolidata e ben sedimentata con Simon Parfrement impegnato a costruire un tappetto di suoni e rumori, di beat accattivanti, rimandi a piè di pagina sempre in funzione della voce di Jason Williamson che è quando di più punk sia dato da ascoltare negli ultimi anni. Ma questa volta la coppia che appariva chiusa e inossidabile si apre a nuovi amici e conoscenti e allora è un vero piacere verificare come l’aprirsi all’altro aggiunge sempre qualcosa di nuovo. God save the Sleafords.
https://sleafordmods.bandcamp.com/album/uk-grim
Squid. O Monolith (Warp)
Un disco che spiazza nella sua imperscrutabile appartenenza a tutto e a nulla. I dischi precedenti lasciavano intuire una vocazione al caos e all’anarchia stilistica ma con questo nuovo lavoro si è andati molto oltre. Il monolite che rimanda a odissee spaziali è stato divelto, frantumato, sbriciolato in miriadi di nuove ontologie sonore. Si respira da queste parti il buo profumo del post punk appena sfornato che subito viene superato da gelide correnti di new prog, di math rock insolente, dal jazz più catastrofico e da una spavalda attitudine alla provocazione. Forse è solo punk sotto nuove forme o forse è solo Squid che in questo momento sono unici è inimitabili. Anche da se stessi.
https://squiduk.bandcamp.com/album/o-monolith
The Gaslamp Killer meets The Heliocentrics. Legna (Cuss)
Vederli dal vivo è gioia pura. Si retrocede a uno stato di primitiva euforia trasportati dai ritmi e dalle soluzioni armoniche proposte dalla migliore sezione ritmica del pianeta. Malcom Catto e soci sono gli artefici di un progetto sempre aperto e in progress e ogni collaborazione si spinge nel trovare il beat giusto per ridefinire i termini della questione. Terzomondismo senza sconti, afrofuturismo, funky di quello buono e passione che trasuda da ogni colpo di bacchetta. Ma affiora anche il motorik di krautiana memoria, certe epifanie di freak jazz e una infinita voglia di essere felici semplicemente percuotendo le pelli dei tamburi. Come quella scimmia del caro Kubrick.
https://thegaslampkiller.bandcamp.com/album/the-gaslamp-killer-meets-the-heliocentrics-legna
Yalla Miku. Yalla Miku (Bongo Joe)
Se passate a Ginevra fate un salto alla sede della Bongo Joe che si trova in un’isoletta nella parte finale del grande lago. Un tempo questa era una zona industriale poi la città ha cambiato aspetto e questi spazi sono stati messi a disposizione e riconvertiti in luoghi di aggregazione, sale per concerti, centri sociali. In uno di questi isolotti si trova proprio la sede della Bongo Joe con un enorme negozio di dischi, uno spazio sociale, un bar, una terrazza esterna nella quale spesso è possibile assistere a concerti e performance varie. Poi è arrivata la Bongo Joe Records il cui catalogo è decisamente cool e pieno di belle cose che vanno dalla sperimentazione post accademica della Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp a cose più legate ai suoni del mondo. Una delle cose più interessanti proposte da Bongo Joe in questo 2023è il disco degli Yalla Miku che raccoglie musicisti in fuga dal proprio mondo e che in questo spazio hanno trovato rifugio e possibilità di espressione. Un disco di ritmi e suoni senza patria che guarda avanti cercando di smaltire le scorie di un universo in forte crisi.
https://yallamiku.bandcamp.com/album/yalla-miku
Yo La Tengo. The Stupid World (Matador)
Difficile parlare di questa band senza cadere nelle banali considerazioni che si fanno di fronte ad artisti che il tempo non scalfisce e non turba. Bisognerebbe chiedere a loro come si fa a essere sempre in tiro dopo quasi 40 anni di onorata carriera, a essere sempre sul pezzo, a non ripetersi e soprattutto a far sembrare tutto molto semplice e naturale. Forse è l’aria di Hoboken o qualche medicina magica che noi non conosciamo. Non è dato sapere ma di certo questa musica fa bene al corpo, all’anima e in qualche modo ci tiene vivi e più felici. Fossi un medico prescriverei una dose giornaliera di Yo La Tengo a tutti i miei pazienti.
https://yolatengo.bandcamp.com/album/this-stupid-world
Yousef Elqedra
“Quattro sotto le macerie… yàmma quanto sono belli”.
Nido e Pampers
“Ho ritirato il Nido e i Pampers”, racconta un padre con immensa gioia mentre torna dalla moglie portando una scatola di Nido e una confezione di Pampers per i bambini.
Ti chiederai forse “Com’è che questa cosa merita così tanta gioia”? La risposta è che sì, Nido, il latte in polvere, significa vita per un neonato nei giorni che vengono, e i Pampers vogliono dire la salute di quel bimbo. Le mamme sono state costrette a sostituire i pannolini con un qualsiasi pezzo di stoffa a disposizione, e questo ha provocato strane malattie della pelle; non ci sono i medici per occuparsene nelle condizioni di una “guerra maledetta” che non produce se non ferite gravi e martiri, quindi le madri hanno dovuto affrontare la situazione arrangiandosi con un latte in polvere qualunque oe qualsiasi cosa tornasse utile.
Una cesta alimentare per una settimana
Due scatole di fagioli, una di carne in scatola, due bottiglie di acqua, due vasetti di miele nero e due confezioni piccole di formaggio: questa è la razione che spetta a una famiglia con un numero medio di almeno sette persone. Viene portata alla famiglia da un padre sfollato che ha perso la casa, ed è felice di averla ricevuta. “Finalmente berrò un sorso di acqua dolce”, dice, come se avesse raggiunto il paradiso. “Bontà e benedizioni”, così descrive lo scatolame contenuto nel cartone arrivato come parte degli aiuti passati dal valico di Rafah alla Mezzaluna Rossa Palestinese a Khan Yunis. Sulla parte anteriore del cartone si legge il mittente: Banca alimentare egiziana. “Il cibo si può dividere e può bastare per tutta la prossima settimana”, dice l’uomo, aggiungendo: “Il problema resta il pane”.
Una pagnotta intera
“Solo le donne ce la possono fare!” esulta una donna appena tornata dalla fila davanti al panificio, portando con sé diversi filoncini di pane raccolti in un fascio. È una grande vittoria, come potete immaginare. Con questo fascio di pane, la donna ha provveduto al cibo della famiglia per l’intera giornata, e forse ne rimangono avanzi per la colazione del giorno dopo, fosse fatta anche solo di “pane nudo”, poiché l’economia nel cibo è una necessità assoluta; “wallah sono uscita all’alba, perché i piccoli sono andati a letto senza cena”, dice la donna per spiegare la sua gioia.
Sì, queste piccole vittorie e conquiste sono significative nella vita collettiva, e questo è un popolo che, all’ombra della morte, ama la vita con tutte le sue forze.
Si può lasciare il proprio cuore in un posto?
“Siamo usciti dall’inferno dei missili, del fuoco e della devastazione per arrivare all’inferno della vita. Si entra in bagno in fila, si prende il pane in fila, il cibo scarseggia, si dorme a turni a causa dello spazio ristretto e della scarsità di letti, persino bere acqua potabile richiede un miracolo”, dice una donna di cinquant’anni sfollata da Gaza in un rifugio a Khan Yunis. E aggiunge: “Spero nella shahada da Dio”.
Mentre tenti di consolarla con due parole gentili, scopri che dal suo cuore a porte spalancate è uscito un inferno, al punto di sentirla dire: “I miei nipoti sono sotto le macerie. Non sappiamo se sono vivi o morti, e non sappiamo se li hanno trovati e sepolti, o se sono rimasti là sotto.” Tace per un momento poi riprende, mentre due lacrime le brillano negli occhi ma si rifiutano di scendere: “Quattro… yàmma quanto sono belli, sono ancora piccoli, mi si spezza il cuore, non volevo lasciarli soli e andare via. Mi hanno portata via con la forza. Si può lasciare il proprio cuore in un posto e tuttavia dover continuare a fuggire?”
Sono 1250 i bambini dispersi sotto le macerie, secondo il Ministero della Salute. Sono 1250 le storie di dolore e sofferenza, e la sensazione è che il mondo sia in via di estinzione con la morte brutale di bambini innocenti, che lascia nella desolazione più totale i cuori dei loro familiari sopravvissuti.
“wallah yàmma solo coloro che sono andati dal loro Signore, si sono salvati. Il loro Signore è più misericordioso con loro che questo mondo ingiusto. Noi che viviamo moriamo mille volte al giorno. Moriamo mille volte yàmma.”
Abbiamo bisogno di farina
“Hanno polverizzato il paese, distruggendo il verde e il deserto”, racconta un ventenne tornato deluso dal suo errare alla ricerca di un panificio ancora aperto, per portare almeno una pagnotta alla famiglia. Qui tutti i panifici della zona hanno smesso di funzionare come forni, non c’è gas, distribuiscono la farina alla gente che fa quel che può, cioè impasta e cuoce il pane, si gestisce da sola,” aggiunge esasperato. Un altro replica che c’è una panetteria ancora attiva nel centro della città, ma la gente si accalca raggruppandosi come in un’immagine in miniatura del Giorno della Resurrezione.
“Dai, andiamo. Dove esattamente? Daremo dei biscotti ai bambini. Sono due giorni che non mangiano pane.”
Si sono diretti verso una panetteria che si diceva fosse ancora in funzione, sapendo che li aspettava la lunga attesa, dalla quale non vi è scampo.
Le memorie di Gaza sono la vita sospesa rimasta dopo tutta questa morte, dopo lo sfollamento e la malinconia, o ciò che resta della vita che tenta di continuare in condizioni che ad essa non sono adeguate: sono più adatte alla morte.
*
Yousef Elqedra è un poeta palestinese residente a Gaza. Su Nazione Indiana appare nella traduzione di Sana Darghmouni e Pina Piccolo.

di Neil Novello
Inanna è una dea sumera. Il suo nome, così magico e arcano, appare tra i segni cuneiformi di tavolette d’argilla. Diversi tra loro i luoghi di apparizione. Le epifanie della dea riguardano il mito, l’epica, l’inno, il salmo, l’elegia funebre e la favola. La sua presenza è dunque una costante diffusa tra mille frammenti e altrettanti passi scritti su antiche crete sumere. E così le sue gesta, testimoniate pressoché ovunque nell’antica civiltà letteraria orientale, fondano un mondo. Per il sumerologo Samuel Noah Kramer, Inanna è la «divinità sumera più amata e venerata». Sotto il segno del femminino, si è dinanzi a una dea in cui vive l’intera cultura di Sumer, perché Inanna è inscritta nella totalità di cielo, terra e oltremondo.
I canti di Inanna regina del cielo e della terra (trad. it. Franco Marano, prefazione Maria Edgarda Marcucci, Mimesis, 2023) è l’esito filologico di una selezione eterogenea, o meglio dell’acribia filologica di cui Kramer rende ragione nel saggio in appendice intitolato Scoperta e decifrazione di “La discesa di Inanna”. Si tratta di una congerie di materiale letterario, nel lavoro di raccolta da parte di Kramer, a carattere monografico. Esso appartiene, tra l’orizzonte divino e la vicissitudine umana, alla dea come simbolica interezza dell’identità sumera. Ma non solo. Per mano di Diane Wolkstein, studiosa del folclore e «narratrice», I canti di Inanna, cioè il materiale “grezzo” raccolto da Kramer, assumono, tramite un lavoro a bulino, una «forma» letteraria. Un’opera di rassemblement, di culta amalgama genera infine un compiuto tracciato in versi. Modellando in poesia i frammenti sparsi di Kramer, Wolkstein traduce lo spurio in sublime. Alla fine, le tracce sulle tavolette ad arte sono sottratte al loro carattere multiforme e disarticolato, e trattate come materia di pura ricostruzione versificata. Oltretutto, a Wolkstein è da tributare un encomio anche per il brillante commento critico al lavoro. La sua bellezza emerge dall’articolato, meraviglioso saggio d’appendice intitolato Interpretazione delle storie e degli inni di Inanna.
Inanna risale i millenni. E con la dea la mitologia del suo nome: regina del cielo e della terra, madre degli animali e delle piante, responsabile della fecondità umana. Dopo la sua nèkyia archetipica, Inanna ha attraversato la totalità: dapprima il cielo e la terra, e alla fine il mondo infero. Tutta la natura, la natura fisica e la metafisica, è il luogo del suo regno aperto. E la storia di Inanna, un Bildungsroman poetizzato nel «Ciclo» di Wolkstein, ormeggia il cammino di una vita: L‘albero di huluppu o le tracce della dolorosa formazione all’amore e la conquista del potere, Inanna e il Dio della Saggezza o il momento della «regalità», Il Corteggiamento di Inanna e Dumuzi, cioè la storia d’amore tra la dea e il pastore, l’uomo destinato a diventare Re di Sumer, La discesa di Inanna e il suo viaggio nell’oltretomba, e infine Sette inni a Inanna o le forme di venerazione della dea.
L’arco esistenziale di Inanna è dunque un racconto poetico per frammenti, una narrazione a schegge in cui Wolkstein tratteggia una biografia divina. L’esperienza di eros e del potere, nell’Albero di huluppu, eco palese dell’ebraico Albero della vita, emerge come un fatto, il primo, della Creazione. Nei «giorni primi», nei «primissimi giorni» della nascita del mondo, quando il «Padre fece vela,/Enki, il Dio della Saggezza, fece vela per l’oltretomba», il sentimento di eros e del potere infiamma Inanna. E la lotta aperta con la natura, il conflitto tra le «acque dell’Eufrate» e l’«albero di huluppu», strappato da Inanna al fine di essere portato con sé, fa dell’«albero» sacro l’oggetto di una contesa sovrumana tra il «serpente» e l’«uccello Anzu» che lo abitano, e «Lilith» che «fece del tronco la sua casa». «Io trassi l’albero dal fiume/E lo portai nel mio giardino sacro», nella confessione di Inanna al fratello Utu, che però le rifiuta il soccorso in occasione della pericolosa occorrenza, esprime la testimonianza vittoriosa di una donna non defraudata, non violata nella sua innocente volontà di unione simbolica. La riconquista della res amissa è affidata a Gilgamesh, l’eroe della celeberrima Epopea, il fratello «guerriero» di Inanna, che nell’«albero di huluppu» intaglia proprio il grande sogno della sorella, il «trono» del potere e il «letto» d’amore. Con il «trono» tratto dall’«albero di huluppu», come in una metamorfosi mitologica, nella biografia poetica di Inanna Gilgamesh introduce il suo momento più regale. Dall’«albero di huluppu» sgorga dunque un destino, si genera un atto di creazione divina. Esso origina da un desiderio, ricercare il «Padre», il «Dio della Saggezza» Enki, di cui Inanna è la «figlia». E ciò per ratificare, nella realtà del «trono regale», l’eredità del potere attraverso il simbolo dei «me». Essi sono i diversi poteri del regno di Inanna. Troviamo qui i «me» della «discesa nell’oltretomba», il topos esemplare di La discesa di Inanna. Conquistare il destino, nei Canti significa attraversare il conflitto, avallare la pulsione della libido dominandi. Per Inanna, i «me» sottratti a Enki identificano, come il sentimento dell’amore e del potere, la presa di coscienza che il potere reale equivale non a un bene ma alla catastrofe del mondo. Genera dunque un disastro, da parte del derubato Enki, sia il tentativo di carpire a Inanna la «Barca del Cielo» con i «me» sia la volontà di ricondurre nuovamente a Eridu, il paese di Enki, tutti i poteri ormai giunti a Uruk, il paese di Inanna.
Il seme del potere è fiorito nella conquista dei «me», quello dell’amore è espresso nel Corteggiamento di Inanna e Dumuzi. È il pastore sumero a conquistare Inanna, il cui infausto destino, di essere cioè perseguitato, dopo la sua discesa, dai «galla» infernali, replica, dopo Inanna, il rischioso viaggio nell’«oltretomba». L’intreccio di parole tra Inanna e Dumuzi, l’aspra levità del corteggiamento, genera l’amore: «La parola che avevano detto/Era la parola del desiderio/Dal loro attaccar lite/Venne desiderio di amarsi». Il Leitmotiv belligerante dei Canti, riflesso nell’orizzonte tumultuosamente carnale degli amanti, espone una scena d’amore alla maniera di una tenzone, un andirivieni tra canto e controcanto. Una tenzone nata nel segno palese di un’esposta carnalità, un incontro naturale, spontaneo, tra il «cedro» di Dumuzi e la «vulva» di Inanna. Gli oggetti sessuali diventano i simboli di due anime riunite, non soltanto sul talamo del loro incontro erotico ma nella più splendida scena della loro unio mystica. I Canti allora sono attraversati da un èmpito di corporale spiritualità, qualcosa che ricorda la levità amorosa del Cantico dei cantici.
Il nomos del mondo terrestre nei Canti risponde alle più misteriose regole di una sacralità celeste. Il mondano si spiega alla luce dell’oltremondano. E così La discesa di Inanna nel «Grande Infero» appartiene più a un’esperienza interiore, meno alla mistificazione letteraria di un viaggio reale. La «sacerdotessa» Inanna, che approda nell’«oltretomba» al termine di un volo sciamanico, così avrebbe amato scrivere Mircea Eliade, è munita dei «sette me». Sono i suoi più grandi poteri sacri, le potenze utili ad arginare il pericolo non già di morire, protetta com’è, Inanna, da «Enlil» e «Nanna», e soprattutto da «Enki», ma di non ritornare sulla terra. Di restare laggiù, come per altre ragioni accade a Euridice.
Nel saggio di Samuel Noah Kramer, in appendice al volume, Storia, cultura e letteratura sumera, si legge qualcosa in più sui me. Essi sono anche un «complesso di regole e di limiti universali e immutabili», una sorta di cifra del vivente, la stessa lingua del mondo creata sia per l’uomo sia per gli dèi. Il viaggio con i «me» non è senza ragione. La regina di Sumer vola nell’oltretomba per «Gugalanna», nientemeno che per lo sposo morto della regina degli Inferi, «Ereshkigal», la sorella di Inanna. Il passaggio nell’aldilà richiama in Inanna l’immaginario sacrale, i «riti funebri» mancati proprio al venerato «Gugalanna», così com’è per il mito greco. Un afflitto Sisifo nell’oltretomba confessa ad Ade che la moglie Merope non gli ha ancora reso gli onori funebri. Al di là dell’ideale agnizione, anche Rizieri Mercatante, nel romanzo l’Ultima erranza di Giuseppe Occhiato, senza «riti funebri» perdutamente vaga nel «mondo sottano». La sua dolente erranza, non diversa da quella di Sisifo, si spiega alla luce del topos sumero. Così l’assenza dei «riti funebri» come momento dissacratorio del sacro, in Inanna è un monito alla risacralizzazione, la via ai «riti funebri» come liberazione interiore. L’immaginario sacrale di Inanna, nei Canti, giustifica culturalmente il viaggio. La dea opera all’interno di una religiosità originaria, un’idea di sacralità per cui i «riti funebri» in onore di «Gugalanna» valgono più del rischio di non ritornare sulla terra. Al cospetto di «Ereshkigal», il nostos di Inanna è però pregiudicato. È una donna nuda quella che oppone il sogno del sacro alla violenza del potere oltremondano della regina infernale. Per accedere agli inferi, Inanna ha dovuto rinunziare forzatamente ai «me», rinunziarvi pur di coronare il desiderio dei «riti funebri» per «Gugalanna». E ancora per ricondurre la realtà al livello dell’immaginario religioso. La sua rivoluzione nell’aldilà resta più ideale che reale. Combattere la legge infernale ritrovandosi inerme, senza «me», a Inanna costa un passaggio inatteso, essere cioè degradata a «cadavere» solo per conquistare una duplice salvezza. Dinanzi a «Ereshkigal», Inanna muore. La sua resurrezione e il suo ritorno sulla terra tramite l’intercessione del gabbato «Enki», che salva Inanna per mezzo dei suoi emissari «kurgurra» e «galatur», non testimonia l’inutilità del viaggio. Chi raggiunge «Ereshkigal» per gratificare il proprio immaginario sacrale, e dunque volare nell’aldilà per rendere i «riti funebri» a «Gugalanna», opera per difendere l’ordine culturale, la religiosità profonda del proprio mondo. Quella di Inanna è dunque una caparbia fedeltà alla credenza, l’atto estremo e testimoniale di una difesa del magico al di là della propria vita. Ricomporre l’ordine infranto dell’immaginario sacro di Inanna, nella rivoluzione mancata, riafferma il senso di una presenza, quella per cui la realtà religiosa di una cultura, fedelmente perseguita, è destinata a durare oltre ogni possibile fine.
di Giacomo Sartori

L’agricoltura ha sempre cercato i suoli migliori, e per gli arativi i coltivatori andavano a caccia delle terre più fertili e più soffici, con meno problemi possibili. A livello planetario non c’era di meglio di quelle delle grandi piane di sedimenti fini portati dal vento, il loess, presenti nell’Europa nord orientale, in Cina, nelle Grandi Pianure statunitensi e nella Pampa argentina. Generosamente dotate di elementi chimici, con una capacità di immagazzinare una notevole riserva di acqua, e facili da lavorare. Molte di queste zone privilegiate sono coltivate in modo intensivo da millenni, e hanno alimentato e reso possibili le grandi civilizzazioni. Ma anche tutte le piane alluvionali o di altro tipo, erano ambite, laddove non ci fosse un eccesso di acqua.
Le agricolture tradizionali sapevano però adattarsi anche alle situazioni meno fortunate, vale a dire alle terre in pendenza, e/o non molto profonde, pietrose, troppo argillose o troppo sabbiose, povere di elementi, mal drenate, e insomma per qualche motivo problematiche. Questi sono la grandissima maggioranza, e anche adesso nutrono, lo si dimentica sempre, la maggior parte della popolazione mondiale. Lo facevano adeguando tecniche colturali e varietà vegetali impiegate alle specificità dei vari angoletti dei differenti territori, e ai loro suoli, escogitando soluzioni puntuali. Se per esempio le superfici erano troppo pendenti, si costruivano terrazzamenti sostenuti da muretti a secco, in modo da ottenere, recuperando la terra buona, minuscole pianure artificiali. Se erano troppo magre si portava ogni anno molto letame, o si privilegiavano specie poco esigenti, se c’erano troppe pietre le si riunivano in mucchi o strisce, e via dicendo.
Le cose sono cambiate radicalmente con la meccanizzazione, perché i mezzi agricoli non possono lavorare bene nei campi troppo piccoli, o troppo in pendenza, troppo pietrosi. Questi si trovavano quindi impossibilitati a salire sul carro dell’epocale rivolgimento, e nel giro di pochi decenni sono stati tagliati fuori dal nuovo corso. Anche per un altro motivo: la selezione genetica che ha accompagnato il dilagare delle macchine sfornava varietà vegetali molto produttive, ma calibrate solo per le situazioni migliori. Dove i terreni erano poverelli, o siccitosi, queste stesse si rivelavano un completo fallimento. Una fuoriserie superveloce entra subito in crisi, su una stradina di montagna, dove un vecchio macinino robusto e facile da riparare si rivela invece un portento.
Di fatto l’agricoltura industriale considera buoni i suoli che permettono di dare grasse produzioni con le tecniche che impiega, uguali dappertutto, che considera le uniche possibili. Non importa che essi abbiano grosse limitazioni, se queste possono essere corrette con i potenti mezzi di cui dispone, e in particolare con la sua arma più micidiale, i composti chimici. Questi sono nello stesso tempo la cura e l’elemento aggravante, perché permettono di nascondere temporaneamente i danni fatti, pur fiaccando le terre. E poco importa che i rimedi richiedano molta energia di origine fossile, l’essenziale è che nei tempi brevi i guadagni superino i costi. Fino a poco fa i combustibili non costavano nulla, nessuno si dava pensiero per limitarne l’impiego. Nelle derrate agricole confluivano, senza che nessuno ci facesse caso, fiumi di petrolio.
C’è da spianare una serie di collinette che impediscono di avere enormi campi ben geometrici? Si spianano, poco importa se gli ottimi suoli che le foderano ci hanno messo quindicimila o duecentomila anni per formarsi. Bisogna creare un impianto di irrigazione per dei suoli capaci di trattenere pochissima acqua, in modo da poter coltivare specie che sono molto esigenti dal punto di vista idrico? Si crea, se queste sono pagate bene. Anche pompando l’acqua da un livello topografico ben inferiore, o da una falda che non può permetterselo, l’importante è che affluiscano i quattrini. Per la loro natura i terreni non possono trattenere gli elementi minerali? Si continua a fornirglieli, come riempiendo un barile senza fondo, poco importa che questi finiscano a inquinare falde e acque superficiali. Bisogna rasciugare una valletta umida con specie vegetali rare e una notevole ricchezza animale? Si rasciuga.
Quando invece l’agricoltura della chimica non ha soluzioni, le terre sono considerate inette, e perdono qualsiasi attrattiva. Le sue grandi macchine non possono per esempio utilizzare i suoli dei terrazzamenti, e quindi per lei queste superfici non valgono niente. Non conta nulla che siano ottime per certe colture, e siano essenziali per la conservazione del paesaggio e la sua bellezza: i muri vengono lasciati cadere, si lasciano impazzare i rovi e i franamenti. La Liguria fa scuola. Quello che dirime è solo il bilancio benefici e costi, senza conteggiare le perdite ambientali e quelli delle misure di ripristino, quando sono possibili, che prima o dopo si renderanno necessarie. Senza conteggiare il capitale naturale dei suoli, che viene dilapidato fino a esaurimento.
Questo avanzare da rullo compressore, incapace di venire a patti con le specificità locali, a cominciare dalle caratteristiche dei suoli, ha portato a una drammatica divaricazione geografica. Da una parte ci sono le zone pianeggianti sempre più meccanizzate e più produttive, e dall’altra quelle recalcitranti, che a meno di non trovare una loro nicchia altamente specializzata e con un mercato disponibile (viticoltura di qualità, serre…), sopravvivono subendo danni ancora più grossi di quelli della pianura, vista la loro fragilità, o vengono abbandonate. Da una parte le aree di pieno successo, e dall’altra quelle perdenti o escluse, come si deve in epoca neoliberale. Con la sua prevalenza di superfici agrarie in pendenza, che sono state in larga parte maltrattate e poi lasciate andare in malora, come si gettano nei rifiuti dei resti senza valore, l’Italia è un esempio paradigmatico. Un terzo dei nostri terreni considerati coltivabili non sono attualmente coltivati.
Il metro attuale per giudicare la bontà della terra è insomma quello dell’agricoltura industriale, che ha bisogno di vastissime superfici, poco inclinate, meglio ancora perfettamente orizzontali, molto uniformi, non pietrose, senza alberi o cespugli o muretti che rompono i coglioni alle macchine. In genere le doti organolettiche e qualitative dei prodotti sono molto basse, ma di questo lei non se ne cura, pensa alle tonnellate. Ignora che i suoli che lei disdegna possono essere ottimi, e ben vocati per determinate colture di qualità o determinate pratiche.
Che senso ha far correre come forsennate – a suon di sovvenzioni – una parte delle terre, le velociste, nascondendosi i costi energetici e ambientali, per lasciare che le terre meno dotate, le quali potrebbero dare il loro contributo, vadano al diavolo, assieme ai loro paesaggi, e alle persone che ci vivono sopra e hanno bisogno di cibarsi? La fame che imperversa in tanti Paesi poveri, è un fenomeno prevalentemente rurale, legato a queste realtà svantaggiate, non a quelle più fortunate. Può essere eliminata solo lavorando su soluzioni locali.
Pensiamo un attimo alle terre dei vigneti. Sostanzialmente i vini buoni vogliono suoli pessimi, se si adotta il metro dell’agricoltura industriale. Tutti vengono da terre con una o più grosse magagne: pietrose, o troppo superficiali, poverissime, squilibrate, con pendenze anche proibitive. Terre con difetti che non si possono correggere, e che per qualsiasi altra coltura non varrebbero un soldo. Se non fosse appunto per i vini magnifici che sanno dare, come quegli artisti ben poco prestanti o malaticci, e forse anche per questo pregnanti, che sfornano capolavori. In questo caso si pone al centro la qualità, non la quantità.
È davvero così utopico immaginarsi modi di coltivare in sintonia con i vari terreni e proprio per questo attenti al portato ambientale e ecologico, miranti alla qualità sanitaria e organolettica degli alimenti, a sfamare tutti gli esseri umani? Perché produrre troppe derrate di cattiva qualità, per poi sprecarne – come è implicito nell’approccio solo quantitativo e mercantile – una grossa fetta, per la precisione un terzo? Davvero non siamo capaci di affrontare il problema delle derrate agricole e dell’alimentazione mediando quantità e qualità?
Davvero dobbiamo rassegnarsi che una persona su dieci non abbia abbastanza da mangiare, tre su dieci non abbiano la sicurezza di potersi alimentare, quattro su dieci non abbiano i mezzi per alimentarsi in maniera sana, tre su dieci (cinque su dieci nel 2035) siano sovrappeso o obesi? Le terre, quelle superdotate e quelle più limitate, tutte egualmente preziose, potrebbero contribuire, tutte assieme, a fornire alimenti diversificati, sani e buoni, invece che a ingaggiare sfide per record di produzione del pugno di vegetali al quale si è affidato il quasi monopolio alimentare, distruggendo la fondamentale biodiversità e la resilienza a essa legata. Tanto per cominciare sbarazziamoci dei metri attuali che definiscono il valore delle terre, che sono quelli della logica estrattiva/distruttiva. E accettiamo che queste abbiano anche difetti e pecche, e facciano quello che possono, come noi umani.
(l’immagine: Curzola, Croazia, 2013)
di Fabrizio Sani

Tre testi da Il contrario di abitare, I Quaderni Del Bardo Edizioni 2022.
Mettiamo un mattino come un altro
Mettiamo un mattino come un altro,
fischiettando tra i marciapiedi della tua città
– fosse fine primavera –
tra gli smilzi fili d’aria
che la mia bocca lascerebbe cadere
abbandonassi anche qualche lacrima,
tu cosa raccoglieresti?
Mettiamo in un mattino come un altro
volessimo incontrarci in un bar per il caffè
– fosse fine primavera –
e io mi fossi un po’ attardato.
Una volta terminato il caffè,
mi chiederesti, con aria immatura,
di restituire quel tempo insieme che ti ho sottratto?
Mettiamo, dicevo, un mattino come un altro,
chiudessi i tuoi occhi e con le mani le tue orecchie su di me
– fosse fine primavera –
evaporassi assieme a tutto il mondo.
Supporresti che la vita procede ancora,
che oltre la tua morte nient’altro morirebbe?
Sapresti, con certezza celeste, di avermi davanti?
Vorrei sapere: un mattino come un altro,
ravvisando la luce sensuale del sole
– fosse fine primavera –
cominceresti a pensare al caldo che si attenua
in un mattino di fine estate
e alla vigna dove potremmo spogliarci e baciarci,
tra l’uva matura?
In conclusione, mi piacerebbe capire
semplicemente se posso chiamarti amore.
***
Una canzone triste
Mia nonna è il dipinto di mia nonna.
Mia nonna è l’inquilina di mia nonna.
Per me era il volto della domenica mattina
e qualche nascita e qualche morte e qualche eternità
che rotolavano dentro le rughe di un paese,
senza spingersi mai oltre la vecchia chiesa.
Mia nonna si avvicina lentamente,
molto più lentamente di ogni altra volta.
Mia nonna è il male minore di mia nonna.
Mia nonna mi mette una mano sulla spalla
e i capelli smorzano la carezza che dona.
Mia nonna è quel gesto obliquo con cui le tengo la testa
e ci insegna che niente dà più intimità della sofferenza.
Si ricorda quella canzone triste,
dice che fa: na na-na-na-na na na.
Per la prima volta in una vita intera
le sorrido per davvero.
***
Uomini-sabbia
Siamo uomini-sabbia,
equivalenti, ammassati, sottili, trascurabili;
in balìa della pietra e dell’aria,
del tuttavia che ridimensiona le fantasie.
Per questo motivo Pierpaolo ha rotto il bicchiere,
stamattina. Quello che avevi rubato per me.
E non mi sei mancata.
Si è liberato dei frammenti,
mi ha chiesto scusa
e non mi sei mancata.
Nel pomeriggio Lorenzo ha buttato la spazzatura:
adesso non c’è più nessun bicchiere
rubato per me, sopra il lavandino.
E non mi sei mancata.
Briciole di vetro – verosimilmente –
sono annegate in fondo al tubo di scarico;
resti di cibo e tanta acqua per pulire ogni ricordo,
persino il tuo – gli saranno di compagnia.
Proprio perché non mi manchi
ho passeggiato serenamente sul luogo del decesso,
mentre penetravano dalla finestra i rintocchi di una campana,
Anita dipingeva e sulle sue guance e sulla sua tela
gocce marroni rotolavano giù.
Non mi sei mancata, no;
siamo uomini-sabbia e i nostri sogni
non sono che ombre irrilevanti.
Se mi fossi mancata sarebbe andata diversamente:
ogni cosa si sarebbe seccata al mio sguardo,
il marmo del tavolo si sarebbe crettato
e la pelle del conduttore in televisione sarebbe sgualcita e ingrigita,
scoraggiandomi a cercare uno specchio
per fissare le mie lunghe ciglia appassire
e precipitare laggiù in fondo, assieme alla polvere di vetro,
quasi sabbia, ma non mi manca.
Se non fossimo uomini-sabbia
mi ameresti di nuovo
e accadrebbe presto,
sarebbe semplice per chi ha dei sentimenti
e se proprio tu fossi l’unica ad averli
vorrai vedermi di nuovo e non potrai
e questo sarà il perché: siamo uomini-sabbia.
E tu ci crederai, non avrai alternativa.
È così che deve andare, cadranno le tenebre,
l’acqua che ci inghiottirà – attraversandoci –
diventerà sempre più scura
impedendoci di vedere attraverso,
non proveremo nostalgia.
Foto di PublicDomainPictures from Pixabay
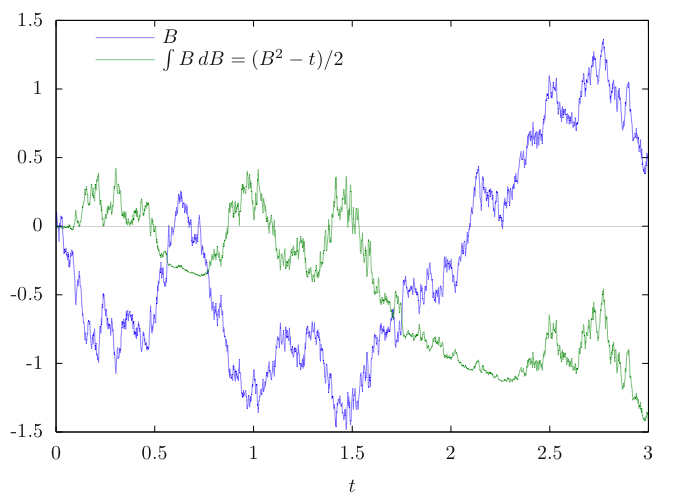
di Daniela Besozzi
Sono una persona volgare. Dico cazzo, vaffanculo e bestemmio la madre del cristo. La mia bocca è come un buco di culo, quando serve esce merda.
Daniela ironizzava spesso sull’ipotesi che io fossi affetta dalla sindrome di Tourette, ma io vi giuro che la mia mente è sana. La ricerca scientifica congettura che la coprolalia sia un indizio di sincerità. Di fatto, l’assoluta verità sugli eventi precedenti e successivi allo stupro è l’unica cosa che avrete da me. Di come progettai l’omicidio, invece, vi dirò ben poco.
Conobbi Daniela il terzo giorno del terzo mese del millenovecentonovantatrè. Zero-tre zero-tre uno-nove-nove-tre. Facile ricordare una data così se sei una matematica. Anche Daniela lo era. O meglio, voleva diventarlo.
Noi matematici classifichiamo il mondo in base al numero di buchi. Se sei un bicchiere, hai zero buchi: ciò che entra, resta. Se sei una ciambella, hai un buco e ci puoi infilare il dito che, come entra, così esce. Se sei un essere umano, il tuo buco è quello che crea continuità fra ciò che entra dalla tua bocca ed esce dal tuo culo. Nel caso dell’essere umano, però, ciò che esce non è uguale a ciò che entra. Nel caso dell’essere umano, a volte, ciò che entra non esce più. Ho una invidia fottuta per quelle specie di ctenofori che non hanno l’ano collegato alla cavità orale e possono cagare da qualsiasi punto del corpo. Una gran comodità, io credo, quando hai molto da dire.
Luca, di parole, ne diceva poche. Lui era un pragmatico. Lui era il misterioso, il noncurante, l’impenetrabile. Luca, l’orfanello cresciuto dagli zii. Luca, il grandissimo figlio di puttana.
Il terzo giorno del terzo mese del millenovecentonovantatrè, Daniela e io ci trovammo per caso a condividere lo stesso tavolo nella biblioteca comunale. L’una accanto all’altra la mia e la sua copia del Kosniowski, l’unico testo universitario con la copertina arancione. A che anno sei? Al terzo, e tu? Io al secondo. Ciao, mi chiamo Daniela. Anche io.
Daniela era il mio esatto contrario, tutto ciò che non avrei mai potuto essere. Io, capelli corti tagliati a cazzo, il seno piatto indossato nudo sotto maglioni sformati, la magrezza sulle ossa. Lei, l’equazione perfetta della femminilità: un alternarsi di convessità e concavità che iniziavano dai boccoli e proseguivano sulle spalle, scendevano dalle labbra al seno decisamente troppo generoso, e culminavano in un fondoschiena così rotondo e pieno da far sembrare Giotto un qualunque principiante.
Iniziammo a studiare insieme ogni pomeriggio. Passavo a prenderla a casa, citofonavo, scendeva, la sfottevo per le stragi di fiorellini o di pois sparpagliati sui suoi vestiti come sequenze di Sobol, e ci incamminavamo verso la biblioteca. Il venerdì ci accompagnava suo fratello, che era all’ultimo anno di chimica e un adorabile stronzo. Elio ci chiamava la Thelma e Louise di Como. Vi manca solo la Ford Thunderbird, diceva. Ma a noi bastava il nostro tavolo in biblioteca, i nostri libri, la nostra matematica, le sue curve e le mie superfici piane. Alla fine del quarto mese del millenovecentonovantatrè, Daniela aveva rubato il mio cuore e io la sua matita.
Ma tu lo conosci? Abbastanza per dirti che è meglio evitarlo. Ma sai cosa studia? Ingegneria gestionale, il classico figlio di papà. Ma è vero che ha perso entrambi i genitori quando era piccolo?, deve avere avuto una vita difficile, poverino. Difficile un cazzo, è un Taiana, sono pieni di soldi quelli. Ma tu non lo trovi bello? Dani, dammi retta, stagli lontano. Ma ogni tanto mi guarda. Dani, qui tutti ti guardano, hai due tette sparate sul mondo e un culo che è un inno alla gioia, quello vuole solo scoparti. Ma come fai a essere sempre così, non pensi che anche i ragazzi abbiano voglia di parlarci, con noi ragazze, di camminare mano nella mano, di essere abbracciati? Non riesci proprio a prendere in considerazione che siano capaci di provare amore? Come no, vedrai che quando usciamo da qui troviamo pure il cavallo bianco del tuo principino che pascola nel giardino della biblioteca.
Non sono mai riuscita a capire come Daniela conciliasse il suo schifoso romanticismo con il mio, a suo dire insopportabile, cinismo. Ipotizzo, ma non dimostro, che ognuna di noi avesse bisogno di sentirsi dire dall’altra ciò che non era in grado di pensare, e tanto meno di vivere.
Il quinto mese del millenovecentonovantatrè fu piovoso, la biblioteca si trasformò nella tana di chi voleva studiare e di chi avrebbe preferito farne a meno ma pensava fosse meglio andare a caccia di figa piuttosto che bagnarsi. Il figlio di puttana diventò un assiduo. Io lo guardavo con diffidenza, Daniela con troppa attenzione.
Ciao, Besozzi. Ciao, Taiana. Tu studi matematica, vero?, ho un problema con gli integrali di Itō, se non passo l’esame di matematica finanziaria mi salta l’Erasmus, mi dai qualche dritta? Posso aiutarti io, se vuoi, sto preparando istituzioni di analisi superiore, il calcolo differenziale stocastico non è difficile come sembra. Matematica anche tu, quindi?, grazie, saresti un angelo, mi chiamo Luca. Io sono Daniela, felice di conoscerti.
Il sesto mese del millenovecentonovantatrè l’orfanello sferrò il primo attacco. È stato incredibile, Dani, è stato tutto così romantico da sembrare un sogno. È venuto a prendermi dopo le cinque, era elegantissimo, mi ha dato un bacio sulla guancia, mi ha aperto lo sportello dell’auto, si è seduto al posto di guida e mi ha sorriso. Pronta?, ti porto in un posto speciale. Ho parlato per tutto il tragitto, c’era una luce bellissima nel cielo e nessuna traccia del temporale previsto dal meteo. Mi ha portato in una zona dove non ero mai stata, poco fuori dalla città. Ti sarebbe piaciuta moltissimo, c’era tanto verde, prati, un piccolo bosco. Era tutto così bucolico che quando ha parcheggiato ho temuto mi avesse portato in camporella, e mi venivi in mente tu con i tuoi stai attenta e non fidarti. E invece è sceso, mi ha di nuovo aperto lo sportello, mi ha teso la mano perché la stradina era sterrata e io avevo i tacchi, mi ha detto appoggiati a me, mi ha detto ti tengo. Ci siamo incamminati verso il bosco, finalmente l’avevo accanto, mi stringevo al suo braccio, Dio che profumo aveva. Alla fine della strada c’era un cancello, ci credi che il bosco è una proprietà privata dei Taiana? Ha aperto il lucchetto che serrava la catena e mi ha detto che mancava poco, che non c’erano pericoli. Quindi qualche parola l’ha detta pure lui questa volta?, si è degnato di esporsi con te, l’agnellino di dio. In effetti non è un chiacchierone, ma quando siamo sbucati dall’altra parte del boschetto è mancata la voce anche a me. Dani, sembrava di essere dentro un film: c’era una casetta di legno e un laghetto con una coppia di cigni, fiori di ninfea e cespugli di giunchi tutt’intorno. E magari siete arrivati lì proprio al tramonto, eh?, sa giocarsi bene le sue carte l’orfanello, strano che non abbia fatto comparire pure gli unicorni. No, credimi, è stato tutto perfetto. Mi ha detto che non aveva mai portato nessuna ragazza lì, che quello era il posto preferito di sua madre. Non è come dici tu, sai?, è un ragazzo molto dolce.
Era davvero raggiante, cristo santo. Ma per cosa poi?, un paio di gesti gentili dell’orfanello, qualche parolina elargita al momento giusto, e una buona dose di scattering di Rayleigh a scomporre le lunghezze d’onda della luce nel cielo. Il tramonto è il peggiore inganno della natura per i romantici, si sa. Ma Daniela era una sognatrice, e io non ci potevo fare un cazzo. Quel giorno aveva un sorriso che le spaccava il viso. Mi buttò le braccia al collo. La tenni stretta, non volevo lasciarla andare. Daniela, sono felice se lo sei tu, ma fammi una promessa: stai attenta, non ci si può fidare di un senza madre.
All’inizio del settimo mese del millenovecentonovantatrè, trovai Elio ad aspettarmi all’uscita della biblioteca. Sua sorella non usciva di casa da tre settimane. La voce della madre al citofono mi riferiva che Daniela non si sentiva bene. Citofonai ogni giorno della prima settimana. No, Daniela oggi non viene in biblioteca. Citofonai ogni santo giorno della seconda settimana. Mi dispiace, Daniela, non se la sente ancora di uscire. La terza settimana chiesi di poter salire, vederla, con la scusa di portarle i testi per gli esami. Niente da fare, Daniela era inaccessibile. Feci quindi l’unica cosa che sapevo fare ogni volta che la vita mi girava storta: mi impadronii del nostro tavolo in biblioteca e mi misi a studiare senza tregua. Il figlio di puttana intanto era partito per Londra, per i suoi tre mesetti di figa gratis spesati dalla comunità europea.
Mi ha chiesto di portarti questo. Il Kosniowski?, io ce l’ho già, perché vuole darmi la sua copia? Ma che ne so, non ci capisco più un cazzo di mia sorella, non sembra più lei, non studia più, qualche giorno fa ho addirittura trovato un libro nel cestino, roba di calcolo stocastico o qualcosa del genere, le pagine tutte strappate. Ma cosa cristo le è successo?, non vuole nemmeno vedermi. Non lo so, non parla, se ne sta chiusa in camera sua tutto il giorno, ci ha svegliato in piena notte urlando già tre o quattro volte, ha pure pisciato nel letto, mi fa venire i brividi, cazzo. Quando ha iniziato a stare male ho pensato che le fosse venuta una crisi d’ansia per gli esami, ma non è da lei, non ha mai saltato una sessione in tre anni. Mia madre è in palla totale, io di giorno devo andare in laboratorio per finire la tesi, quando rientro la sera sono messe una peggio dell’altra, mi tocca fare da fratello, figlio, padre e pure marito, non ce la faccio più. Con te parlava, Louise, non è che è successo qualcosa all’università?
Il secondo giorno dell’undicesimo mese del millenovecentonovantatrè, che sia gloria a tutti i santissimi morti, nella mia bocca entrò la lingua di Luca. L’avevo incrociato fuori da un’aula, lui aveva fatto finta di non vedermi, io ero andata dritta nella sua direzione. Un cenno con la testa, come a dire ciao, come non fossi degna di sentire la sua voce, come fossi un qualsiasi togliti dal cazzo. Di rimando, avevo sfoggiato il migliore dei miei sorrisi. Bentornato, com’è andato l’Erasmus? Mah, niente di che, però Londra è il massimo. Qui che si dice, invece? Senti, Taiana, andiamo al sodo, che a nessuno dei due piace perdere tempo. Mi dicono che ti arriva roba buona, ho bisogno di una botta per star dietro alle lezioni, se tu pensi al fumo io porto da bere.
Mi portò al laghetto, nella casetta di legno tirai fuori la bottiglia di Gordon’s. Lui si fece un Last Word, io il gin lo bevo liscio. Sbriciolò l’hashish, rollò la prima canna, fece un paio di tiri e me la passò. Io fumo fuori, Taiana, voglio vedere le stelle, tu fattene un’altra. Camminai sul prato, fino all’acqua nera, e ci buttai dentro quella merda. Mica sono così scema da sputtanarmi i neuroni, io ci voglio campare con la matematica. Lo ritrovai sdraiato sul divano, il bicchiere vuoto posato per terra, la canna fra le labbra, gli occhi due fessure da bestia ubriaca. Gli girai le spalle, frugai rapida nella borsa e presi il necessario. Non ti facevo così, Besozzi, sembravi la solita secchiona stronza e cagacazzi. Beh, in effetti lo sono, e quindi?, facciamo invece che ti riempio il bicchiere, che stai parlando pure troppo per i miei gusti. Se non vuoi sentirmi, stronzetta, tappami la bocca.
E così feci. Lo raggiunsi sul divano, mi sedetti a cavalcioni su di lui, posai il bicchiere sul suo petto e gli misi la mano sinistra intorno al collo. Adesso ti fotto, Taiana, come mai nessuna. Gli slacciai la cintura, il bottone e la cerniera dei jeans. Aveva già il cazzo duro. Presi il bicchiere e lasciai scendere nella mia bocca un sorso del suo gin, me ne colò un po’ sul collo. Mi afferrò per le spalle e mi tirò contro la sua faccia. Quello era mio, stronzetta, ridammelo. Lo vuoi tutto così, dalla mia bocca nella tua bocca, un sorso dopo l’altro, mentre ti stringo il cazzo fino a fartelo esplodere?
Mi tolsi le scarpe, i jeans e le mutande. Lo presi per un braccio e lo trascinai per terra, sbatté la faccia sul pavimento, non disse nulla. Fu tutto piuttosto veloce, mi bastarono pochi minuti per mettere il figlio di puttana nella posizione giusta e prepararmi a parlare. Quando sentii lo spasmo, mi accucciai sopra la sua faccia, gli spalancai la bocca e ci cagai dentro. Usai le mutande per pulirmi il culo alla meno peggio, e gli cacciai in bocca pure quelle. Sciacquai i bicchieri e me ne andai.
Riuscii a incontrare Daniela durante le vacanze di Natale, un giorno che sua madre era andata a far visita a dei parenti. Fu Elio ad aprirmi la porta. Mi aveva avvisato, ma mi paralizzai vedendola. Si era rasata i capelli, era magra come un deportato.
Ti ho riportato il Kosnioswki, Dani. Ho letto tutto.
Si mise a piangere. Si afflosciò sul pavimento. Mi accucciai di fianco a lei e la abbracciai e la lasciai piangere e le baciai la fronte e le accarezzai la testa e ingoiai in silenzio tutta la merda che avevo sul cuore. Restammo così per un’ora, forse due. Il pavimento di marmo era freddo come una tomba. Tremavo. Elio si sedette accanto a noi, con due calici di spumante. Venite qui, una a destra e una a sinistra, che quando mi ricapita di abbracciare due Daniela in una volta sola. Sei pronta, Thelma? Mi strinse la mano. Non si torna indietro, Louise. Le fu sufficiente un sorso.
Il figlio della madonna puttana si trasferì a New York a gennaio. Di lui non so più nulla.
[Per Interlinea è uscito un libro importante: Autorizzare la speranza. Giustizia poetica e futuro radicale di Italo Testa. In questo saggio, a cavallo tra teoria della poesia e esemplificazione di poetica, l’autore mette a frutto la propria duplice esperienza di poeta e filosofo. Ne risulta un libro denso di riferimenti e riflessioni, che approfondisce in modo particolare il nesso tra genere poetico e utopia. Abbiamo invitato alcuni autori a realizzare una lettura di questo saggio. I primi due interventi sono di Vincenzo Bagnoli e Francesco Deotto sono apparsi qui. I due nuovi interventi sono a firma di Stefano Modeo e Tommaso Di Dio. a. i.]
Nostalgia, antimemoria del futuro
di Stefano Modeo
Tempo fa a Bologna, al termine della presentazione del suo L’indifferenza naturale (Marcos y Marcos 2019), dopo aver discusso a lungo di luoghi, chiesi ingenuamente e con una certa vaghezza a Italo Testa quale fosse il tempo a cui quella raccolta faceva riferimento. Un tempo inteso anche come luogo da abitare o da costruire, a cui tendere o immaginare. Non sapevo allora, ma avevo percepito che la sua poesia avesse a che fare con la possibilità, con la lecita pretesa di autorizzare una speranza. Versi come: «[…] tutto è pronto, il sentiero è spianato, / il cancello divelto tra i pali, / noi aspettiamo, non resta che questo, / con la falce nel pugno in silenzio / aspettiamo che venga domani.» mi avevano suggerito quella domanda, versi nei quali l’attesa faceva risuonare la stagnazione del presente, l’impasse onnipervasivo oltre il quale non c’era (e non c’è?) alternativa, idea di futuribile e a cui il poeta rispondeva con una presa d’atto: non resta che aspettare, «non resta che questo». Nel frattempo due dibattiti intrecciati l’uno con l’altro, in Italia e in Europa, prendevano sempre più piede: la questione ecologica e la gentrificazione e mercificazione delle città. Circa un anno dopo così, riproposi quella domanda a Italo Testa, in forma più articolata, in un’intervista che uscì sul n.96 della rivista Atelier e su Nazione Indiana sul tema Poesia&città. Nella risposta, inserita e ampliata nel saggio Autorizzare la speranza. Giustizia poetica e futuro radicale, Testa a proposito della funzione della poesia scrive:
Questo è il perimetro del tempo in cui oggi la poesia viene al mondo. Eppure, la poesia si legittima se è in grado di esprimere una resistenza e una differenza dell’immaginario, una fenditura del presente, ricordandoci una diversa memoria, un’antimemoria del futuro. Oggi tendiamo ad identificare, per usare due categorie di Luhmann, il ʻʻfuturo presente’ʼ – il futuro per come ce lo rappresentiamo – e il ‘ʻpresente futuro’ʼ – ciò che tendiamo a divenire, che sarà domani, il versodove per cui ci incamminiamo oscuramente. Non sappiamo verso quale mattino si muova il mondo, ma in fondo, come scriveva Paul Celan nei suoi appunti per Der Meridian, «les jeux ne sont pas encore faits» è il «pensiero centrale» che «accompagna qualunque intenzione poetica». Noi soffriamo di determinatezza, crediamo di vivere nella gabbia d’acciaio di un presente senza confini ma iperreale nei suoi dettagli determinati, in nicchie virtuali che ci isolano dagli altri, in una bolla temporale che ci separa da un futuro possibile. Ma tra le possibilità della poesia, e di ciò che chiamavamo letteratura, c’è quella di ricordarci lo scarto tra presente futuro e futuro presente – l’inesauribilità del primo da parte del secondo – gli aspetti di latenza, e indeterminatezza, delle nostre traiettorie, la vaghezza del presente e gli spazi possibili, divergenti, dell’immaginario e del paesaggio sociale. Le nicchie sono immaginari in inverno, ibernati, la bolla del presente è solo una bolla, e può essere soffiata via.
Antimemoria del futuro, ma come si costruisce, come si mette in pratica questa parola che suona quasi un controsenso? Per provare a dare un’interpretazione di questo concetto, dovrò necessariamente partire dalla mia esperienza personale.
Io sono nato in una delle città più inquinate d’Europa in cui il problema del futuro, di immaginare un’alternativa a quella desolante realtà è ancora oggi una questione irrisolta. Ho vissuto lì per ventisei anni, poi sono andato via, come molti, troppi, un’infinità di persone. Quando si parte, si abbandona un luogo per molto tempo, forse per sempre, inizia per ogni uomo la grande questione dell’identità: chi siamo? Quali differenze portiamo? E perché? Cosa ci divide dal luogo in cui siamo e da quello che abbiamo lasciato? Allora per trovare delle risposte ci si può fare più vicini ai classici: si capisce perché Ulisse piange sulla spiaggia di Calipso; perché Itaca occupata merita una liberazione; la disperazione di Telemaco; il grande viaggio di Abramo per raggiungere una terra; il mare, il cammino. Si cerca nel passato, nelle voci degli altri, la nostra. Quello che ci divide è certamente un dolore, talvolta è nostalgia, qualcosa che ferisce, un’idea originaria di noi stessi nel mondo che non c’è più. Oppure è la nostra assenza: mancare sempre. Oppure ancora è il sentirsi stranieri ovunque, anche quando si torna. Mi sono interrogato a lungo su questo sradicamento, sul dolore che può nascere dalla perdita di una comunità in cui ti riconosci, in cui comprendi gli spazi, la loro significazione, gli sguardi della gente, i rumori, i sotterfugi, le contraddizioni. Soprattutto, mi sono interrogato a lungo su cosa possa significare tornare indietro.
Mi viene in mente la storia raccontata da Ernesto De Martino in La fine del mondo quando una volta, lungo una strada in Calabria, mentre stava guidando, chiese a un vecchio pastore indicazioni su un bivio che stava cercando. De Martino racconta che, poiché le spiegazioni del pastore erano poco chiare, gli propose di accompagnarlo in macchina fino al bivio e poi riportarlo al punto iniziale. Il vecchio pastore accettò con diffidenza e durante il viaggio cominciò ad osservare in modo agitato fuori dal finestrino, alla ricerca di qualcosa di importante. Improvvisamente esclamò: «Dov’è il campanile di Marcellinara? Non lo vedo più!». Il campanile di quel villaggio infatti non era più visibile all’orizzonte. Di conseguenza, non fu possibile proseguire con il pastore e fu necessario riportarlo al punto di partenza dove salutò con gioia il ritorno del campanile smarrito. Questa sparizione, spiega De Martino, evidentemente sconvolse il mondo familiare del pastore, il suo spazio domestico. Per lui, la scomparsa rappresentava un’angosciante perdita della propria patria culturale.
Se vogliamo, questa condizione di sradicamento e spaesamento, in una società frammentata e omologata, fatta di individui e sempre meno di comunità e in cui è in atto un vero e proprio assalto alla memoria, su diversi livelli vale sempre.
In un certo senso si è costantemente orfani di qualcosa e questa condizione irrisolta genera un nomadismo disperato, per cui si cerca di rintracciare costantemente espressioni di quella comunità, di quei luoghi o di una minima e residuale patria culturale nell’altrove in cui si è stati precipitati.
Tuttavia ciò che è distante o perduto si può ricostruire costantemente su piani immaginari, si può contaminare ed espandere. E proprio su questi piani immaginari in cui si alternano malinconia, gioia del ritorno, nostalgia, si può costituire anche una coscienza, come presa di parte, scelta di legame e difesa ancora più forte di ciò che ci è stato sottratto. Scrive Leopardi nel suo Zibaldone:
Ogni uomo sensibile prova un sentimento di dolore, o una commozione, un senso di malinconia, fissandosi col pensiero in una cosa che sia finita per sempre, massime s’ella è stata al tempo suo, e familiare a lui. Dico di qualunque cosa soggetta a finire, come la vita o la compagnia della persona la più indifferente per lui (ed anche molesta, anche odiosa), la gioventù della medesima; un’usanza, un metodo di vita. […] La cagione di questi sentimenti, è quell’infinito che contiene in se stesso l’idea di una cosa terminata, cioè al di là di cui non v’è più nulla; di una cosa terminata per sempre, e che non tornerà mai più.
Un giorno Paolo Febbraro mi disse: «La nostalgia per ciò che sparisce deve e può modellare il nuovo mondo, perché altrimenti questo mondo non sarebbe nuovo, ma fingerebbe di essere l’unico». È infatti attraverso la perdita di un mondo, dal dolore che ne scaturisce, che ci si proietta in avanti, nel futuro. Non nella restaurazione, bensì nella costruzione. Qui avviene anche la poesia. Negli anni mi sono reso conto che nei versi ho provato a restituire un mondo che avevo perduto, creandone uno nuovo. Con la poesia si afferma in noi una quasi verità, una percezione di raggiungibilità o di avvicinamento a quel luogo, che è appunto il luogo della verità, con cui facciamo i conti con noi stessi e non solo, in cui si scontra o si accarezza la memoria e il nostro desiderio di conservazione, di sopravvivenza, di autodistruzione, estinzione o miglioramento. Ma si tratta di una quasi verità, questo non bisogna scordarlo, un luogo annebbiato e dagli incerti contorni, un luogo che rimanda ad altri mille luoghi, uno specchio infranto. La poesia – che è forma della mente – è dunque anche antimemoria del futuro e si trova in fondo all’«ombelico dei sogni» per citare Freud e un libro recente di Vittorio Lingiardi. Ma proprio perché parliamo di ombelico sappiamo che alla sua origine c’è un taglio, una separazione, un trauma che lo genera. È necessario innanzitutto generare o, in altri casi, risalire, ripercorrere questa origine, questo taglio per raggiungere la poesia. Nella Teogonia di Esiodo, Gea dà alla luce il Cielo stellato (Ouranòs asteróeis) affinché possa coprirla e fungere da dimora per gli dei. Dalla loro unione nascono i Titani, tra cui Crono che, guidato da Gea, taglia i genitali di suo padre Ouranós con una falce. Questo atto permette a Cielo e Terra di separarsi. Il Cielo diventa distante e inaccessibile, si fa vuoto, distesa di assenza. Al cielo si rivolgono i desideri: guardando l’infinito cielo stellato, l’uomo sperimenta una mancanza ma anche l’aspirazione verso l’alto, incarnando il movimento del desiderio e dell’elevarsi partendo dal proprio limite terreno.
Concludendo: nel tempo in cui scrivo questa nota non sono affatto sicuro che in generale, seguendo Testa, si possa autorizzare una speranza o se sia più corretto dare sfogo al pessimismo della ragione. O meglio, ciò che mi chiedo è: se la poesia in sé non autorizzasse naturalmente e spontaneamente una speranza – anche la poesia più cupa – esisterebbe? Forse tutto ciò che ha a che fare con l’immaginazione autorizza sempre una speranza. Credo dunque che vi siano in me almeno due differenti risposte: quella del poeta e quella dell’intellettuale e che nessuna delle due sia più onesta dell’altra. Faccio mie le parole di Andrea Zanzotto che in un suo intervento del 2006 dal titolo Sarà (stata) natura?, scriveva:
L’ubi consistam della poesia si è ridotto alla verifica della propria futilità, oggi che lo stesso nome di ʻʻnaturaʼʼ è divenuto un relitto fonico privo di senso, avendo perduto la possibilità storica di riferirsi a una realtà pur minimamente adeguata alla nobilitas del suo significato – cui, del resto, si ostina caparbiamente ad alludere. Ma, nel medesimo tempo, la poesia si trova ad essere investita di un ruolo paradossalmente fondamentale: quello di instaurare, magari ricreandole ex novo, le pur esilissime connessioni vitali tra un ʻʻpassato remotissimoʼʼ e l’odierno ʻʻfuturo anterioreʼʼ di un rimorso che, pur percependosi come tale, non è oggi nemmeno in grado di spiegarsene la ragione.
Resta ferma, insomma, la convinzione che la poesia debba ostinarsi a costituire il ʻʻluogoʼʼ di un insediamento autenticamente ʻʻumanoʼʼ, mantenendo vivo il ricordo di un ʻʻtempoʼʼ proiettato verso il ʻʻfuturo sempliceʼʼ – banale forse, ma necessario – della speranza.
*
Per un’idea patica della teoria
di Tommaso Di Dio
Della lettura del libro Autorizzare la speranza di Italo Testa mi sono rimaste nella mente diverse impressioni. Innanzitutto a colpirmi è stato il punto di vista formale. Non è un infatti un saggio unitario, non è un monumento teorico; sembra che Testa abbia volutamente evitato che il suo lavoro apparisse un monolite inattaccabile. Autorizzare la speranza è un libro selvatico, scaleno, poroso e in questo sta anche il suo fascino strabico e sfuggente. Se raccoglie diversi interventi intorno a alcuni definiti fuochi tematici, non si preoccupa sempre di coordinarli fra loro in un vero e proprio discorso unitario: i temi tornano fra le pagine e riaffiorano sempre colti a partire da esigenze specifiche diverse. Il volume ci dà l’impressione di essere un asterismo di occasioni in cui a essere veramente costante, al di là dei temi, è un’insistenza, una sorta di temperatura di fondo: un’idea patica della teoria che ha la poesia come gemello. È come se Testa si proponesse di scrivere della poesia legandosi al suo oggetto non solo da un’esteriorità, ma da un vincolo intimo che non vuole nascondersi, ma anzi offrirsi al lettore come ineluttabile prodromo della discussione. Ecco, è come se Autorizzare la speranza ci dicesse a ogni pagina: o siamo coinvolti dal nostro oggetto di studio o non ne vale la pena. È così che i temi emergono: come pulsazioni di una ricerca, dentro un cammino di ricerca, uno fra i possibili, che non ha tanto di mira una parola definitiva che non ammetta repliche, ma al contrario è più interessata a mostrarci un’etica del lavoro teorico, un certo modo – ibrido e contaminato – di stare dentro i discorsi.
In questo modo mi pare che Testa ottenga un effetto importante. Invece di consegnare il suo lavoro a un anacronistico tribunale della storia che ne debba giudicare la perfezione, l’unitarietà del libro è integralmente nelle mani del lettore che è sollecitato da questa dimensione formale a intessere un dialogo, a partire dalla sua prospettiva, con le riflessioni suggerite: un dialogo che sia anche contraddittorio, dialettico, antagonistico. Il libro insomma lascia dei buchi, degli sbreghi, degli spazi, punti non pienamente risolti né esauriti: e va benissimo così. A me pare che questo sia un aspetto straordinariamente prezioso perché il libro di Testa non vuole chiudere i giochi su ciò che scrive, non è un libro che arriva postumo a sé stesso o a una riflessione già svoltasi altrove e della quale qui se ne dispongano gli inerti resti; mi pare voglia invece indicare una molteplicità di piste per gli studi della poesia che sono ancora tutt’ora aperte e che è bene che restino aperte.
Innanzitutto riprende un tema antico e – anche per me – decisivo: il legame fra poesia e verità. È un tema classico, addirittura esiodeo; è da esso, come si sa, che per Platone dipende il destino della poesia nella polis. La poesia va ospitata dentro i saperi della città democratica oppure è il misero orpello di una manìa seduttiva pericolosa e in ultimo da scacciare? Ma il tema attraversa tutta la trattatistica rinascimentale e barocca per divenire centrale nel romanticismo (pensiamo solo a Leopardi e Manzoni) e non ha smesso di agire nel Novecento: facciamo solo i nomi di Montale, Fortini, Mesa. Ecco, questo rapporto era caduto totalmente nell’oblio: era davvero troppo tempo che nessuno affrontava la questione. Il libro di Testa ha il merito innanzitutto di catapultarlo nuovamente all’attenzione, ma poi di non voler trattarlo come un elemento di una veneranda storia della letteratura, ma mostrarne fin da subito le implicazioni radicali a cui questo rapporto chiama: quelle che non possono essere evitate per chi scrive oggi. In che modo sta il rapporto fra poesia e verità del paesaggio, per esempio? Oppure: in che modo si declina questa paradossale sfasata coincidenza fra poesia e giustizia? Dove sta la verità di un futuro che da più parte in tanti chiedono e che non trova forme linguistiche condivise in cui abitare? Temi sterminati, si dirà, e certamente aporetici e forse inconcludenti, ma la forza di questo lavoro è anche costringere a pensare questa aporia e questa non-conclusione (p. 82) come qualcosa che è appartiene al nocciolo di ciò che è diventata la poesia.
A questo rapporto «obliquo al vero» (p. 7), si lega la questione fondamentale del libro, ovvero il tema della speranza radicale. Uno dei primi paragrafi del libro Testa scrive: «Per questo nell’appello alla verità si rifrange l’immagine di una comunità futura rispetto alla quale la poesia si assume il compito di autorizzare la speranza» (p. 8). Questo il paradosso che Testa pone subito al lettore e che ci chiede di provare a abitare per le pagine del suo volume. Testa è come se individuasse alcune forme pure a priori dell’agire poetico, forme che da un lato sembrano essere transtoriche, perché inerenti alle strutture stesse della poesia e alla loro cogenza, al di là dei contenuti che l’esperienza di questo o quel poeta di volta in volta darà loro; ma che ci appaiono così soltanto adesso, proprio per via della nostra peculiare condizione contemporanea. Nella parola di una poesia frantumata fra mille schermi e supporti, che ha perduto ogni mandato sociale – se poi mai l’ha avuto altrove che nella fantasia dei teorici e dei poeti stessi – persiste nondimeno una struttura, una forma retorica, tale per cui essa suscita, al di là di ogni controverifica e verità fattuale, un’idea di comunità possibile e un’idea di futuro realizzabile. A queste due forme a priori, Testa ne aggiunge una terza: la natura bastarda della parola poetica, ovvero il fatto che l’autorizzazione che indica «ha come condizione di possibilità di non poter essere soddisfatta dalla poesia stessa» (ibidem). È quella della poesia una parola che non può essere richiusa (né andrebbe mai pensata mai come chiusa) in una dimensione esclusivamente verbale. L’uso che fa della lingua – se è poesia – fa appello a un’oltranza, a una dimensione pragmatica extralinguistica che è chiamata a raccolta e ingaggia i saperi altri in un fine sempre da determinare, ma che nondimeno si fa presente come urgente nell’atto poetico stesso. Insomma c’è una performatività inerente all’atto poetico che sebbene sia stata già indagata sulla linea di una certa riflessione che va da Butler al recente Culler, lascia ancora aperti ampissimi margini di esplorazione. Cosa fa chi fa una poesia? Cosa accade quando la si legge? Perché nonostante la bassissima ricompensa sociale e lo scarso risarcimento narcisistico che concede, è ancora letta in pubblico e ascoltata da centinaia di persone? Sono domande che non trovano risposta nel libro Autorizzare la speranza ma assumono maggiore consistenza grazie a esse.
Mi pare molto interessante poi che Testa leghi la proposta di queste forme pure a priori proprio a partire da una certa visione di questa epoca. Come da più parti è stato già ampiamente segnalato, la parola poetica sembra aver perduto ogni diretta efficacia sociale e la società letteraria ha perso ogni antico prestigio. Testa non rifiuta affatto questa interpretazione del contemporaneo, eppure il suo libro non si ferma a questa constatazione, ma cerca di articolarla in una prospettiva operativa. Ci spinge a immaginare – per il tempo di un contropassato prossimo, che è arcaico e futuro insieme (p. 95) – la persistenza di una poesia al di là della letteratura, collocata interamente in un’epoca post-letteraria. Ecco, al di là di ogni forma di esistenza storicamente nota, cosa resta alla poesia? Resta, innanzitutto, che nulla in poesia si arresta mai. Della poesia è proprio un elemento xenotico e futuribile: c’è un’improprietà al cuore di ogni tentativo di trovarne il proprio. La scrittura poetica si dà – e oggi più come mai, scrive Testa – come pratica nomadica di forme estranee. A una poesia che non resta accade di essere una forma infestante i margini dei discorsi e gli interstizi fra le pratiche verbali dominanti. Alla poesia accade di essere questo impulso di non-luogo a procedere: la poesia sancisce che il reato della realtà non è estinto mai. Al di là di ogni evidenza, al di là di ogni utilitarismo, la poesia vive di questa radicale e straniata vitalità che ne fa il «luogo di invenzione del possibile» (p. 71).
E questo proprio perché essa è irriducibile al pensiero filosofico, così come a quello logico scientifico. Questo anche è un aspetto che ho trovato centrale nella riflessione di Testa. Da un lato Autorizzare la speranza ribadisce la natura conoscitiva della poesia: cosa non scontata affatto. Testa lo dice con forza: alla poesia pertiene una modalità del sapere. La poesia non è solo un intrattenimento, una pausa oziosa dall’impegno di una conoscenza che avviene altrove, ma è una peculiare articolazione conoscitiva del mondo; tale però in quanto sfida le categorie del pensiero tradizionale:
La possibilità di una conoscenza eventuale dell’individuale, di un individuale colto non semplicemente come caso particolare di una norma, quale nota caratteristica di un concetto, ma afferrato nella sua ecceità – nell’elemento che non è riportabile a norma ma è da sé norma esemplare – è uno dei punti su cui la poesia sfida il pensiero. (p. 44)
Su questo secondo me Testa apre una grande pista. La poesia rappresenta il luogo di un esercizio per cui conoscenza qualitativa non si oppone a conoscenza quantitativa. Praticare la poesia, scriverla, leggerla e studiarla, significa anche tentare di abitare un mondo dove la via qualitativa e quella quantitativa possono trovare una problematica, non pacificata conciliazione. La poesia è quella pratica di linguaggio che attraverso modelli produce individui, ovvero modificazioni continue, inarrestabili, condivisibili e aperte, ma mai pronosticabili. Scrive Testa «Ogni poesia, all’altezza delle sue pretese, sarebbe così contro la poesia come essenza fissa, invariante» (p. 135). Che storia è allora possibile per questa tradizione? Come farne memoria? Come riarticolare un racconto possibile di questa spinta all’individualità in movimento? Di fronte all’intricato presente, la riflessione di Testa torna alla poesia senza inerzia, né superbia. Mi sembra che tutto il libro di Testa continui a ripetere che in poesia non si tratta di custodire qualcosa che può perdersi o piangere qualcosa che è andato per sempre perduto, ma anzi si tratta di imparare a perdere sempre e la poesia vada dove deve andare; è in questo inarrestabile della poesia, «rotolando dal centro verso la X» (p. 94), ai margini dei margini di ciò che si pensava potesse essere, che si rivela una forma che ha da dirci qualcosa del nostro tempo – se solo ci sappiamo ancora fidare di lei.
Yousef Elqedra
Viviamo di alternative finché queste non finiscono o non finiamo noi.
I carretti, un’alternativa alle auto
Quando si passa per una qualunque strada, in un qualsiasi quartiere della Striscia di Gaza, prima ancora di notare le case ammassate su loro stesse, si notano soprattutto auto di ogni tipo, da quelle di lusso a quelle più economiche, parcheggiate in fila, a destra e a sinistra di ogni via. Per via della carenza di carburante si è perso proprio il senso dell’esistenza di queste auto.
Ma il genio gazawi è molto abile nel trovare alternative: si vedranno dunque carretti trainati da animali, carichi di passeggeri, donne e uomini, che vanno al mercato, in ospedale, o che si spostano da un luogo a un altro, oppure talvolta carichi di feriti e di martiri, quando le ambulanze tardano per la scarsa comunicazione o per le strade interrotte.
I carretti sono diventati un’alternativa alle automobili, nessuno sembra esserne seccato né irritato, qui le persone affrontano le occasioni in modo naturale e piuttosto intuitivo, come se il carretto trainato da un asino o da un cavallo fosse stato da sempre l’unico mezzo.
La legna, un’alternativa al gas
Così è anche per la vecchia legna da ardere, alternativa che ha prontamente sostituito il gas. Quando si esaurisce una bombola a gas, le persone finiscono per utilizzare la legna o addirittura il cartone. L’importante è cuocere con il fuoco tutte le pietanze disponibili e sfamare la bocca dei bambini affamati. È così che gli abitanti di ogni quartiere sono riusciti a fornire un forno di terracotta a chi ha della farina e vuole cuocere qualche pagnotta per la giornata. Si vedono perciò bambini che corrono per strada alla ricerca di carta, cartone o qualsiasi cosa che bruci per cuocere galayat bandura (pomodori in padella) o un barattolo di fave, mentre chi ha olio e zaatar è fortunato perché si risparmia tali fatiche.
Chi ha abbastanza soldi, invece, trova bancarelle che vendono la legna di vecchi aranci e di limoni e quindi non dovrà mandare i suoi figli in giro a cercare legna e carta. Ma alla bisogna si possono usare pure fogli di quaderni e di libri.
Alternative all’elettricità
Se disponi di energia solare sei fortunato: sei in grado di ricaricare i telefoni e i modem per internet, quando questa è disponibile. Puoi illuminare la tua casa in mezzo alle tenebre assolute in cui sono avvolte le zone della Striscia di Gaza ogni giorno dopo il tramonto. E forse – dico forse – puoi tenere un po’ di cibo in frigo.
Senza energia solare invece sei indigente, tutti i tuoi elettrodomestici sono fuori servizio e inutili, e sei costretto a fare la fila davanti a chi ha un generatore elettrico per caricare metà della tua ricarica. Questo finisce per costarti un’attesa di almeno due ore, o significa recarti in posti che dispongono di generatori ad alta potenza per caricare soltanto una batteria o un telefono cellulare, anche qui dopo lunghe file.
Puoi ricaricare il tuo cellulare o una piccola batteria anche tramite il caricabatteria di un’auto se ne possiedi una e se la sua batteria è ancora funzionante.
Crisi dell’acqua
All’acqua non c’è altra alternativa se non l’acqua stessa, quindi se non si riesce a far arrivare l’acqua in casa pompandola attraverso delle botti collocate sui tetti, tutta la famiglia è costretta a collaborare, portando secchi, pentole e qualunque recipiente dal basso verso gli appartamenti in alto. Se l’acqua non viene pompata nelle case a causa della mancanza del carburante necessario, bisogna uscire e cercare qualcuno che possa trasportarla su un carretto per il doppio del prezzo, altrimenti aspetti in una lunga fila per riempire di acqua potabile un recipiente da quasi quattro litri, che in realtà non lo è mai, ma che tu bevi lo stesso ringraziando il tuo Signore per la benedizione del bottiglione; tutti sono complici nel sostenere che contenga acqua potabile.
Crisi correlate
La crisi del carburante a sua volta ha prodotto la crisi dell’elettricità, e la crisi dell’elettricità ha portato alla crisi dell’acqua e la crisi dell’acqua ha causato malattie di cui non conosciamo la natura. Allo stesso modo, la mancanza del carburante di cui hanno bisogno i veicoli comunali ha prodotto la crisi della spazzatura ammucchiata in mezzo alle strade e sui lati, che emette un odore nauseante. I carretti passano due volte alla settimana per raccogliere i rifiuti, quando è possibile.
Crisi correlate fra loro che la popolazione di Gaza vive nella vita quotidiana, accanto alla morte quotidiana, finché le alternative non finiscono o non finiamo noi.
*
Yousef Elqedra è un poeta palestinese residente a Gaza. Su Nazione Indiana appare nella traduzione di Sana Darghmouni e Pina Piccolo.
[Questo articolo è uscito nel n° 10 de “L’indice” (ottobre 2023) con il titolo: Intelligenza artificiale fra sistemi esperti e regolarità statistiche.]
Di Andrea Inglese
A partire dal novembre 2022, una curiosità dilagante ha portato milioni di persone in tutto il mondo a realizzare sul web un dialogo tête‑à‑tête con una di quelle entità che da almeno mezzo secolo popolano romanzi e film di fantascienza, ossia una macchina che esibisce lo stesso agio di Hal 9000, quando conversa pacificamente con gli astronauti del Discovery, in 2001. Odissea nello spazio di Kubrick. Prima che questa esperienza si traducesse in uno schietto entusiasmo per le sorti della collettività – in procinto di essere sollevate grazie agli indubitabili vantaggi dell’intelligenza artificiale – o che, al contrario, destasse svariate paure – riguardo alle enormi minacce che quest’ultima farebbe pesare sulle nostre vite –, il contatto diretto con ChatGPT ha prodotto qualcosa che ha a che fare innanzitutto con le emozioni e con la meraviglia in particolare. E se Aristotele aveva ragione, concependo quest’ultima come lo sprone originario della riflessione filosofica, allora tutti noi, dopo il nostro personale appuntamento con ChatGPT, abbiamo assunto, consapevolmente o meno, un’attitudine più meditativa nei confronti dell’intelligenza artificiale. Attitudine, però – come evidenzia sempre Aristotele nella Metafisica – che è costituita non solo da stupore, ma anche da dubbio, ossia dal riconoscimento “di non sapere”.
È solo uno degli svariati paradossi a cui ci confronta l’attuale macchina intelligente. Nel momento in cui esce dal laboratorio per prendere la parola davanti a noi, esibendo competenze enciclopediche e poliglotte, lascia emergere non solo gli abbaglianti raggi del progresso scientifico, ma anche una vasta e perturbante zona d’ombra. In genere gli esperti – che ci parlano da un luogo ambiguo, alla frontiera tra l’istituzione pubblica e l’azienda privata – non hanno naturalmente dubbi o sorprese, non filosofeggiano. Cercano soprattutto di persuaderci delle loro pragmatiche certezze: le nuove forme di IA sono disponibili sul mercato, e hanno un’indubitabile utilità ed efficacia, malgrado gli sconvolgimenti che finiranno per creare nel mondo del lavoro, delle istituzioni educative, della tutela del diritto d’autore o della privacy dei comuni cittadini. Nonostante la fiducia nelle tempeste distruttive di Schumpeter, le disinvolte risposte di ChatGPT suscitano tuttavia inquietudini e fantasie, tra cui quella del robot come nostro “doppio”, in grado forse di fagocitarci o soppiantarci una volta per tutte. Insomma, abbiamo ancora qualche remora prima di accogliere con schietto entusiasmo le conseguenze che questo livello inatteso di automazione introdurrà nelle nostre vite.
Uno specialista che non ha paura d’indugiare sul terreno della riflessione filosofica e di far fronte agli equivoci che popolano il nostro immaginario intorno alle macchine, è Nello Cristianini, professore di IA all’Università di Bath, nel Regno Unito, e autore di La scorciatoia, uscito per il Mulino nel 2023. Il libro di Cristianini ha grandi pregi, e nonostante la valanga di cose che si scrivono con giornalistico eccitamento sull’intelligenza artificiale, si qualifica come uno strumento di rara pertinenza e chiarezza, per cominciare a determinare i confini estremamente mossi di questa entità tecnologica. Uno dei tratti distintivi del suo stile è una certa pacatezza, che lo mette al riparo sia dal messianismo tecnologico oggi tornato in voga, sia dal catastrofismo aprioristico. Malgrado ciò l’autore non elude nessuna delle difficoltà e dei rischi rilevanti che l’IA produce nei vari ambiti dell’attività sociale, in cui è o potrebbe essere adoperata (marketing, banche e assicurazioni, istituzioni giuridiche, ecc.).
Su questi aspetti critici, del resto, vale la pena di ricordare almeno altri due studi recenti. Il primo, apparso dapprima in Francia (Seuil 2019) e poi in Italia (Feltrinelli 2020), è di Antonio A. Casilli, sociologo che insegna presso il dipartimento di ingegneria delle telecomunicazioni del Politecnico di Parigi. In Schiavi del clic. Perché lavoriamo tutti per il nuovo capitalismo, Casilli indaga quelle forme di lavoro in gran parte “invisibili” o “inconsapevoli”, che permettono l’esistenza e lo sviluppo delle macchine intelligenti, sfatando il mito di una progressiva obsolescenza dell’attività umana, soprattutto quella meno qualificata. La crescente automazione non rima con crescente disoccupazione, ma con sfruttamento e precarietà ancora più diffusi su scala planetaria. I grandi gruppi industriali digitali statunitensi, ma anche russi e cinesi, hanno bisogno di subappaltare, spesso nel Sud del mondo, un micro-lavoro sottopagato, ma indispensabile per moderare i contenuti delle piattaforme e addestrare gli algoritmi.
Uscito nel 2021 per il Mulino, Né intelligente né artificiale. Il lato oscuro dell’IA è un’inchiesta firmata dalla scrittrice australiana Kate Crawford, studiosa dell’impatto sociale dell’IA. Inutile dire che una tale disciplina non esiste, in quanto – come illustra il lavoro della Crawford – mobilita una serie di competenze pluridisciplinari e di ricerche pionieristiche che spaziano dalle enorme risorse energetiche necessarie per il funzionamento dei “data center” ai pregiudizi umani attraverso cui si costruiscono le griglie di classificazione dei dati. Crawford insiste su di un fatto tanto evidente, quanto tenacemente ignorato: al di là dei suoi costi sociali e ambientali, l’IA “acuisce asimmetrie di potere esistenti”, in quanto è uno strumento di sfruttamento, controllo e condizionamento sempre più presente nelle nostre vite, ma sul quale, come singoli cittadini, abbiamo pochissima presa. Se questa inedita condizione storica è di continuo occultata da un ideologico ottimismo, non saranno comunque condanne generiche a portare maggiori strumenti di consapevolezza e azione.
Quanto a Cristianini, per sfuggire agli effetti stordenti del “miracolo”, introduce un po’ di storia e chiarezza concettuale a monte, fornendo alcune necessarie nozioni di epistemologia, connesse con quel campo di esplorazione che, a partire dalla metà degli anni Cinquanta, è stato definito “intelligenza artificiale”. Prima di tutto, però, si premura di dissolvere la fantasia metafisica che tanto ci assilla: l’indubitabile comportamento intelligente delle macchine attuali non presuppone che “l’agente abbia un cervello, un linguaggio o una coscienza”. Inutile, quindi, prestargli buone o cattive intenzioni, o ingaggiare competizioni con esso. Indebolendo ulteriormente il nostro già precario antropocentrismo, Cristianini ci ricorda che l’intelligenza – adeguare strumenti e azioni a degli obiettivi in contesti in parte mutevoli – non è una prerogativa dei soli esseri umani: animali e piante già la possiedono. Dobbiamo allora riconoscere che gli agenti che ci raccomandano video o libri sulle nostre piattaforme, o i filtri anti-spam della nostra posta elettronica, manifestano sì un’intelligenza, ma non simile alla nostra; si tratta di un’intelligenza aliena, come quella che mettono in atto un formicaio o una lumaca, quando perseguono i loro obiettivi in modo efficace. Il punto non è solo che GPT-3 ha immagazzinato una quantità di testi “che richiederebbe oltre 600 anni per essere letta dal più veloce lettore umano”, ma che noi non abbiamo la capacità di comprendere e tracciare i suoi ragionamenti, le “rappresentazioni” che si fa del nostro mondo. Possiamo constatarne gli effetti, ed eventualmente correggerli. Conosciamo i risultati, ma non il modo attraverso cui sono stati ottenuti. Questa opacità è uno dei principali aspetti, che determina la nostra difficoltà “a trovare la giusta narrazione per questa ‘intelligenza aliena’, ormai parte delle nostre vite”.
Cristianini, in realtà, sceglie un filo narrativo principale, ed è quello che dà il titolo al libro. La scorciatoia di cui si parla, riguarda un cambio di paradigma, nel senso assegnatogli dal filosofo della scienza Thomas Kuhn. Nel corso di circa un trentennio si sperimentarono due modelli principali di ricerca nell’ambito dell’IA, quello riconducibile ai cosiddetti “Sistemi esperti”, sostenuti da Ed Feigenbaum, uno dei fondatori del dipartimento d’informatica dell’università di Stanford, e quello sviluppato da Frederick Jelinek, in seno al Continuous Speech Recognition Group di IBM, all’inizio degli anni Settanta. La supremazia tra i due modelli fu sancita nel primo decennio del nostro secolo dalle aziende operanti in rete, che ottennero più efficacia commerciale grazie all’utilizzo del modello di Jelinek. Tra di esse c’erano Amazon e Google. Il campo di prova era stato il rapporto dell’agente digitale con il linguaggio umano: riconoscimento del parlato e traduzione automatica. Il modello perdente, “basato sulle conoscenze”, scommetteva sulla possibilità d’implementare nella macchina il massimo numero di norme grammaticali e d’inferenza logica. Molto più efficace si dimostrò la “scorciatoia” operata da Jelinek: all’utilizzo di regole esplicite aveva sostituito l’identificazione di regolarità statistiche, attraverso il trattamento di un numero sempre più ampio di dati.
Amazon tra i primi sperimentò i vantaggi di un tale sistema. L’obiettivo estremo di Bezos era la realizzazione di una vetrina personalizzata per ogni cliente. Per fare questo, avrebbe dovuto disporre di una teoria che non esiste, quella relativa ai gusti dei suoi clienti. In principio, l’unico modo per avvicinarsi ad essa fu il coinvolgimento degli stessi utenti attraverso il riempimento di un questionario, sulla base del quale un gruppo di redattori di Amazon avrebbero proposto recensioni e raccomandazioni per futuri acquisti. Grazie alla “scorciatoia” fu poi creato “Amabot”, l’agente autonomo che coniugava algoritmi di personalizzazione e apprendimento automatico. Non importava farsi un’idea di cosa i clienti volevano o desideravano, bastava osservare quello che facevano, e compararlo con quanto avevano fatto altri clienti. “Amabot non era animato da regole esplicite, né da alcuna comprensione dei clienti o dei contenuti: il suo comportamento dipendeva da relazioni statistiche scoperte nel database delle transazioni passate.”
Tale principio sta alla base non solo di tutti i sistemi di raccomandazione, ma anche di quelli di predizione del comportamento umano o delle risposte fornite da ChatGPT alle domande indirizzategli dagli utenti. Nessuno di questi agenti intelligenti pretende di fornire una risposta certa o vera, in quanto si basa su previsioni che avranno nel migliore dei casi solo una buona probabilità di essere corrette. Ma il problema non riguarda solo i margini di errore presenti nelle prestazioni di tali agenti, ma anche la nostra possibilità di prevenirli e identificarli. Qui si apre il discorso non più esclusivamente epistemologico o tecnico di Cristianini, ma propriamente etico e politico. Oggi ci troviamo in una situazione per certi versi assurda: come se alcuni giganti dell’industria automobilistica e delle infrastrutture stradali avessero rivoluzionato di punto in bianco la mobilità umana su larga scala, senza che ancora sia mai stato elaborato e applicato un codice della strada. Noi siamo perpetuamente in rete, e a contatto con agenti intelligenti che si nutrono delle nostre interazioni quotidiane con loro, senza che si sappia: 1) come essi funzionino e forniscano le loro prestazioni e 2) quale influenza essi possano avere sulle nostre decisioni autonome e sulla nostra salute mentale. Il primo problema esige che gli agenti intelligenti messi a diposizione dalle imprese siano “ispezionabili” (auditable), ossia controllabili da organismi terzi, nella loro costruzione. Il secondo, ancora più del primo, richiede la mobilitazione delle scienze sociali e naturali oltre che di quelle informatiche, per valutare l’impatto che l’esposizione a questi agenti produce sulla psicologia individuale e sulla società nel suo insieme. Tutto questo è un lavoro che in larga parte va ancora fatto, e bisognerà farlo in corso d’opera, elaborando norme di sicurezza stradale, mentre le vetture già ci portano in giro a tutta velocità. D’altra parte, non saranno né le potenti vetture, né le strade ben asfaltate, a produrre di per sé l’indispensabile normativa della sicurezza stradale.
Testi inediti di Giulia Bocchio

II
Quanto tempo sarà passato davvero?
Le ombre sono cambiate, il preavviso è un tranello inascoltato
c’è sempre stata una certa pigrizia di mezzo
è un torto al mondo:
quel giorno qualcuno uscì dall’acqua
per essere più di un batterio.
Qualcosa ribolle dal fondo di un fiume che sembra anonimo
si dice avesse il potere di addormentare le persone
infatti qualche secolo prima di oggi trovarono un uomo addormentato da giorni
lo pensarono morto
quando si svegliò era certo di aver mutato sangue,
si ferì per verificare: ne uscì del miele.
C’era un merlo lì: bevve dalla ferita.
Cambiò piumaggio. E cominciò a parlare.
Chiederemo a Midjourney di fargli un ritratto.
*
Per trovarlo dovrete percorrere un sentiero di ghiaia
il suono dei passi si fece friabile, infatti.
Cosa si chiede a un oracolo?
Non importa se non parlerà
anche il suo silenzio allude a qualcosa di vero.
È nato il giorno in cui piovvero spine
da allora non si contano più gli inverni
sappiamo solo che fece un sogno
l’unico della sua vita:
uno sciame di api gli invase le viscere entrando dal culo
per poi uscire dalla bocca.
Quando si svegliò
il suo sangue ormai era melassa, s’era trasformato in qualcosa
di molto vicino al miele.
Fu una rivelazione:
cominciò a predicare, a disconoscere il dovere e il lavoro
era la sua stessa pelle a dettare la via della ragione.
Per trovarlo dovrete abbandonare l’io
tornare al tempo precedente la nascita: non esistere
perché qui non esiste prima persona.
Divenne ciò che non troviamo oggi
e se questo è un bene oppure un male ce lo dirà un nuovo sogno.
Caen
C’era una festa molto sudata ai piedi del castello
parlavamo lingue ibride
lingue straniere senza aggettivi
per meglio andare al sodo, al nocciolo della visione.
L’erba era umida
non avevo nulla addosso
i piedi nudi,
la voglia di un tuo tocco umano
segno di ogni liberazione dall’ansia
dal futuro sonno meridiano
nel sangue scorreva il grado di qualcosa
asterisco per l’ipocondriaco
il sollievo per il sifilitico
l’indifferenza del vaccinato.
Sapevo che non ti avrei amato
più di quell’atmosfera
uscita dalla testa di un fratello Grimm
degna figlia di un aborto di Baba Jaga.
Un merlo color panna ci osservava inquieto:
era una festa o un sabba interiore
se al centro l’essenza di chi non era ancora arrivato
danzava con lo spirito di chi non sarebbe mai venuto?
*
Ti venero come sangue sale e grano
che verbo inutile stantio marciforme
furono le sue uniche parole davanti a un fiume in secca.
È quel sentiero di ghiaia
che avrebbe dovuto condurci all’oracolo, all’unica risposta
alla non esistenza dell’essere e del tempo.
Per raggiungerlo abbiamo bevuto il nostro piscio
ingoiato terra cruda in nome di un sogno solarpunk
Le sue parole potrebbero essere lontane dal vero, ma utili.
Tutto prende fuoco
è il precipizio della fine
i ricordi ricompongono spettri che non abbiamo sepolto
non ho voglia di sentire il loro alito
per salvarci dovremo immaginarci nel Medioevo;
non so cosa avremmo venerato laggiù
di sicuro molto sangue e poco grano.
Tutto quello che esce dalla sua bocca viene dal basso e si trasforma.
Sembra sapere che saremo venti miliardi
sa che non esiste rimpianto prima di nascere
manca poco,
manca l’acqua,
manca l’aria
in tutto questo mi resta di umano una vena serpentesca
una safena gonfia che si avvinghia alla caviglia e sale
mi annoda all’ego
L’unico da abbandonare
mi lega alle ossessioni
il dolore non ha perso il vizio.
Uno sciame di api che abbiamo già incontrato fa ritorno dal sogno
oscura l’unica porzione di cielo che riusciamo a vedere:
venti miliardi…
Quel giorno piovvero spine.
***
Giulia Bocchio è scrittrice e giornalista. In poesia ha pubblicato le raccolte Harmattan Poetico (Ass. Talento) e Il vento del vanto (Genesi). Nel 2016 esce il saggio L’Olimpo nero del sentire (Marsilio) e nel 2020 il romanzo La febbre dell’io (Il Ponte Vecchio). È direttrice editoriale di Poetarum Silva. Suoi articoli sono usciti su minima e moralia, Il Fatto Quotidiano, Vernice e altre riviste e blog online. Scrive per Il Piccolo.
[Presentiamo tre testi estratti dal volume di poesia Canto dei morti sul lavoro apparso per Zona editore nel 2022.]
di Guido Caserza
Claudio Toso andava al lavoro
andava al lavoro Franco Viberti
ci andava Gemma Corradi
e ci andava sua figlia Carla
pure Marco Guerriero andava al lavoro
e ci andava suo figlio Piero
e tutti andavano sulla soglia della morte,
anche Carlo Volterra andava al lavoro
e forse quello era l’ultimo giorno,
andava al lavoro Cristiana Ferrari
e ci andava Fabrizio Pietri
e tutti conducevano la loro vita al termine
tutti erano destinati alla morte,
dove andavano costoro?
Andavano al lavoro
andavano a morire,
dove andava Francesco Colasante? Andava
al lavoro, aveva venticinque anni
andava a morire, saliva sul traliccio,
il traliccio si incendiò,
abbracciato alle fiamme scivolò
dal traliccio, era il 18 agosto 2020
quel giorno andava a morire,
e dove andava Michele Cacco? Andava
al lavoro, aveva quarantanove anni,
nato da sangue operaio andò come ogni giorno
in quella fonderia di Marcon,
morì schiacciato sotto
il peso di una porta forno, era il 4 novembre 2020
quel giorno andava a morire,
e dove andava Stefano Zanni?
Esperto come nessuno di carpenteria
andava al lavoro, di anni ne aveva sessantuno,
salì sull’impalcatura di una cappella privata
nel cimitero di Orta Nova
e cadde dall’impalcatura,
era il 27 maggio 2021
quel giorno moriva,
e dove andava Ugo Gilardi il
25 novembre 2020?
Quel giorno Ugo Gilardi andava al lavoro,
aveva trent’anni,
è morto sotto il carico di un furgone,
la morte gli aveva stipulato un bel contratto.
***
Ora
la divisione del lavoro
qualcuno l’ha chiamata
approccio olistico – c’era vita in quei corpi
prima di entrare nella fabbrica, tutto
è fabbrica revolvente,
fabbrica-linguaggio,
fabbrica dal materiale all’immateriale al materiale,
fabbrica-saccheggio,
fabbrica-mattatoio,
per essa tutto fluisce per virtù sua propria
come i pianeti per gravitazione
e le stelle confitte nel cielo,
la stupenda fabbrica del cielo
anch’essa revolvente nella medesima guisa
tutto è fabbrica revolvente.
Impulsi di muscoli o di cervelli in nuda vita,
elettriche eclissi di vita, a ogni corpo una funzione,
ma i cadaveri eludono ogni descrizione,
cadaveri di uomo,
cadaveri di donna, perfetti alla morte,
perfetti nel martirio,
l’espressione del loro stupore
si manifesta nel volto
una volta
fatto per vivere
uno spruzzo di sangue
che taglia l’orizzonte.
Alcuni avevano una natura dolce
e un portamento amichevole,
erano fatti per essere contemplati,
promanavano vita, incontrollabile vita,
ma così arrendevoli ormai,
snervati,
costretti a svernare
fra le braccia del lavoro
millenni di lavoratori – azione e forza –
le ricchezze proprietarie sono in loro
da loro nascono per loro si moltiplicano,
millenni di lavoratori all’incanto,
osservate le loro meraviglie
fate la vostra offerta,
osservate le loro membra,
la perfetta tessitura di tendini e muscoli,
li denudiamo perché possiate correttamente valutarli,
fate la vostra offerta,
guardate i loro occhi accesi di vita,
ognuno di loro – considerate anche questo –
è non solo corpo forza lavoro ma un padre
padre di un figlio che diverrà a sua volta padre,
millenni di lavoratori in un solo lavoratore,
ogni corpo è un corpo brulicante di altri corpi,
braccia mani gambe
la linfa scorrente del lavoro
prego venite a lavorare per noi,
un lavoratore ha compiuto il suo lavoro è morto,
arriva un altro lavoratore felice dello stipendio,
i ticket per il pranzo li può usare come vuole tra poco muore,
arriva un altro lavoratore lì pronto a rimpiazzarlo,
il turno di notte gli vale un extra,
la notte gli cola l’occhio
piegato sui ferri da fondere
in cielo pende la luna tra poco muore,
un altro lavoratore arriva, uno all’incanto,
in somministrazione di lavoro tanto
per fare una prova fra poco muore.
Arriva un altro lavoratore
felice prima di uscire, ore sette del mattino,
dice alla moglie appena mi danno l’aumento
pensiamo a fare un figlio tra poco muore.
***
Quello faceva il turno di notte
che notte che era!
una luna grassoccia
lo sbirciava
da dietro una nuvola
e dall’arteria sprizzò
uno zampillo di sangue,
neppure il tempo
di cacciare un grido
Al lavoro! Al lavoro!
e la testa rotolò
per parecchi metri sul selciato
faceva il turno di notte
e una luna terribile
Al lavoro! Al lavoro!
e un piede venne
ritrovato nel fossato
e una luna grassoccia
Al lavoro! Al lavoro!
e brandelli di carne
erano ovunque
nel cielo monco
l’occhio della luna,
che notte che era!
la verde primavera violentata
dagli odori pungenti,
sputi di luce le stelle nel cielo,
la moglie stesa
sulla bara come una bandiera
con la bocca squarciata dal dolore
pianse il suo pianto su quel corpo amato
che notte che era.

di Giulia Delogu
Fin dall’uscita del trailer la scorsa estate i commenti sulla storicità, o piuttosto sulla mancanza della stessa, del film Napoleon di Ridley Scott si sono sprecati. Giornali, blog, social hanno visto un profluvio di interventi da parte di storici di mestiere e da parte di appassionati, tutti preoccupati dall’assenza di precisione storica nel colossal statunitense, non senza reazioni polemiche da parte del regista e difese da parte del cast. Dialoghi, svolgimento delle battaglie, età e aspetto dei personaggi sono stati scrutinati attentamente.
Facciamo, però, un passo indietro. È il 2023 ed esce un film su Napoleone Bonaparte (1769-1821), generale e poi imperatore dei francesi, morto in esilio sull’Isola di Sant’Elena, uno scoglio roccioso nel mezzo dell’Atlantico a quasi 2.000 km dalle coste dell’Africa. Peraltro, esce non un semplice film, ma un colossal, prodotto da un acclamato regista hollywoodiano, che a sua volta ha ripreso il pluriennale progetto di Stanley Kubrik, il quale sempre aveva sognato di produrre una pellicola sul tema (vicenda e documenti preparatori sono stati ricostruiti e raccolti in Stanley Kubrick’s Napoleon: The greatest movie never made, curato da Allison Castle nel 2009). Insomma, un uomo morto duecento anni fa in un “tristo esiglio” viene giudicato ancora oggi un soggetto meritevole di esplorazione nell’arte cinematografica, al suo massimo potenziale di visibilità e distribuzione, e davvero ci dobbiamo domandare se le due ore e mezza di film sono precise come un saggio storico accademico?
Le questioni da porsi – mi sembra – sono di tutt’altra natura e ruotano attorno a questa: perché ancora Napoleone? A fianco a questa domanda, imprescindibile ma come vedremo assai difficile a sciogliersi, c’è un secondo ordine di riflessioni: cosa può aggiungere l’arte, con la sua felice e creatrice imprecisione, a quanto già sappiamo o crediamo di sapere sul nostro passato, per come ci viene raccontato nelle opere degli storici?
Partendo con ordine, bisogna considerare alcuni elementi della vicenda storica di Bonaparte. Napoleone fu in vita una celebrità. Il concetto di celebrità, come ha di recente illustrato Antoine Lilti, si sviluppò proprio nel corso del XVIII secolo e tra i primi ad essere identificati come tali vi furono i filosofi illuministi Voltaire e Rousseau, ammirati non solo per il loro pensiero, ma come persone uniche, speciali eppure umane e fragili, di cui il pubblico voleva conoscere morbosamente i dettagli della vita privata. Similmente, Napoleone fu al centro di miti positivi e anche negativi – la famosa leggenda nera, come scrisse lo storico francese Jean Tulard – e seppe utilizzare consapevolmente in prima persona i meccanismi della popolarità.
Napoleone, tuttavia, non era solamente un “influencer” capace di sfruttare i media del suo tempo (gazzette, fogli volanti, incisioni vendute per pochi soldi, ritratti ufficiali, statue colossali e molto altro), ma era anche una figura dotata di eccezionali capacità intellettive e doti di comando, che lo resero un leader carismatico, nel campo di battaglia e nell’arena politica. Lo storico David A. Bell, in un volume recentemente tradotto in italiano (Il culto dei capi. Carisma e potere nell’età delle rivoluzioni, 2023), ha illustrato l’emergere, tra Sette e primo Ottocento, di nuovi stili di governo e legittimazione politica, incentrati sul carisma personale, comprendendo nella sua galleria, oltre a Napoleone, Pasquale Paoli (1725-1807), George Washington (1732-1799), Toussaint Louverture (1743-1803) e Simón Bolívar (1783-1830) rispettivamente leader dell’indipendenza corsa, statunitense, haitiana e sudamericana.
Napoleone, in buona sostanza, unisce due tendenze che caratterizzano il sorgere della modernità tra Sette e Ottocento, celebrità e carisma, e condivide questi tratti con figure rilevanti della storia politica e intellettuale del mondo occidentale, personaggi senz’altro tuttora noti e studiati nelle scuole… ma davvero ancora famosi come appare essere l’imperatore? Cosa rende Napoleone così attrattivo, nonostante le ormai molteplici condanne verso alcune sue controverse decisioni, come quella di reintrodurre la schiavitù nelle colonie caraibiche della Francia o di aver comunque causato, a conti fatti, milioni di morti con le sue campagne militari, come non manca di osservare anche Scott nei titoli di coda del suo film?
Ciò che da duecento anni “salva” Napoleone, al punto di rendere la sua celebrità duratura e globale ben al di fuori dei confini della sua Francia, è non sono il carisma, una vita al comando e i successi, ma la fragilità, la sconfitta e l’esilio. Il vero mito nasce a Sant’Elena: il luogo che secondo gli avversari inglesi doveva sancirne l’oblio ne decreta invece l’immortalità, come sottolineato anche nel volume pubblicato da Vittorio Criscuolo nel 1821, anno del bicentenario dalla morte (Ei fu. La morte di Napoleone). Con Napoleone lontano, tacitato e sofferente si moltiplicano le opere che parlano di lui e delle sue gesta, giocando sui meccanismi della nostalgia e del rimpianto nel cupo clima dell’Europa in “Restaurazione”. La morte suscita un’ondata di commozione senza precedenti: molti che lo avevano avversato in vita, colpiti dal “martirio” della dura prigionia impostagli dai vincitori, finiscono per dare giudizi più sfumati, se non addirittura positivi.
È il caso di Alessandro Manzoni, che compone di getto l’ode Il cinque maggio (1821), che tutti ricordano (forse pure con fastidio!) dalle scuole, ma di cui forse è meno noto il successo globale con traduzioni, entro la fine del secolo, in latino (6), francese (3), spagnolo (7), catalano, (1), inglese (1), portoghese (2, di cui una promossa in Brasile dall’Imperatore Dom Pedro II) e tedesco (8, di cui una immediata a cura di Goethe). Quella di Manzoni è una buona lente per cercare di comprendere “perché ancora Napoleone”: il poeta stesso ammette di non aver avuto interesse per il generale vittorioso o l’imperatore sul trono. Ma l’uomo solo, sconfitto, stanco e tormentato è un’altra cosa: è quello che affascina, di cui si può persino riconoscere la grandezza passata. È quello che si può persino piegare e re-immaginare in base alla propria sensibilità, come fa pure Manzoni, che si figura un Napoleone finalmente umile e intriso di fede cristiana.
Al di là dell’elemento religioso, è la declinazione “umana” di Napoleone che decreta il successo mondiale della poesia manzoniana presso i contemporanei e non solo. Al Napoleone “umano” e “privato” guardano anche le tante memorie che appaiono nel corso dell’Ottocento, mostrandolo padre affettuoso o amante devoto e non solo provetto militare o deciso sovrano. Non sono opere “storiche” non badano alla precisione dei dettagli, ma ricostruiscono caleidoscopiche immagini di un Bonaparte nel quale il pubblico può empaticamente identificarsi. È questo in larga parte il Napoleone che ritroviamo nel film di Scott: imperatore, amante, tiranno, leggenda. Si tratta di una figura complessa, che non si può né condannare né difendere interamente, pieno di tratti eccezionali, ma anche estraneamente fallibile.
Napoleone era davvero così? A due secoli dalla sua morte, con la sua immagine così iconicamente riconoscibile usata in meme sui social, vignette, pubblicità, insegne e ogni tipo di prodotto quotidiano e popolare, dalle calze alla cancelleria, forse ormai poco importa. Ognuno ha un suo Napoleone. Il mio, ad esempio, non è affatto quello di Scott, ma quello dei versi di Foscolo e del dipinto di Appiani: ventisettenne, pallido e col volto scavato, biondo e scarmigliato, alla testa delle sue truppe sul ponte di Arcole, una parte dell’epopea napoleonica del tutto assente nel film, che decide di saltare la Campagna d’Italia (1796-1797). Manzoni, che pure coltivava la prosa e l’indagine storica, per parlare di Bonaparte sceglie la poesia, l’unica forma adatta per lo scandaglio dei pensieri e delle emozioni, che nessuna ricerca documentaria e archivistica può restituire fino in fondo. Lo scrittore italiano seppe cogliere allora ciò che a molti sfugge ora: Napoleone aveva una potenza immaginifica che travalicava gli eventi che lo avevano visto protagonista e che per capirne il motivo bisognava andare oltre una minuziosa ricostruzione dei fatti.
Rispondere alla domanda “perché ancora Napoleone?” – e credo non esista ad oggi una risposta definitiva e completa – richiede probabilmente un simile salto; un salto che guardi non a ciò che è successo, ma a come lo si è raccontato nelle arti e nei decenni a venire. Sono le rappresentazioni artistiche che hanno reso così riconoscibile il volto di Napoleone e sono le versioni romanzate e poetiche della sua vita, delle sue gesta, dei suoi pensieri e dei suoi sentimenti che ce lo rendono “interessante” anche nel terzo millennio, insieme alle fonti e ai dati storici. È la congiunta possibilità di vederlo come uomo pubblico di stato con un cervello straordinario, leader carismatico insomma, e al contempo persona (quasi) comune con un cuore del tutto ordinario che spingono a rinnovarne continuamente il mito (come Il Naufrago e il dominatore, icastico titolo che Antonino De Francesco ha dato alla sua Vita politica di Napoleone Bonaparte, uscita nel 2021).
La libera, felice e creatrice “imprecisione” delle arti (letterarie, visive, cinematografiche, in tutti i loro livelli, dal più basso al più alto) ha permesso di colmare i limiti dell’indagine storica e di avvicinarsi al Napoleone più umano, mantenendo così elevati attenzione e attaccamento alla sua figura. Questo continua a fare il film di Scott, che ci restituisce il suo Napoleone – un Napoleone con gli occhi del 2023 – e ha il merito di sollecitare storici (e non solo) ad interrogarsi non su quanta aderenza al vero ha un prodotto artistico (quale vero, poi?), ma piuttosto su fenomeni assai attuali come la preponderanza del leaderismo e del personalismo in politica, o il peso sempre più rilevante della memoria e della nostalgia nelle costruzioni culturali. Risolvere l’enigma della vitalità di Napoleone, in conclusione, sembra essere una buona strada per capire di più dell’epoca in cui ha vissuto, momento di stridenti conflitti e di genesi della modernità, e di quelle che sono seguite, attraversate tutte dal suo mito.

di Sergio Oricci
In una città dell’Europa dell’Est, una delle tante città di media grandezza che possono essere percepite come grandissime e piene di opportunità da chi ha sempre vissuto in provincia, oppure piccole e noiose da chi aspetta di trasferirsi in o pensa di essere la persona giusta per una metropoli tentacolare, come si sarebbe detto in una puntata di una serie TV noir di un’epoca passata, due uomini camminano in direzioni opposte su una strada che collega il centro storico alla periferia nord per poi continuare oltre i confini dell’abitato e raggiungere una zona boschiva in cima a una collina.
Sono destinati a incrociarsi, a meno che uno dei due non decida di attraversare e di spostarsi sull’altro lato della carreggiata, ipotesi piuttosto improbabile perché la strada è a scorrimento veloce, o comunque è una strada su cui le vetture – automobili per lo più occupate da un solo passeggero, l’uomo o la donna alla guida, ma anche motociclette di grossa cilindrata e qualche tir di dimensioni ragguardevoli; non si vedono motorini – viaggiano a velocità sostenuta, dando alle corsie l’apparenza di qualcosa che se pure non fosse stato concepito per scorrere velocemente adesso lo sta facendo.
I due uomini che camminano in direzioni opposte e che sono destinati a incrociarsi non hanno molto in comune, le loro vite anzi non potrebbero essere più distanti – quello che sale ha quarantun anni, è sposato, ha due cani, un lavoro a tempo pieno che lo costringe a spostarsi in treno più di quanto vorrebbe, l’altro, che scende, di almeno quindici anni più vecchio, è single da sempre, vive da solo e prova a sopravvivere con una pensione d’invalidità che non basta neanche per soddisfare i suoi bisogni primari, tra cui c’è quello di andare a puttane almeno tre volte all’anno – ma c’è una cosa che li accomuna: entrambi soffrono di zoppia, l’uomo sposato per una patologia neurologica degenerativa destinata nel giro di cinque, forse dieci anni, a paralizzarlo del tutto, e l’uomo single a causa di una dismetria degli arti inferiori di circa tre centimetri e mezzo.
L’uomo con due cani e un lavoro a tempo pieno che lo costringe a spostarsi in treno più di quanto vorrebbe, e che ha una patologia che con il tempo si aggraverà fino a impedirgli perfino di respirare, si accorge dell’altro uomo per primo, e nota subito un’andatura che, seppure con delle differenze visibili anche da quella distanza, gli ricorda la propria. Cerca di immaginare quale sia la causa della zoppia dell’uomo che sta camminando verso di lui, e prova perfino un certo senso di tenerezza nel guardarlo faticare in discesa almeno quanto lui stesso sta faticando a salire quelle poche centinaia di metri che lo condurranno a casa.
L’uomo sposato e con due cani non ha ancora preso in considerazione l’idea di usare un bastone, un deambulatore o un qualsiasi dispositivo che lo aiuti a camminare, e ha deciso che non lo farà fino a quando non sarà strettamente necessario. Inoltre non ha mai preso la patente, cosa di cui oggi si rammarica ma a cui non riesce a porre rimedio per questioni che riguardano un certo senso di inadeguatezza nel fare qualcosa fuori tempo, oltre che l’eventualità, ormai quasi certa, di non passare gli esami clinici e di non risultare idoneo alla conduzione di un mezzo motorizzato. L’uomo single da sempre, sessualmente frustrato e senza neanche i soldi per andare a puttane tre volte all’anno come riterrebbe indispensabile per mantenere la sua frustrazione entro certi limiti e non farla sfociare nel patologico, si accorge a sua volta dell’uomo che cammina verso di lui zoppicando, e pensa che ci sia una probabilità – non riesce a quantificarla né a formulare una percentuale approssimativamente realistica, ma sa che esiste – che lo stia facendo dopo averlo notato, come in una sorta di imitazione grottesca, una presa in giro, qualcosa che in questo momento l’uomo – dopo l’ennesima giornata trascorsa in solitudine, in uno stato d’animo che adesso definirebbe tra l’apatia e una tenue disperazione, per quanto la disperazione possa esserlo – proprio non sente di poter sopportare.
Un cane randagio passeggia risalendo la strada, con il muso rivolto verso l’asfalto, annusando ogni più piccola, infinitesimale molecola odorosa – principalmente feci, urina e resti di cibo – e supera rapidamente l’uomo che sale e quindi incrocia l’uomo che scende, per poi svoltare in una stradina laterale e sparire veloce come era apparso. Si sta facendo buio e i due uomini sanno esattamente che ore sono perché entrambi guardano di frequente i propri telefoni, l’uomo che sale lo fa per essere sicuro di non aver perso una chiamata della moglie – tiene sempre il telefono in modalità silenziosa – mentre per l’uomo che scende si tratta di una sorta di tic, un gesto automatico a cui si aggrappa per far passare il tempo e non pensare ad altro. Fa freddo, sono entrambi soli ed entrambi non aspettano altro che arrivare a casa; uno sarà accolto dai due cani che gli salteranno addosso come se non lo vedessero da settimane, e poi dalla moglie che lo abbraccerà facendogli sentire quel contatto che lui non potrà fare a meno di percepire almeno in parte come definitivo, il bacio sulla fronte che i figli danno al genitore nel feretro, mentre l’altro sarà accolto dal silenzio di una piccola, piccolissima pace, dalla solitudine che precederà di poco la prima e poi la seconda bottiglia, fino alla pace un po’ meno pacifica e un po’ meno piccola del sonno.
I due uomini sono ormai vicinissimi, solo pochi metri separano l’uno dall’altro. Per un osservatore non coinvolto sarebbe evidente che l’uomo che sale stia procedendo con una claudicazione falciante, lo si capisce dal modo in cui circonduce l’anca, mentre la camminata dell’uomo che scende ha i tratti caratteristici di una zoppia di caduta, con la gamba sinistra che tende a lasciarsi andare fino al trascinamento. Ma i due uomini non sono osservatori non coinvolti e adesso non riescono a fare altro che guardarsi a vicenda e specchiarsi in quella coincidenza formulando teorie e ipotesi.
L’uomo che sale, sposato e con due cani, adesso che riesce a guardare negli occhi l’uomo che scende, pensa di riuscire a vedere in lui una tristezza che non crede di avere mai provato, ma allo stesso tempo sa che c’è la possibilità che questa sia una percezione falsata, e di non avere nessun elemento oggettivo su cui basarsi per credere a quel pensiero che in fondo ha prodotto in maniera istintiva. L’uomo che scende, single da sempre e sessualmente frustrato, nell’accorgersi del sorriso dell’uomo che sale, si convince che quella zoppia simmetrica rispetto alla sua sia davvero una maniera per prendersi gioco di lui e inizia ad avvertire un moto di rabbia. Ma anche lui ha ben presente che c’è una probabilità, seppur minima, che si tratti di un semplice caso, e non vuole che la sua parte irrazionale prenda il sopravvento, non tanto perché crede che sia sbagliato lasciarsi guidare dal momento ma perché davanti a sé vede soltanto due possibilità: la prima è che l’uomo stia davvero fingendo, e in quel caso arrivare a uno scontro – verbale e poi fisico – non porterebbe a niente di buono perché non sarebbe in grado, con la sua zoppia, di affrontare una persona sana e così cattiva da fingere di zoppicare per prendere in giro chi davvero fatica a camminare, e la seconda è che l’uomo non stia fingendo e che abbia le sue stesse o ancora peggiori difficoltà, e allora arrivare a uno scontro – verbale e poi fisico – non avrebbe davvero senso e sarebbe soltanto l’ennesima dimostrazione che i suoi problemi non risiedono nella zoppia, nella dismetria di tre centimetri e mezzo dei suoi arti inferiori, ma in uno stato psicologico che – almeno questa è la sua impressione – peggiora di anno in anno e che sta rischiando di trasformarlo in una persona fuori dalla persona, e nonostante la confusione che questo pensiero genera, l’uomo è certo che sia l’immagine più aderente alla realtà dei fatti.
Sopra le teste dei due uomini che procedono zoppicando, un nido di cavi elettrici si annoda tra i lampioni. L’uomo che sale e l’uomo che scende si fermano quasi contemporaneamente, il primo perché viene assalito da un pensiero improvviso mentre l’altro solo per riprendere fiato. L’uomo sposato e consapevole che tra dieci anni sarà completamente – o quasi completamente, o parzialmente perché il concetto di completamente o quasi completamente cambia quando si tratta di fare i conti con le proprie gambe, con le proprie braccia e con il proprio apparato respiratorio, il cuore eccetera eccetera – paralizzato guarda con più attenzione l’uomo che scende e si chiede se nella città in cui vivono non ci sia una percentuale superiore alla media di malattie neurologiche degenerative, prende il telefono e inizia a cercare risultati che confermino o smentiscano il pensiero da cui è stato appena assalito; prova a individuare una corrispondenza tra la presenza di una enorme discarica ai confini della città, la qualità dell’aria, e il numero di persone affette da multipla, laterale amiotrofica, malattie autoimmuni, e finisce per trovare tutto e il contrario di tutto e anche in lui monta una rabbia irrazionale che lo avvicina pericolosamente – o così sente o crede di sentire – a una crisi, un attacco di panico, un momento insopportabile in cui non gli sarà più possibile mantenere l’equilibrio, perfino respirare, rabbia irrazionale che cerca di controllare – è una persona piuttosto equilibrata, o così crede di essere, attacchi di panico a parte – e che a poco a poco si tramuta in una serie di onde che assumono l’aspetto di cali di pressione che non passeranno subito ma che prima o poi verranno assorbiti e lasceranno traccia di sé nella memoria dei muscoli e del corpo, e diventeranno quindi più gestibili, più prevedibili e sembreranno meno terminali anche nel caso in cui lo fossero veramente.
L’uomo che sale cerca di respirare a fondo e stringe i pugni per sentire il proprio corpo, e l’uomo che scende cerca di respirare a fondo e prova a pensare a qualcos’altro, a sua madre, a sua nonna, alla solitudine che lo attende nell’appartamento, a qualsiasi cosa che non sia l’uomo che sale e che forse lo sta prendendo in giro – e che allora non potrà in nessun modo affrontare – o che forse zoppica proprio come lui – e che allora non avrebbe nessun senso affrontare.
I due uomini finalmente si incrociano, e l’uomo che sale fa un passo laterale per mettere dello spazio tra sé e l’altro, abbozza ancora un mezzo sorriso, mentre l’uomo che scende tiene lo sguardo fisso sul marciapiede e, proprio quando l’uomo che sale gli sfila accanto, si piega sulle ginocchia e raccoglie una lumaca che restando lì rischierebbe di farsi schiacciare. La tiene in mano per un po’, stringe il guscio tra le dita aumentando la pressione fino al punto in cui crede di individuare come il limite superato il quale, anche di un niente, il guscio si romperebbe. La lumaca emette una sorta di barrito; l’uomo lo percepisce chiaramente e, interpretandolo come un tentativo di aggrapparsi alla vita, un segnale di una volontà di sopravvivenza, smette di stringere, non perché ne sia impietosito ma perché non aveva idea che le lumache potessero soffiare, barrire, con tanta forza, né che potessero esprimere in modo così chiaro la propria volontà: smettere di premere gli sembra dunque un giusto riconoscimento.
Il guscio non si è rotto, e l’uomo che pur essendo adesso fermo sta ancora in un certo senso scendendo appoggia la lumaca in una zona erbosa al di là di una rete metallica. Si gira e vede l’uomo che sale ormai lontano: zoppica ancora. Poi guarda in direzione dell’edificio poco distante, le luci accese del negozietto di generi alimentari lo rassicurano: comprerà del pane, del latte, una o due bottiglie, magari qualcosa di dolce, pagherà in contanti e saluterà la cassiera augurandole una buona serata o perfino una buona notte. L’uomo adesso smette davvero di scendere e alza lo sguardo: il cielo promette pioggia.
di Yousef Elqedra
“Pronto yà ba , stiamo bene”
“Siamo usciti sotto una pioggia di missili e bombe al fosforo bianco che ci piovevano addosso dagli aerei israeliani, correvamo senza portarci dietro nulla, passando sopra cadaveri e resti di corpi, mentre le fiamme oscuravano il cielo con masse enormi di fumo.”
Così, con la mente distratta, Abu Bilal si è seduto a raccontare la storia del suo esodo dalle torri di al Karama, a nord di Gaza, fino al suo ricongiungimento con la famiglia, dopo aver perso la casa e due nipoti ed essersi stabilito in un rifugio a Khan Yunis.
Dove sono le ragazze?
Il sessantenne prosegue il racconto del giorno della fuga: “Abbiamo lasciato le nostre case così, senza la minima capacità di orientamento persino in zone che conosciamo a memoria, figli sulle spalle e donne in corsa al nostro fianco. Siamo andati avanti più che potevamo in tutte le direzioni, e ogni volta che avanzavamo di qualche metro e ci guardavamo alle spalle, scorgevamo la follia e l’isteria inseguirci.”
Solo una volta arrivati a circa un chilometro di distanza, i membri della famiglia hanno iniziato ad accertarsi se c’erano tutti e, dopo essersi riuniti, si sono accorti che all’appello mancavano la figlia e il figlio maggiore: una perdita durissima.
Abu Bilal continua: “Dopo mezz’ora è apparso mio figlio. Gli ho chiesto notizie sulle sue due ragazze: quando è scoppiato in lacrime ho capito qual era la risposta. Per cui ho suggerito a mio figlio di mezzo di andare avanti con la famiglia, di portare tutti il più lontano possibile, nei rifugi a sud di Wadi Gaza, mentre io e mio figlio maggiore siamo tornati a casa, metà della quale era crollata e l’altra rimasta sospesa in aria. Lì abbiamo cercato le mie due nipoti, sul posto c’erano molti cadaveri e molti feriti sanguinanti e le ambulanze non erano ancora arrivate”.
Questa è una tra le migliaia di storie e non è solo la storia della famiglia Abu Bilal. Cambiano i nomi, ma gli eventi e le storie del giorno dell’esodo da Gaza sono simili. Non c’è famiglia che non abbia perso alcuni dei suoi membri dall’inizio della guerra, e diverse famiglie sono scomparse del tutto senza un testimone che racconti la loro storia.
Abbiamo sepolto le due ragazze e abbiamo continuato la nostra fuga
L’uomo prosegue: “Abbiamo trovato le due ragazze, annegate nel loro stesso sangue. Io ho sollevato la prima, e il padre la seconda, poi abbiamo camminato tra i feriti sanguinanti e le case in macerie, ammucchiate su sé stesse e sui propri abitanti. Abbiamo camminato circa due chilometri prima di trovare un’auto che ci portasse all’ospedale. Lì la situazione non era migliore: era affollato di persone in fuga dalla morte, vittime e feriti. Finalmente siamo arrivati al pronto soccorso, ma era troppo tardi.”
La vicenda, così come la descriveva l’uomo, può sembrare assurda. I medici hanno confermato che le due ragazze erano morte e hanno ordinato di trasportare i cadaveri all’obitorio; lì hanno annotato i loro dati e poi le hanno avvolte in sudari. Aggiunge: “Abbiamo pregato per le due ragazze con le persone presenti in ospedale, poi le abbiamo trasportate con il carro funebre al cimitero vicino, dove le abbiamo sepolte.”
Di come fermarsi per un attimo sul proprio dolore sia considerato un pericolo e un ostacolo alla fuga, l’uomo dice: “Così in un lampo, senza il tempo di versare neppure una lacrima né di emettere un sospiro abbiamo sepolto le due ragazze. Tutto questo è avvenuto sotto il rombo dei droni di sorveglianza e tra i continui bombardamenti qui, là e ovunque.”
Stiamo bene, yà ba (papà)
Le lacrime brillano negli occhi di Abu Bilal, che ha più di sessant’anni e bellissimi capelli grigi che gli coprono la testa, esaltandone l’autorevolezza; emette un sospiro che già mi scuote, prima di continuare il suo racconto.
Dice: “In quel momento non sapevo dove fosse la mia famiglia, chi fosse rimasto di loro, né sapevo dove andare. Mi aggrappavo a mio figlio, che aveva bisogno a sua volta di qualcuno a cui appoggiarsi: aveva appena sepolto le sue due figlie.”
Abu Bilal aveva cercato ripetutamente di contattare il figlio di mezzo, che aveva lasciato con la famiglia, per sapere dove erano arrivati e come raggiungerli, dato che non avevano parenti né conoscenti nel sud. L’uomo prosegue: “Non sapevo in quel momento se si fossero effettivamente spostati a sud o se avessero scelto un’altra destinazione, così mi sono seduto sul marciapiede, aspettando una chiamata o una risposta. Infine, dopo due ore è arrivata la telefonata, che mi ha rincuorato:
– pronto yà ba, stiamo bene, siamo al rifugio della Mezzaluna Rossa Palestinese a Khan Yunis.
– Grazie a Dio, yà ba… vi raggiungiamo.
Abu Bilal continua a raccontare: “Ho riagganciato il telefono senza lasciare spazio per parlare delle due ragazze. L’arduo compito che dovevamo affrontare in quel momento era trovare un’auto che ci portasse da Gaza a Khan Yunis in mezzo ai bombardamenti e tra le strade interrotte. Ho provato con ogni macchina che passava, avanzavamo e chiedevamo un passaggio, avanzavamo e speravamo, avanzavamo e offrivamo somme di denaro raddoppiate, finché non è arrivato finalmente un automobilista che ha accettato”.
Un automobilista pazzo ci ha portati a sud
Il tragitto non era facile, come lo descriveva Abu Bilal: molte strade sono state interrotte e distrutte dai bombardamenti. Un’ora dopo aver lasciato Gaza, l’uomo e suo figlio sono arrivati in via Salah al-Din direzione sud.
Tutto ciò di cui la famiglia aveva bisogno in quei momenti era un luogo sicuro, che consentisse alla tristezza di uscire allo scoperto, lasciasse lo spazio al pianto, che bastasse per contare i membri della famiglia e sapere chi fosse rimasto in vita e chi no.
L’uomo conclude: “L’automobilista era allo stesso tempo prudente e spericolato fino alla pazzia e noi stavamo uscendo dalla stessa follia, volevamo arrivare in qualunque luogo, cercavamo un po’ di sicurezza e conforto e tentavamo di comprendere che cosa fosse successo. Tutto quel che ricordo è che eravamo al sicuro a casa, a prepararci per la colazione, prima che iniziasse tutta questa follia.”
*
Yousef Elqedra è un poeta palestinese residente a Gaza. Su Nazione Indiana appare nella traduzione di Sana Darghmouni e Pina Piccolo.
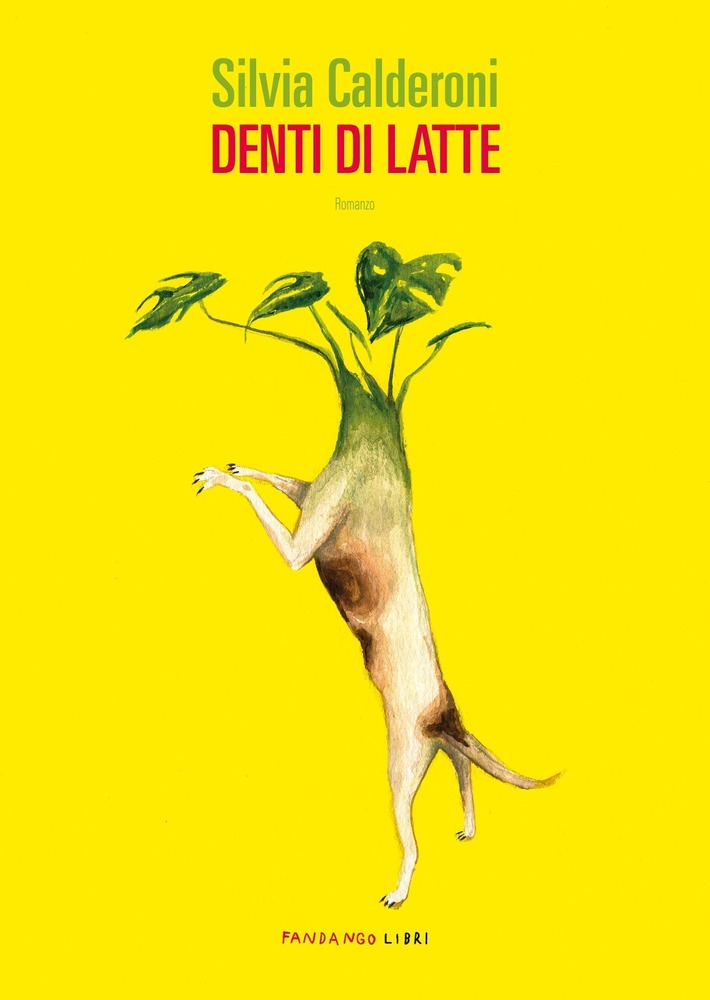
Un dente strappato come il ricordo; tutto si tiene, tutto traballa: «nonostante che le persone e i luoghi citati non siano inventati, questo non è un romanzo autobiografico». Si apre così Denti di latte, il romanzo di Silvia Calderoni pubblicato recentemente da Fandango.
È, questo di Calderoni, un libro di giuramento all’inquietudine, di vita spalancata e di schianto con l’acqua fredda di ogni infanzia. Libro dei tremolanti, delle piccole persone che cercano di abitare il proprio tremore, e di farne racconto luminoso. Libro che per questo che non assolve alcun compito prestabilito; che anzi ricomincia, sorprendentemente, ad ogni capitolo, decidendo di essere fedele fino in fondo alla memoria più-che-naturale, al regno del sogno e della seconde vite, quelle selvatiche, quelle che sempre bruciano in noi, come del resto brucia il corpo di Silvia Calderoni ogni volta che la vediamo varcare la scena. Ripenso a una riga da lei pronunciata in Paesaggio con fratello rotto del Teatro Valdoca: «sento il cosmo che tiene / e non è stanco. / Solo l’uomo è stanco».
Tutto si tiene, dicevamo. Tutto s’agita nell’intreccio magnifico delle righe: il dettaglio di gioia e lo spasmo, la memoria e la lacuna, la tosse e il fiore di forsizia: «e all’improvviso un uccello ha iniziato a batterle le ali nel torace. È doloroso, diceva, ha bloccato il respiro.». Poi, piano piano, ha smesso di agitarsi ed è tornata a respirare.
***
Ospito qui un capitolo dal libro. Grazie a Fandango per la concessione.

È da giorni che non riesco a mordere le mele. Mi balla un dente. È la prima volta che sento che un pezzetto di me ha deciso di lasciarsi andare. Lo dico a lui, è pomeriggio e come al solito siamo soli in casa. È seduto sul divano a tre posti con le gambe incrociate l’una sull’altra. Non ha le scarpe e in una delle due calze color blu notte c’è un buco all’altezza del dito medio. Sento forte l’odore acre dei suoi piedi.
“Vieni qui, fammi vedere…”
Accompagna la frase con un gesto della mano. Come per semplificare una lingua già semplice. Lui è così, è tutto corpo, non è mai una cosa senza l’altra. Io non mi avvicino subito, sono schiva, afferro il mio dente incisivo tra pollice e indice della mano sinistra e abbasso la testa. Sospiro, il dentino si muove ancora, ma ormai non ho più il primato su nessun segreto.
“Ti ho detto di venire qui!”
Adesso il tono della voce si alza e, per paura di contraddirlo, mi avvicino rapida. Le mani di lui sono enormi. Quando camminiamo per strada uno accatto all’altra, invece di tenerci mano nella mano, ci teniamo dito-mano. Perché le sue dita sono grosse come zucchine e lunghe più delle manopole del manubrio della mia bicicletta. Il suo indice è stato forgiato su misura per le mie manine magre e, quando mi aggancio, posso camminare anche a occhi chiusi: e se inciampo, lui mi tiene, sempre. Mi avvicino a testa bassa verso il divano e, senza lasciarmi il tempo di schivarlo, mi tira verso di lui e mi afferra la mandibola coprendomi con il palmo quasi tutta la faccia. Mi ritrovo a bocca spalancata, con il collo flesso all’indietro e inizio a piangere. Le sue mani sono troppo grandi per infilare le pantacalze alle mie Barbie e le sue dita sono troppo grosse per entrare nella rotella numerata del telefono, azione che compie o con il mignolo o con una matita senza punta che sta sempre vicino a un blocco note sul mobile davanti alla porta. Sono intrappolata in questa morsa ma non chiudo gli occhi e sforzo i miei bulbi a compiere un gesto innaturale, nel tentativo di mettere a fuoco ciò che sta accadendo sotto il mio naso. Vedo che un grande dito entra nella mia bocca e la riempie. Un sapore salato fa arretrare la mia lingua in fondo, nella sua tana e stimola la mia salivazione. Il dito con estrema delicatezza si appoggia al mio incisivo che tentenna incastrato nella gengiva. Tutto finisce in un attimo e mi ritrovo libera. Deglutisco. Nonostante la sua completa mancanza di grazia, non mi ha fatto alcun male, anche se per ora si è solo accertato che il mio dentino di latte fosse veramente traballante. Siamo al punto di partenza, mi allontano camminando all’indietro, sperando che qualcosa di più interessante del mio dente straripi da questo pomeriggio d’ottobre. E proprio quando sta per uscire dal mio campo visivo, spegne la tv e si alza all’improvviso. Va in balcone con un passo spedito come se fosse l’unico a sapere le regole di questo nuovo gioco, io lo seguo con lo sguardo incuriosita e tornando sui miei passi raggiungo il centro del tappeto, una pelle di mucca bianca a macchie marroni che è per ora l’unico animale domestico che io abbia mai avuto. Sento il suono dell’armadietto degli attrezzi che si apre e un bofonchiare che riconosco, ma che non riesco a decifrare. Probabilmente sta cercando qualcosa che non trova. Ritorna con in mano un filo da pesca e inizia a spiegare a una platea di cui anche io faccio parte:
“Adesso ti lego il filo al dente, poi lego l’altro capo alla maniglia della porta. Poi in un colpo solo sbatto la porta che ti toglie il dente, neanche te ne accorgi.”
Per un attimo rimango titubante ma poi il suo entusiasmo mi coinvolge tanto da spalancare io stessa la bocca in complicità. Leghiamo insieme il dentino con un nodo a cappio e, nell’assicurarci che sia bene saldo, un po’ di sangue amaro mi si mischia alla saliva. La porta che ha scelto è il portone dell’appartamento: la apre, mi posiziona al di là e lega l’altro capo del filo alla maniglia che è esattamente all’altezza dei miei occhi. Ci siamo, siamo tutti e due complici e operativi. E da qui tutto diventa velocissimo. Ho la bocca spalancata come un pesce all’amo, le fauci si seccano, il filo è teso e ogni piccola flessione della colonna fa scendere un po’ di sangue dalla gengiva. Non faccio in tempo ad alzare la fronte al cielo e a cercare di mettere i miei occhi nei suoi, che lui urla divertito:
“Vado!”
Sono certa che sto sentendo quel “vado” e il suono dello sbattere della porta senza nessuna pausa in mezzo, senza nessuno spazio per far accadere ciò che deve accadere. Tutto succede adesso, nello stesso istante. Il suo urlo, il mio dolore, lo strappo che sento al collo, il boato dello sbattere della porta amplificato dalla tromba delle scale. Tutto accade insieme e finisce sempre nello stesso adesso in cui sta accadendo. Porto entrambe le mani alla bocca e mi chino in avanti, crollo educata sulle ginocchia e appoggio il sedere ai talloni. Abbasso gli occhi e vedo fiorire delle gocce di sangue sulle calze di lana color panna. Lui arriva poco dopo con un cubetto di ghiaccio avvolto nel suo fazzoletto di stoffa. Mi dice che anche lui ha tolto il primo dente così e non l’ha mai dimenticato.
trad. di Daniele Ventre
Aurea prima una stirpe di uomini nati a morire
fecero i numi immortali che hanno dimore in Olimpo.
Vissero al tempo di Crono, allorché sul cielo regnava;
ebbero vita di dèi, e l’animo immune da angosce,
scevri d’infelicità, di travagli; vile vecchiaia
non li opprimeva, ma sempre di piede e di mano immutati,
nell’allegria s’allietavano, ignari di tutti i malanni;
poi come vinti dal sonno morivano; v’era per loro
ogni bontà: dava frutto la terra nutrice di biade,
spontaneamente, in gran copia e senza negarsi; essi, paghi,
placidi, colmi di tutte delizie, abitavano i campi,
[ricchi di greggi com’erano e cari ai beati, agli dèi.]
Ma sin da quando la loro genia la coperse la terra,
spiriti son divenuti –volere di Zeus, di quel grande–,
saggi, abitanti terreni, guardiani alle genti mortali,
che stanno a guardia del giusto agire e degli atti nefandi,
cinti di nebbia s’aggirano e scorrono ovunque la terra,
dànno ricchezza: anche questo ottennero, premio regale.
Dopo di quella, seconda, assai meno nobile stirpe
fecero, argentea, i numi che hanno dimore in Olimpo,
impari all’aurea sia nell’aspetto sia nell’ingegno.
E per cent’anni ogni figlio accanto alla madre signora
era allevato e cresceva in casa, da stolto fanciullo.
Come ciascuno cresceva, giungeva nel fiore degli anni,
tutti vivevano un tempo effimero, avendo dolori,
ma per stoltezza: non seppero, infatti, evitare fra loro
malvagità tracotante, e non vollero essere servi
degli immortali, e officiare agli altari sacri ai beati,
come nell’uso è pur giusto fra gli uomini. Ed ecco che infine
li subissò, incollerito, Zeus Crònide, ché di tributi
non omaggiavano i numi beati che sono in Olimpo.
E sin da quando anche questa genia la coperse la terra,
sono chiamati mortali che stanno sotterra beati,
i successivi, e però l’onore s’accorda anche a loro.
E il padre Zeus, terza stirpe di uomini nati a morire,
bronzea progenie, del tutto diversa da quella d’argento,
trasse, dai frassini, truce e violenta, a cui solo gesta
d’Ares dolenti piacevano, e oltraggi; e non certo di pane
s’alimentavano, avevano un animo fiero, adamante,
gli infaticabili: grande vigore, invincibili mani
da quelle membra possenti crescevano, sopra le spalle.
Erano bronzee le loro armature e bronzee le case,
e lavoravano il bronzo, ed il nero ferro non c’era.
Di propria mano costoro si uccisero gli uni con gli altri,
sì che la sordida casa raggiunsero di Ade crudele,
privi di gloria; e benché tremendi, alla fine li prese
nera la morte e lasciarono il fulgido raggio del sole.
Poi, non appena anche questa genia la coperse la terra,
ecco che il Cronide Zeus, su terra nutrice di vite,
ne creò allora una quarta, più giusta e ben più valorosa,
stirpe divina d’eroi, di quelli che sono chiamati
i semidei, la progenie degli avi, su terra infinita.
Tutti costoro la guerra tremenda e l’orribile mischia,
o nella terra cadmea, a Tebe, settemplice porta,
li trucidò, da poi che per le greggi d’Edipo in lizza
vennero, o a bordo di navi, oltre il vasto abisso del mare,
quando li inviarono a Troia per Elena bella di chiome.
Tutti costoro, in quel tempo, il fine di morte li avvolse,
vita e costumi diversi dagli uomini il Crònide padre,
Zeus, diede loro e li pose all’estremità della terra:
là, presso gorghi-d’abisso, Oceano, nelle beate
isole, tutti han dimora, e animo immune da angosce,
quei fortunati, gli eroi, a cui dà tre volte in un anno
florido frutto di miele, la terra nutrice di biade
[dagli immortali lontano, e su loro è Crono a regnare.
Già, ché il suo laccio lo sciolse il padre di uomini e dèi.
E parimenti, a quegli ultimi onore e prestigio ha concesso.
Poi, come quinta, altra stirpe ha creata, Zeus ampio-veggente,
d’uomini, quelli che sono su terra nutrice di vite*].
Ah, se soltanto non fossi io vissuto in mezzo alla quinta
stirpe d’umani, se fossi già morto o di là da venire!
Già, poiché ormai la semenza è ferrea; gli uomini mai
cessano infelicità, fatica, e di giorno e di notte,
nel macerarsi, e gli dèi infliggono cure angosciose;
anche per loro, comunque, si mescola bene con male.
Zeus disfarà questo seme di uomini nati a morire
quando la prole avrà già, nel nascere, tempie canute.
Né sarà simile il padre ai suoi figli, o i figli ai parenti,
l’ospite non sarà caro all’ospite come in passato,
e non l’amico all’amico e non il fratello al fratello.
Né ai genitori, per poco che invecchino, onore faranno;
anche li rampogneranno con dure parole, gridando,
folli, né occhio di dèi cureranno più, né sostegno
ai genitori offriranno, allorché saranno invecchiati:
per legge il pugno; e le proprie città spianeranno l’un l’altro.
Né gratitudine avrà, chi giura sincero, né il giusto,
né l’uomo buono, a chi opera infamie, all’oltraggio in persona,
tributeranno ogni ossequio: nel pugno il diritto; il pudore
non sarà più: farà danno ad uomo più nobile il vile,
e spanderà voci oblique, per esse farà giuramento.
Lieto del male, parola d’infamia, aborrito d’aspetto,
Zelo s’accompagnerà con gli uomini tutti, infelici.
Dunque in Olimpo, fuggendo la terra spaziosa di vie,
e ravvolgendo fra bianchi mantelli le candide membra,
si partiranno dagli uomini, andranno alle stirpi immortali,
sia Pudicizia sia Nèmesi; e agli uomini lugubri pene
poi rimarranno, ai mortali, né più s’avrà scampo dal male.