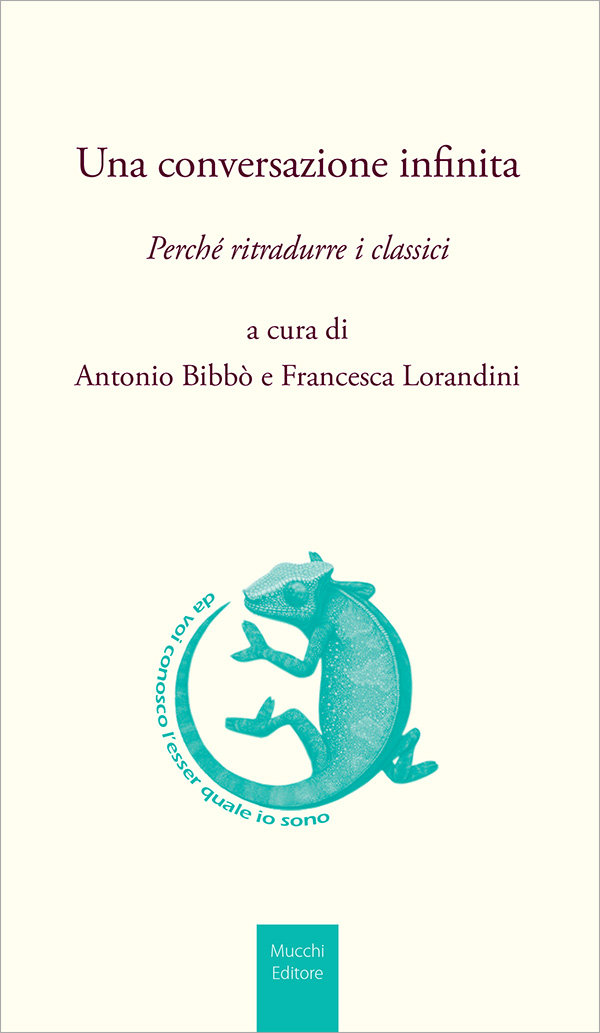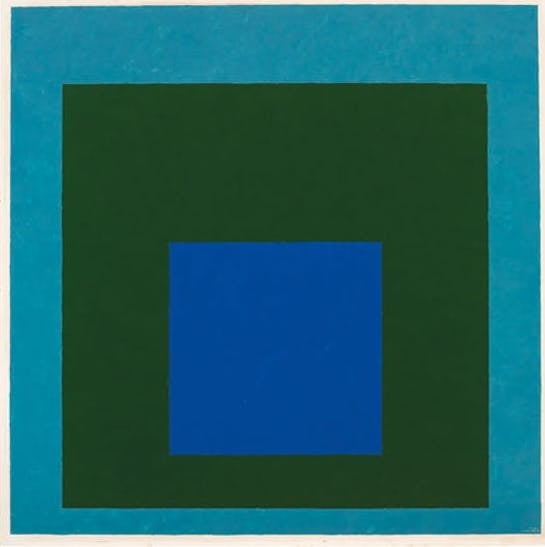di Andrea Inglese
[Questo testo fa parte di un dialogo innescato da Giuseppe A. Samonà in risposta a un mio intervento del 17 ottobre. La sua replica scritta è apparsa il 26 ottobre. Ma lo scambio è continuato per mail e di persona. La capacità di salvaguardare un ascolto reciproco, di continuare a ragionare, pur nel frastuono delle voci della propaganda e delle immagini di morte e distruzione, è qualcosa di importante, anche se appare derisorio di fronte alla potenza dell’accecamento collettivo. Questo è un ulteriore episodio del dialogo, e una riflessione sulla pace a margine della guerra.]
- La trappola di Israele
Caro Giuseppe,
questo mio intervento non vuole limitarsi a un appello generico alla pace o alla nostra comune umanità, per ricordare che, nell’attuale guerra tra Hamas e Israele, le atrocità contro i civili e i crimini contro il diritto internazionale sono perpetrati da entrambi gli attori del conflitto. Spiegherò più avanti perché questo approccio, nella situazione attuale, mi sembra necessario, ma non sufficiente a comprendere quello che sta accadendo. Nemmeno voglio, però, limitarmi a condannare Israele, in nome del sacrosanto diritto all’autodeterminazione dei popoli, ribadendo, come già ti dissi, che non posso non essere filopalestinese. Quanto al giudizio sui bombardamenti indiscriminati e sistematici su Gaza, è stato chiaramente espresso dalle più importati istituzioni internazionali come dalle popolazioni in piazza in una gran quantità di paesi non solo arabi. Le grandi manifestazioni della gioventù di sinistra proprio in Occidente (Stati Uniti, Regno Unito, ecc.) mostrano, per altro, quanto sia difficile giustificare, nel XXI secolo, uno Stato che porta avanti una politica di colonizzazione. Come potrebbe essere altrimenti, visto che da anni ormai uno dei temi progressisti all’ordine del giorno è la lotta contro le discriminazioni perpetrate da individui o istituzioni che, in modo consapevole o inconscio, si arrogano il privilegio della piena umanità, fabbricando un altro da sé disumanizzato? La condanna nei confronti della politica israeliana non ha niente a che fare ovviamente con la negazione del diritto di Israele a esistere, ma vuole anzi essere un invito a una definitiva “normalizzazione”, cioè a divenire uno Stato come qualsiasi altro, fissando una volta per tutte i suoi confini secondo le norme condivise del diritto internazionale.
Il punto che voglio affrontare è comunque più specifico e riguarda non tanto la politica dei dirigenti israeliani – che mantiene per altro una triste continuità nonostante le alternanze di governo – ma la cultura dei cittadini che quei dirigenti hanno bene o male fino ad ora sostenuto. Ma sarò ancora più esplicito: voglio capire come sia possibile, ad esempio, che degli israeliani di sinistra, dei “liberal”, che hanno fino a ieri contestato il governo Netanyahu come corrotto e antidemocratico, oggi lo appoggino in un’azione militare dalle finalità dubbie e dalle conseguenze politiche disastrose, che per di più scredita Israele sul piano del diritto internazionale, a causa dei continui massacri della popolazione di Gaza. C’è qualcosa di assurdo nell’ascoltare editorialisti di “Haaretz” (il più grande quotidiano di sinistra) affermare, da un lato, che la risposta militare contro Hamas è per ora inevitabile (costi quello che costi in termini di vite civili) ma che, dall’altro, finita la guerra, i cittadini israeliani faranno i conti con il primo ministro, la cui politica è risultata disastrosa sul piano della sicurezza nazionale. Questa incongruenza, però, ha una storia ben più lunga, e io l’ho constatata anche, come ti dissi Giuseppe, nelle parole di amici ebrei italiani o francesi di sinistra. Per alcuni di loro, al di là delle malefatte più o meno gravi del governo israeliano in carica, la guerra con i palestinesi appare come una sorta di maledizione, di fatalità, dal momento che il desiderio profondo del popolo israeliano, o di una maggioranza di esso almeno, sarebbe la pace. Senza il nostro dialogo non avrei compreso appieno la natura di questa contraddizione, che riguarda – lo ripeto – non tanto la politica dei dirigenti israeliani, ma la cultura politica della società che li ha in maggioranza eletti e legittimati. Alcuni di questi dirigenti – lo si è visto da quando l’estrema destra è al potere – non hanno alcun problema a rifiutare apertamente qualsiasi ragionevole soluzione di pace, predicando l’estensione ulteriore delle frontiere di Israele sui territori palestinesi. La difficoltà sorge in quella parte della società israeliana che afferma di volere la pace e riesce però a convivere quotidianamente con uno Stato colonialista. Perché una tale situazione si stabilizzi, come è accaduto nella storia di Israele, è necessario introiettare diffusamente un’attitudine sistematica al diniego. Ed è questo, mi sembra, il male più grave della società israeliana, anche di quella parte laica e “liberal” che poco o niente ha da spartire con i fanatici religiosi e con i fascisti che Netanyahu ha portato al governo.
Appare oggi evidente che Israele, come progetto politico nazionale, è prigioniero di una trappola. Ma questa trappola si è andata costruendo fin dall’inizio della sua storia, ed è stata rafforzata attraverso tappe successive. Una trappola costruita da Israele stesso, ma con l’ampia collaborazione delle sue forze nemiche, gli Stati arabi e i palestinesi* (vedi glossa a fine pezzo). Oggi, quella che è stata giustamente definita la “trappola di Hamas”, la trappola in cui Hamas ha trascinato Israele, è possibile anche perché a monte vi è una trappola più vasta e dalle strutture storicamente profonde, che minaccia Israele dal proprio interno. L’ho già scritto nel mio primo intervento, l’ho ripetuto a te voce, ma lo riscrivo qui a scanso di equivoci. Comunque si voglia definire Hamas come entità, quello che ha fatto il 7 ottobre è un atto terroristico, sicuramente un crimine di guerra, che nessuna forma di occupazione coloniale o guerra giustifica né moralmente né militarmente. Nella formula di George Orwell (in un articolo del 1943): “Un’atrocità è un atto terroristico senza un autentico obiettivo militare”.
Ma ritorniamo alla trappola di cui Israele e la sua società sono oggi prigioniere. In una formula estremamente succinta: Israele ha deciso, nella sua storia, in modo più o meno consapevole, di assicurare la difesa del proprio popolo attraverso la forza piuttosto che attraverso il diritto. La trappola è questa. E la storia ha già dimostrato, e purtroppo dimostra ancora, che si tratta di una postura controproducente e distruttiva (per i palestinesi certo, ma anche per gli stessi israeliani). Essa, infatti, presenta due linee di fuga, due prospettive, due tendenze, e nessuna di esse è destinata ad assicurare la pace (e quindi la sicurezza) a lungo termine. La prima tendenza sfocia nella situazione propriamente tragica nella quale Israele si trova attualmente. Uso questo termine, estrapolandolo dalla riflessione che fa Peter Szondi nel suo Saggio sul tragico. Szondi, a un certo punto, analizzando l’Edipo Re, afferma che “l’uomo soccomb[e] proprio percorrendo quella strada che ha imboccato per sottrarvisi”. Quello che soccombe nell’attuale situazione in cui si trova Israele nella guerra con Hamas, non è Israele stesso, ma l’obiettivo che si è dato fin dall’inizio: garantire la sicurezza dei suoi cittadini, e questo – ne conveniamo credo tutti – non può avvenire sul lungo periodo che attraverso una situazione di pace condivisa. Non certo lasciando dietro di sé una scia di odio e disperazione, per l’enormità delle vittime civili prodotte tra la popolazione palestinese, come accade oggi.
Vi è una seconda tendenza, che potrebbe imporsi a partire dalla medesima situazione bloccata, una tendenza priva, in questo caso, di ombre o ambiguità. Non sembra tragica, ma puramente criminale: è la soluzione dell’estrema destra più dura, che sogna l’espulsione definitiva dei palestinesi dalla Cisgiordania ed eventualmente anche da Gaza. L’estrema destra israeliana, così come gli elettori che la sostengono, da tempo non fa mistero dei propri obiettivi. Bisogna riconoscere che, anche se nessun “liberal” israeliano è disposto ad accettarla, questa soluzione ha una sua logica stringente: l’unico modo per non concedere ai palestinesi ciò che vogliono – uno Stato – e per continuare a occupare le loro terre in totale sicurezza, è quello di allontanarli definitivamente da Israele e dagli israeliani.
Ho già detto che considero quest’ultima un’opzione non realistica, ma anche se lo fosse, in definitiva, non sarebbe che una variante più spaventosa della situazione tragica: senza i palestinesi alle proprie porte (perché espulsi altrove), gli israeliani potrebbero essere al sicuro, ma non certo tutti gli ebrei sparsi nel mondo e gli israeliani stessi al di fuori del “loro” territorio fortificato. Il terrorismo islamista e antisemita avrebbe sicuramente un lungo futuro di fronte sé al di fuori di Israele.
In termini storici è chiaro che il sionismo è responsabile di questa cultura che affida alla forza piuttosto che al diritto la salvaguardia di Israele, ed è per questo motivo che una critica del sionismo è necessaria per creare i presupposti “realistici” della pace. Una tale critica, per Israele, non avrebbe alcun bisogno di presentarsi come una negazione di sé, ma condurrebbe a una difficile ma sana demistificazione rispetto al mito delle proprie origini e al riconoscimento delle ingiustizie e degli orrori che fanno parte della propria storia nazionale. È un processo questo, d’altra parte, che ha riguardato e riguarda ancora una gran quantità di nazioni nel mondo, a partire dagli Stati Uniti d’America. Insomma, anche in questo Israele non avrebbe né privilegi ma neanche colpe eccezionali: sarebbe una nazione “normale” come tante altre, con un “romanzo nazionale” da sottoporre, in una fase avanzata della sua storia, a lucida revisione critica. (Lavoro di revisione critica, che diversi studiosi e storici israeliani hanno per altro già cominciato.)
Vorrei aggiungere una considerazione sulla scelta del sionismo di scommettere sulla legge del più forte piuttosto che sulla legge del diritto internazionale. E si tratta di un attenuante che va riconosciuta agli ebrei che direttamente o indirettamente hanno contribuito alla nascita dello Stato israeliano in Palestina. Due terzi degli ebrei d’Europa furono sterminati sotto il regime nazista, in virtù di leggi dello Stato, che permettevano di discriminarli, di spogliarli di tutti i diritti civili, d’impossessarsi di tutti i loro beni materiali, di deportarli in massa, di separare le loro famiglie, di farli morire di fatica, di fame, o assassinandoli direttamente. Nessuna legge umana, fuori o dentro la Germania nazista, poté salvaguardare, proteggere, le vite degli ebrei. (E varrebbe qui la pena di ricordare che fu soprattutto la pietà fuorilegge a contribuire in Europa alla salvezza di un certo numero di vite ebree.)
- Perché ci interessiamo della guerra tra Israele e i palestinesi?
Veniamo ora, Giuseppe, ad alcune questioni di cui abbiamo parlato, e che mi preme chiarire anche per iscritto, pubblicamente. Perché siamo qui a parlare di Hamas e Israele, perché seguiamo i bombardamenti dell’esercito israeliano su Gaza, e non ci occupiamo con altrettanta attenzione della guerra che continua ormai da una trentina d’anni nella Repubblica Democratica del Congo, ad esempio? Una guerra che ha prodotto, secondo stime recenti (fine ottobre) un numero di sfollati interni pari a quasi sette milioni di persone. La domanda è pertinente, e la risposta dev’essere chiara. Il destino di israeliani e palestinesi m’interessa molto da vicino per ragioni storiche, è un dato di fatto. Sono un italiano, nato in un paese che ha prodotto il fascismo e ospitato i nazi-fascisti. Ho letto Primo Levi, un italiano ebreo, che dai nazi-fascisti è stato spedito nei campi di sterminio. Vivo attualmente in un paese dove è esistito il regime di Vichy, che ha collaborato alla deportazione nei Lager di decine di migliaia di uomini, donne e bambini ebrei. Più in generale, sono la storia lunga dell’antisemitismo europeo, oltre a quella breve e devastante della Shoa, e infine la storia del colonialismo europeo (inglese, in particolare) a determinare la nascita dello Stato di Israele nella Palestina mandataria. Inoltre, sono un occidentale, impregnato di cultura statunitense, e gli Stati Uniti sono il principale alleato politico e militare di Israele. Tutti questi elementi, oltre alle mie amicizie con ebrei francesi o italiani, fanno sì che la mia attenzione nei confronti degli orrori e delle guerre nel mondo si rivolga in modo prioritario a quanto accade laggiù. Inoltre, intorno a questa ennesima fase di una guerra mai sopita, si gioca un’altra cosa che mi riguarda: la credibilità di quell’Occidente a cui culturalmente appartengo. Le contraddizioni e le ipocrisie di Israele, degli Stati Uniti, dell’Europa non fanno che indebolire quei valori, che all’interno dell’eredità occidentale, m’interessa difendere come cittadino e scrittore.
- L’approccio umanista e la pietà selettiva
Nel tuo intervento uscito il 23 ottobre su NI, Giuseppe, scrivevi: “è la questione umanista, prima che politica, che mi opprime, mi annoda lo stomaco, e che è importante capire, sciogliere, per poter tornare a parlare e fare politica”. E aggiungevi in un passo successivo: “Laggiù per altro, da una parte e dall’altra, sono comprensibilmente troppo pieni dei propri lutti, della propria paura, per poter pienamente abbracciare i lutti e i dolori degli altri: noi, più distanti, abbiamo il dovere di farlo”.
Ora condivido del tutto quest’ultima frase, e il tuo discorso, più in generale, è stato per me importante, in quanto mi ha costretto a confrontarmi anche con le mie tentazioni di pietà selettiva. Malgrado ciò rivendico l’idea che non sia possibile disgiungere pietà e giustizia, nel momento in cui ci sforziamo di comprendere quanto accade oggi. Non posso quindi limitarmi a un discorso che si appelli alla nostra umanità, di fronte alla minaccia di tutta quella disumanità che vediamo all’opera nel corso di questa guerra tra Israele e Hamas. Naturalmente possiamo tentare di fare questo gesto comunicativo, possiamo tentare di risvegliare in noi – esseri umani, testimoni del conflitto e più o meno coinvolti in esso – possiamo, dicevo, tentare di risvegliare la nostra umanità, e possiamo farlo additando la disumanità, la mancanza radicale di pietà e compassione, esibita dagli attori di questa guerra. Ma la nostra umanità sedicente universale – senza bandiera e colore della pelle, senza appartenenze nazionali e specifiche credenze religiose – appena si pronuncia su questa guerra, vede certe disumanità, ma non certe altre, riconosce le atrocità di Hamas, ma non quelle dei bombardamenti israeliani sulla popolazione di Gaza, oppure riconosce il massacro israeliano dei bambini palestinesi, ma non quello di Hamas sui civili inermi del 7 ottobre. Dove non avviene una sorta di aprioristica selezione, dove i testimoni si pretendono più spassionati, entra in gioco il criterio gerarchico: in questo caso si riconoscerà che alcune disumanità sono più necessarie di altre. Vista la situazione senza via d’uscita del blocco di Gaza (dal 2007) e dell’occupazione palestinese della Gisgiordania (dal 1967), i militanti di Hamas sono stati costretti a commettere delle atrocità; visto l’attacco barbaro del 7 ottobre contro i civili israeliani, Israele è costretto a difendersi militarmente, procurando ingenti perdite civili, nonostante la sua volontà di perseguire unicamente i combattenti di Hamas. Insomma, l’appello alla comune umanità non funziona come l’appello a un superiore e ultimo tribunale, un tribunale senza confini nazionali, esteso ovunque sulla terra, e nello stesso tempo ben custodito nel cuore di ognuno. Il grado di tolleranza nei confronti della disumanità – quella disumanità che ovviamente si esprime vigorosamente in ogni guerra – varia a seconda delle nazionalità, delle convinzioni politiche, delle appartenenze religiose. Questo non significa che un discorso sulla nostra capacità di umanizzarci o disumanizzarci non sia importante, anche riguardo all’attuale conflitto di cui molti di noi sono, nel migliore dei casi, testimoni esterni.
Trovo in un pezzo scritto da Antonio Prete su “doppiozero” (“I corpi, le vittime, la pace” I corpi, le vittime, la pace | Antonio Prete (doppiozero.com)) un approccio consonante con tuo. Egli scrive:
“L’insidia dell’astrazione talvolta può operare togliendo alla pietà la sua propria natura, quella di non avere collocazione di parte, perché prossima alla verità dei corpi, al loro respiro, al loro sentire. È invece da questa presenza corporea della vittima, una presenza singolarmente definita, che può muovere sia l’indignazione contro le forme di potere che portano alla distruzione delle vite umane sia la ricerca delle cause, queste sì politiche, che hanno preparato giorno dopo giorno la scena del disastro.”
Non si potrebbe esprimere meglio il legame che esiste tra pietà e deliberazione politica, ma perché questo nesso funzioni, dev’essere possibile uscire dall’astrazione e avvicinarsi alla singolarità dei corpi. Ed è proprio questo che è difficilissimo fare. Chi è in grado e come è possibile accedere a quello che Prete chiama “la presenza corporea della vittima”? In realtà non vi è nulla di meno trasparente, di meno evidente, di tale presenza. Ne è prova proprio la diffusa empatia selettiva, di cui è impossibile non fare esperienza sia nelle ordinarie discussioni che in ciò che si scrive sui giornali o si dice in televisione. Possono le immagini dell’orrore ovviare a questo? Dobbiamo anche noi, semplici cittadini, vedere il video che l’esercito israeliano ha mostrato ai media internazionali, 44 minuti d’immagini montate appositamente a partire dalle centinaia di ore filmate dai telefonini delle vittime e dei soccorritori, dalle telecamere di videosorveglianza installate nei kibbutz, dalle bodycam rinvenute sui cadaveri degli assalitori uccisi? E basteranno i tre quarti d’ora d’eccidi per avvicinarci alla singolarità dei corpi delle vittime? O dovremmo visionare qualcosa di più “vero”, dal momento che ogni montaggio è una inevitabile forma di manipolazione, d’intervento soggettivo, sulla presunta oggettività di un’immagine documentaria? Dovremmo insomma sottoporci alla visione integrale di tutto quanto è stato filmato il 7 settembre, da vittime, carnefici, occhi elettronici? E i morti di Gaza, i cadaveri dei civili, delle donne, degli anziani, dei bambini soprattutto? Dovremo senz’altro cominciare a guardare anche in direzione di quelle vittime, ma in quale proporzione? Il 22 novembre, ad esempio, le agenzie di stampa riportano la cifra fornita dal governo di Hamas: 14532 persone uccise, delle quali 6000 sono minorenni e 4000 donne. Questi numeri, ovviamente, ci tengono prigionieri della più insopportabile astrazione: ma quante immagini di palestinesi morti sotto i bombardamenti dobbiamo vedere, per convincerci della disumanità della risposta militare israeliana? Basterà passare venti minuti di fronte agli schermi di Al Jazeera, ogni giorno, per visionare tutti i filmati che fanno da sottofondo agli aggiornamenti sulla situazione della popolazione a Gaza o costituiscono specifici reportage su nuovi massacri causati dall’aviazione israeliana? Ma dovremo dare credito a un’emittente televisiva araba, e che, per di più, ha sede in Qatar, nazione che ospita la direzione politica di Hamas?
Fare un discorso che si pretenda innanzitutto capace di percepire il dolore di tutte le vittime non è per nulla facile, anche se è doveroso incitare le persone ad agire in questo senso. Ma anche quando riuscissimo a riconoscere le sofferenze (e le memorie traumatiche) dell’uno e dell’altro popolo, non saremmo di per sé in grado d’immaginare una qualche soluzione del conflitto. Se alla fine tutti sono stati sia vittime che carnefici, tutti sono al contempo responsabili e innocenti. Ma una tale prospettiva, seppure è in parte giustificata, non permette di progredire verso la pace. Inevitabilmente, la questione della giustizia dev’essere sollevata e non rinviata a un secondo momento.
4. Il diniego
Non è necessario entrare ogni volta in un dibattito specialistico sulle occasioni di pace perse tra i dirigenti israeliani e le autorità palestinesi, per constatare un fatto che ho ricordato all’inizio del mio intervento. L’inarrestabile processo di colonizzazione della Cisgiordania, ossia dei territori occupati nel 1967, non è lontanamente giustificabile in termini militari, di sicurezza, ed è la prova che Israele, sia sotto governi di sinistra che di estrema destra, non considera vincolanti le norme del diritto internazionale, nel rispetto delle quali solo potrebbe avere senso una pace duratura. Nello stesso tempo, io credo che una parte della popolazione israeliana voglia la pace, voglia la sicurezza per sé e per i propri figli. Ma com’è possibile volere e non volere la pace nello stesso tempo? Questa domanda riguarda soprattutto i cittadini israeliani, e non i loro dirigenti, dal momento che quest’ultimi hanno perseguito e perseguono i loro obiettivi con triste lucidità. L’unico modo per comprendere una tale situazione assurda è quella di riconoscere che un diniego diffuso abiti la popolazione israeliana e che questo diniego sia un fatto culturale oltre che politico.
Un esempio lampante di questo diniego l’ho riscontrato in un’intervista a una coppia di coloni di Cisgiordania (Oranit), presentata in un documentario di Arte Israele: le strade dell’annessione del 2021 (Israël : les routes de l’annexion | ARTE Reportage – YouTube).
La coppia in questione non corrisponde per nulla al ritratto del colono fanatico religioso o apertamente fascista, che difende l’idea del Grande Israele ed è favorevole all’espulsione dei palestinesi dalle terre che il dio biblico ha assegnato al popolo eletto. Le motivazioni che hanno spinto questi israeliani a installarsi a Oranit sono semplici e del tutto pragmatiche: sono a venti chilometri da Tel Aviv, possono accedere a strade veloci che percorrono i territori occupati ed entrano in Israele (“Se non ci sono ingorghi, in venti minuti sei a Tel Aviv”), il prezzo al metro quadro è straordinariamente conveniente rispetto all’affollatissima e carissima metropoli israeliana. La zona è più amena e priva d’inquinamento che la periferia di una metropoli.
In poche frasi, che riporto qui, marito e moglie esibiscono, in modo innocente ed esemplare, il sintomo della trappola coloniale e dell’attitudine al diniego che permette di tollerarla. Ecco il passaggio dell’intervista, al minuto 16 e 20 del documentario:
“Il marito:
Non siamo qui per realizzare il comandamento divino di popolare la terra di Israele, Non diciamo: abbiamo conquistato questa terra e ci appartiene, e non ci muoveremo. Qui potrete trovare ogni tipo di persona, dei religiosi, dei laici, di tutto.
La moglie:
Questo non ha niente a vedere con la politica. Nessuno qui pensa al fatto che siamo nei territori [palestinesi occupati]. Quotidianamente non ci accorgiamo di nulla, quando torno a casa non vedo nessuno sbarramento, nessuno mi chiede un lasciapassare, o da dove vengo e dove vado, nulla di tutto questo.”
Non è un caso che un’associazione israeliana che milita veramente per la pace si chiami: “Guardare in faccia l’occupazione”. Un semplice proverbio riassume la trappola che Israele ha costruito per sé: volere la botte piena e la moglie ubriaca. I francesi dicono: volere il burro e i soldi per il burro. In questo caso è ancora più parlante. Gli israeliani voglio approfittare delle magnifiche occasioni immobiliari della Cisgiordania e nello stesso tempo vogliono la pace con i palestinesi. La trappola delle colonie, d’altra parte, coinvolge nella contraddizione gli stessi palestinesi. Chi lavora per costruire le superstrade che permettono concretamente l’annessione sempre maggiore delle terre della Cisgiordania? Gli stessi operai palestinesi, che hanno delle famiglia da sfamare, e che vivono in una sorta di limbo territoriale privo di economia e lavoro.
Nessuno può negare che l’orrore del 7 ottobre ha finito con il configurare anche un’allegoria macabra. L’allegoria di una guerra che non solo è sempre e ancora presente, ma che è in grado di assumere (di nuovo) le manifestazioni più estreme e atroci. E tale guerra emerge inaspettata, colpendo magari proprio coloro che siccome non la vogliono vivere, neppure la vogliono vedere. Una testimonianza mi ha particolarmente colpito, di quelle relative a parenti di vittime del massacro di Hamas. Viene da un giovane ragazzo israeliano di ventuno anni che sia chiama Noy Katsman. Interviene in un documentario girato da un altro giovane israeliano, trasmesso sempre da Arte nelle settimane scorse: Israele: vivere dopo il terrore (Israël : Vivre après la terreur | Tracks East | ARTE – YouTube). Noy ha perso suo fratello maggiore nell’attentato di Hamas, un fratello che era un attivo militante per la pace. È breve il suo spazio di parola, ma in qualche minuto dice l’essenziale (dal minuto 21): “Il mio governo non è stato in grado di garantire la mia sicurezza, né quella di mio fratello né quella di tutte le altre persone che vivono in Israele. Ma il nostro governo non vuole riconoscere i propri errori e preferisce attaccare Gaza e commettere delle atrocità che non ci fanno minimamente progredire. (…) Israele bombarda la regione, ma non vedo in che modo questo ci aiuterà a instaurare la pace né a costruire una vita migliore”. Se qualcuno è davvero interessato alla pace (e non, ad esempio, alla vendetta), non vedo come le sue parole possano essere confutate. Certo, non è facile rinunciare alla vendetta, ma Toy mi sembra dire che, ad un certo punto, devi scegliere: o la vendetta o la pace. Non puoi avere entrambe, e soprattutto non puoi dire che t‘interessa la pace, ma adesso bisogna lasciare spazio alla vendetta. La trappola tragica di Israele finisce, però, per colpire anche quelli dei suoi figli che vorrebbero neutralizzarla. È il caso del fratello di Toy, ucciso a pochi chilometri da Gaza, lui che aveva militato sempre contro l’occupazione in Cisgiordania e aveva collaborato con i palestinesi.
Sulla bacheca della sua pagina Facebook trovo oggi un post di una sua amica sulla questione degli ostaggi. Una frase in traduzione risulta del tutto comprensibile: “La più grande minaccia attualmente che galleggia sulle teste dei rapiti è un’operazione militare per salvarli.” Già, un’altra manifestazione della medesima trappola.
E con questo Giuseppe, per ora, passo e chiudo. Senza conclusioni. Senza troppe speranze, se non quella incarnata da gente come Toy, o da quegli ebrei francesi che, in questi giorni, a Parigi, protestano contro l’azione israeliana a Gaza, nell’incomprensione dei molti altri ebrei francesi, che sostengono invece il governo.
⇔
*
Non si vuole ignorare il peso delle aggressioni che Israele, fin dalla sua nascita, ha subito da parte sia degli Stati arabi che dai Palestinesi. Ma la difesa di Israele, fin dalla guerra del 1948-49, ha legittimato un uso della forza che ha spinto Israele al di là dei confini stabiliti delle Nazioni Unite.
Sulle diverse interpretazioni della specificità del “colonialismo” israeliano da parte di diversi storici, fuori e dentro Israele, è possibile consultare un articolo che ritengo equilibrato su Mediapart: De quel colonialisme Israël est-il le nom ? | Mediapart
Infine, qualsiasi critica nei confronti di Israele, del sionismo, della politica coloniale e persino dei bombardamenti disumani su Gaza, non deve implicare l’idea di una fantomatica riparazione, attraverso l’espulsione degli ebrei dai territori israeliani oggi riconosciuti (quelli legalmente riconosciuti). Come scrisse in modo chiaro e del tutto condivisibile Alain Gresh, in Israele, Palestina. La verità su un conflitto (trad. Einaudi 2014):
“D’altra parte, anche se è stato fondato su un’ingiustizia, Israele è ormai uno stato riconosciuto dalla comunità internazionale, dalle Nazioni Unite. Pensare, come è stato fatto e alcuni continuano a fare, che si possano ‘espellere’ gli israeliani, rispedirli ‘a casa loro’, non è moralmente difendibile né politicamente realistico. Un’ingiustizia non si puo’ riparare con un’altra ingiustizia. Vivono ormai in Terra Santa due popoli, uno israeliano, l’altro palestinese.”
Immagine: Absalon, “Cell. n° 5”, 1992.

































 di Giacomo Sartori
di Giacomo Sartori