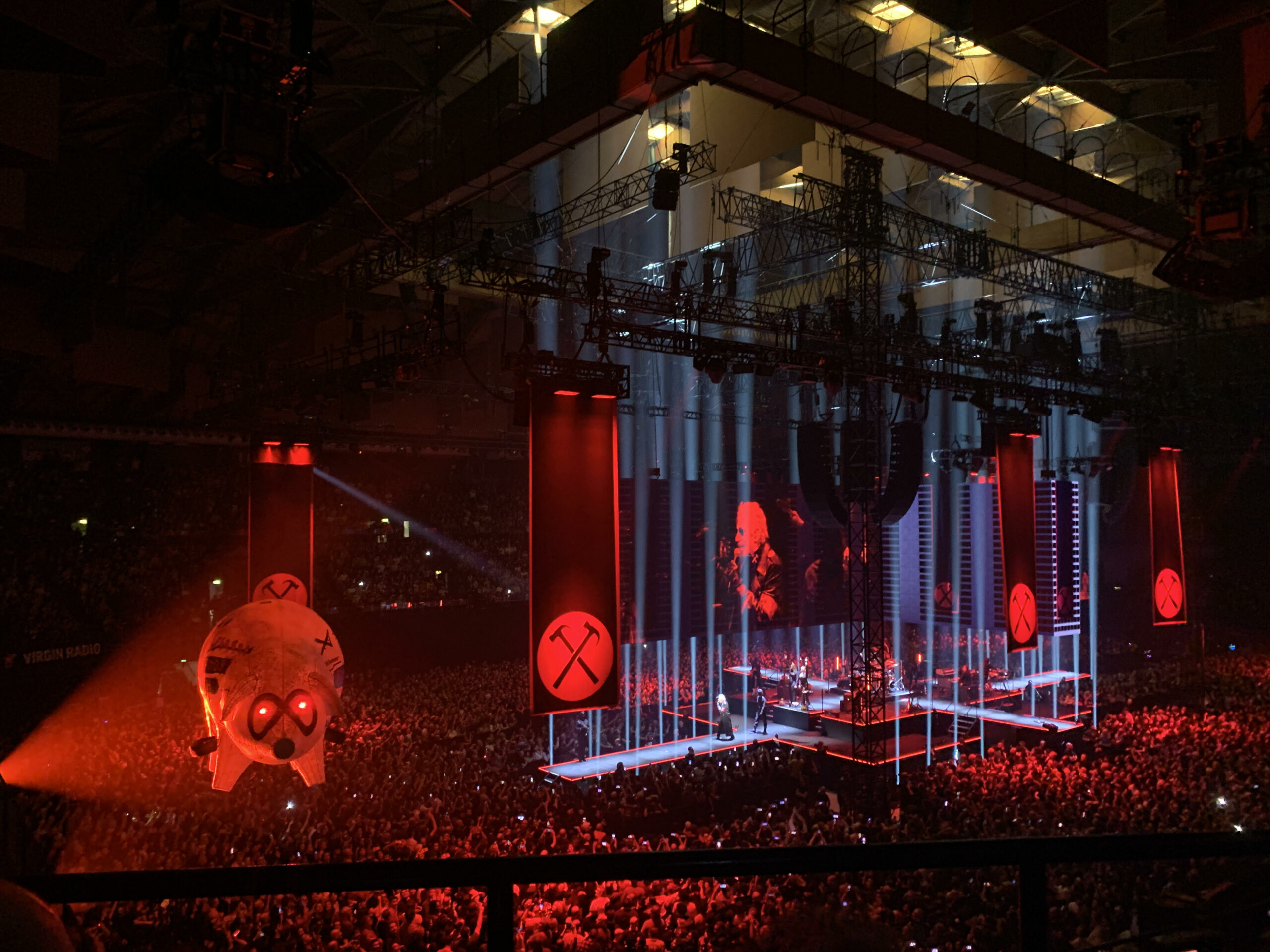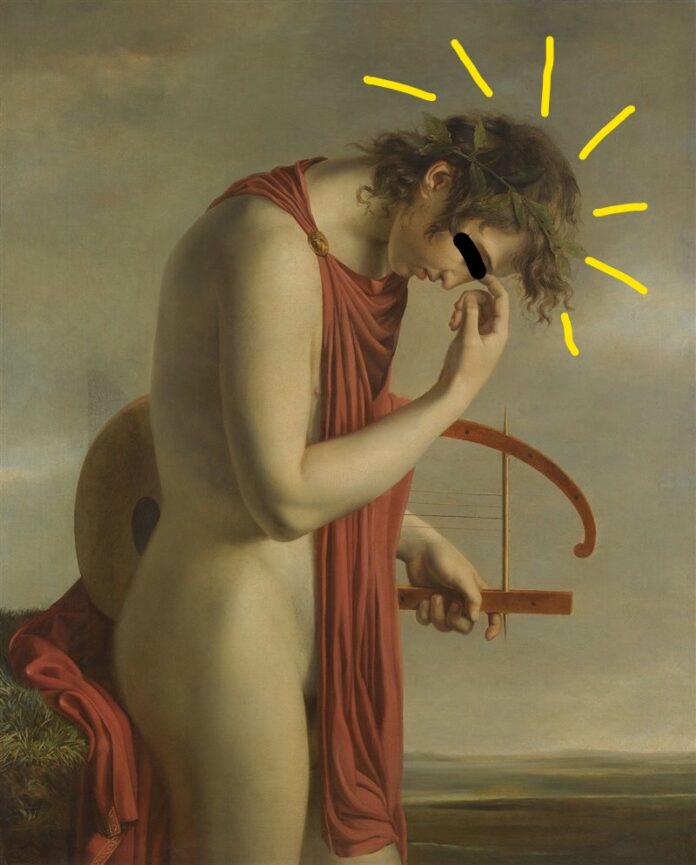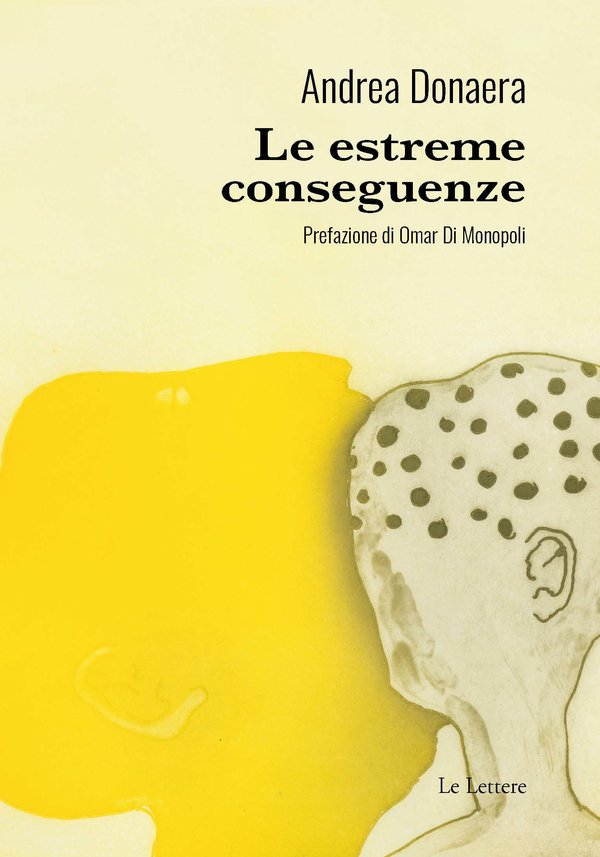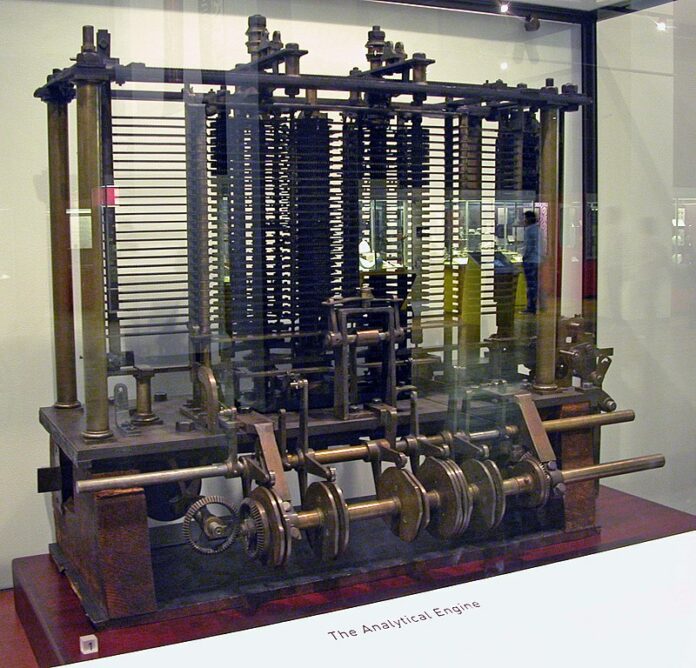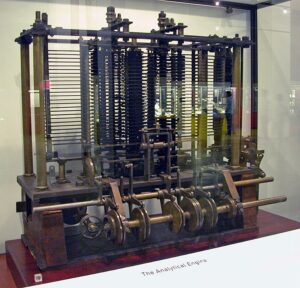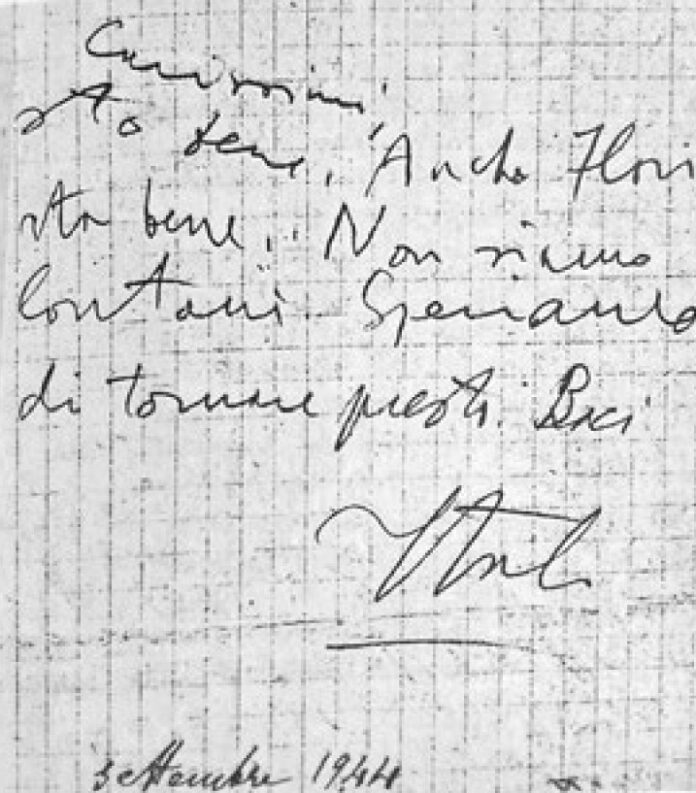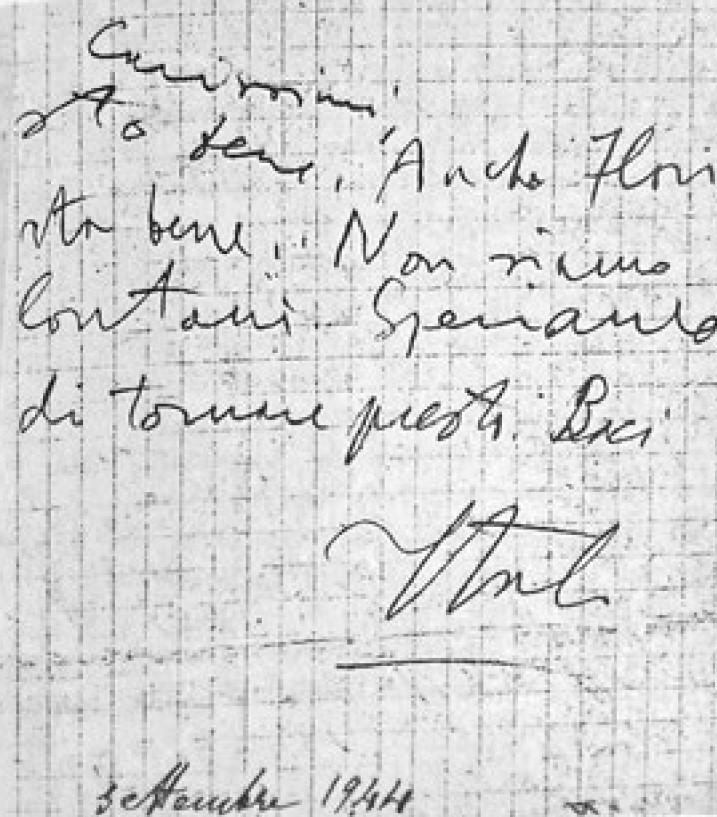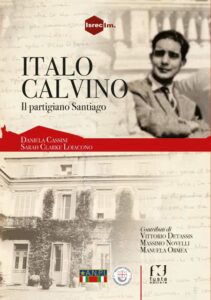di Carla Isernia

L’appartamento della signora Elena affaccia su due cortili interni: il balcone su quello con la fontana a forma di agrifoglio (che a lei dal primo piano sembra più un cuore); le finestre delle stanze al di là del corridoio, invece, si aprono sulle facciate di due palazzi, uno ocra e l’altro caffellatte. Su entrambi i cortili molte finestre e balconi sono chiusi da verande con vetri opacizzati, grate di sicurezza, tende da sole. L’appartamento è silenzioso anche se l’ingresso principale dello stabile dà su una delle strade più trafficate del quartiere. Potere schermante dei palazzi con otto piani e almeno due scale.
Da qualche mese la mattina la signora Elena si gode il silenzio dal balcone su una sedia a sdraio coperta da un plaid con immagini natalizie anche se è aprile. Le piace aspettare le signore che attraversano il cortile e vanno verso l’androne, sentire i loro saluti – a volte le chiedono come sta, come sta sua figlia, a volte camminano veloci e le riservano solo un cenno di saluto –, vederle tornare cariche di buste, con verdure, frutta, pane, detersivi e dolcetti, a stento coperte dalla pattina del carrello della spesa. Spesso pensa che se non ci fosse tutto quel silenzio nel cortile non coglierebbe il suono dei supermercati, il fruscio delle buste di carta, il sibilo delle affettatrici, il ticchettio delle bilance elettroniche, il rumore bianco dei congelatori a pozzetto che tutte si portano attaccato addosso.
Da allora, la giornata sonora della signora Elena inizia con l’eco delle conversazioni pettegole sui ballatoi delle scale, nella maggior parte dei casi in lingue straniere, in casa il ticchettio dell’orologio da cucina, il ronzio, a volte, del condizionatore, il borbottio della caffettiera, la voce argentina della badante che scarabocchia in cirillico la lista delle cose da comprare. A volte, in camera da letto c’è la radio accesa. Se è fortunata ed è ancora sulla sdraio in balcone, la signora Elena sorride insieme agli scolari che tornano a casa, alle voci che raccontano storie incredibili, qualche pianto, un capriccio, lo strofinio delle scarpe trascinate sul pavimento grezzo del cortile, il drin di un campanello, il suono grave di un citofono.
Dopo pranzo nella sua vecchia poltrona vicina alla finestra la signora Elena nota di più i suoni delle case: metallici di pentole e posate, bassi di piatti e bicchieri, qualche voce in lontananza, sottile, spezzata, musica e parole dai televisori accesi, dalla sua cucina solo il suono sordo provocato dalla vibrazione bassa e continua del megafrigorifero – quando venne il tecnico, chiamato apposta per registrare l’altezza dei piedini, il mastodonte tacque senza ritegno –. L’ora successiva è morta, resa ancora più silenziosa dalle tende, dalle mantovane, dalle persiane e dai doppi vetri.
Verso le cinque, quando la facciata del palazzo ocra tira fuori tutto il giallo, la signora Elena recita il rosario a bassa voce sintonizzata su TV2000. In piedi alla finestra osserva i pensionati che si accingono alla loro passeggiata quotidiana – parlano sempre di calcio con il portinaio – e i pochi signori silenziosi che due volte alla settimana aspettano pazienti l’arrivo del medico di famiglia. Uno fuma una sigaretta elettronica, il fumo produce un’ombra volante sull’impiantito grezzo e grigio. Gli altri suoni, quelli di fuori, della strada al di là dei palazzi, non arrivano a lei, filtrati dalle persiane, dai muri, dalle verande, dagli infissi, dalle zanzariere.
La sera, quando il portone di ingresso viene chiuso, la strada è già invasa da macchine in doppia fila di giovani che consumano pizzette, panini, pita, graffe e gelati. E mentre in strada l’aria si riempie di odori acri, dolci, salati, fastidiosi, invitanti, stuzzicanti, appetitosi, di voci alte, basse, allegre, brillanti, forti, sguaiate, e di suoni di clacson, prolungati o appena accennati, ripetuti, infastiditi, arrabbiati; e i motorini dei rider si infilano tra le auto, frenano all’improvviso, urtano il bordo dei marciapiedi, facendo sobbalzare le vivande depositate nei portapacchi coibentati, la signora Elena commenta al telefono con la sorella le notizie del giorno. Solo molto più tardi, dopo la cena e il programma in cui ballano o cantano, o il film poliziesco pieno di azione, sparatorie, sirene, inseguimenti e scontri, un po’ in lontananza le arriva il clangore metallico del camion della differenziata.
Era un fisico il marito della signora Elena e quando avevano parlato dei suoni e dei silenzi – oh, quanto avevano parlato della bellezza del silenzio –, lui aveva spiegato che i filtri sono dispositivi che selezionano un particolare tipo di onde e che il suono che passa dipende dal filtro utilizzato. E così l’onda che arriva al suo appartamento dopo avere provato ad attraversare i palazzi, averli aggirati, essersi infilata negli interstizi, essere stata portata dal vento, diffusa, riflessa, è smorzata, è una miscela di onde laceranti delle sirene, scoppiettanti delle marmitte, roboanti degli acceleratori, stridule dei freni. Una somma di suoni che nel mondo di dentro dei cortili non copre il cinguettio degli uccellini, ed è spesso difficile scomporre in quelli che la compongono.
Qui, i filtri sono fatti di stampe e quadri, poltrone e divani, tavoli e tavolini, sedie di legno, di metallo e di tappezzeria, credenze contenenti servizi buoni, soprammobili preziosi, fotografie di famiglia; di materassi e biancheria, vestiti, soprabiti e cappotti, collane, bracciali e orologi, scarpe e cappelli; di libri, carte, cartelline, computer e stampanti; di sanitari, piastrelle, termosifoni e caldaie. Dispositivi diversi, che assorbono, appannano, velano, deformano, aggiungono, ai rumori di fondo delle case, ai rumori bianchi quando ci sono, alle voci che provengono dalle radio e dai televisori, musica leggera, classica, disco, acid, rap, rock, telegiornali, il rosario su RadioMaria.
Da qualche mese Elena prende un farmaco che le era stato prescritto per la nausea in gravidanza, cinquanta anni fa. La focomelia, il primo effetto collaterale, venne osservato troppo tardi; malformazioni del feto, teratogenicità, è stata una fortuna che Maria sia nata soltanto con un difetto di udito. «Ammesso che la causa sia stata veramente quella», dissero pure senza vergogna. Elena ha chiesto con forza un altro farmaco, ha pensato di arrendersi al tumore, e poi si è fatta convincere proprio da questa sua figlia alta e spigolosa che ha bisogno di una luce ad indicarle il campanello che suona. «Non puoi lasciarmi da sola», le ha strillato Maria su un blocco a quadretti con la penna che si porta sempre dietro, «non ti assisterò» ha detto a gesti, «non ti parlerò più», le dita a indicare la bocca cucita.
E Maria le ha anche trovato una badante che la assista mentre lei è fuori, che la accompagni dalla sedia al divano, dal divano alla poltrona, che le aggiusti il plaid e decida quando fa troppo freddo per stare fuori, che le cucini, le accenda la TV alle cinque, che la aiuti a mettersi a letto. È uscita sul ballatoio delle scale una mattina Maria e ha chiesto alle ucraine, russe, rumene e filippine che lavorano nel palazzo, si è fatta capire, ha spiegato bene – Elena, con la sua voce e le sue orecchie, non avrebbe saputo fare meglio –. Dimentica sempre la madre che Maria ha studiato, si è fatta strada, ha vinto un concorso non riservato, lavora, come quasi tutte le donne della sua generazione.
Non si è spaventata Elena, quando ha cominciato a perdere un po’ del suo sano appetito, né della arsura continua, né dei piccoli tremori che non riesce a controllare – niente a che vedere con la morsa allo stomaco che non l’abbandona da quando si rese conto che in Maria qualcosa non andava –. Neanche ora ha perso il suo senso dell’umorismo, né l’attenzione agli abiti che indossa, all’ordine in casa, al cibo sano e variato. È solo la sera a letto, quando i suoni sono affievoliti dalla porta della camera, dalle lenzuola, dal cuscino, dalle coperte, che si domanda se esista un filtro per i pensieri che lasci passare solo quelli belli, che permetta un sogno leggero, che la faccia tornare indietro a quando la vita prometteva senza condizioni. Da qualche parte in fondo lei sa che un filtro così non esiste e se esistesse neanche sa se per lei funzionerebbe. Allora accende la radio, come dispositivo di materiale opportuno che lascia passare una particolare informazione sonora (tagliando fuori tutte le altre), e finalmente dorme.


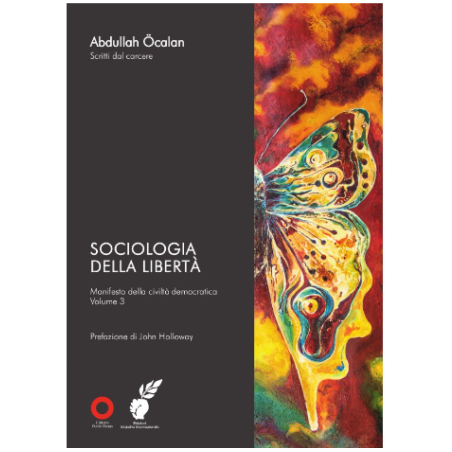
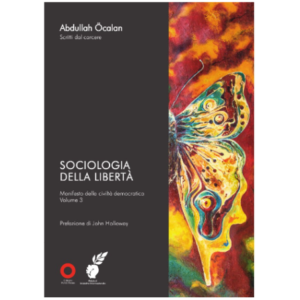



 Per motivi famigliari ho trascorso 21 giorni nella mia casa di origine e ho foggiato oggetti al tornio nel “garage dei topi”, un piccolo laboratorio casalingo ricavato da una stanza di rimessa che apparteneva a mia nonna, in disuso da parecchi anni e solo ultimamente rinnovata. Visitata nelle sere di maggiore umidità da una famigliola di scorpioni, sono andata avanti a modellare 21 oggetti di uso comune in terra bianca, quali tazze, ciotole, bicchieri, piatti, barattoli e uno spremiagrumi, non senza qualche imprecisione e qualche incidente. Essi sono andati a comporre Gea’s Dinner, un progetto sperimentale che vede un mio testo poetico frammentarsi in 21 parti, un ipertesto su ceramiche di uso comune. Ognuno dei 21 oggetti è stato decorato e cotto seguendo il processo tradizionale della maiolica che prevede una prima cottura dei manufatti a 980° e una seconda dei manufatti decorati a 930°. Gli oggetti sono rimasti dall’inizio alla fine uniti nei vari passaggi, nell’idea di perseguire il concetto di frammentazione e unione in contemporanea. Ho corso tutti i rischi del caso: di rottura, di danneggiamento, di non riuscita. Probabilmente Gea stessa si è fatta divinità tutelare dell’esperimento e ogni passaggio è riuscito senza intoppi. Ogni oggetto contiene qualche parola di un mio testo poetico inedito, che potrà esistere ed essere letto, nella sua interezza, soltanto quando gli oggetti verranno riuniti in una ipotetica “cena”.
Per motivi famigliari ho trascorso 21 giorni nella mia casa di origine e ho foggiato oggetti al tornio nel “garage dei topi”, un piccolo laboratorio casalingo ricavato da una stanza di rimessa che apparteneva a mia nonna, in disuso da parecchi anni e solo ultimamente rinnovata. Visitata nelle sere di maggiore umidità da una famigliola di scorpioni, sono andata avanti a modellare 21 oggetti di uso comune in terra bianca, quali tazze, ciotole, bicchieri, piatti, barattoli e uno spremiagrumi, non senza qualche imprecisione e qualche incidente. Essi sono andati a comporre Gea’s Dinner, un progetto sperimentale che vede un mio testo poetico frammentarsi in 21 parti, un ipertesto su ceramiche di uso comune. Ognuno dei 21 oggetti è stato decorato e cotto seguendo il processo tradizionale della maiolica che prevede una prima cottura dei manufatti a 980° e una seconda dei manufatti decorati a 930°. Gli oggetti sono rimasti dall’inizio alla fine uniti nei vari passaggi, nell’idea di perseguire il concetto di frammentazione e unione in contemporanea. Ho corso tutti i rischi del caso: di rottura, di danneggiamento, di non riuscita. Probabilmente Gea stessa si è fatta divinità tutelare dell’esperimento e ogni passaggio è riuscito senza intoppi. Ogni oggetto contiene qualche parola di un mio testo poetico inedito, che potrà esistere ed essere letto, nella sua interezza, soltanto quando gli oggetti verranno riuniti in una ipotetica “cena”.



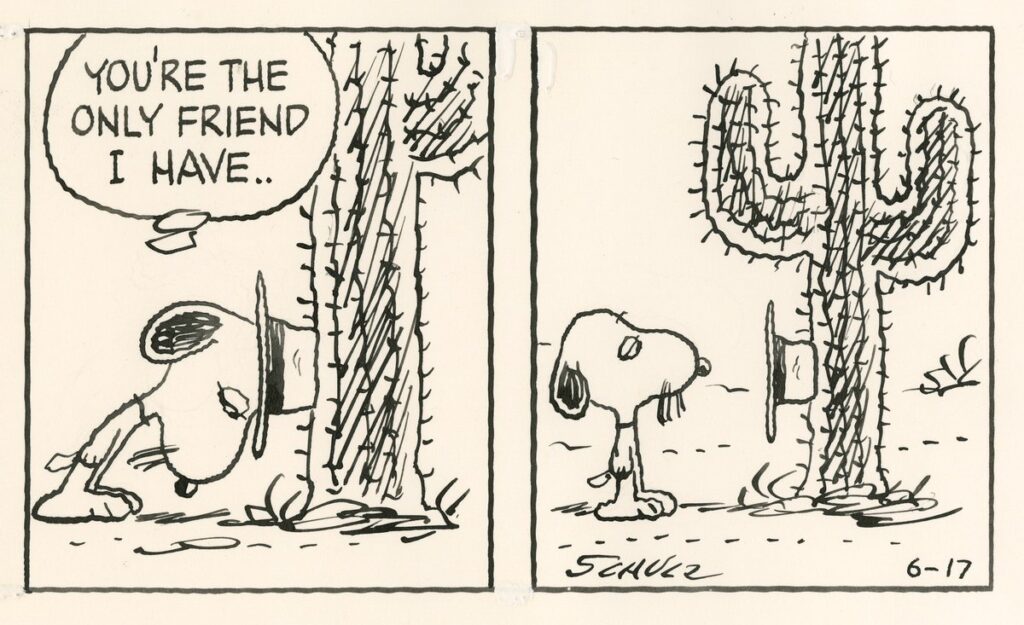

 Cronistoria di un minuto
Cronistoria di un minuto