di Daniele Barbieri
Leggo Linea intera linea spezzata di Milo De Angelis (Mondadori 2021) e mi colpisce subito la sensazione di una magica fluidità sintattica e narrativo-poetica. Ma poi, progressivamente, in questa dimensione così positiva si insinua un fastidio. Penso, all’inizio, che si tratti di invidia, la mia, per uno che sa scrivere così bene. E quella un po’ c’è, immagino; eppure, come spiegazione, man mano che il fastidio cresce, diventa sempre più debole.
Cercando di capire, mi accorgo, ora, della frequenza di parole che, secondo la mia sensibilità, andrebbero utilizzate con estrema attenzione, possibilmente in contesti che ne neutralizzino l’eccesso di poeticità. Già subito ci sono infatti espressioni come tempo che hai misurato mille volte, che non è di questa terra, spettri che corrono; e poi poco più avanti un concilio segreto di secoli, l’infinita moltitudine, tutto è silenzioso per sempre, gli infiniti luoghi della sera. Si potrebbe continuare, in un’apoteosi di poetese che cresce sulla propria facilità (per non dire banalità).
Eppure, mi dico, ho sempre apprezzato De Angelis. Non me ne sono mai accorto, oppure c’è qualcosa di diverso qui? Vado a ripercorrere la sua produzione precedente e vedo che le espressioni incriminate erano presenti anche prima, e tuttavia il fastidio non si manifesta in me con la stessa forza; anzi, pur presente, è trascurabile, perché ben compensato, comunque, da una più compiuta integrazione della loro carica di echi. Che cosa è cambiato, allora? Incomincio a pensare di provare a valutarne la frequenza, pensando che magari prima fossero più rare e accettabili; quando mi rendo conto di qualcos’altro che qui c’è e che prima non c’era: non sono, cioè, soltanto i termini utilizzati a richiamare una dimensione di troppo facile efficacia sentimentale, ma anche e soprattutto le situazioni descritte dai singoli componimenti, con tutti questi amici che escono dalla morte, questo ripetersi della figura letteraria dell’evocazione, sempre suggestiva, sempre nostalgica, sempre crepuscolare. Da questo clima, non solo non si esce; ma vi si entra, pagina dopo pagina, sempre di più. E, pagina dopo pagina, cresce la mia voglia di smettere, di abbandonare quella che mi appare sempre di più come una celebrazione dell’io e delle sue ombre.
Mi viene da rifugiarmi nelle considerazioni di un autore ben diverso, anche lui letto da poco, e parlo di Jean-Marie Gleize, nel libro Qualche uscita. Postpoesia e dintorni, curato da Michele Zaffarano (Tic, 2021). Già nella prima pagina, commentando alcune parole da Illuminations di Rimbaud, Gleize ci dice:
Certo, si tratta di frasi senza frasi, di frasi nude ai limiti delle possibilità, di frasi molto vicine a quello che per me avrebbero rappresentato più tardi le pratiche e gli oggetti dell’arte: nulla che s’imponga come monumentale, o carico di senso, carico del peso di un senso; nulla che spinga alla fascinazione adorante, alla posa, alla recitazione ottusa, all’orpello, alla cosmesi, al costume. Nessuna di queste superstizioni. Solo materia e lingua, e forma; solo tratti e cifre, e lettere. Nulla di eccessivo, anzi tutto tendenzialmente a levare, sempre a levare: finalmente!, come dice Rimbaud con un’esclamazione, verso la «più semplice espressione». È una morale. Una politica. Una ragione d’essere, e di agire. (p.7)
Una boccata di ossigeno, almeno a prima vista. Di fronte alla monumentalità crepuscolare di De Angelis (di questo De Angelis), che certamente spinge alla fascinazione adorante, alla posa, questa esortazione al levare appare liberatoria.
Tuttavia, passato il primo entusiasmo, qualcosa che non quadra appare anche qui. Va bene stigmatizzare il monumentale (almeno per noi oggi – ma su questo tornerò verso il fondo), ma mica solo ciò che è monumentale è carico di senso, o del suo peso: per come la vedo io, semiologo, tutto quello che non è carico di senso è per noi semplicemente irrilevante. Se richiama la nostra attenzione, che si tratti di parole o di oggetti del mondo o di eventi, è perché un senso ce l’ha. Ma Gleize conferma: “Solo materia e lingua, e forma; solo tratti e cifre, e lettere.” Sembra che si stia passando da un condivisibile rifiuto dell’eccesso retorico a una poetica del nulla, peraltro non del tutto consapevole.
Naturalmente, bisogna andare oltre questa prima pagina e leggersi l’intero libro per capire dove Gleize voglia arrivare. Non dimentichiamo che Gleize è l’inventore dell’espressione prosa in prosa, a cui si ispira il titolo dell’antologia del 2009, in cui appare lo stesso Zaffarano, e con lui anche Marco Giovenale e Andrea Inglese, che sull’autore francese hanno scritto in varie occasioni.
Anche Gleize scrive bene e con chiarezza, ma conferma in più modi la mia sensazione iniziale che si stia (idealmente) buttando via il bambino con l’acqua sporca. Ecco un paio di riflessioni che questa lettura mi ha ispirato.
Gleize distingue nella poesia contemporanea quattro posizioni. Le chiama, rispettivamente, lapoesia (scritto tutto attaccato come lalangue di Lacan), ripoesia, neopoesia e postpoesia. “Lapoesia si presenta, si confessa e si rivendica in quanto tale e, in quanto tale, viene accolta senza la minima possibilità di dubbio” (p.45): siamo, insomma, nel pieno alveo della tradizione. Non è molto diversa la ripoesia, che però arriva a riproporre la tradizione dopo essere passati attraverso qualche contestazione (altrui) di tipo neo- o postpoetico. Penso che l’intera poesia di De Angelis verrebbe situata da Gleize nell’aera della ripoesia.
A distinguere la neopoesia da lapoesia e dalla ripoesia è il fatto che a praticarla sono tutti quelli che intendono il processo poetico come trasformazione della poesia e che, senza indugio e prima di ogni altra cosa, collocano la sua essenza specifica in questa sua rifondazione permanente, in questo suo eterno ridefining. Insomma, tutti quelli che pensano che la poesia possa benissimo non assomigliare più alla poesia proprio perché la sua definizione passa attraverso la sua particolare capacità di riformarsi in modi sempre altri, di alterarsi. Osservata da questa prospettiva, la poesia si sforza di negare sé stessa così com’era, così com’è e così come viene recepita, e tenta di reinventarsi in procedure sempre nuove. La poesia è costantemente a venire. E anche i neopoeti, così come i ripoeti, sono dei poeti. La loro pratica implica e mette in atto una negazione della poesia che è, allo stesso tempo, un’affermazione ulteriore della poesia. (p.48)
Per quanto riguarda invece gli attori della postpoesia, quello che va detto è che tendono a pensare il proprio lavoro come qualcosa che sta al di fuori della sfera della poesia. Il che ovviamente non significa che le istituzioni, a quella sfera, non cerchino di riportarli di continuo. Per modificare le griglie della ricezione sociale, della Scuola, della Biblioteca, della Libreria, ecc., per uscire dalla poesia, non basta in effetti dichiarare di volerlo fare, neppure se ci si è armati di una pratica che sembrerebbe confermare tale dichiarazione. (p.49)
È a questo punto (tra l’inizio degli anni Ottanta e i giorni nostri) che cominciano ad apparire tipologie diversissime di testi: oggetti testuali e oggetti specifici di cui qui mi limiterò a segnalare in termini molto generali solo pochi tratti peculiari.
-Si tratta di oggetti che non funzionano partendo da un’interiorità creatrice o da un’esperienza personale e che escludono qualsiasi dimensione espressiva.
-Si tratta di oggetti che non si piegano a particolari intenzioni estetiche e che non fanno riferimento ad alcun sistema estetico di valore, convenzionale o modernista che sia.
-Si tratta di oggetti estremamente compromessi con le proprie modalità di produzione e riproduzione (per esempio, sono inconcepibili senza i vari programmi per l’impaginazione o la manipolazione delle immagini e del suono).
-Si tratta di oggetti profondamente riflessivi, meta-tecnici e meta-discorsivi: fanno quello che dicono, dicono quello che fanno e rendono esplicito (cioè lasciano intravedere) il modo con cui le rappresentazioni che ci formiamo condizionano le nostre percezioni e i nostri discorsi.
-Infine (ed è questo che li rende più immediatamente spettacolari) si tratta di oggetti caratterizzati da dispositivi di montaggio che loro stessi pongono in essere: citazioni, prelievi, campionamenti, loop, formattazioni, compressioni, restituzioni grafiche e via dicendo. Montaggio e trattamento di materiali eterogenei. (p.50)
A Gleize le prime due posizioni non interessano. Ponendosi dal lato della postpoesia, ritiene comunque proficuo il dialogo con la neopoesia.
Sin qui, tutto molto chiaro. Con ammirevole modestia, Gleize usa questi due neologismi (il secondo in particolare) per definire il campo proprio e della poesia che lui sostiene. Sulla scena italiana sembra essere invece invalsa l’abitudine di utilizzare, per indicare all’incirca la medesima area, l’espressione poesia di ricerca, che non è un neologismo, e che sembrerebbe rimandare piuttosto a tutta la poesia che si basa su una ricerca, e non solo al campo indicato da Gleize. Questa cosa ha l’aria, insomma, di un’appropriazione un po’ indebita. Mi domando se le virgolette che “alcuni critici e studiosi sentono il bisogno” di mettere attorno all’espressione “poesia di ricerca” – come fa notare Marco Giovenale qui, dopo un’attenta disamina della storia dell’uso del termine (una storia che include anche Calvino, e non solo Balestrini) – dipenda davvero, come sostiene lui, dall’“astio che li separa dalle punte sperimentali del Novecento” e non piuttosto da un rifiuto di questa appropriazione. (Mi piacerebbe, a titolo di esempio, capire se un poeta come Luigi Di Ruscio sia ascrivibile alla ricerca intesa in questo senso, là dove, personalmente, io non avrei dubbi nel suo caso a parlare di ricerca poetica.)
Ma il problema vero della classificazione di Gleize sta altrove. Sembra cioè che si dimentichi, qui, la fastidiosa tendenza che ha la novità (qualsiasi novità, minore o maggiore che sia) a farsi sistema, nella poesia come altrove: la conoscenza umana stessa, sembra, in generale, funzionare così. Quando emergono delle novità, sullo sfondo di un sistema costituito da quello che è già noto, o esse sono scarsamente rilevanti (o solo localmente rilevanti) e vengono poi dimenticate, oppure, se un qualche rilievo ce l’hanno, vengono progressivamente assorbite dal sistema, e al prossimo giro di conoscenza fanno già parte del noto, del sistema medesimo.
Gleize chiama lapoesia questa poesia divenuta sistema, della quale quella che lui chiama ripoesia sarebbe la prosecuzione acritica, mentre neopoesia e postpoesia due diversi livelli di distacco e tentativo di rinnovamento. Il problema è allora che anche la postpoesia più estrema, nella misura in cui ha un successo almeno locale, e quindi un qualche numero di lettori ed emuli, nel giro di qualche anno acquisisce una qualche regolarità; entra cioè a far parte anch’essa di una regione de lapoesia. Il vero postpoeta, dunque, dovrebbe trovare delle soluzioni che si differenzino da quelle dei postpoeti precedenti, rendendo inevitabilmente obsolete quelle già percorse (quelle per esempio elencate qui sopra). Il vero postpoeta non dovrebbe mai appartenere a una corrente: l’intera cosiddetta poesia di ricerca italiana (su quella francese non mi sento a sufficienza competente) non dovrebbe di conseguenza essere considerata postpoesia. Sarà piuttosto semplice ripoesia di un canone assestato relativamente recente.
Questa conclusione mostra abbastanza chiaramente la difficile sostenibilità della posizione di Gleize, che, se si generalizza un poco, non è precipuamente sua, ma appartiene abbastanza diffusamente alle avanguardie del Novecento. La questione viene adombrata già da Claude Levi-Strauss nell’introduzione a Il crudo e il cotto (1964), quando accusa Pierre Boulez non tanto di voler portare la musica verso nuovi lidi (il che è del tutto legittimo) quanto di arrivare a considerare il viaggio in sé più importante della meta. Come dire, banalizzando un po’, che cercare sarebbe più importante che trovare, cosa che potrebbe anche apparire affascinante (specie dal punto di vista del creatore) se non fosse che una ricerca che non trova diventa rapidamente frustrante; mentre in una ricerca che trova, il trovato diventa base per nuove ricerche, e quindi si istituzionalizza, si fa sistema.
2.
Molto più confusa è la questione della letteralità.
Di fatto, esiste solo un modello che possa essere contrapposto a questa transitività, assoluta o relativa, diretta o indiretta, positiva o negativa che sia; e questo modello corrisponde a una rappresentazione della poesia che chiamerei letterale. In questo ultimo scorcio di Novecento, è a Jacques Roubaud che dobbiamo le formulazioni più nette e semplici al proposito. È da lui che prenderò quindi spunto per sostenere che la poesia non dice nient’altro se non quello che dice; o che la poesia dice letteralmente quello che dice. Formule da considerare come equivalenti o prossime all’assioma pongiano secondo il quale (appunto) non esiste verità se non letterale; o non c’è altra verità al di fuori di quella letterale. In sostanza: la poesia non ammette parafrasi. (p.64)
Definita in questo modo, la letteralità sembra pura tautologicità. Ma qualcosa che “non dice altro se non quello che dice letteralmente” in realtà non esiste nemmeno, perché il senso stesso è fatto per sua natura per rinviare indefinitamente (e il principio della semiosi illimitata di Charles Sanders Peirce è uno dei punti chiave di qualsiasi teoria sensata del senso). Gleize sembra persino accorgersene, quando a pagina 85 dice testualmente: “La letteralità non esiste, non può esistere”.
Forse dovremmo prendere la letteralità come una condizione verso cui tendere, come sembra suggerire Andrea Inglese in un suo interessante intervento di qualche anno fa (“Iconoclastia artistica e concetto di littéralité”) ma anche questa prospettiva porrebbe una serie di problemi che ho a suo tempo sottolineato qui (“La letteralità impossibile. Risposta ad Andrea Inglese”), e a questo dibattito rimando per approfondire la questione, perché i termini esposti anche da Gleize nel suo libro (certo con molti più esempi) vi sono già del tutto chiari.
Credo, in fin dei conti, che la posizione di Gleize si basi su una presunzione di stampo razionalistico, tipica delle avanguardie, quelle artistiche come quelle politiche: l’idea (platonizzante) che si possa ricostruire il mondo sulla base di un’idea razionale, e che tutto il passato debba essere valutato a partire da questa idea, accettandolo o rifiutandolo nella misura in cui va o meno nella direzione voluta. Per Gleize, mentre la neopoesia cerca di rinnovare le forme poetiche senza rifiutarne alcune basi tradizionali, la postpoesia tende a sovvertire tutto, nella sicurezza di restare comunque all’interno dell’ambito della poesia, perché l’ambito della poesia è un ambito residuale, dove si finisce comunque per mettere quello che non si può mettere altrove.
Per questo, in generale, la tradizione viene vista come un ostacolo, qualcosa che ci riconduce inevitabilmente ai vecchi lidi. Mentre, viceversa, la tradizione postpoetica (che ormai esiste da molti decenni) non viene nemmeno vista da lui come tradizione, bensì come semplice emanazione dell’idea (quella di riferimento). Del resto, per poter classificare i poeti in rapporto alla tradizione poetica, come Gleize fa, bisogna poter contare su un’idea molto chiara, e certamente statica, di quali siano i limiti di tale tradizione. Un’avanguardia non può, insomma, permettersi dubbi: deve poter distinguere chiaramente chi (o che cosa) ne fa parte, e chi no. L’area della cosiddetta poesia di ricerca italiana non fa eccezione.
Per chi ha dei dubbi la via è senz’altro più difficile: chi ha dei dubbi non può permettersi per esempio di distinguere cosa sia bene e cosa sia male facendo semplicemente uso di criteri che riguardino le modalità costruttive. Deve affidarsi piuttosto a quella cosa imponderabile che è il gusto, un canone pericoloso specialmente dal punto di vista della posizione avanguardista, in quanto inevitabilmente contaminato dalla tradizione. Si obietterà che un dubitante intelligente ha assorbito tutta la tradizione nel proprio gusto, avanguardie comprese, perché concepisce la tradizione (avanguardie comprese) come una risorsa, non come qualcosa da negare; come la base nota su cui costruire il nuovo, non come qualcosa da distruggere per fare emergere il nuovo.
Il che ci riporta al tema di partenza, la poesia di De Angelis. Questo rifiuto che essa può ispirare al nostro gusto, che valore ha? Rifiutare il platonismo di Gleize e dintorni non è rifiutare la ragione, ma solo i suoi eccessi. Il gusto (correttamente alimentato) può essere un buon punto di partenza per un giudizio, ma ha bisogno poi di trovare un sostegno critico. In altre parole, quali sono i valori che sosterrebbero la qualità della poesia di De Angelis, e che, correlatamente, si trovano in opposizione a quelli che sostengono la mia delusione nei suoi confronti?
Non basta appellarsi alla tradizione, visto che la tradizione comprende anche le avanguardie, ormai. Mi sembra che sia dominante in questi valori l’idea che il poetico possa essere una regione del commovente, del patetico. Il commovente e il patetico sono i registri dominanti del libro di De Angelis, ed è questo, viceversa, a causare il mio fastidio. Nel dettaglio: ciò che produce il fastidio non è che vi sia del commovente e del patetico, la cui presenza sarebbe in sé accettabile; ma che questi due valori siano fondanti dell’intera raccolta, e praticamente di tutti i suoi componimenti. Come dire che, in gastronomia, una sfumatura di dolce può benissimo essere accettabile e anche piacevole, ma un eccesso di zucchero può rendere stucchevole qualsiasi cosa, persino una torta.
Risalendo ancora a monte, indubbiamente, il mio rifiuto della dominanza del commovente e del patetico è legato a quella che sentiamo come un’immagine troppo facile, e quindi banalizzante, della poesia, legata al lirismo quotidiano che permette di definire “poetico” un bel tramonto. Come ogni banalità, anche questa è figlia di un successo storico. Io potrò anche sentire, insieme con Gleize, che la poesia non dovrebbe essere monumentale; ma questo non mi deve impedire di capire che in altre epoche la monumentalità della poesia è stata un fatto apprezzabile, ovvero apprezzato dal gusto dominante; e che lo è stata la sentenziosità (per riprendere il bell’intervento di Davide Castiglione che si trova qui, dove si parla in maniera intelligente sia di De Angelis che di Giovenale); e che lo è stata pure la pateticità (e così come lo sono state, possono pure ritornare a esserlo, prima o poi). Tutte queste cose si sono sedimentate nella tradizione. A un livello più raffinato, nella tradizione si è sedimentata anche la volontà di épater le bourgeois, ed è per questo che persino un eccesso di spirito avanguardista produce in me una delusione analoga a quella da cui siamo partiti qui.
Può essere di rilievo notare come, nonostante tutto, io continui a trovare interessanti molti testi poetici sia di Gleize che di Giovenale, segno che, per fortuna, essi sono i primi a non praticare sistematicamente quello che teorizzano. La novità in poesia, come altrove, sembra stare molto più in quello che si trova, che non in quello che si cerca.
 Nuova indagine per il commissario Ferruccio Falsopepe, investigatore di origini messapiche trasferito a Genova e ora in procinto di partire per Roma. Uomo saggio e flemmatico, marito affettuoso e padre attento ma propenso all’autoflagellazione, il capo della squadra anticrimine incappa in una caso quanto mai spinoso: la giovane farmacista Egle Presutti, figlia di un potente uomo politico genovese, viene barbaramente uccisa a coltellate mentre trascorre le vacanze agostane in quel di Courmayeur. Egle è legatissima alla inquieta gemella omozigote Mira, entrambe sono orfane di madre e poco possono contare su un padre così assorbito dall’attività politica. Il delitto si consuma sulle rive della Dora ed è messo in opera con le stesse modalità di un omicidio occorso nell’agosto 1953, nei giorni in cui il segretario del Partito comunista, Palmiro Togliatti, da poco scampato a un attentato che fece tremare l’Italia, trascorse un periodo di vacanza nella valle insieme alla compagna Nilde Iotti e alla figlia Marisa. La vittima si chiamava Angela Cavallero, era una sartina torinese e aveva la stessa età di Egle. Quanto alle indagini, la confusione regna sovrana in entrambe le inchieste, gli investigatori del posto si muovono con scarsa perspicacia e Falsopepe verrà inviato, dapprima quasi in incognito, per farsi un’idea della situazione. La agognata vacanza nel trullo di Ceglie Messapica sembra sfumare, ma in compenso lo status ufficioso dell’incarico consentirà al commissario di accompagnarsi col figlio Salvatore appena tornato dagli Stati Uniti.
Nuova indagine per il commissario Ferruccio Falsopepe, investigatore di origini messapiche trasferito a Genova e ora in procinto di partire per Roma. Uomo saggio e flemmatico, marito affettuoso e padre attento ma propenso all’autoflagellazione, il capo della squadra anticrimine incappa in una caso quanto mai spinoso: la giovane farmacista Egle Presutti, figlia di un potente uomo politico genovese, viene barbaramente uccisa a coltellate mentre trascorre le vacanze agostane in quel di Courmayeur. Egle è legatissima alla inquieta gemella omozigote Mira, entrambe sono orfane di madre e poco possono contare su un padre così assorbito dall’attività politica. Il delitto si consuma sulle rive della Dora ed è messo in opera con le stesse modalità di un omicidio occorso nell’agosto 1953, nei giorni in cui il segretario del Partito comunista, Palmiro Togliatti, da poco scampato a un attentato che fece tremare l’Italia, trascorse un periodo di vacanza nella valle insieme alla compagna Nilde Iotti e alla figlia Marisa. La vittima si chiamava Angela Cavallero, era una sartina torinese e aveva la stessa età di Egle. Quanto alle indagini, la confusione regna sovrana in entrambe le inchieste, gli investigatori del posto si muovono con scarsa perspicacia e Falsopepe verrà inviato, dapprima quasi in incognito, per farsi un’idea della situazione. La agognata vacanza nel trullo di Ceglie Messapica sembra sfumare, ma in compenso lo status ufficioso dell’incarico consentirà al commissario di accompagnarsi col figlio Salvatore appena tornato dagli Stati Uniti.

 Il mio Regno per un libro ( buono)
Il mio Regno per un libro ( buono) Cosa ne pensi delle classifiche qualità?
Cosa ne pensi delle classifiche qualità?





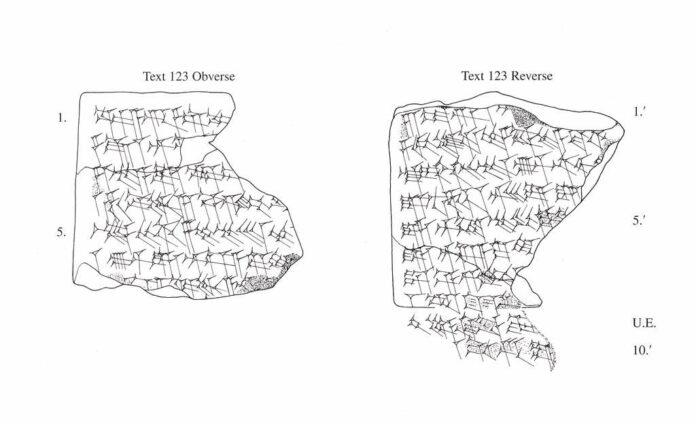
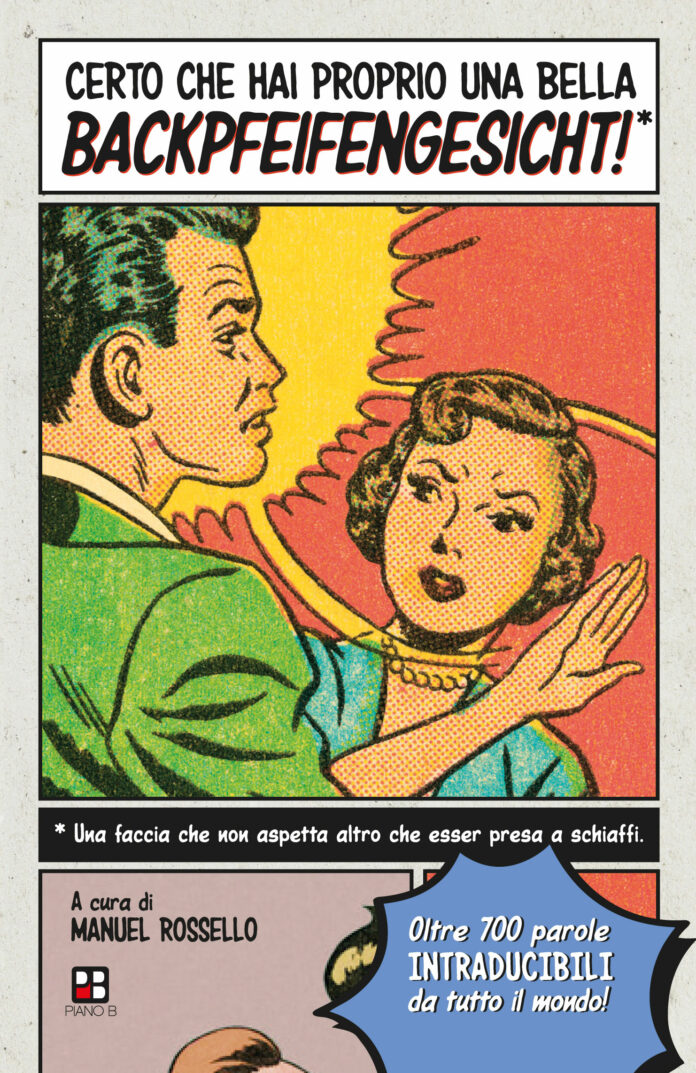
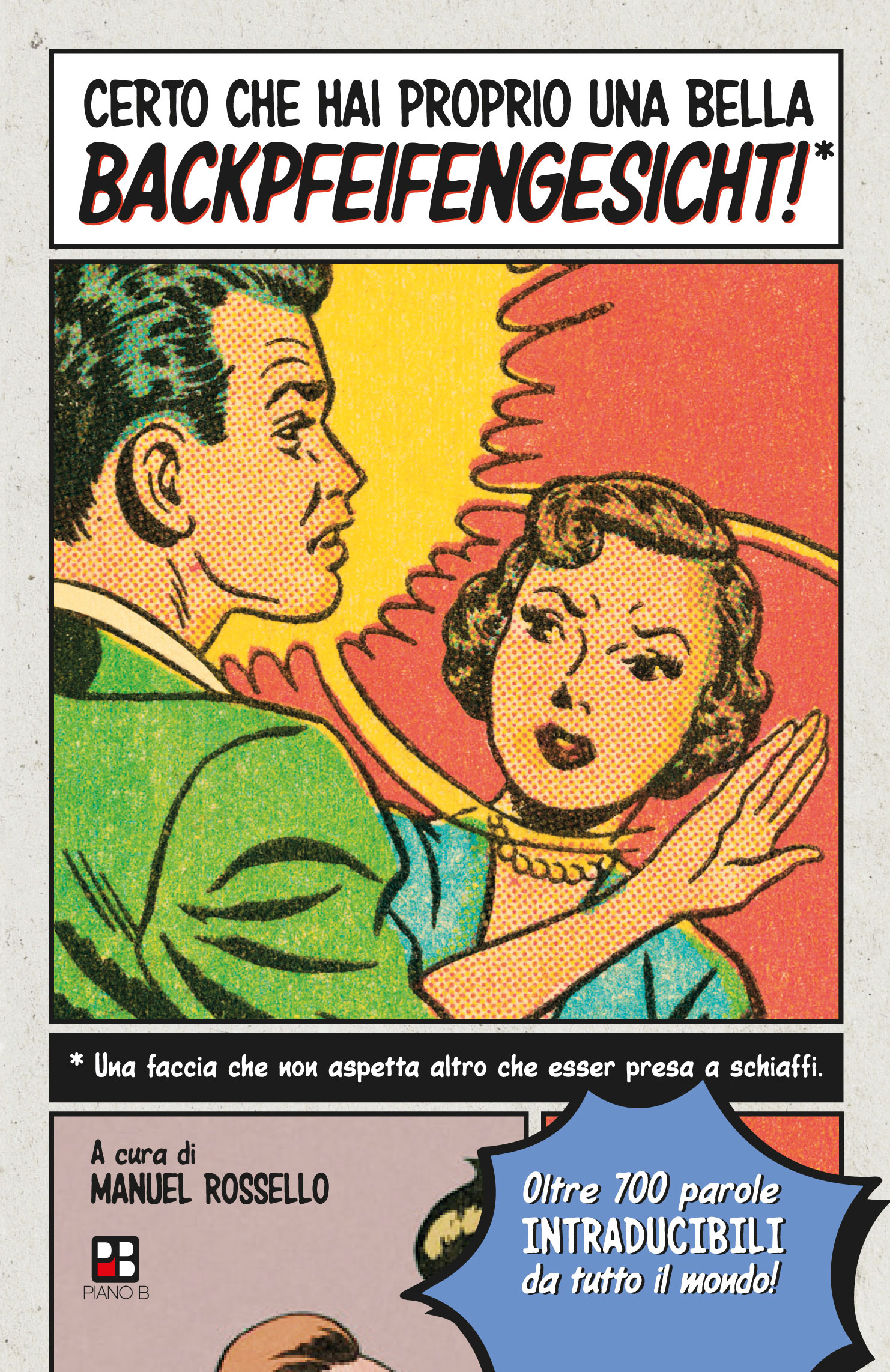















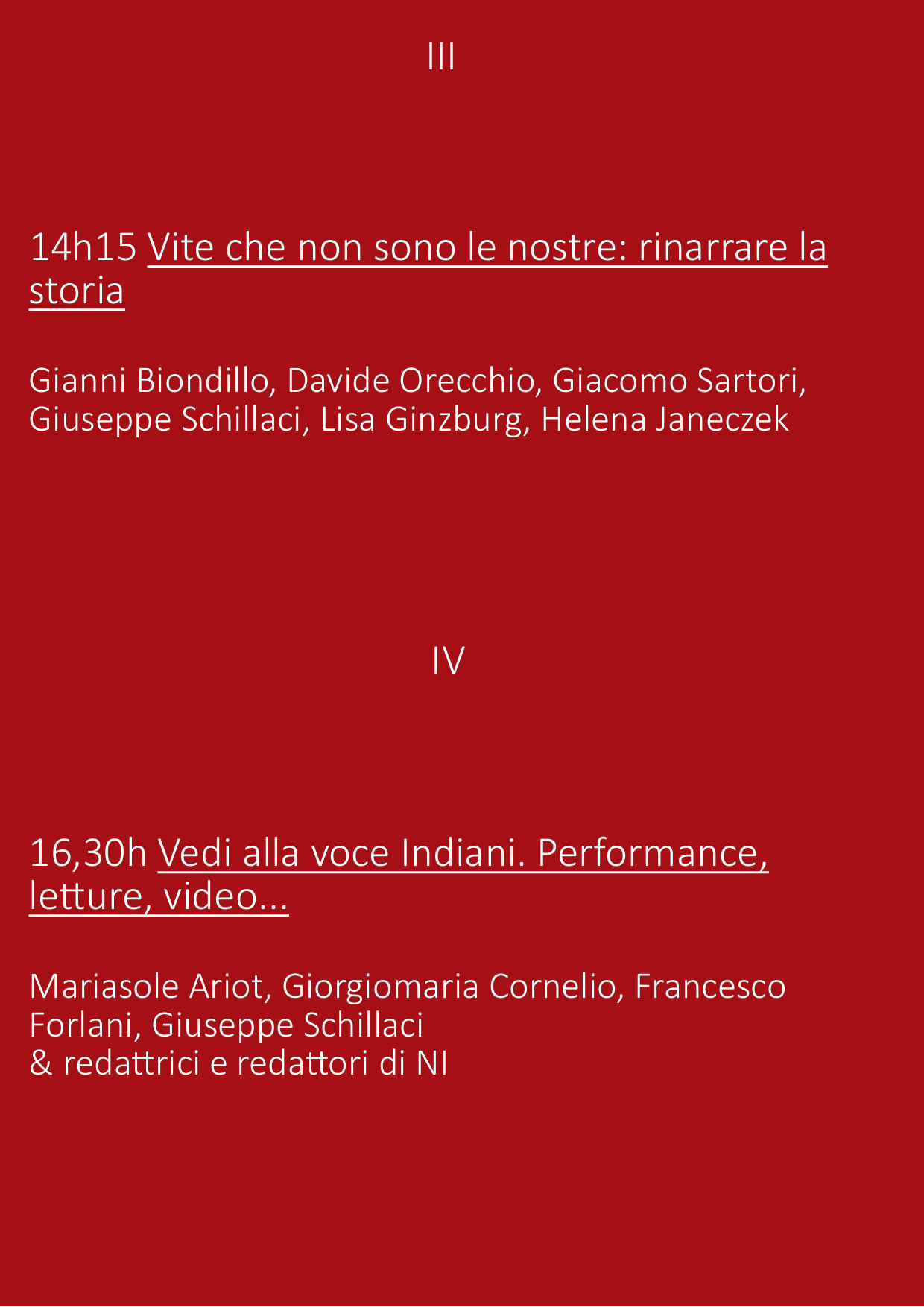


































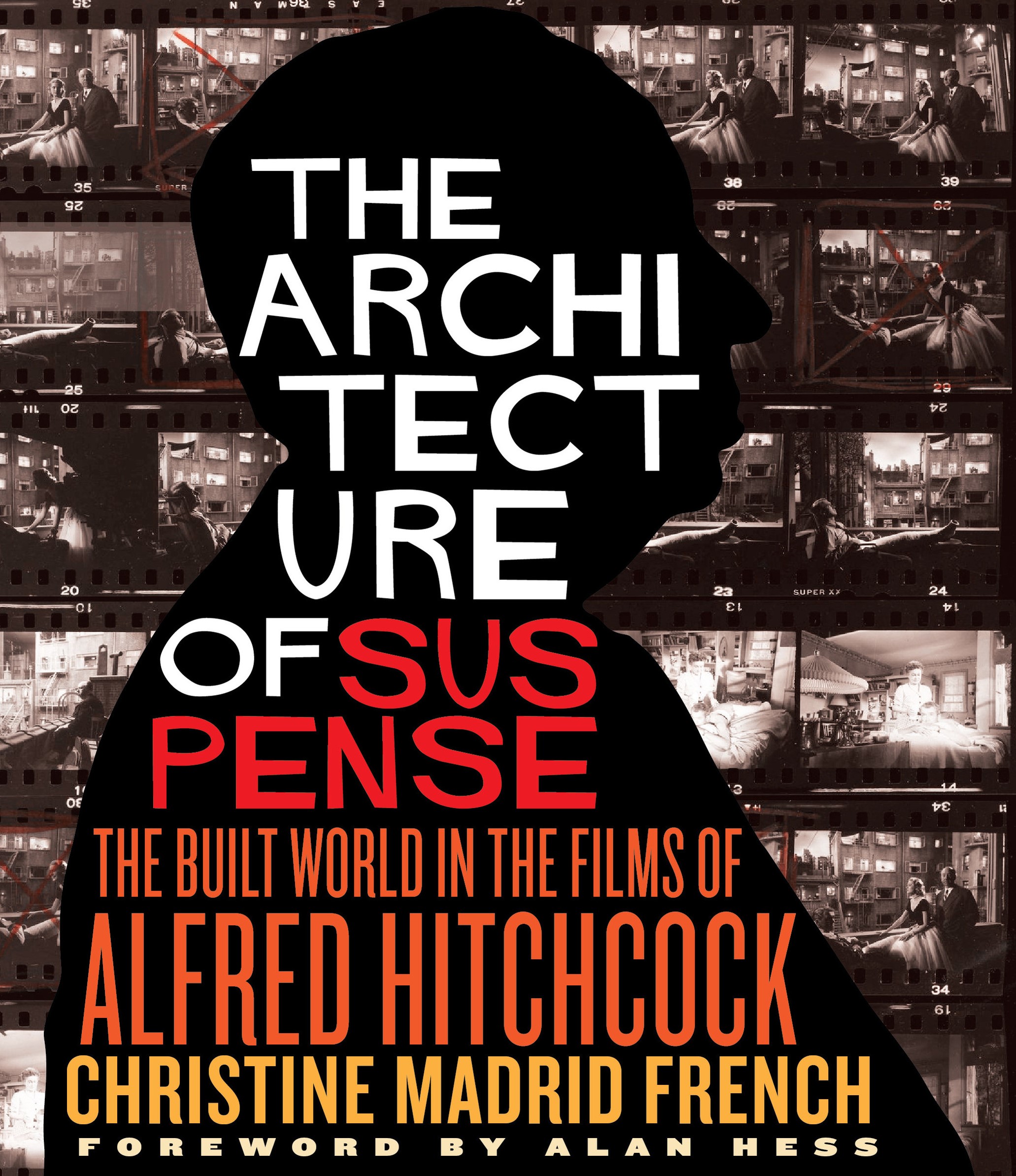 di Gianni Biondillo
di Gianni Biondillo








